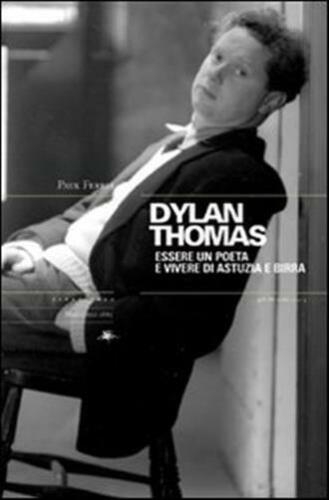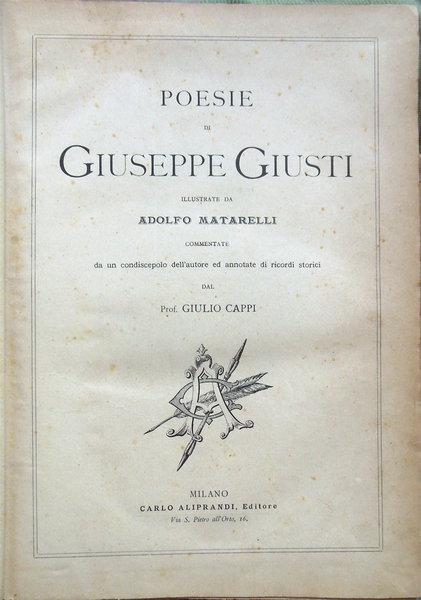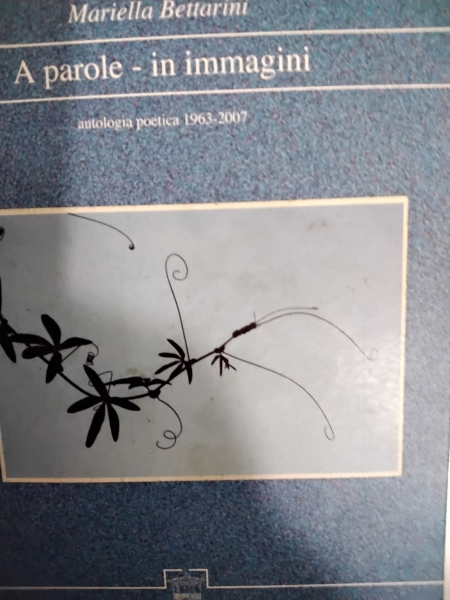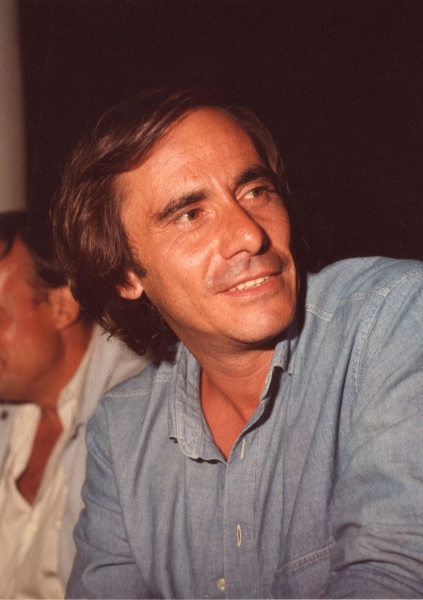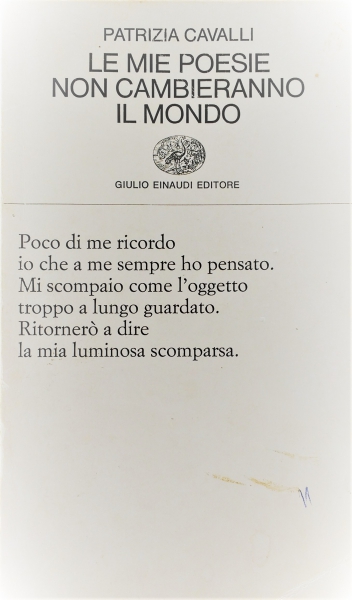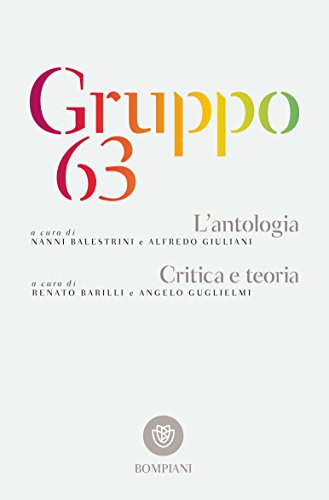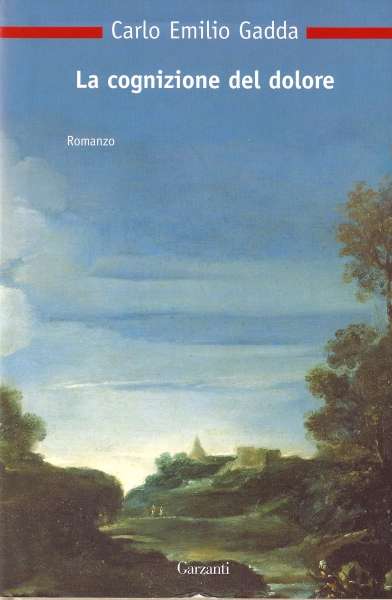set 252022

Forse tutto è già stato scritto e quello che non è stato scritto forse non meritava di essere scritto, non era degno di nota, era puro nonsense.
Forse -dicevo- tutto è già stato scritto.
La Neoavanguardia già nel dopoguerra sembrava aver divorato tutte le poetiche. È impresa ardua, quasi improponibile cercare di riformulare dei codici espressivi. Il ‘900 letterario è stato artefice di grandi stravolgimenti. Il panorama nell’ambito della poesia è mutato completamente. Per secoli ha predominato una tradizione aulica, intessuta di preziosismi, latinismi, grecismi. Per secoli il linguaggio poetico è stato vago, raffinato e circoscritto. Le sperimentazioni tutt’al più erano metriche.
Tutto a un tratto nel 1900 ecco una miriade strabiliante di innovazioni sintattiche, morfologiche e lessicali. Ecco affacciarsi l’antilirica, se si paragona la poesia moderna a quella dei secoli addietro. Un’antilirica, che sempre più si disinteressa della metrica e pone tutto il suo interesse nelle poetiche e nell’ampliamento del lessico. Non esiste più la poesia come entità autonoma di conoscenza e produzione, di corrispondenza prelogica e preconscia tra l’essenza delle cose e l’essenza dell’animo umano. Avviene il dominio del contenuto sulla forma, della poesia del fare poesia sulla poesia, dell’arte dell’arte sull’arte.
Alcuni critici riprendono il concetto hegeliano di “morte dell’arte”, ma piuttosto si tratta di serie di radicali trasformazioni, della dissoluzione di canoni preesistenti ormai sclerotizzati. Non esiste una “morte dell’arte”, ma il prevalere della poetica sulla poesia e ciò comporta una maggiore consapevolezza del proprio fare artistico e talvolta un eccessivo smontaggio analitico delle opere creative. Ogni aspetto del reale può ispirare, anche ciò che un tempo poteva essere considerato impoetico per eccellenza. Ogni termine di qualsiasi campo semantico può diventare poetico. Si pensi ai tecnicismi di Zanzotto recentemente, ma a dire il vero avevano iniziato Pascoli e Montale, profondi conoscitori della botanica. Ecco comparire all’improvviso l’inconscio con il surrealismo e il paroliberismo dei futuristi: i sintagmi sono in libertà, non c’è alcuna struttura interna.
Nella poesia sembra essere ammesso quello che ordinariamente non è ammesso altrove. Per seguire i flussi di coscienza l’artista spesso procede per associazioni, frammenti, immagini-frase.
Nel’900 è vietato ogni presupposto assolutistico. I poeti sono politeisti dell’arte. Ci si può perdere di primo acchito in questo caleidoscopio, in questa confusione di linguaggi che ha come comune denominatore il relativismo e il prospettivismo (la realtà viene indagata da più angolazioni).
Niente sembra più stabile e il cultore di poesia non sa più di chi e cosa fidarsi in questo apparente disordine, in questa molteplicità stilistica. Dopo lo schizoformismo di Giuliani, la prosa poetica di Nanni Balestrini, l’asintattismo di Elio Pagliarani, la Palus Putredinis di Sanguineti, il ritmo di Amelia Rosselli, il tono colloquiale e privato di Dario Bellezza, “Il disperso” di Maurizio Cucchi, le folgorazioni di Milo De Angelis è difficile non essere banali. È fuori luogo poi essere loro manieristi. Altra era la temperie culturale vissuta da questi grandi autori, altro era il contesto sociale del ‘900 e le problematiche annesse e connesse (boom economico, unificazione linguistica, comparsa della televisione, scomparsa della civiltà contadina, migrazioni interne dal Sud al Nord, contestazione studentesca, anni di piombo, il ruolo e lo status del letterato nell’era industriale, netta divisione tra cultura di massa e cultura alta).
Molte poi sono le scuole (l’idealismo, il crocianesimo, lo storicismo gramsciano, la critica formalista, lo strutturalismo, la semiologia), gli ismi letterari (il simbolismo, il crepuscolarismo, il surrealismo, l’ermetismo, il futurismo, il neorealismo, il neosperimentalismo, la neoavanguardia, il neo-orfismo), i maestri di pensiero (i più recenti ad esempio: Lacan e l’inconscio come linguaggio, Wittgenstein e i suoi giochi linguistici, Lyotard e il postmoderno, Heidegger e la sua ontologia della poesia, Gadamer e la sua ermeneutica, Foucalt ed il suo concetto di potere, Derrida ed il suo decostruzionismo e ancora… R. Barthes, Levi-Strauss, Chomsky, Marcuse, etc, etc) a cui un autore può fare riferimento. Molte sono le strade percorribili. Svariate sono le problematiche stilistiche: scegliere tra suggerire e nominare, tra prosaico e lirico, tra tradizione e innovazione, tra metafora e analogia, tra un linguaggio puro e astorico e uno ricco di contaminazioni.
Difficile oggi poi fare una mappatura esaustiva della poesia italiana, difficile definire attualmente che cosa sia in quest’epoca di “tradizione del nuovo”, di autori neo e post la vera poesia.
Simposi, convegni, corsi di creative writing, articoli, saggi hanno cercato e cercano di pontificare a riguardo.
set 142022

Analisi e commento di "Così siamo" di Andrea Zanzotto:
Dicevano, a Padova, “anch’io”
gli amici “l’ho conosciuto”.
E c’era il romorio d’un’acqua sporca
prossima, e d’una sporca fabbrica:
stupende nel silenzio.
Perché era notte. “Anch’io
l’ho conosciuto”.
Vitalmente ho pensato
a te che ora
non sei né soggetto né oggetto
né lingua usuale né gergo
né quiete né movimento
neppure il né che negava
e che per quanto s’affondino
gli occhi miei dentro la sua cruna
mai ti nega abbastanza.
E così sia: ma io
credo con altrettanta
forza in tutto il mio nulla,
perciò non ti ho perduto
o, più ti perdo e più ti perdi,
più mi sei simile, più m'avvicini.
Sarò possibilista dal punto di vista metrico. Il primo verso potrebbe essere un endecasillabo, se usiamo la dialefe. Il secondo verso è un decasillabo. Il terzo verso è un doppio settenario, sempre se consideriamo la dialefe. Il quarto verso è un endecasillabo, sempre con dialefe. Il quinto verso è un settenario. Nei primi cinque versi di Zanzotto, in questi due primi periodi, mi sembra che le parole debbano essere soppesate, ponderate. Nessuna parola è di troppo in questa lirica e ogni parola è al posto giusto: ciò denota una precisione chirurgica nella nominazione. Se non utilizziamo la dialefe invece gli endecasillabi sono solo due (uno è l’ultimo verso della poesia). Inizialmente si noti l’iperbato. Il romorio è un termine desueto per indicare un rumore persistente, incessante. Solo l’acqua sporca e la fabbrica scalfiscono il silenzio. Nelle prime due frasi il grande poeta si rifà metricamente alla tradizione, alternando due endecasillabi (uno solo se non contiamo con la dialefe) a un doppio settenario e a due settenari. Successivamente ci sono diversi ottonari, diversi novenari, diversi settenari e svariati enjambements. I versi sono liberi, ma c’è il rispetto delle regole metriche. In questa lirica non abbiamo ancora lo Zanzotto de “Il galateo in bosco”, che con il suo ipersonetto rinnova la tradizione del sonetto “classico”. Qui Zanzotto non tratta del petèl (della lingua dei lattanti) né della “psicanalessi” né utilizza il suo plurilinguismo. Qui Zanzotto non gioca con il linguaggio, non è in bilico tra balbettio e sproloquio, né tra afasia e amnesia. Qui non c’è ancora lo Zanzotto che tratta degli ossari del Montello. Qui ancora non c’è l’io “male sbozzolato” e neanche “Io – in tremiti continui, – io – disperso e presente”. Il poeta mette da parte psicologismi e nevrosi, insomma “l’esistere psichicamente”. Zanzotto qui doveva ancora diventare il poeta sperimentale, quello che si riferiva al significante (a Saussure, a Lacan), assolutamente non legato alla neoavanguardia, ma che però aveva fatto la sua gita a Chiasso (come voleva Arbasino) e aveva cultura non provinciale ma europea. Il poeta doveva ancora utilizzare il dialetto. Zanzotto doveva ancora diventare il poeta che voleva salvaguardare a tutti i costi il suo amato Veneto dall’industrializzazione selvaggia, dallo scempio edilizio, dall’inquinamento. C’è un fatto personale da un certo punto di vista che mi lega alla grande poesia di Zanzotto: avevo amici in giovinezza a Pieve di Soligo, Conegliano, Vittorio Veneto. Sono stato in quei posti. I miei amici mi raccontavano di questo loro grande poeta, di questo loro grande concittadino, schivo e riservato. Ho conosciuto anche io quei luoghi. Sia ben inteso che il Veneto che ho visto io è più quello cantato da Zanzotto che quello narrato a tinte fosche da Carlotto (con tutto il rispetto e la stima per quest’ultimo). A ogni modo questo componimento è tratto da “IX ecloghe”, raccolta scritta tra il 1957 e il 1960. Zanzotto doveva far ancora sua la frase di Hölderlin “siamo segni senza significato”, anche se leggendo attentamente questi versi memorabili c’erano già tutte le premesse, ma è altrettanto vero che qui il poeta è alla spasmodica ricerca di un’autentica significazione, che però naturalmente non trova, dato che di fronte alla morte ogni parola di conforto, di consolazione è vana. In questa lirica c’è un lutto e il suo tentativo di rielaborare il lutto. Ora anche il poeta è morto da anni, ma questo capolavoro è ancora attuale, ci parla ancora a noi e di noi perché la grande poesia è eterna. In fondo suo padre è morto, ma è stato eternato, immortalato. Zanzotto è morto, ma ha avuto gloria postuma e noi ancora lo leggiamo. La grande poesia quindi rende immortali. Qui c’è solo un brevissimo cenno descrittivo al contesto, all’ambiente nel terzo, quarto, quinto verso. Non c’è nessun bozzetto paesaggistico e non c’è nessuna descrizione minuziosa, ma vengono riportate alcune frasi degli amici del padre (a cui questa poesia è dedicata). Il verso più terribile è questo: “neppure il né che negava”. Il padre ormai se pensiamo al mondo dei viventi e al mondo del visibile non è più nulla. Però anche il poeta è allo stesso tempo nulla perché vive nella precarietà esistenziale e come tutti è prossimo alla fine. Il poeta cerca uno spiraglio, una fessura (la cruna), ma invano. Non è con la percezione usuale e nemmeno con la ragione che si trova un pertugio di speranza, ma come vedremo più tardi solo con un atto di fede nella propria umanità e nella propria interiorità (ricordando cosa diceva Sant’Agostino sul rapporto tra interiorità e verità). È impossibile per la ragione umana pensare a qualcuno che esiste ma che è non è più niente né nessuno, né oggetto né soggetto.

Mentre nella parte centrale era il “né”, ripetuto più volte (queste iterazioni determinano il ritmo di questi versi) a condizionare ogni periodo e a negare la presenza del padre su questa Terra, è decisiva negli ultimi sei versi la particella avversaria “ma”, che determina tutto. Nella parte centrale c’era quell’avverbio “vitalmente” poi seguito da “ho pensato” che era una sorta di eufemismo, un modo elegante e meno brusco per non usare le parole “morte”, “morto”: Zanzotto infatti non utilizza concetti banali come “passato a miglior vita”, eppure non utilizza nemmeno termini mortuari né necrofili. Se nei primi versi sembrerebbe che di un morto resti soltanto l’averlo conosciuto di persona, nell’ultima parte c’è l’affermazione della memoria, della vita, di una nuova vita, anche se mai esplicitata pienamente. Lo testimonia l’espressione “E così sia”, ripresa dalle formule liturgiche, che dimostra il fatto che questa splendida poesia è una preghiera laica. Zanzotto credeva nel divino. Non fu casuale a mio modesto avviso se criticò positivamente e promosse la poesia di David Maria Turoldo. Ritornando a questo componimento, a onor del vero, sono importanti tre parole che condizionano il discorso: “ma io credo”. Zanzotto fa un atto di fede, quello di credere con tutta la sua forza in tutto il suo nulla (dato che ogni uomo è poca cosa, essendo carnale e mortale). Altrettanto importante è la convinzione che ne consegue: “perciò non ti ho perduto” perché le parole, i gesti dei morti restano nella memoria dei vivi e prepotentemente ritornano quando meno uno se lo aspetta. A mio avviso in questo modo anche non essere più il né che nega significa ancora una volta che la doppia negazione afferma. Eppure la morte è terribile perché è fortissimo il contrasto tra assenza e presenza. L’autore ebbe a dichiarare che la poesia è “un elogio della vita”, però -aggiungo io- la morte nullifica non solo ogni poter essere ma ogni nostra dicibilità. La morte è l’evento clou, il trauma finale. Se esiste il trauma della nascita, quello della separazione dalla madre, esiste anche il trauma della morte, quello della separazione dai propri cari dal morente e del morente dai propri cari. Comunque è da notare è che il grande poeta quando tratta della morte lo fa con chiarezza memorabile, evitando citazioni, astrazioni, raffinatezze. Zanzotto di fronte alla morte non è mai troppo sentimentale né distaccato, ma sempre coinvolto e partecipe. Non è mai troppo semplice né troppo complesso. Sa trovare la giusta distanza e la giusta dimensione. Sa trovare le parole esatte. Si veda ad esempio “Idioma”, raccolta scritta tra il 1975 e il 1986, in cui compaiono una poesia dedicata a Maria Fresu, vittima della strage di Bologna (di cui non restò più niente, morta insieme alla figlia), e il Tato padovano. In quest’ultimo componimento l’autore scrive dell’anima immortale. In fondo questa concezione religiosa, ma prima di tutto metafisica, era già presente in questo componimento. Non è un caso che in ogni civiltà per fondare un’etica o anche solo una nuova cultura ci sono sempre stati due punti insostituibili: l’immortalità dell’anima e l’esistenza di Dio o delle divinità. È stato così per gli antichi greci. È stato così per gli illuministi, che credevano nella ragione in modo quasi totalizzante, ma erano anche deisti (credevano cioè in una sorta di panteismo). In fondo non è necessario e non l’ho fatta apposta una parafrasi di questo testo. Basta ricordarsi del titolo: “Così siamo”. Per ognuno, indistintamente, suona la campana, citando Hemingway.
set 082022

Ha un bel dire con tutti i suoi platani Firenze.
Non è uguale la musica, non può esserlo.
Ma uguale a che, la stessa di quando -
discetta perdutamente il senso
non trovando fondale a quel risucchio
di mancamento o rimorso.
Né so cosa m'intenerisce di lei,
se davvero la spina che le è infissa della mia vita
o quell'aria di congedo in lei da me, in me da lei. O il niente
di questo.
Mario Luzi è stato uno dei protagonisti della poesia italiana del Novecento. Attraversò quasi tutto il secolo breve. É stato anche senatore a vita. Fu candidato per anni al Nobel della letteratura. Consiglio a tutti di leggere le sue opere e magari anche di leggere "Saggio su Mario Luzi" di Anna Panicali. Luzi fu uno dei protagonisti al Caffè delle Giubbe Rosse. Fu professore universitario e saggista oltre che grande poeta. Apparentemente in questa lirica sembra che Luzi vada a capo quando vuole senza rispettare alcuna regola. In realtà si tratta di versi liberi che rispecchiano i canoni della metrica italiana, tutti con i giusti accenti tonici, anche se senza rime e con alcuni enjambements. Luzi utilizza alcune volte la sinalefe perché questa è la consuetudine tra poeti, mentre la dialefe è l'eccezione. La sinalefe infatti è più eufonica, mentre la dialefe è più disarmonica e più entropica. Ci sono anche degli endecasillabi canonici in questo testo. Non vi traggano in inganno alcuni versi più lunghi del componimento perché sono anch'essi metricamente ineccepibili. Mario Luzi nel corso di tutta la sua carriera poetica non è mai andato a capo a caso, come molti versoliberisti (forse a torto, più probabilmente a ragione). Il primo verso ad esempio è un doppio settenario con sinalefe. Il terzultimo verso è un doppio novenario, scandendo normalmente le sillabe. Il penultimo verso è un doppio ottonario con sinalefe. Certamente la sua prima produzione poetica era metricamente più rigorosa di quella in età matura e in vecchiaia, ma il poeta ha dimostrato sempre grande prolificità, capacità di rinnovarsi, una scrittura impeccabile. In questa poesia esprime sia un'idea che un sentimento. Non si perde nel dettaglio del dettaglio. È una lirica che va presa nella sua gestalt globale. È una poesia breve, ma solo apparentemente semplice.
"Ha un bel dire con tutti i suoi platani Firenze" è una personificazione. Firenze sembra parlare con i suoi platani. Luzi non cita la Firenze celebrata da cartolina, dei grandi capolavori artistici. Non rievoca neppure Firenze come grande città di marmo, come lui stesso ebbe modo di definirla. I platani appartengono al campo semantico della natura ma anche a quello associativo della familiarità (leggi anche della consuetudine).
Luzi è un grande poeta ermetico, che usa sapientemente le analogie e le metafore.
In questo senso è anche simbolista. Per lui fare poesia significa ricercare "corrispondenze", come nella celebre lirica di Baudelaire, e allora dopo aver trovato corrispondenze tra i propri stati d'animo e i paesaggi ogni città diventa un luogo dell'anima, un posto interiore, una "foresta di simboli", sempre per riprendere il poeta maledetto francese. Ma cosa significa "Non è uguale la musica, non può esserlo"? Significa che le corrispondenze cambiano continuamente, incessantemente perché cambia continuamente la città e cambiano sempre i moti dell'animo dell'autore. "Discetta" significa esamina. "Non trovando fondale a quel risucchio/ di mancamento o rimorso" significa che se la parola per Luzi deve volare verso il vertice della significazione (lo zenit) la memoria invece è un abisso, non ha fondo, eppure è un grande vortice, un grande gorgo. Ma di cosa? Di assenza (mancamento), perché mancano visi, volti, luoghi di un tempo, e di rimorso, ovvero di sensi di colpa per gli errori commessi. Si noti anche tutta l'umiltà e il basso profilo del grande poeta fiorentino che naturalmente non attribuisce niente di negativo a Firenze (non parla di nessun borgo selvaggio), ma paragona la propria vita a una spina infissa dentro la sua città. Ma cosa significa "quell'aria di congedo in lei da me, in me da lei"? Significa probabilmente che la Firenze di quei giorni non sarà più la stessa e forse non avrà più tutti i suoi bei platani, ma anche qui Luzi pensa alla sua dipartita. Oppure una terza opzione: Luzi chiude con "...o il niente di/ questo", con un versicolo ungarettiano di una sola parola, una clausola dal tono dimesso, che però significa che il poeta non è certo di niente, non sa davvero il senso della sua tenerezza, sa solo dell'affetto profondo che lo lega a quei luoghi senza saperne i motivi. Firenze per Luzi non è un posto come un altro. Leggendo questi versi sorgono in me alcuni interrogativi. Quanti anni bisogna vivere una città per conoscerla veramente? Quante strade bisogna conoscere? Quanti luoghi bisogna aver frequentato? Quante persone bisogna aver incontrato? Quante storie bisogna aver avuto? E se questo rapporto fosse una catena indissolubile? Cosa è che ci lega veramente a questo posto? Di cosa sentiremo la mancanza? Non ci sono risposte, ma solo impressioni e un vago sentore di essere abitudinari o recidivi. Approssimativamente posso solo dire che ogni paese ha il suo cielo e ogni cittadino ha un angolo di cielo, a cui spesso rimane fedele negli anni. Ma questa poesia mi dice altre cose, mi suggerisce altre cose. Quando descriviamo un paesaggio in realtà descriviamo il nostro punto di vista. Quando parliamo del mondo in realtà parliamo della nostra visione del mondo. L’umanità è una moltitudine incredibile di punti di vista, di visioni del mondo. Ognuno è una sintesi di interno ed esterno, di idee e cose, di soggettività e oggettività. Forse siamo fatti male, ma è così ad onor del vero. Questo è ciò che mi fa ricordare questa poesia. In definitiva Firenze sembra voler dire tante cose e sembra voler significare molte cose al grande poeta. Sempre Mario Luzi in una sua intervista dichiarava riguardo alla città: "La raffigurazione, naturalmente, è reale e simbolica nello stesso tempo e vuole denunciare che la città umana senza idea vitale si sfascia". Non a caso a conti fatti è difficile, anzi è quasi impossibile trovare il senso compiuto di una città, anche se è cara e familiare.
ago 132022
Maria Turtura (1930-1972) fu un medico bolognese, sorella della sindacalista Donatella, prima donna nel 1980 a far parte della segreteria generale della Cgil. La poetessa si suicidò dopo essere stata lasciata dal marito. Pubblicò "Qualcosa deve venire" (Rebellato, 1966) e "I cancelli della mattina" (Argalia, 1970). Unico critico letterario ad averla considerata è stato il grande Franco Fortini in "Poeti del Novecento", che ha definito la sua poesia "significativa" e di lei ha scritto che era una voce "severa e profonda". È stata una mia cugina di secondo grado, ma è morta l'anno che sono nato. Ecco alcune sue poesie:
Caro dottore che mi curi i nervi
voglio dirti in questi giorni com'è andata
affinché tu ti possa regolare
per quello che mi serve in questi giorni:
ho dei sintomi al cuore
nella parte che nessuno vede:
sapessi che disastro, dottore!
Il mattino lavoro
il pomeriggio lavoro
e di sera ho la netta sensazione
di essere un guscio vuoto in un cartoccio.
Ho altri mali che non dico
perché la lista è molto piena
e non posso far tardi soprattutto
ho quel mal di cuore
nella parte che nessuno vede:
ti consiglio di ascoltarmi, dottore.
Questi occhi che hai
non dimenticati
con dentro un'ombra
di mare del Nord tempestoso
che cosa guardano stasera
nel tuo freddo paese, amico,
mentre io mi ricordo
di una luce sul lago e di una
esile speranza, così esile
come solo può essere
un amore al principio.
Alberi di neve che non vedi
respiro corto della terra e voci
da luoghi ignorati
mentre suonano passi sul tuo capo
e la notte si prepara anche per gli altri.
Io non trovo più Dio, bambino cieco,
nel celeste sospeso dei tuoi occhi
nelle cose che indovini con parole ardite:
"Questo luogo è chiuso da mura".
Io so che fuori non sono centauri
né terre di lunga corsa.
Altre mura
chiudono altri luoghi.
Ogni recluso ha un orologio
che batte sbagliato i quarti.
Questo è tutto, e qualcosa
deve venire
a distruggere i muri
e all'ora giusta confondere i luoghi,
a cancellare gli ordini di Dio
perché valga la pena di vedere.
(Di lei che ama un mio amico sposato
e ha una malattia difficile da guarire,
di lei in ogni caso
padrona di sé stessa):
cara amica, io ti ho visto
su un ponte di primavera
tu eri là guardando in avanti
con uno sguardo che pareva azzurro,
dicendo parole di quieta meraviglia
e muovendo le tue esili mani.
La sua bontà capovolta
il rifiuto delle cose assolute
per un mondo di treni
e di letti da rifare,
il suo vestito, ai piedi
di uno da non confondere con altri.
Sempre lei, che di mattina
si prepara con cura
a un altro giorno di silenzio.
Si oscura l'aria sul tuo prato, Anna,
e con lenti giri
cala il falco.
Una notte di pioggia è in cammino
per accordare il tuo respiro al calmo
frusciare dell'acqua.
Stasera un cielo di inchiostro veleggiava sulle case
e la città muta guardava dalle finestre di maggio.
Un caldo vento mi spingeva innanzi
traendo il suono sospeso di un telaio.
Io venni alla tua casa
per un discorso che mi urgeva
nato da quelle immagini.
Tu sorridevi alla porta.
Alle undici Gesù è risorto.
Sulla Certosa il sole era alto.
Poiché non ho pregato: - Prendi per mano mio padre
e portalo con te a fare un giro nel cielo -
il babbo è rimasto dietro la sua pietra
e Gesù se n'è andato per conto suo.
Prima che scomparisse gli ho gridato:
- Fai morire quelli che uccidono i Viet! -
La luce è calata di una luce
e ora pare sera
ma l'uomo dai capelli bianchi
alto sullo sfondo dei vetri
deve avere in sua mano
il segreto finire del giorno.
L'ora di notte mi porta
alla piazza delle Sette Chiese
dai silenziosi cipressi.
Un inverno di piccoli passi
si irraggia verso il punto che tardi
chiamai la casa, luogo che nulla
dice agli altri, breve
inverno stellare, dove l'anima
tende a riavvolgersi.
Per aver visto il suo nome
su tre cose che gli altri
dicono belle, io vorrei
bere pazzamente e battermi
con la mia sfortuna fino a perdere,
fino a far sangue,
tanto mi sottrasse la donna
che si mise nella sua ombra
ed era in niente
migliore di me.
Si sono accese insieme nell'acqua
due luci; il giardino ha rumori;
con veste bianca e chino il capo
due donne dall'infermeria
mentre geme un autunno
di muri e di alberi
inseguiti dal vento.
Se avessi avuto un cappotto
con un colletto di pelliccia
forse non mi avresti lasciato.
Se un fischio arguto
avesse accompagnato i miei discorsi
ti saresti così confuso
da ritenermi importante.
Invece non sapevo fischiare
e avendo mal di gola
parlavo piano, per via di quel colletto
di pelliccia che non possedevo.
Quando il bambino
avrà finito di battere sul suo tamburo
comincerà la danza
delle zanzare,
suonerà qualcuno alla porta
o mi sentirò così triste
di qualcosa che ora non conosco.
Nel silenzio della campagna
a un tratto
chiamava una voce.
Veniva da una siepe oscura
presso gli alberi di confine,
mi gridava di ritornare.
Io cammino così
sotto le nuvole bianche
per raggiungere un sogno
di mezzogiorno.
Non disturbate questa
bellezza degli amanti giovani
che guardano solo dentro i loro occhi
e vivono come i rami degli alberi
strettamente confusi
alteri e senza presagi
della terra che tiene le loro radici.
Come le lettere bianche
sulla tenda azzurra del macellaio
come quest'aria di paese
così confidenziale e nuova
i miei pensieri.
Noi ci amammo poveramente.
Solo una luce di fanali
una tiepida pioggia
nella città di notte, e poco altro
ci diedero per amarci. Ma noi fummo
per il distacco e il ricordo
per la gioia di ritrovarci
sempre grati a noi stessi
di non esserci persi
nelle strade e nei porti
che mai vedemmo.
lug 042022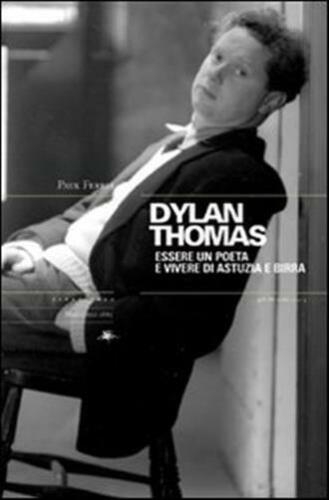
Quest’opera è una biografia del grande poeta Dylan Thomas, che nacque nel 1914 nel Galles e morì in America nel 1953. L’ultimo capitolo del libro sembra far chiarezza in modo definitivo sulle cause della morte del poeta gallese. L’ipotesi più accreditata è che non fu il delirium tremens scaturito dai 18 whisky ingurgitati a causarne il decesso, ma un’eccessiva dose di morfina somministrata dal medico. Il biografo cerca innanzitutto di distinguere gli episodi realmente accaduti da tutta una serie di leggende, aneddoti e dicerie riguardo all’eccentrico Dylan Thomas. D’altronde accade spesso nel caso di grandi poeti, che hanno fama postuma e imperitura. Se poi aggiungiamo che Thomas non è solo ricordato per le sue poesie immortali, ma anche per il fatto che il cantautore Robert Zimmerman ha utilizzato il nome d’arte Bob Dylan per rendergli omaggio, si capisce perché le leggende siano fiorite ad iosa. Nel libro non viene presa in esame la poetica di Thomas. Nessun cenno alle liriche visionarie, agli schemi metrici, alle analogie che gli procurarono la gloria. Nessuna analisi accurata sulla poesia che cercava di “penetrare la chiara nudità della luce”. Piuttosto possiamo leggere alcuni inediti, tra cui le sue prime incerte liriche. Da questi scritti si può arguire che Thomas fu un poeta molto precoce. Inizialmente i pareri della critica letteraria riguardo alle sue poesie furono discordanti. Vengono anche riportate le testimonianze degli amici e i brani più significativi delle lettere scritte alla moglie. Da questa biografia scopriamo quindi alcuni lati della personalità del poeta. In fondo la sua poesia traeva linfa proprio dalla sua personalità. Un amico del poeta dichiarò che Thomas non faceva altro che costruire e riassemblare la sua personalità incessantemente. Infatti Dylan Thomas dichiarò: “Dentro di me albergano una bestia, un angelo e un pazzo, la mia indagine riguarda le loro opere, il mio problema è soggiogarli vittorioso, scaraventarli a terra e risollevarli, la mia fatica è la loro espressione”.

Dylan Thomas morì a soli 39 anni. Ebbe una vita breve, ma intensa. Visse spesso di espedienti. Fu un clown per gli amici e un assiduo frequentatore di pub e di bordelli. Quando era in comitiva amava sempre essere al centro dell’attenzione. Fu un accanito fumatore e probabilmente soffrì di asma. Per alcuni fu solo un compagno di sbronze, uno che beveva come una spugna. Certamente amava la “compagna bottiglia”, ma il biografo non riesce a stabilire esattamente, dopo aver raccolto molte testimonianze in proposito, se fosse un forte bevitore o un vero alcolizzato. Fu un clown per molti amici. Essendo spesso squattrinato approfittò spesso di loro, chiedendo ospitalità e dormendo spesso sui loro divani. Fu un pessimo studente, nonostante suo padre fosse un insegnante della scuola in cui studiava. Fu cronista locale, ma venne licenziato. Per un periodo visse a Londra, frequentando pseudoartisti e pseudorivoluzionari. Fu sregolato e a tratti si ha la netta impressione che fosse indifferente a tutto (anche alla guerra), tranne che alla propria arte. Si sposò con Caitlin: una ragazza disinibita, piacente, infedele, amante del ballo, inquieta, litigiosa, spesso ubriaca. Alcune incomprensioni nacquero anche perché lei proveniva da una famiglia aristocratica e si disinteressava totalmente di ciò che dicevano vicini e conoscenti, mentre invece il grande poeta gallese - essendo di estrazione borghese - cercava di non dare adito ai pettegolezzi, pur vivendo anche lui di eccessi. Sua moglie odiava i piccoli paesi perché a suo dire nelle piccole comunità vigeva una mentalità ristretta e retrograda, mentre Thomas - pur essendo cosciente di ciò - riteneva che in un borgo poteva fare vita più sana e essere più concentrato per scrivere. Caitlin inoltre era un’aspirante artista e non voleva accontentarsi di essere solo e semplicemente la moglie del poeta. Un’estate andarono in vacanza all’isola d’Elba, ospitati dall’intellettuale Luigi Berti. Passarono anche qualche giorno nei pressi di Firenze, ma da ciò che Thomas scrisse nelle lettere si deduce che non si trovò affatto a suo agio. Molti intellettuali americani e italiani volevano incontrarlo e ciò lo infastidiva. Si guadagnò da vivere per alcuni anni scrivendo le sceneggiature di documentari per il cinema. Per un periodo lavorò anche alla BBC. Infine si recò in America in quanto il direttore del Poetry Center dell’associazione giovani ebrei di New York era disposto a pagarlo perché tenesse conferenze e readings. Questa opera è quindi una biografia rigorosa, accurata e per niente romanzata di uno dei più grandi poeti inglesi e del secolo scorso.
giu 302022

La letteratura è minacciata dalla comunicazione di massa, al punto che Montale nel suo discorso per il Nobel nel 1975 si domanda se in una società di massa possa sopravvivere la poesia e conclude così: "Si potrebbero moltiplicare le domande con l’unico risultato che non solo la poesia, ma tutto il mondo dell’espressione artistica o sedicente tale è entrato in una crisi che è strettamente legata alla condizione umana, al nostro esistere di esseri umani, alla nostra certezza o illusione di crederci esseri privilegiati, i soli che si credono padroni della loro sorte e depositari di un destino che nessun’altra creatura vivente può vantare. Inutile dunque chiedersi quale sarà il destino delle arti. E’ come chiedersi se l’uomo di domani, di un domani magari lontanissimo, potrà risolvere le tragiche contraddizioni in cui si dibatte fin dal primo giorno della Creazione (e se di un tale giorno, che può essere un’epoca sterminata, possa ancora parlarsi)".
La letteratura è amplificata, potenziata, ma in parte deformata e resa un poco asettica dal web. Siamo sicuri che la critica non diventerà giornalismo? Il significato non prevarrà sul suono, il segno sul simbolo, l'algoritmo sul mito?
La letteratura italiana è inoltre diventata poca cosa, relegata ai margini con il dominio dell'inglese. Siamo una provincia dell'impero anglofono. Non siamo neanche più una riserva. La lingua italiana arricchita o divorata dagli inglesismi? Avrà ancora modo di esistere la letteratura italiana?
La poesia che relazione può avere con la tradizione (a chi deve rifarsi uno scrittore? Con chi deve essere uno scrittore stilisticamente e letterariamente? Oppure deve pensare: "toglietemi la storia, sennò da dove ricomincio?" come negli anni '70 scrisse Milo De Angelis)? Bisogna guardare "Conversazioni su Tiresia", monologo di Andrea Camilleri e poi magari decidere, anche se per Eliot la tradizione e il talento individuale dovrebbero sempre interagire.
Ha più senso scrivere? Cosa può comunicare oggi uno scrittore? Essere per esempio irregolari e di nicchia può servire a qualcuno? Probabilmente né agli altri né a sé stessi. Comunicare la propria incomunicabilità spesso significa parlare da soli contro un muro e sentire l'eco delle proprie parole. Niente altro che questo. E se uno invece vuole arrivare alle masse finisce di solito per non fare letteratura. In ogni caso spesso non vengono salvaguardati né lo scrittore né la letteratura.

"Duchamp diceva: se un oggetto a tre
dimensioni proietta un'ombra a due,
dovremmo immaginare quell'ignoto
oggetto a quattro dimensioni di cui noi
siamo l'ombra. Da parte mia, mi affascina la
ricerca dell'oggetto a una dimensione che
non getta ombra".
Octavio Paz da "Corrente alterna"
Forse l'oggetto a quattro dimensioni di cui teorizzava Duchamp è ciò che ci trascende, ovvero Dio. Meglio rasentare terra col nostro volo, direbbe Bob Dylan. Quindi è del tutto legittima la ricerca di Paz dell'oggetto a una dimensione che non getta ombra. Ma noi esseri umani percepiamo il mondo in modo tridimensionale grazie alla superficie bidimensionale della nostra retina. La quarta dimensione ci sfugge, ma anche una sola dimensione ci sfugge. Una sola dimensione è al di sotto della nostra soglia di coscienza. Noi non possiamo percepirla come gli ultrasuoni, che invece sentono i cani. Noi non abbiamo neanche gli occhi mirifici della mosca. Certe cose sono precluse alla nostra percezione. Lo scrittore deve perciò fare riferimento a un'altra dimensione inaccessibile? Non è chiedere troppo? Forse è troppo. È un dato di fatto. Dobbiamo accettarlo. Non possiamo farci niente, a meno che l'oggetto a una dimensione che non getta ombra non debba intendersi come l'inconscio (non totalmente attingibile) o il nostro Sé (sfuggente). La vera letteratura potenzialmente si dovrebbe confrontare con tutto ciò? E se scrivere significasse gettare un ponte sull'assurdo?

Houellebecq scrive che l'uomo contemporaneo legge perché "ha bisogno di altre vite, diverse dalla sua, semplicemente perché la sua non gli basta". Leggere significa quindi avere un arricchimento esperienziale. Di solito ci arricchiamo con le parole, i pensieri, la fantasia degli scrittori morti, difficilmente degli autori contemporanei. Ma come affrontare il mondo? Con la crudezza anche se con la penetrazione psicologica di Houellebecq, che talvolta finisce nella provocazione fuori luogo e nelle forzature estremistiche? Oppure con il rigore morale di Dante, che addirittura si erge a giudice delle azioni altrui, ma anche con la sua grazia e la sua leggiadria, come per esempio in queste terzine del primo canto del Purgatorio, in cui descrive come si lascia alle spalle l'inferno. In queste terzine è Virgilio che pulisce il viso di Dante con la rugiada:
Quando noi fummo là ‘ve la rugiada
pugna col sole, per essere in parte
dove, ad orezza, poco si dirada, 123
ambo le mani in su l’erbetta sparte
soavemente ‘l mio maestro pose:
ond’io, che fui accorto di sua arte, 126
porsi ver’ lui le guance lagrimose:
ivi mi fece tutto discoverto
quel color che l’inferno mi nascose.

La prima cosa che il potere vuole è interferire su quelli che Lewin chiamava “campi di forza”. Anche questo è un modo per imbrigliare le carte, per confonderci interiormente. È sempre più difficile trovare il modo, lo spazio e per molti il tempo di concentrarsi, di riflettere. Anche molte persone che svolgono professioni intellettuali non ci riescono e delegano perciò a intellettuali riconosciuti il compito arduo di pensare. Però a molti cittadini oltre alla possibilità di riflettere sul mondo manca la possibilità di riflettere, di meditare sulla propria psiche, sulla propria vita; per questo chiedono aiuto a un/a analista. In poesia spesso è il testo che ci fa da analista. Oppure paziente e analista coesistono in noi stessi all’interno della scrittura, della valutazione, della censura, della revisione. In poesia uno può dar libero sfogo al suo materiale spurio psichico, così come può controllare l’inconscio. Ma l’inconscio non si può rimuovere totalmente: qualcosa sfugge sempre. Esprimere il proprio inconscio oltre che una rispettabile scelta artistica è anche un atto di libertà interiore, per alcuni addirittura una necessità interiore.
Un’altra cosa che il potere vuole fare è imporre un immaginario e un inconscio collettivo che sovrasti totalmente sull’inconscio individuale. Ho già espresso a più riprese questo concetto: l’inconscio collettivo attuale non ha più archetipi decenti perché mass media, moda, cinema, televisione non sono più mitopietici come un tempo lo era la letteratura. Oggi gli archetipi propinati sono tutti negativi. È anche questo un modo per renderci senza principi, per farci mancare punti fermi e terreno sotto i piedi. Ma non c’è solo questo. Andiamo oltre.
“Se la funzione alfa non agisce sulle percezioni, ad esempio emozioni dolorose, allora l’esperienza viene espulsa, mediante un’attività pilotata dall’angoscia. Una paziente diceva: “non mi sono dovuta alzare per andare in bagno, nel bel mezzo della notte, perché ho fatto un sogno”. Intuitivamente riconosceva che il sogno trattiene qualcosa in modo che non si debba evacuare precipitosamente. Bion chiama questi elementi che non possono essere trattenuti nella mente elementi beta. […] Sono non-digeriti e danno la sensazione di essere cose-in-sé. Come corpi estranei all’interno della mente. Sono solo adatti ad essere evacuati perché non li si può pensare. Sono persecutori: pezzi di scarto dei quali la mente vuole sbarazzarsi; secondo il principio di piacere quel che provoca disagio viene espulso.” (Symington J e N. (1996), Il pensiero clinico di Bion, Raffaello Cortina, Milano, 1998. [p. 68]). Il potere tramite mass media, moda, pornografia non vuole che metabolizziamo gli oggetti del nostro desiderio. Non vuole che li comprendiamo, che li interiorizzamo globalmente, che li rielaboriamo criticamente e consapevolmente. Per Kernberg in questo modo non siamo più in grado come un tempo di “integrare le parti buone con quelle cattive”. Il potere vuole da noi la scarica, l’acting out senza naturalmente che mai avvenga l’abreazione. Così facendo il potere cerca di ridurre la funzione alfa e di aumentare gli elementi beta. La funzione alfa digerisce tutto ciò che è psichicamente negativo. Bion usa proprio la metafora della digestione. Il desiderio non è che una delle tante cose umane su cui agisce la funzione alfa. La poesia è funzione alfa allo stato puro. Ecco perché la poesia dà noia al potere e i mass media rivolgono un’attenzione insufficiente nei confronti della poesia. La poesia è conoscenza e comunicazione dal nostro profondo al profondo altrui ed è per questo che dà noia al potere, che ci vorrebbe conformisti, frivoli, superficiali, consumistici.
A ogni modo lo scrittore non può autoesaltarsi. Dovrebbe essere contro il potere. Dovrebbe denunciare il disastro ecologico, le ingiustizie economiche. Dovrebbe fare denunce sociali e/o esprimere disagio esistenziale. Ci si potrebbe accontentare quando non tratta delle grandi assurdità della vita e del mondo se riesce a mostrare quelle piccole, come un turista, che da dieci anni non va in ferie e quando va in vacanza è costretto a stare tutto il tempo in albergo a causa del maltempo, oppure come una donna che porta con sé il suo bambino, gli mette anche il casco, e poi attraversa con il rosso.
Ma non scordiamoci che l'uomo sarà sempre un "animale simbolico" come lo definì Cassirer e inoltre anche Goethe nel Faust scrisse: "Tutto ciò che passa è solo un simbolo; l'inattingibile, qui si fa evento; l'indescrivibile, qui ha compimento; l'Eterno Femminile ci fa salire".

La scrittura, anche quella di infimo livello (come la mia) è memoria o suo tentativo goffo, maldestro. Quando scrivo mi ricordo, cerco di ricordarmi. Ma cosa? Per quel che mi riguarda è ricordarmi all’improvviso di pomeriggi afosi ed estivi in una stanza d’albergo in una località imprecisata del lago di Garda oppure di una delle tante sere sulla soglia dell’ingresso a guardare la vita della piazza in attesa di chiudere la cassa e il negozio. È ricordarmi all’improvviso di tutto il tempo perso a rigirarsi nel letto, rimuginando in un mix quasi letale fantasie erotiche e frustrazioni sessuali. Ricordarmi scene di vacanze da bambino o da adolescente sotto l’ombrellone a Cecina oppure al bagno Trieste a Rosignano. Ricordarmi da giovane delle mie notti brave e poi il tempo passato in sala di attesa ad aspettare il treno del mattino, che mi riportava a casa. Ricordarmi tutte le notti insonni e i giorni sonnambuli da giovane. Ricordarmi i viaggi di due/tre giorni fatti con mio padre, a giro per l’Italia e pensare che forse non andremo mai a visitare Matera o che non ritornerò più nelle Marche o all’Aquila. Ricordarmi le cene con gli amici in varie località d’Italia, amici persi, mai più rivisti. Ricordarmi i pochissimi amori e i tanti rifiuti, le delusioni cocenti. Ricordarmi le ore distratte a leggere libri da studiare e le lezioni frequentate svogliatamente. Ricordarmi il vocio indistinto di una strada principale del centro o il brusio in una osteria. Ricordare i viaggi in treno, le impressioni guardando fuori dal finestrino, le viaggiatrici nello stesso scompartimento, i giochi di sguardi, le conversazioni, i silenzi. Ricordare tutte le passanti che abbiamo guardato e che non ci consideravano minimamente. Ricordare le passeggiate col mio cane, con mia madre al parco dei Salici o alla Sozzifanti. Ricordare tutti i sogni, le aspirazioni, i voli pindarici, le albagie, le illusioni, alcuni dichiarati, altri mai minimamente confessati, tutti abbattuti dalla realtà, dalla ragione, dall’età. Ricordare tutti i viaggi, tutte le città che ho visto. Ricordare tutte le nostre metamorfosi, le nostre idee, i nostri sentimenti, la nostra rabbia, le nostre malinconie, i miti creduti. Ricordare tutti gli omicidi, le scene di violenza reali o fittizie a cui abbiamo assistito alla televisione o su Internet. Ricordare tutti i libri letti e accorgersi che è rimasto solo un senso implicito, una conoscenza implicita. Ricordare le astrazioni, gli intellettualismi che non servono a proteggersi dai colpi bassi della vita né a fare da schermo per non mettersi a nudo. Ricordare che nessuna opera d’arte rende la vita fedelmente così come è. Ricordare della maturità acquisita, della pochissima arte, della insipida e scontata saggezza. Ricordare della teoria che si fa esperienza di vita e dell’esperienza di vita che si fa teoria. Ricordarmi di tutte le nozioni apprese, interiorizzate e poi lasciate andare, perdute per sempre. Ricordarmi tutte le nostre conversazioni, le frasi dette agli amici, ai familiari, frasi di circostanza, spesso di convenienza e chiedersi quanto fosse di vero, di autentico in tutte le parole dette e scritte (ma solo io, nessun altro cretino, posso stabilire se siano autentiche o meno le mie parole e forse nel momento in cui le ho scritte o proferite erano autentiche). Ricordare tutte le persone sfiorate, intraviste e tutte le persone conosciute, apparentemente in modo profondo, ma che non abbiamo mai afferrato, mai colto totalmente. Ricordare e dopo aver fatto notevoli sforzi di memoria capire che probabilmente tutto ciò che era più importante ci è sfuggito, è passato dalle maglie della memoria, si è involato chissà dove. Quale archivio disordinato e immenso di cianfrusaglie, di cose squallide è la memoria di ognuno! Fatico a trovare un senso a tutto questo, anzi sarò più sincero: non lo trovo assolutamente. Lo smemorato di Collegno e il Funes di Borges sono due facce della stessa medaglia. L’ippocampo serve per l’apprendimento, ma poi ci vuole la reiterazione per conservare tutto a lungo termine. La memoria talvolta degenera fino alla malattia degenerativa, ma non improvvisatevi neurologi! Si può vivere senza ricordare? Ogni sera prima di addormentarci facciamo il riepilogo spesso del giorno trascorso. Si può ricordare senza vivere? Non ci si può limitare a ricordare senza più vivere perché ricordare non è vivere ma tutt'al più rivivere. Memoria e vita sono legate a doppio filo, ma forse il loro impasto è sadico, crudele, eppure così raffinato. Alcuni perdono memoria e altri si perdono nella memoria. Ci vorrebbe un uso saggio della memoria per vivere! Ma non ci sono leggi certe perché ogni vita, ogni memoria hanno le loro regole. Aveva ragione Proust: la selezione, l’archiviazione, il richiamo della memoria è grosso modo involontario. Do ragione a Proust senza erigere una cattedrale della memoria come fece lui perché non ne avrei il genio né ne scorgerei la benché minima utilità: non frequentai la crema della crema della società come fece lui. Ho in mente solo piccoli ricordi, minuscoli pensieri, pronti a ogni evenienza, spesso adibiti a scacciare la noia. Francamente ammettiamolo pure: ognuno di noi nel profondo conserva una certa ossessività, ritornano nella sua mente, anche quando essa è libera di scorrazzare liberamente, sempre le solite immagini ricorrenti.
giu 282022

Non è così tanto alla luce del sole, ma chi scrive versi non deve farsi nessuna illusione. Nel migliore dei casi la strada è impervia e in salita. Uno pensa bonariamente che il mondo della poesia sia senza macchia e alieno da ogni forma di mercificazione, di compromesso commerciale. Pensa che sia un'isola felice, un'eccezione in questo mondo consumista. È vero che il business poetico è poca cosa e che c'è poco giro di denaro. Ai tempi degli antichi romani dicevano che carmina non dant panem (lo sosteneva Orazio per l'esattezza). Oggi scrivere versi e venire un minimo riconosciuti non è un atto gratuito ma addirittura una spesa. Non è così ovvio e scontato, ma comunque per fare carriera poetica ci vogliono soprattutto i soldi. Sono un requisito indispensabile, una conditio sine qua non. Oltre a un minimo di talento ci vogliono gli schei detto alla veneta, i danee detto alla milanese. Non è richiesta una grande quantità di capitale, ma bisogna avere uno stipendio oppure una famiglia alle spalle disposta a investire/spendere per arricchire la nota biografica/il curriculum artistico del figlio o della figlia. La carriera poetica può dipendere dalle opportunità economiche o quantomeno da quanto una persona è disposta a spendere per la sua passione. Non è un atto di accusa, un'invettiva o chissà che. È un dato di fatto assodato ormai. Sono rarissimi i casi in cui ciò non avviene come ora vi esporrò. Non succede se un poeta pubblica con Einaudi, Mondadori, Garzanti, Crocetti o Feltrinelli e poi si ritira dalle scene. Nei restanti casi, anche i poeti affermati sono costretti a spendere qualcosa e difficilmente fanno pari o guadagnano. Non c'è niente di male: la mia è solo la presa di coscienza dello stato in cui versa la poesia italiana attuale. I poeti affermati non campano come poeti ma lavorano come giornalisti, impiegati, editor, insegnanti, non parlando di quelli non integrati come erano la Merini o Zeichen.
"Io non ho bisogno di denaro.
Ho bisogno di sentimenti.
Di parole, di parole scelte sapientemente,
di fiori, detti pensieri,
di rose, dette presenze,
di sogni, che abitino gli alberi,
di canzoni che faccian danzar le statue,
di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti...
Ho bisogno di poesia,
questa magia che brucia le pesantezza delle parole,
che risveglia le emozioni e dà colori nuovi."
Alda Merini, Terra d'Amore (Bari, Acquaviva 2003).

Una parte delle proprie entrate economiche, una voce in bilancio per le spese poetiche va messa in conto. Innanzitutto un poeta nella stragrande maggioranza dei casi deve pubblicare a pagamento. Spesso come costo ulteriore c'è l'editing che viene fatto. Autopubblicarsi non è visto di buon occhio dalla critica. Gli ebook, anche se pubblicati gratis su riviste online pregevoli, non vengono presi in considerazione. Inoltre il poeta deve spendere per la prefazione, per organizzare un aperitivo per la presentazione del suo libro. Non solo ma deve spedire decine e decine di copie a critici, direttori di riviste online e blog letterari perché questi poi recensiscano la sua opera: spedire un semplice pdf significa non essere presi in considerazione; non è comunque una grande spesa, se si invia tramite posta ordinaria e non per raccomandata. Un poeta deve partecipare a dei premi letterari, nella maggioranza dei casi deve pagare la tassa di iscrizione e poi se vince il premio o concorso deve viaggiare, pernottare nella località della premiazione, deve bere e mangiare, quindi presenziare alla cerimonia. I rimborsi spese non esistono per poeti effettivi, aspiranti e sedicenti. Per non farsi mancare niente qualche poeta si rivolge a un'agenzia letteraria, che lo promuove, lo istrada, lo avvantaggia, lo fa entrare nel giro giusto. Ma tutto ciò ha anch'esso un costo. Quindi ci sono le antologie di poesia. Molto spesso si tratta di antologie non scolastiche e dopo essere stati inseriti i poeti devono acquistare almeno una o due copie: spese irrisorie, ma pur sempre delle spese. Ci sono anche i libri di poesia e di critica letteraria comprati per acculturarsi ulteriormente, per approfondire o estendere le conoscenze culturali. Non sempre le biblioteche comunali, anche quando esiste una rete efficiente di prestito interbibliotecario nella provincia come a Pisa, si trovano i libri attuali. Quindi ci sono le riviste letterarie a cui abbonarsi per informarsi ulteriormente e per aggiornarsi. Ma la comunità poetica non è solo online. Bisogna anche frequentarsi, andare alla presentazione dei libri, frequentare i festival poetici, incontrarsi con poeti affermati e critici, partecipare alle conferenze universitarie o a quelle delle associazioni culturali. Non solo ma un poeta o una poetessa che si rispetti ha un suo sito personale con un suo dominio registrato, con la sua brava informativa della privacy, con la sua grafica accattivante creata da un webmaster professionista: insomma altri soldi da spendere. Quindi ci sono poeti che pagano per appartenere a un'associazione culturale o un'accademia poetica. Poi ci sono alcuni siti di poesia che mettono in vetrina online i propri iscritti, ma bisogna versare una quota annua. Come se non bastasse ci sono anche delle scuole di scrittura e alcuni sia per migliorare a scrivere che per entrare in contatto con critici o scrittori importanti spendono centinaia di euro per frequentare. Infine ci sono i poetry slam e uno spende per recarvisi. Inoltre per combattere l'ansia beve qualche birra oppure spende bevendo qualche birra per avere maggiore comprensione empatica nei confronti dei partecipanti: in ogni caso dopo un certo tasso etilico anche i mediocri sembrano Montale nella notte in cui tutte le vacche sono nere e le poesie sono capolavori. Però anche viaggi, panini, piadine, birre costano.

Inoltre bisogna offrire qualcosa al bar o al pub al cronista, che molto spesso non si intende assolutamente di poesia contemporanea, perché scriva un trafiletto su un quotidiano in modo da certificare alla comunità locale che uno esiste come poeta. Non solo ma va considerato tutto il tempo speso a occuparsi di poesia e che poteva essere occupato in attività più remunerative, Molte di queste cose non l'ho mai fatte (qualcuna sì, ma pochissime e le più economiche), però per fare carriera poetica è questo ciò che legittima culturalmente. Non dico che tutto ciò sia giusto o sbagliato. La mia è una pura e semplice constatazione di fatto. I soldi sono una grande facilitazione, aprono molte porte, anche nel mondo apparentemente puro e incontaminato della poesia. Nel mondo della poesia un poco di soldi da spendere sono una premessa indispensabile. Ci sono poeti che mettono al primo posto nei loro valori e come priorità nella loro vita la carriera poetica. Così si ritrovano con la casa piena di libri pubblicati a proprie spese e di premi e targhe di scarsa importanza, ma in ristrettezze economiche e con pochissimi soldi per fare la spesa. Pur con tutta la solidarietà dell'intera comunità poetica forse potrebbero gestire in modo più avveduto e oculato i loro soldi. Ma molto spesso dopo tutti questi sforzi economici e dell'impegno profuso la maggioranza dei poeti ha successo oppure diventa memorabile? Assolutamente no. Ogni sforzo spesso è vano. Tutto è destinato a finire nel dimenticatoio. Poi i soldi non vanno considerati lo sterco del diavolo. Di solito si assiste a questo doppio sacrificio: 1) i genitori hanno speso soldi per mandare all'università i poeti con scarso o addirittura nessun ritorno economico 2) i poeti sacrificano tempo e denaro per la loro passione, vivendo un'esistenza precaria.
Mi è stato riferito da alcuni che conoscono a menadito la comunità poetica che la maggioranza dei poeti proviene da famiglia benestante, ma nel corso della vita sono destinati di solito a impoverirsi tra mancati guadagni di una educazione umanistica che non dà frutti economici e le spese per partecipare all'agone lirica.

Di solito però quando un poeta recita le sue liriche alla maggioranza della gente questa gli dice che le sue poesie sono belle, come contentino. In realtà la poesia contemporanea è vista dai più come oziosa, inutile, noiosa, incomprensibile. Alla cosiddetta gente non importa nulla della poesia e dei poeti contemporanei. Come scrive il critico e poeta Davide Brullo fino a quando non ci saranno soldi statali per finanziare i poeti e fino a quando non verrà istituito un centro di ricerca per la poesia statale ci sarà un grande bailamme di poeti, alcuni veri ma anche molti presunti, pronti a fare un baccano inenarrabile. La poesia, anche la migliore, viene considerata solo un hobby. I poeti quindi dovrebbero rimanere con i piedi per terra. Spesso ai poeti manca il senso pratico e un poco di sano realismo. Non c'è niente di male in questo. Ognuno ha le sue pecche. Nessuno è perfetto, come la celebre battuta di Casablanca. Basta esserne consapevoli. Non sempre il talento viene riconosciuto. Lo pensavo proprio stamani che ero seduto al bar e solo dopo che se ne è andata ho riconosciuto una bella donna come la sorella di una ragazza che trent'anni fa mi aveva rifiutato. Allo stesso modo non sempre si riconosce la poesia come tale, anche se è bella. Comunque la poesia può essere considerata per alcuni un atto di pace, per altri un atto di insubordinazione nei confronti della società attuale (scrivere in questo senso è un piccolo atto "rivoluzionario" anche da parte di chi non è rivoluzionario politicamente), per altri ancora un atto d'amore che poche persone, forse nessuno raccoglierà. Questo bisogna tenerlo presente, pur tra molte difficoltà per i poeti e tra tanta ilarità delle persone pragmatiche. Se è vero che i poeti in Italia suscitano ilarità, la libertà di scrivere è concessa. Qui non accade come a Brodskij che nel regime russo decenni fa fu accusato perfino di parassitismo. A ogni modo i poeti non possono fare a meno di scrivere. Quindi si sobbarcano, più o meno incoscientemente, costi e crisi reputazionali.
giu 282022

Il verso libero:
Nel corso del '900 si è diffuso il verso libero. Questo è avvenuto non solo tra quelli che vengono definiti dai cattedratici poeti dilettanti ma anche da grandi poeti stranieri e italiani. Laforgue fu il primo grande poeta ad adoprare il verso libero e a tal proposito scrisse: "mi dimentico di rimare, mi dimentico il numero delle sillabe, mi dimentico la distribuzione delle strofe". Anche Pound fece un uso moderato nelle proprie liriche del verso libero. I poeti dell'imagismo scrivevano tutti in versi liberi. E. Lee Masters nella celeberrima Antologia di Spoon River adoprò spesso nei suoi epitaffi versi liberi e non prestò molta attenzione al rispetto della metrica. Per quel che riguarda il nostro paese i crepuscolari Corazzini, Gozzano, Govoni, pur utilizzando anche forme metriche tradizionali, introdussero il verso libero nella poesia italiana. Anche il poeta simbolista Gian Pietro Lucini scriveva soprattutto versi liberi e dichiarò che al momento della creazione non cercava "misure prestabilite (versi), né sequenze numerate di misure (strofe)", né il posizionamento di accenti tonici. Inoltre bisogna ricordare che i poeti vociani Jahier e Boine scrissero solo prose poetiche. Infine i futuristi utilizzarono solo ed esclusivamente il verso libero. Se in poesia e in letteratura devono essere messe delle regole forse devono riguardare il rapporto tra l'arte e il tentativo di ideologizzazione dell'arte stessa. Ritornando al verso libero alcuni intellettuali ritengono che la vera libertà si acquisisca nell'ambito delle regole imposte e degli schemi precostituiti o almeno questa è la loro giustificazione alla loro concezione di una poesia, che per essere tale deve adoprare le forme metriche classiche. Altri intellettuali ritengono invece che nell'arte la libertà non esista, per cui devono essere accettate le regole imposte dalla tradizione. Per il poeta Robert Frost "scrivere versi liberi è come giocare a tennis senza rete».
Ma non è detto che chi scriva versi liberi e non rispetti la metrica tradizionale non si imponga altre regole riguardanti altri ambiti. Un tempo erano presenti dei canoni estetici. Oggi forse è più problematico valutare un poeta. Sono rari i casi di coloro che scrivono endecasillabi canonici. I più scrivono in versi liberi.

La crisi della poesia:
Comprendere le poesie non sempre è facile. Un testo può essere analizzato per il suo significato psicoanalitico, esistenziale, sociale, letterario, ideologico. Ogni testo può essere studiato valutando il contesto storico, la parafrasi, le figure retoriche, la metrica. Non solo ma va anche detto che ogni lirica può scaturire dal sentimento, dall'osservazione o dalla trasfigurazione. Inoltre non sempre un poeta si basa sulla realtà oggettiva ma spesso anche sulla vita segreta delle cose e della natura. Nel Novecento tutto diventa ancora più complesso. Basta pensare a Eliot e Pound con le loro citazioni colte e il loro montaggio. Nel secolo scorso sono stati molti gli ismi letterari. In Italia agli inizi del Novecento l'Ermetismo non era affatto di facile comprensione sia perché in esso era presente l'Orfismo (connotato dal valore sacrale della poesia e dalla ricerca costante di assoluto e infinito) sia perché i testi erano colmi di simboli, analogie e sinestesie. Negli anni Sessanta si registra un notevole cambiamento. Erano contro l'Ermetismo sia i poeti di Officina (Pasolini, Roversi, Volponi, Fortini, Leonetti) che i Novissimi (gruppo 63), ma anch'essi non erano di facile comprensione. Da un lato i poeti di Officina avevano buoni intenti: volevano il rinnovamento, erano contro l'intimismo degli ermetici, erano contro i reazionari. Dall'altro lato erano anche contro il Neorealismo, uno dei pochi ismi del Novecento (insieme ai crepuscolari) i cui autori si facevano capire da tutti. Forse nel Neosperimentalismo erano presenti troppe premesse teoriche. Anche la Neoavanguardia era ammirevole negli intenti perché contro il neocapitalismo, contro l'egemonia culturale e l'estetica dominante, contro la mercificazione dell'arte. Però spesso spiazzava i lettori per i suoi non sensi, il suo linguaggio multidisciplinare, i suoi shock verbali, la ricerca di essere originali a tutti i costi. Infine la poesia degli anni Settanta con il Neo-orfismo cambia di nuovo le carte in tavola perché prende le distanze sia dalla Neoavanguardia che dal Neosperimentalismo, ma il linguaggio poetico è sempre oscuro e di non facile decifrazione. Per capirne di più basta leggere due antologie poetiche: "La parola innamorata" e "Il pubblico della poesia". Il poeta comunque da decenni non ha più alcun status e la poesia contemporanea è divenuta marginale. Molti scrivono. Pochi leggono. C'è anche troppa creazione ma è scarsa la fruizione. La poesia contemporanea è determinata talvolta dall'egocentrismo, dal narcisismo, dall'autobiografismo. È una poesia talvolta autoreferenziale e non comunicativa. I poeti sono sempre più appartati. Il loro messaggio talvolta non è chiaro. Il gradimento del pubblico è scarso. I giornali raramente recensiscono libri di poesia. Nelle Facoltà di Lettere i poeti contemporanei non trovano spazio. Il fatturato dei libri di poesia in Italia è inferiore all'1% del fatturato globale. I libri di poesia nella stragrande maggioranza dei casi finiscono al macero. I poeti sono stati sostituiti e rimpiazzati socialmente da cantanti e cantautori. Sono molteplici i motivi di questa situazione e non li analizzeremo ora. Comunque oggi i poeti viventi sono sconosciuti al grande pubblico. Come sono cambiati i tempi da quando Vico scriveva che i poeti sono i primi storici delle nazioni! Oggi è innegabile che la poesia di questi anni è in crisi e alcuni critici l'hanno definita minimalista. La lirica di questi tempi è talvolta illeggibile e non memorabile. Comunque non bisogna essere ottimisti né apocalittici.
Poesia e moralità:
È sempre difficile giudicare la qualità delle poesie. È vero che è improponibile il paragone tra la poesia di un bambino di prima elementare e una di Montale. Ma spesso le differenze non sono così marcate. Un tempo si consideravano la metrica e l'eufonia. Oggi non più. Decenni fa in Italia si considerava anche la persona del poeta, che doveva essere assennato e ponderato. Al poeta si richiedevano delle virtù come una certa moralità e la saggezza. Se era sregolato allora era solo un erudito e/o un immaturo. Non poteva considerarsi persona di cultura. Si guardava il comportamento. Si considerava soprattutto l'etica. Si giudicava la condotta. C'era molto moralismo. D'altronde anche la Neoavanguardia valutava la persona (che doveva essere schierata ideologicamente). Loro erano gli unici puri e onesti. Consideravano anche la poetica. Quindi il contenuto veniva giudicato in modo fazioso perché secondo loro il linguaggio era "ideologia". Insomma si doveva combattere. Erano in trincea. Bisognava condannare la borghesia. Quindi bisognava per forza di cose odiare i piccoli borghesi. È chiaro che la Neoavanguardia ha avuto anche dei meriti come quello di rinnovare il linguaggio, inventare il pluristilismo, etc etc. Le due "chiese" comunque si sono appropriate della cultura nella seconda metà del Novecento. La maggioranza della gente se ne fregava. Negli anni Settanta le nuove generazioni erano perse nella droga o nella politica. La letteratura era ritenuta cosa di poco conto e non incisiva. Addirittura era ritenuta evasione. Molti giovani di allora pensavano ad altro e si rovinavano con altro: l'eroina o il terrorismo. La stessa poesia da allora è stata relegata ai margini e non si è più ripresa. Giudicare le poesie è sempre impresa ardua e risente di una certa soggettività. Spesso è questione di gusto più che di criteri estetici.

Poesia e ideologia:
Quali qualità deve possedere un artista per essere tale? Sono sicuro che a questa domanda molti risponderebbero che deve avere talento. Ma forse questo è un prerequisito fondamentale ma non sufficiente. Vittorio Sgarbi in "Lezioni private" scrive che un artista deve avere uno stile. Per esempio un poeta deve avere una visione del mondo. Successivamente avrebbe una poetica (ovvero una dichiarazione di intenti) e uno stile. Un artista di conseguenza secondo tale concezione deve anche essere un intellettuale, che riflette sul mondo e che rappresenta una coscienza critica per gli altri. Secondo Sgarbi l'artista è tale innanzitutto per il proprio pensiero (che deve contraddistinguersi per una certa originalità) e questo è valido sia per chi appartiene alla tradizione che per chi appartiene ad una avanguardia. Secondo altri si può scrivere anche senza una piena consapevolezza di sé stessi e del mondo, ma in fondo sono un'esigua minoranza. Molti critici la pensano come Sgarbi. Altra cosa importante oltre al pensiero è quella che alcuni chiamano la posizione intellettuale. Un artista può esprimere dissenso, consenso o non schierarsi rispetto alla politica e al potere. Per Gramsci ogni artista doveva essere un intellettuale organico. Sartre nella presentazione a "I tempi moderni" proponeva l'engagement. Lo scrittore era da ritenersi sempre responsabile. Non doveva scrivere per i posteri ma per i contemporanei. Non doveva evadere dalla realtà ma essere sempre testimone. Però molti altri erano per una posizione intellettuale meno impegnata politicamente. Per Saba i poeti dovevano essere "sacerdoti dell'eros". Anche D'Annunzio faceva dire a Claudio Cantelmo ne "Le vergini delle rocce" che gli artisti dovevano soltanto difendere la bellezza. Ma in fondo era in buona compagnia. Lo stesso Dostoevskij scriveva che la bellezza avrebbe salvato il mondo. Chissà cosa avrebbero pensato oggi di questa epoca in cui l'arte è soprattutto ricerca del nuovo a tutti i costi e provocazione fine a sé stessa?
Lo stile comunque può essere giudicato subito dai critici letterari, mentre le scelte politiche devono essere comprese e interpretate almeno dopo qualche decennio. Il rischio infatti è quello di essere troppo faziosi e di confondere l'estetica con l'ideologia. In alcuni casi c'è la possibilità di confondere l'estetica con l'etica. Non ci scordiamo che in alcuni autori l'appartenenza politica è più che una presa di posizione politica una scelta dettata da idealismo. Per alcuni artisti il liberalismo, il comunismo, il socialismo, la socialdemocrazia, l'anarchia sono categorie dello spirito. Non dimentichiamoci neanche che furono pochi gli intellettuali a opporsi all'entrata in guerra e al fascismo. Condanniamo pure il loro fascismo ma bisogna anche considerare obiettivamente le loro opere artistiche. Lo stesso dicasi per altre ideologie e altri regimi. Facciamoli però processare dagli storici, anche se si può legittimamente mostrare una certa repulsione per i loro atteggiamenti e comportamenti. Condanniamoli pure come uomini ma non rimuoviamo totalmente gli artisti che sono stati e neanche quello che hanno rappresentato per gli uomini della loro epoca.
Poeti di ricerca e neolirici:
Forse è troppo riduttiva la distinzione tra poesia di ricerca (sperimentatori del verso) e poesia neolirica. Non è detto che tutto lo sperimentalismo porti per forza di cosa sempre al rinnovamento del linguaggio e al rovesciamento di prospettive. In fondo anche alcuni poeti lirici o neo-orfici possono essere originali ed innovativi: non è assolutamente detto che siano sempre dei manieristi o degli epigoni. Non è detto inoltre che questa distinzione tra i due generi di poesia possa racchiudere tutte le dicotomie concettuali ed espressive (comprensibile/difficile, tradizione/innovazione, impegnato/reazionario, etc. etc.). Per quanto riguarda la comprensibilità dei testi la Dickinson scriveva che si doveva dire la verità in modo criptico, mentre K. Popper sosteneva che niente è così facile che scrivere in modo difficile e che tutti coloro che scrivono devono porsi come dovere la chiarezza espositiva (però era un filosofo). La realtà in poesia è che i componimenti dovrebbero in teoria cercare sempre di raggiungere i vertici della significazione. Però i poeti spesso cercano termini ricercati, talvolta antiquati, perché li considerano più consoni. I poeti tra gambo e stelo scelgono sempre il secondo vocabolo, anche se non sarebbe necessario. Anche i poeti in fondo hanno il loro gergo. Mi sembra che Pasolini avesse dichiarato a riguardo che esistesse in poesia un codice classista del linguaggio. Ma non è forse riduttiva questa distinzione tra poesia di ricerca e neolirici? Non potrebbe essere considerata anche una poesia aforistica come quella dell'ultimo Montale, degli Shorts di Auden, dell'ultimo Cesare Viviani? Non sarebbe forse originale se questo genere di poesia aiutasse a chiarire i pensieri, portasse talvolta a "pensare contro sé stessi" per dirla alla Cioran (il riferimento è alla sua opera "La tentazione di esistere")? Naturalmente una scrittura aforistica rischia sempre di essere troppo didascalica oppure ostensiva. Ma in fondo anche gli sperimentatori o i neolirici rischiano anch'essi di perdersi in virtuosismi, di innamorarsi troppo delle parole. I rischi ci sono per tutti. Comunque la distinzione autentica che dovrebbe essere fatta è tra chi cerca di descrivere/raggiungere/ rendere tutta la complessità del reale (il rischio è quello di rendere ancora più complicato e di più difficile comprensione ciò che è già complesso) e tra chi cerca di semplificare la realtà (il rischio è quello di rendere tutto troppo semplicistico, di creare delle smagliature da cui evade il reale). Queste dovrebbero essere le due scuole di pensiero (ma forse sarebbe meglio dire due atteggiamenti esistenziali) di una poesia, che allora potrebbe essere veramente ricerca di senso. Ma forse è solo una utopia. Però la distinzione basilare è tra chi cerca di raggiungere la soglia del dicibile e chi cerca la sostanza delle cose, l'essenziale. Questi a mio modesto avviso sono i due modi di porsi in estrema sintesi. Poi a prescindere dal tipo di atteggiamento chiunque può essere o meno innovativo. Per cercare l'essenziale intendo l'estrema sintesi del reale. La soglia del dicibile non è detto che sia estrema sintesi. L'essenziale lo si raggiunge con il levare. È la caratteristica tipica della scrittura epigrammatica. La soglia del dicibile invece la si raggiunge con il battere, con l'accumulo: significa cercare di descrivere in modo esaustivo la realtà, di comprenderla in modo totalizzante.
giu 242022
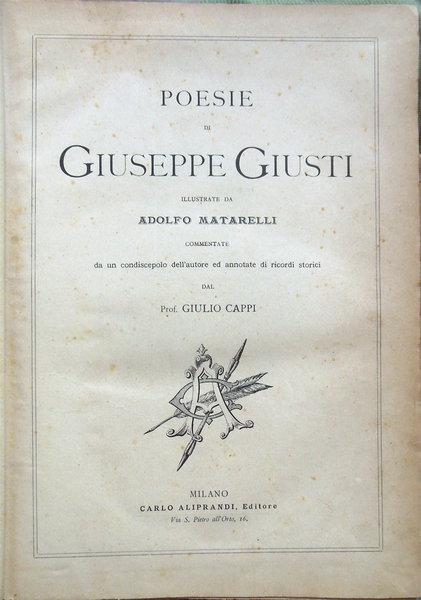
Giuseppe Giusti nacque a Monsummano nel 1809. Dopo aver frequentato diversi collegi toscani, si iscrisse a legge all’università di Pisa. Divenne avvocato, però non esercitò mai la professione. Visse la maggior parte della vita a Pescia. Affetto da tubercolosi polmonare si trasferì a Montecatini per curarsi. Morì di tisi a Firenze nel 1850 e fu sepolto a San Miniato. Nel corso della sua breve vita ebbe modo di conoscere Alessandro Manzoni. Fu anche accademico della Crusca e deputato al parlamento di Firenze. Il Giusti fu un liberale illuminato e uno dei migliori poeti satirici italiani della ’800. Anche Benedetto Croce si occupò della sua arte e lo definì "poeta prosastico". Il nostro avanzò critiche nei confronti delle istituzioni e delle ambizioni individuali. Le sue opere satiriche sono perfettamente aderenti alla realtà dell'epoca; presentano parodie e tratteggiano tipologie di persone senza alcun moralismo: i politici voltafaccia, i nobili esterofili, gli arricchiti, i falsi preti, i governanti indolenti. Il poeta comunque non si atteggia mai a censore di vizi e non è mai paternalista. Giunge sempre alla comicità, enfatizzando certi tratti ed esasperando certe caratteristiche di figure, che esistevano realmente ai suoi tempi. Il Giusti fu un artista colto, ferrato nella cultura classica e nella tradizione letteraria. Nelle sue poesie però fa la caricatura del potente, ma non offre una parola di conforto al povero. Certamente non fanno parte del suo retroterra poetico l'impegno civile e la partecipazione emotiva del Porta e del Belli, che riuscirono a dare risalto nei loro lavori a quel popolo, che fino ad allora non aveva mai avuto voce.

Il nostro poeta tratta spesso e volentieri di crapule e baldorie di persone, che non vivono in ristrettezze economiche. Resta da definire però se questo sia un difetto o un pregio. Infatti se da un lato può apparire distaccato, dall'altro non fa mai demagogia, non si abbandona a facili utopie e non ha la presunzione di dire qualcosa alla gente, che soffre e fatica. I poemetti satirici dei suoi "Scherzi" sono stati riconosciuti pregevoli all'unanimità, hanno avuto vasti consensi sia all'epoca (anche Gino Capponi era un grande estimatore del poeta), sia nel '900 (si pensi al Palazzeschi). Meno apprezzato dalla critica letteraria invece per le opere intime e di carattere sentimentale. Anche se in alcune liriche si può identificare il carattere risorgimentale, il Giusti non fu un mazziniano perché timoroso del popolo e di eventuali insurrezioni popolari. Comunque sono costanti nei suoi versi l'avversione per lo straniero conquistatore e il patriottismo. Difficile collocarlo politicamente. Fu davvero un liberale singolare in quel tempo: né un neoguelfo alla Gioberti, né un federalista come Cattaneo. Il Guerrazzi, suo avversario politico, disse di lui che scardinò lo stabile della società del periodo, avendo però paura dei calcinacci. Non mancano critici letterari che hanno una visione più giacobina dell'opera del Giusti. La sua produzione poetica è vasta e originale. Tocca gli argomenti più disparati. Spazia dall’ambito politico-sociale a quello storico. Notevole l’uso sapiente del poeta della metrica italiana. Prima dell’avvento nel ’900 del verso libero i poeti utilizzavano soprattutto l’endecasillabo (che non è necessariamente un verso di undici sillabe, ma l’importante è che abbia l’accento tonico sulla decima sillaba e un altro accento tonico sulla quarta o sulla sesta). Il Giusti invece varia prosodia continuamente. Spesso utilizza quinari e settenari. Più raramente usa le strofe saffiche (tre endecasillabi ed un quinario) e le ottave. Si può notare la sua autoironia in vari componimenti. Ad esempio in “Rassegnazione e proponimento di cambiar vita” scrive: “in quanto al resto, poi non mi confondo: / faccia chi può con meco il prepotente: / io me la rido e sono indifferente”. Il suo umorismo però talvolta è pervaso da un sentimento di nostalgia come nell’opera “Le memorie di Pisa”, in cui descrive la goliardia degli studenti universitari toscani.

La poesia satirica che mi ha divertito di più è l' "Apologia del lotto", che tra l'altro è ancora attuale. Il Giusti decanta i pregi del lotto, tra cui diventare signori con pochi soldi, far fare studi approfonditi sull'interpretazione dei sogni. Come se non bastasse scrive che il Lotto è l'unica fede rimasta al popolo e che giocando non si rischia la libertà, come invece accadde a Galileo che fu processato per aver professato la verità nell'ambito scientifico. Ma leggendo tra le righe, si capisce che lo Stato non perde mai e che chi è contento della sua condizione economica non gioca di certo al Lotto. La sua opera più famosa è senz’ombra di dubbio la raccolta di proverbi toscani. Popolari per i toscani e gli appassionati di letteratura anche poesie come “Lo stivale” e “Sant’Ambrogio”. Nella prima opera il Giusti adopra l’allegoria dello stivale per narrare le tribolazioni storiche dell’Italia: le dominazioni straniere, gli avvicendamenti di principi e regni dall’epoca dell’impero romano fino ai suoi tempi. Il poeta scrive: “Per un secolo e più rimasto vuoto,/ cinsi la gamba a un semplice mercante”. Questo verso sta a significare che solo durante il tempo dei Comuni l’Italia visse un periodo di relativa libertà, anche se la Sicilia era dominata dagli stranieri. Il capolavoro finisce con l’appello all’unità nazionale. Il Giusti scrive infatti: “E poi vedete un po’: qua son turchino, / là rosso e bianco, quassù giallo e nero;/ insomma a toppe come un Arlecchino: / se volete rimettermi davvero/ fatemi con prudenza e con amore, / tutto d’un pezzo e tutto d’un colore”. In Sant’Ambrogio invece il poeta tratta della dominazione austriaca. All'inizio della poesia l'artista dichiara che è stato considerato anti-tedesco solo perché in alcuni suoi versi ha parlato male degli sbirri. Ma nel finale il poeta ha una levata di umanità anche per i soldati austriaci, che sono lontani da casa e costretti a vivere in un paese straniero. Anche loro che in fondo sono gente comune "l'hanno in tasca". Solo i regnanti ci guadagnano sempre grazie all'antico "divide et impera". Anche la poesia dal titolo "Gingillino" gode di una certa fama. Il poeta descrive un tipo conformista e arrivista, che ingannando gli altri riuscirà a mettere le mani in pasta. Divenuto dottore in legge Gingillino va nella capitale per cercare un posto. Lì diventa "un birro", cioè un ufficiale della polizia e conosce l'ex-cuoca di un notabile, che gli dà tutti i consigli giusti per fare carriera: scansare i liberali e chi pensa con la propria testa, non parlare mai di libri e di giornali, arrufianarsi con il superiore, lodarlo a più non posso, riferirgli i pettegolezzi. Non ho voluto fare un saggio critico sul Giusti, anche perché non ne sarei in grado. Ho voluto invece dare un consiglio di lettura nel modo più semplice possibile. Leggete il Giusti. Le sue rime sono divertenti e mai scontate. Personalmente lo ritengo geniale per il suo estro e la sua arguzia. A mio modesto avviso è uno dei pochi poeti italiani di tutti i secoli che sappia sorridere e accantonare la tragicità.
giu 232022
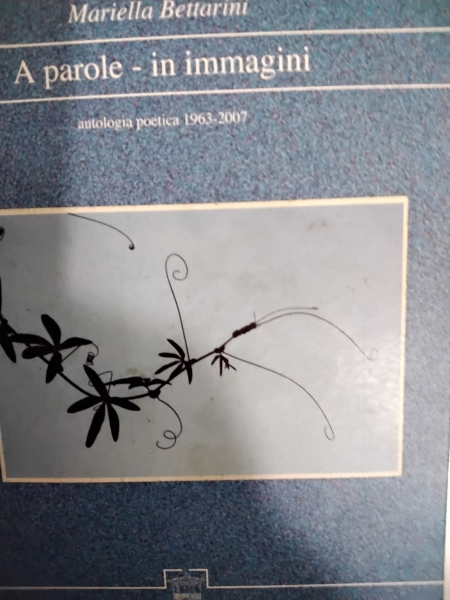
Molti anni fa dopo che le inviai via email un mio saggio breve sulla poesia contemporanea, riletto oggi molto acerbo e pretenzioso, Mariella Bettarini, che ne individuò i punti di forza, omettendo probabilmente quelli deboli per bonaria indulgenza, mi inviò per posta ordinaria la raccolta di tutte le sue poesie, insomma la sua opera omnia lirica, intitolata “A parole – in immagini” (antologia poetica 1963-2007) per la casa editrice “Gazebo”. Per inciso scrivo che la poetessa è sempre stata un’instancabile animatrice e operatrice culturale, ha fondato la rivista letteraria “Salvo imprevisti” (oggi dirige “L’area di Broca”), ha fondato la casa editrice “Gazebo”, ha ottenuto vasto consenso dalla critica, ha colloquiato con molti protagonisti letterari del secondo Novecento, ha tenuto a battesimo molti giovani in poeti. Ha anche curato il libro capolavoro di Alice Sturiale. Un’altra curiosità: è stata anche inserita nell’enciclopedia tematica dell’Espresso Grandi Opere anni fa. Un’altra cosa: non partecipa a premi letterari perché sa come scriveva Ferlinghetti che la poesia non è una gara. Mi invitò comunque anche a una riunione letteraria a casa sua, ma declinai l’invito. A quel tempo ero un piccolo commerciante. Firenze distava poco più di 60 km col treno. C’era il rischio di perdere l’ultimo treno della sera e ritrovarsi sotto stazione tutta la notte. Avevo anche paura del confronto serrato perché non sono un abile oratore. Avevo e ho molte lacune. Avevo paura di un terzo grado o anche di una persona che mi facesse le pulci. Ma forse il vero motivo è che avevo paura di deludere le aspettative. Non ero più abituato alle discussioni intellettuali. Non ero più allenato mentalmente. Soffrivo di timor panico, ovvero di ansia a parlare in pubblico. E poi perché andare? Non ero un letterato. Il mio futuro lavorativo era molto incerto. Avevo altre grane. Le ricordai via email che erano tempi grami per la poesia e che i poeti, aspiranti, sedicenti o effettivi dovevano parlare d’altro e utilizzare la diglossia, parlare nel modo più semplice possibile con la gente. Ciò nonostante mi misi a leggere tutto il suo volume. Sapevo che era un dono prezioso. Ma vivevo in quel periodo una mia crisi interiore e faticavo a esprimere un mio parere articolato. Poi dove pubblicare una mia recensione? Non avevo più un sito né un blog. Inoltre mi arrampicavo sugli specchi perché oltre alle mie contrarietà prettamente interiori, personali mi imbattevo in una voce che faceva dell’unicità la sua caratteristica precipua. La sua poesia sembrava paradossalmente essere a sé stante, autonoma, eppure le sue strutture portanti erano fatte dalla tradizione letteraria novecentesca. Insomma la sua opera si riassumeva nella celebre formula letteraria “tradizione+innovazione”. Ero in un periodo in cui la mia passione per la poesia contemporanea si stava affievolendo. Mi chiedevo a che pro leggere e scrivere? Ma quel libro mi ridava un poco di passione, riaccendeva il desiderio di capire.

La Bettarini però scompigliava le mie certezze poetiche. La sua bravura mi dava addirittura fastidio perché aveva un modo di concepire e fare poesia completamente diverso da come intendevo farlo io. C’era una profondità mista a un’originalità che mi spiazzava. Il suo talento poetico creava in me dei dubbi e delle perplessità. La sua era una poesia sfaccettata in cui confluivano varie anime e molti echi. Era difficile dire la propria e chiudere i miei pensieri così su due piedi come ero abituato a fare. Non era una poesia facile. Ci sarebbe voluto tempo e una certa disposizione d’animo e io rimandai, rimandai e poi abbandonai l’idea di farmene un’idea mia. Ma non c’era niente che non andasse in lei o nella sua poesia; ero solo io che non ero nel momento migliore per accoglierla, farla mia, interiorizzarla. La sua voce arrivava dritta dritta dagli anni ’60, attraversava tutti gli anni ’70 e ’80. Quelle realtà e quel modo di percepirle mi sembravano distanti da me. Eppure con quel passato e con quella poetessa dovevo fare i conti. Non ero un filologo acuto per valutare il suo mutamento linguistico, se era o meno cambiata poeticamente. Quella sua poesia così densa e sostanziosa mi arrivava tra capo e collo all’improvviso e non mi lasciava affatto indifferente. Mi piaceva. Le sue poesie avevano ritmo, musicalità, proprietà di linguaggio, vera intellettualità. Ma da un certo punto di vista mi disturbavano un poco perché non le avevo scritte io e erano totalmente altro da me o almeno sembravano tali di primo acchito. Ma ne ero veramente certo? E se fossimo stati molto più simili di quel che pensavo? A ogni modo non ero certo di niente. Avevo visitato il suo sito. Avevo visto che era stata una maestra. Mi ricordai che anche il miglior poeta pontederese, ovvero Dino Carlesi, era stato maestro elementare. La cosa mi piaceva perché avevo un’ottima opinione dei maestri elementari e mi ricordavo che secondo ricerche internazionali l’unico insegnamento ritenuto valido ed efficiente in Italia era proprio quello elementare. Ma passiamo oltre. Alcuni critici avevano parlato del suo neorealismo fiorentino. Ma la sua poesia era allo stesso tempo complessa concettualmente e denotata da una grande ricchezza lessicale. Immagini, espressioni verbali, metafore, descrizioni, simboli venivano declinati nei modi più disparati: molte erano le tematiche e ancora di più le loro variazioni. La Bettarini col suo modo schietto, confessionale e al contempo discreto metteva in scena tutte le sue sfumature dell’animo. Ma un dato di fatto assodato era che la poetessa scriveva sempre col cuore in mano, pur facendolo con pudore e senza quell’effusione presente in molti, che Sanguineti detestava. Un’altra cosa era che la Bettarini con il suo impegno civile, poetico, letterario, sociale, politico era lì a testimoniarmi e a indicarmi che bisognava di nuovo imparare a vivere sia dal punto di vista privato che pubblico, riprendendo un celebre verso della Achmatova. E imparare di nuovo a vivere significava anche imparare di nuovo a sentire, a pensare, a relazionarsi col prossimo.

Sapevo che quel libro e quella sua dedica erano importanti, erano uno stimolo per me, erano il segno che dovevo continuare a scrivere saggi brevi. Ma quel volume stava anche a certificare un pezzo di poesia fiorentina e poi universalmente italiana. Le lessi una dopo l’altra, ma senza cercare di scorgere metamorfosi interiori né differenze stilistiche. Avvertivo innanzitutto una forte personalità, anche se la presenza dell’io non era assolutamente ingombrante, e il fatto di essere di fronte alla storia di una vita. Ogni poesia si intrecciava con la sua esistenza. L’una richiamava l’altra. Nel volume molto corposo c’erano anche alcuni capitoli delle tesi di laurea che trattavano della sua poesia. Un altro motivo che mi faceva desistere dallo scrivere un commento o una nota critica era che ormai mi trovavo di fronte a una poetessa già riconosciuta, mi trovavo di fronte al fatto compiuto. Che altro avrei avuto da dire? Che altro avrei avuto da aggiungere? Sarebbe stato presuntuoso tentare un nuovo approccio critico. Dovevo farmi da parte e così feci. Mi occupai d’altro. Avevo altri problemi che mi passavano per la testa. Lasciai il libro in un angolo della mia biblioteca. Ogni tanto lo leggiucchiavo di nuovo. Mi sentivo un ingrato a non avergli dedicato del tempo, a non aver scritto niente, a non essermi soffermato. Ero irriconoscente. Ma allo stesso tempo ero ormai convinto che non avrei mai più firmato nessuna recensione per nessuna rivista letteraria. Una cosa che scrissi alla Bettarini, dopo averla letta, è che la sua lingua era impreziosita da tanti toscanismi senza mai forzare troppo la mano e senza mai rivendicare con orgoglio, come fanno moltissimi nostri corregionali, la toscanità. Ora mi viene in mente che in tempi di milanesizzazione nello scritto e nella dizione della lingua italiana la poetessa con la sua opera si opponeva a questa imposizione, quasi questo obbligo morale per chi scrive o opera nei mass media. Già prima dell’avvento di Berlusconi in poesia era egemone la linea lombarda. Una volta addirittura molti anni fa lessi in un muro di una stazione ferroviaria del Nord una scritta leghista, secondo cui non si doveva più parlare toscano. Ma forse, più realisticamente parlando, la poetessa dall’Isolotto provava a concepire una nuova idea della poesia, della letteratura, della cultura, della società, dell’Italia stessa. Queste righe naturalmente non sono un’esegesi. Non voglio fare un’analisi testuale o critica. Era solo un chiarimento doveroso mischiato con alcuni ricordi e con alcune impressioni provate all’epoca. Quel volume è sopravvissuto al trasloco, in cui ho buttato diversi libri e altri li ho regalati alla biblioteca. Lo conservo ancora. Ne sono intimamente orgoglioso di averlo con me. A distanza di anni talvolta rileggo qualche poesia. Non l’ho sottolineato come faccio di solito perché so che è prezioso. Queste righe erano un atto dovuto. Niente di più.
giu 232022

La prova tangibile che i poeti non se li fila nessuno è l’inesistenza del gossip poetico. Se non c’è gossip poetico è perché non interessa nessuno. Cosa volete che importi alle gossippare di professione sotto l’ombrellone o in portineria di poeti e letterati? Se qualche circolo letterario o qualche piccola casa editrice cercasse di ravvivare il mondo poetico con del gossip poetico non alimenterebbe niente, non produrrebbe niente di positivo. Nel migliore dei casi il gossip poetico finirebbe per scimmiottare maldestramente il gossip dello spettacolo. Qualcuno potrebbe sostenere, neanche troppo paradossalmente, che il vero gossip poetico dai tempi di Freud in avanti è la critica psicoanalitica o biografica, che dir si voglia (per intendersi quella che parla delle emorroidi e non degli epistemi, come annotava Montale). Certo a vantaggio di certo psicologismo va detto che il biografismo spesso determina la postura autoriale, lo stile, parte dell’opera, ma non andiamo oltre: il pessimismo cosmico di Leopardi non scaturisce totalmente dal fatto che fosse gobbo, anche se in certa parte ci può influire. Ritornando alla contemporaneità, questo disinteresse totale nei confronti della poesia va avanti da decenni; uno dei segni inequivocabili è che la poesia, almeno quella italiana, sia totalmente fuori dallo show business. La realtà è che la poesia non rientra nel mondo dello spettacolo. Tutti sono artisti nel mondo dello spettacolo, ma per un poeta o una poetessa non c’è mai posto. Nessun poeta di belle speranze ha un agente, un manager. Nessuno caga i poeti. Come distinguere poi il buono dal mediocre? Un tempo l’unico posto concesso dalla televisione generalista, parlo di anni fa, era alla Corrida: qualche spazio veniva lasciato a certi dilettanti allo sbaraglio, che si esponevano al pubblico ludibrio. Ma la stessa televisione generalista ha spesso dileggiato il mondo dell’arte. Vi ricordate quando anni fa Ezio Greggio faceva vedere un quadro e poi sentenziava scherzosamente “tavanata galattica”. La cultura, l’arte, vere o presunte, dovevano sempre subire la presa in giro in nome di una presunta superiorità goliardica. Ogni pretesto, ironico o no, era un modo per dare addosso all’arte. C’era comunque un altro modo di ammazzare l’arte ed era quello di trattarla in modo noioso e soporifero, come accadeva spesso in RAI anni fa. Talvolta oggi si ha l’impressione che qualche poeta cerchi a tutti i costi l’occasione buona per rientrare nel mondo dello spettacolo, cercando di tirare per la giacchetta alcuni cosiddetti vip. Affari loro! Si accontentino pure delle briciole di visibilità che il mondo delle cosiddette “star” danno loro! Eppure un poeta autentico non dovrebbe ambire alla fama a tutti i costi. È vero che per ogni autore esiste il diritto/dovere di essere conosciuto. Ma ciò richiederebbe un minimo di etica, di dignità, di coerenza! Capisco che vivere una vita in perfetto anonimato e con scarsissima riconoscibilità può rovinare il carattere o addirittura la psiche. È altrettanto vero che bisognerebbe avere un minimo di saggezza per godersi pienamente l’anonimato, che – diciamocelo onestamente – la poesia dà. Alcuni/e invece non si accorgono di questi benefici. In definitiva minore è il rumore del mondo circostante e più facile è raccogliersi in meditazione o ammirare le bellezze della natura. Non a tutti capita di essere citati dalla Isoardi per lasciare Salvini come accadde a Gio Evan, che a onor del vero poeta non è e infatti la critica letteraria non lo considera minimamente, nonostante la notorietà (ma tante persone si accontentano beatamente dei surrogati della poesia). Comunque è meglio così. I poeti non avranno gruppi di ammiratrici né bagni di folla, ma possono fare anche giri in centro senza essere disturbati. È vero che un poeta qualsiasi non gode di alcun privilegio, però non ha neanche hater e stalker. Alla stragrande maggioranza dei poeti e delle poetesse non tocca il benessere materiale, a meno che non abbiano una famiglia agiata alle spalle. Pubblicare, andare alle conferenze, incontrarsi con altri letterati, comprarsi libri per rimanere aggiornati sono cose che hanno un costo. È rarissimo che uno con la poesia faccia pari. Di solito ci rimette. E allora vi chiederete voi chi lo fa fare ai poeti? Semplicemente la passione, l’abnegazione, l’amore per la poesia. In fondo oggi tutti sono poeti e nessuno è poeta. Una volta un cantautore diceva molto snobisticamente che oggi scrive poesie anche la casalinga di Voghera. In quel che diceva in un modo molto sbagliato forse un fondo di verità c’era. Di sicuro oggi il tasso di scolarizzazione è aumentato rispetto a qualche decennio fa. La produzione poetica è cresciuta di pari passo. Ci sono talmente tanti premi inutili e talmente tante case editrici non selettive che le cosiddette persone comuni non sanno distinguere chi ci marcia su e chi vale. Per non sbagliare si affidano ai mass media. Così acquista credibilità solo chi viene visto in televisione. Ma i poeti non vengono invitati in televisione di solito; se va di lusso al poeta o alla poetessa viene dato lo spazio di un minuto su RAI3 in tarda serata o di notte. La verità è che la poesia non fa ascolti. Molto probabilmente decenni fa davano spazio a Montale, Ungaretti, Pasolini perché non c’era l’audience e poi i tempi sono cambiati, per alcune cose in peggio e per altre in meglio. Parliamoci chiaro: è mortificante per una poetessa avere studiato, letto, scritto per una vita e non essere considerata dai mass media, mentre la showgirl svampita, dopo qualche passaggio televisivo, ha notorietà e soldi che lei non ha mai avuto in tutta la sua esistenza. È il mercato, purtroppo. Quando Rino Gaetano cantava “allestite anche le unioni dalle dite di canzoni” erano gli anni ’70. Da anni calciatori e showgirl sono sulle prime pagine dei rotocalchi. Vengono celebrati i loro amorazzi, che talvolta sfociano in un matrimonio. Loro hanno la centralità del gossip. Loro hanno l’esclusiva. Ma vuoi mettere starsene in disparte? Ma vuoi mettere essere sconosciuti ai più? Anche perché essere conosciuti ai più come poeti o poetesse non necessariamente è una bella nomina. Molti concepiscono il poeta come persona astrusa che rincorre le farfalle ed è completamente fuori dal mondo. Per molti romani dell’epoca Amelia Rosselli era solo una che scriveva poesie e intendevano ciò in modo canzonatorio, addirittura spregiativo.

Joyce in “Ritratto dell’artista da giovane” scriveva: “Non servirò ciò in cui non credo più, si chiami questo la casa, la patria o la Chiesa: e tenterò di esprimere me stesso in un qualunque modo di vita o di arte quanto più potrò liberamente e integralmente, adoperando per difendermi le sole armi che mi concedo di usare: il silenzio, l’esilio e l’astuzia”. Queste parole sono completamente estranee a certi poeti e poetesse, presenzialisti/e, sempre pronti/e a declamare i loro versi in questo o quel festival. Alcuni/e sono come la gramigna. Sono ossessivamente presenti. Non possono fare a meno di farsi conoscere nei circoletti. Il massimo della soddisfazione e del narcisismo è quando qualcuno chiede loro degli autografi. Hanno coronato il sogno della vita. Tutto sembra basarsi sulla riconoscibilità immediata. Alcuni/e cercano il riscontro del pubblico. Invece sarebbe meglio dosare le forze, centellinare le presenze, essere più preziosi, farsi desiderare di più. Il rischio, a forza di darsi a tutti, è quello di venire a noia. Il mondo quotidiano però è avaro di gratificazioni e di successo per i poeti. Quando si incontrano i poeti talvolta diventa una piccola gara a chi ce l’ha più lungo o a chi è più bella: io ho pubblicato più copie, io ho pubblicato con una casa editrice importante, io ho pubblicato su più riviste letterarie, io ho vinto più premi, io sono in più antologie scolastiche. La cosa paradossale è che se pubblicamente dichiarano la rimozione dell’io lirico in poesia, nei fatti, nei social, nei loro siti internet, nella vita privata cercano l’affermazione del loro io a tutti i costi.

(Nella foto il festival di Catelporziano)
Mai scoperchiare questo vaso di Pandora perché chi descrive pubblicamente questo stato di cose viene criticato, zittito, biasimato in tutte le forme. Gli anni passano per tutti, ma l’importante per certi poeti è avere qualcosa di cui vantarsi nell’angusto mondo delle patrie lettere. Chi denuncia pubblicamente la situazione comatosa in cui versa la poesia italiana è un frustrato, un deluso, un fallito, un aspirante poeta mai riconosciuto. Alcuni dicono che sono cose vere, però non vanno dette. Personalmente a casa mia meno per meno fa più. Personalmente non mi diverto a constatare questo stato di cose, ma lo faccio per spirito di servizio. Ritengo anche che sia questione di avere un minimo di onestà intellettuale e di dire come vanno le cose. Certo ci sono ripicche, invidie, gelosie, compromessi, conflitti, antipatie, simpatie, favoritismi, ostracismi. Anche i poeti sono esseri umani. Allo stesso tempo come canta De Gregori quando tra “buoni poeti ne trovi uno vero è come andare lontano, viaggiare davvero”. Eppure di poeti e poetesse buoni/e e anche ottimi/e ci sono, esistono. Allo stesso tempo non hanno visibilità né dalla critica né dai mass media. Un tempo i poeti che valevano avevano molta più importanza nella cultura. Oggi invece sono relegati a un ruolo marginale, vengono messi in un angolo nascosto. Non c’e da stupirsi se il cosiddetto popolo non considera i poeti, visto che gli stessi letterati, studiosi e appassionati non ne hanno a cuore. Ci sono troppi addetti ai lavori che si occupano di poesia e non l’amano, anzi l’hanno in odio. Eppure ci sono poeti e poetesse brave che meriterebbero successo, denaro, amore. Il sistema invece li respinge, li ricaccia indietro. E loro si estraniano, non partecipano più. La loro funzione sociale sarebbe quella di combattere il sistema dall’interno.

Tutto ciò viene continuamente disatteso e cosa resta in fondo? Un atteggiarsi anticonformista, una posa composta di dolore talvolta mai provato, un piangersi addosso tra sodali, un’elemosinare goffo di consensi. Comunque talvolta per questo scompenso, per questa scarsa considerazione perenne alcuni, non potendo gridare al mondo quanto valgono, finiscono per immalinconirsi, incattivirsi, imbastardirsi, in taluni casi giungono alla smania di grandezza, alla megalomania, al delirio di onnipotenza. Fondamentale è passare sopra queste debolezze umane, queste piccole inezie e prendere il buono: dai poeti e dalle poetesse non bisogna prendere assolutamente le loro tare psicologiche, invece bisogna esclusivamente amare i loro versi. Forse bisognerebbe ricordarsi più spesso ciò che scriveva Rilke: “l’arte è solo una maniera di vivere, e ci si può preparare a essa vivendo”. Spesso ho constatato che poeti più o meno riconosciuti non avendo l’amore dal pubblico e non avendo talvolta pubblico vivono tra rabbia e rassegnazione, in uno stato caratterizzato da grandi delusioni e piccole illusioni. In fondo qualcuno dirà che la poesia stessa è un’illusione, ma anche la vita e il vivere quotidiano che cosa è basato se non sull’illusione costante che tutto domani possa andare meglio? Siamo costretti a vivere di piccole illusioni. Tutti quanti, poeti e no.
giu 222022

Mentre nel mondo si è discusso in questi ultimi mesi dei problemi con i traduttori europei della poetessa americana Amanda Gorman, in Italia si discute per molto meno e per cose di minore importanza in ambito poetico senza nessuna cassa di risonanza mediatica. "Polemica" deriva da polemos, che anticamente era il demone della guerra: nomen omen. Ultimamente i social si sono scatenati contro la modella Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, che ha pubblicato un libro di versi. Alcuni l'hanno definita una "raccomandata", senza scordarsi che molti vip colgono l'occasione di pubblicare con grandi case editrici, sfruttando la notorietà. Qualcuno a riguardo ha scritto che il problema non sono i fenomeni da circo ma il circo stesso. Indipendentemente dal valore dei versi della Soleri bisogna ricordare l'ingenuità di una ventenne. Una poetessa riconosciuta come Maria Grazia Calandrone vi ha trovato dell'originalità, del buono. Poi c'è stata la polemica indegna e ingiusta sul vitalizio ad Aldo Nove. Anche qui alcuni sui social non hanno risparmiato delle critiche, senza considerare i meriti letterari di Aldo Nove. Ci sono state tempo fa polemiche poetiche sulla paternità dello Slam Poetry, che sarebbe del poeta Lello Voce, qui in Italia. Sempre tempo fa ci sono state polemiche sulla validità letteraria effettiva degli Slam Poetry, considerati dal poeta Matteo Fantuzzi una forma di intrattenimento. Più che polemiche sono stati leggeri disappunti quelli della comunità poetica sulla pubblicazione di un'antologia di poesie curata da Jovanotti, (anche se insieme all'editore Nicola Crocetti) oppure sulla grande notorietà di Franco Arminio, Gio Evan, Guido Catalano. In questi casi nessuno si scanna, facendo duelli all'ultimo sangue su Jovanotti, Arminio, Evan, Catalano. I toni si mantengono nei casi suddetti più leggeri. I social e i blog comunque sono talvolta le sagre delle polemiche al vetriolo, polemiche non fatte per niente ad arte. Anche su litblog importanti come Nazione indiana talvolta le discussioni degeneravano. Alcuni leoni da tastiera si facevano forti dell'anonimato e allora giù battute di dubbio gusto, che rasentavano l'insulto. C'era e c'è ancora chi si firma Pippo, Paperino, Nonna Papera. A volte a forza di fare polemiche letterarie si può addirittura rischiare di essere minacciati di morte. Ma di fatto poi non succede niente. Nessuno picchia nessuno. Nessuno ammazza nessuno. Fortunatamente non finisce come con i rapper americani, dato che qualcuno lì negli States è morto assassinato. C'è comunque chi non la prende affatto bene ed esce dal seminato. Ci sono a ogni modo commentatori di blog professionisti, che passano delle ore a leggere, commentare, controbattere, argomentare. È il gusto primigenio della discussione, intesa come momento di crescita culturale. Talvolta il thread ha esiti imprevedibili. C'è chi va fuori tema oppure chi si fissa su una cosa secondaria. La questione si può fare personale, ci possono essere attacchi privati. Ma sono rimasti pochi i commentatori compulsivi. Di solito le persone oggi manifestano il loro gradimento con un like o un cuoricino. Di solito se scrivono per l'appunto sono laconici e scrivono due righe. Forse è il segno che i blog sono morti o che sono dei moribondi e che oggi non è più di moda commentare su di essi. Di certo non è per mancanza di dialettica. È solo che la maggioranza delle persone non vuole polemiche. Le ritiene inutili. Non dico che sia bene o male, giusto o sbagliato, ma penso che la mia sia un'interpretazione corretta. Nei social divampano di più discussioni, che talvolta sfociano in liti. Ci possono essere discussioni costruttive come quelle sull'autoreferenzialità della poesia italiana, sul fatto che i poeti sono troppi, sull'assenza di pubblico, sulla linea di demarcazione tra poesia e non poesia, sulla fine del postmoderno, sul fatto che si possa parlare o meno di neo-neoavanguardia. Però anche in questi casi la discussione può avere risvolti molto negativi. Succede così che le discussioni poetiche diventano spesso dialoghi socratici incompiuti, in cui c'è solo la pars destruens ma manca la pars costruens. Non si risolve mai il problema. Il rischio è quello di perdersi in questioni di lana caprina e di azzuffarsi per niente. Forse sui social si respira un'aria familiare, ci si sente più a casa, si ha la percezione errata che tutto quello che postiamo non sia pubblico e non sia letto dal prossimo. Forse sui social ci sono più reazioni perché consentono una maggiore reattività. La maggioranza dei poeti, veri o presunti, si chiama però spesso fuori dalle polemiche. Anche se qualcuno li istiga, li aizza non rispondono. Hanno tutto o poco da perdere, ma qualcosa da perdere ce l'hanno. Non vogliono rischiare crisi reputazionali. I poeti cercano nella maggioranza dei casi di non farsi nemici. Ecco allora che cercano di stringere alleanze, che cercano sodalizi, collaborazioni. Nascono simpatie, addirittura amori. Dove non c'è l'amore o la stima viene stipulato di solito il patto di non belligeranza. La comunità poetica è a sua volta suddivisa in diverse fazioni. Ci sono i neolirici, i poeti di ricerca, i performer, etc etc. Si affacciano sulla scena anche gli istantpoets. Ci sarebbero poi i poeti di strada. Di solito cercano di sopportarsi a vicenda, nonostante le insofferenze di qualcuno. L'odio quando viene covato rimane un fiume carsico per questione di desiderabilità sociale, di convenienza, di scaltro opportunismo.
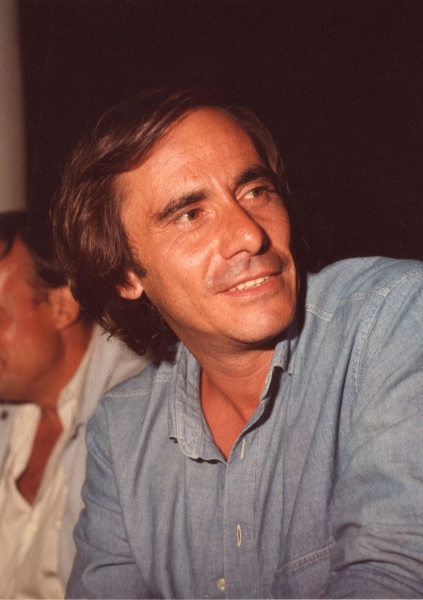
Riguardo ai poeti è vero ancora oggi in parte quel che cantava Roberto Vecchioni:
"I poeti son liberi servi di re e cardinali
Che van ripetendo "Noi siam tutti uguali"
E si tingono di rosso vivo
Ciascuno pensando "Il giorno del Nobel farò l'antidivo"...
...I poeti son giovani stanchi che servon lo Stato
Sputandogli in faccia perché sia dannato
E sbandierano cieli e fontane, messaggi e colombe
A noi le campane, ai ricchi le trombe."

Ma è a mio avviso sempre attuale anche il ritratto che ne fece Francesco De Gregori:
"Vanno a due a due i poeti
Verso chissà che luna
Amano molte cose, forse nessuna
Alcuni sono ipocriti, gelosi come gatti
Scrivono versi apocrifi, faticosi e sciatti
Sognano di vittorie e premi letterari
Pugnalano alle spalle gli amici più cari
Quando ne trovano uno ubriaco in un fosso
Per salvargli la vita gli tirano addosso
Però quando si impegnano lo fanno veramente
Convinti come sono di servire alla gente
Firmano grandi appelli per la guerra e la fame
Vecchi mosconi ipocriti, vecchie puttane. "
Naturalmente un'altra discussione ancora aperta e interminabile è se la canzone d'autore possa essere considerata poesia o meno.
Ma potremmo citare a questo proposito il già classico Dino Campana, che scriveva: "Vo alla latrina e vomito (verità). / Letteratura nazionale / Industria del cadavere. / Si Salvi Chi Può".
Ritornando alla questione delle polemiche, le liti tra letterati, poeti, amanti della poesia sono rare ma accadono. Non sono all'ordine del giorno. Non sono la normalità, ma accadono. Uno si arrabbia, perde le staffe, ci può rimettere a lungo termine in salute. Gli attacchi personali così come le diatribe possono generare ansia ma anche rabbia incontrollata. Croce scriveva: "la polemica mi rinfresca il sangue". In realtà a molti di solito lo può avvelenare il sangue. Oppure uno può fregarsene quasi totalmente o addirittura accettare a malincuore e con rassegnazione questo stato di cose. Ci sono inoltre le shit storm. Viene presa di mira una persona, viene accerchiata virtualmente, fioccano una serie inenarrabili di critiche di bassa lega, di commenti negativi e faziosi, se non di insulti. La diffusione di responsabilità sembra legittimare tutto ciò. Alcuni non percepiscono il discrimine tra un sano diritto di critica e la diffamazione aggravata online. Un tempo esistevano i troll che non lesinavano punzecchiature, toni scherzosi, deridendo chi prendevano di mira. Oggi ho la netta sensazione che la situazione sia degenerata. Ci sono polemiche che generano attriti, antipatie tra appartenenti alla comunità poetica oppure ci sono anche attriti, antipatie preesistenti che generano nuove polemiche. Comunque dovendo rinunciare alle risse dei talk show non avendo tale possibilità mediatica i poeti, veri o presunti, si devono accontentare di quello che passa il web. Se uno assurge a un minimo di notorietà si presentano gli ammiratori acritici e gli hater. Poi non è solamente questione di talento, di pubbliche relazioni, di fortuna critica. Come scriveva Alberto Arbasino: “In Italia c'è un momento stregato in cui si passa dalla categoria di bella promessa a quella di solito stronzo. Soltanto a pochi fortunati l'età concede poi di accedere alla dignità di venerato maestro.” Ma la comunità poetica va detto che è un grande calderone. Chi può a pieno diritto dire di appartenervi? Tutti e nessuno, ovvero poeti e letterati effettivi, aspiranti, sedicenti. È tanto opinabile quanto arbitrario stabilire chi è un poeta. Basta aver pubblicato un libro, seppur a pagamento o esserselo autopubblicato? Bisogna aver vinto un premio purchessia, anche quello della propria parrocchia o del circolo letterario a cui si è iscritti? Bisogna avere pubblicato solo su litblog, riviste letterarie? Oppure possono fregiarsi del titolo di poeti e poetesse solo coloro che pubblicano con grandi case editrici? È vero che il web è la fossa del leone e i nuovi leoni ora sono i social. La critica è quasi inerme, sta sulla difensiva, arroccata nella qualità. Perfino gli editori però controllano la popolarità sui social, il numero di follower degli aspiranti poeti, che ormai devono essere webpoet. Dopo tanto odio ecco che arriva il giusto riconoscimento dopo una sudata carriera letteraria; ecco un profluvio, una massa di necrologi, di attestati di stima, di elogi sperticati al momento della dipartita: una vera e propria celebrazione in pompa magna che durerà pochissimo e non lascerà alcuna traccia perché ormai niente lascia più traccia sui social, come scriveva oggi il poeta Luca Alvino. E allora cosa è che resta se resta? Resta la grande poesia e restano i grandi poeti. Come scrisse Alfonso Berardinelli: "Io non credo nella poesia. Credo soltanto in quelle poesie che mi fanno credere in loro. Se convince il lettore, la poesia non ha bisogno di essere difesa".
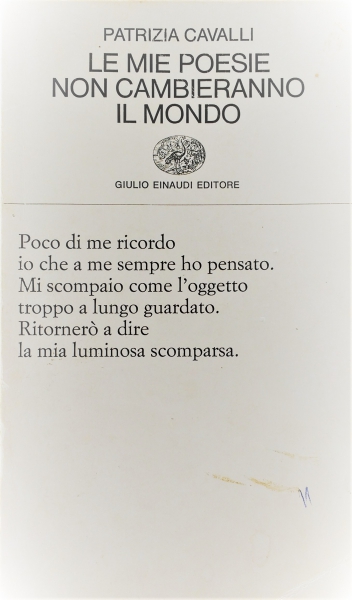
È morta una grande poetessa come Patrizia Cavalli il 21 giugno. Non ho scritto nessuna riga su Facebook. Non ne aveva bisogno. Quando era in vita ho acquistato alcuni suoi libri. Quello che potevo fare l'ho fatto. Era il minimo indispensabile, ma non la conoscevo ed ero impossibilitato a fare di più. Adesso non piango lacrime di coccodrillo né fingo che fosse una persona amica. Restano dentro me alcuni suoi versi e forse non è poco. Scusate se non sono falso e scrivo a ciglio asciutto. Spetta ad altri più titolati di me o anche più vicini a lei scriverne e parlarne. Una mia commemorazione fatta, lodandola come poetessa sarebbe inopportuna e fuori luogo. I coccodrilli li scriva chi di mestiere. E scrivo ciò senza voglia di fare polemica; ci mancherebbe.
giu 202022 PREMESSA:
Il gruppo 63 propose la riduzione dell'io ilirico in poesia. Oggi alcuni letterati vorrebbero eliminarlo, rimuoverlo. Io o mondo? Piuttosto io e mondo, visto che tra io e mondo c'è un'interazione continua. Ma se cognitivamdnte io e mondo possono coesistere, letterariamente di solito c'è una prevalenza.
NOTA BENE:
L’io lirico è la voce interiore nella poesia. Non è detto che coincida sempre con l’io empirico, ovvero con l’autore in carne e ossa. L’io lirico può essere anche in un certo qual modo fittizio. Si veda ad esempio Pessoa e i suoi eteronimi. L’io lirico può essere anche un alter ego.
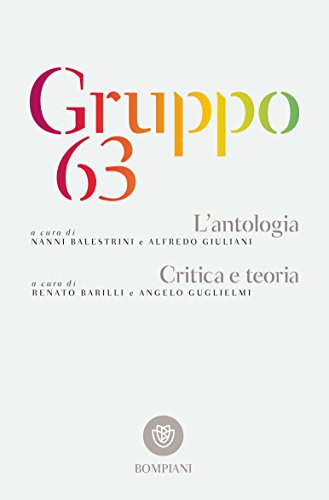
Gadda scrive ne "La cognizione del dolore": "[…] l'io, io!… il più lurido di tutti i pronomi!… I pronomi! Sono i pidocchi del pensiero. Quando il pensiero ha i pidocchi, si gratta come tutti quelli che hanno i pidocchi… e nelle unghie, allora… ci ritrova i pronomi: i pronomi di persona". Però Gadda lo fa dire al protagonista, suo alter ego nevrotico, in una crisi parossistica. Non dimentichiamo che Gadda era notoriamente nevrotico, per quanto geniale, e ha messo molto del suo io empirico nevrotico in quel romanzo. Alcuni oggi, che vorrebbero rimuovere l'io lirico, citano questo brano dell'ingegnere. Inoltre per Gadda tutti i pronomi sono "pidocchi del pensiero", per cui non ci sarebbe via di uscita. Ogni narrazione sarebbe perciò tarata a priori. Infine queste frasi non vanno decontestualizzate. Estrapolare delle frasi dal loro contesto può essere fuorviante e indurre in errore. Si tratta pur sempre di un romanzo, "La cognizione del dolore", che ha senza ombra di dubbio un suo contenuto di verità, ma che è anche creazione di un mondo fittizio e di personaggi immaginari grotteschi, paradossali.
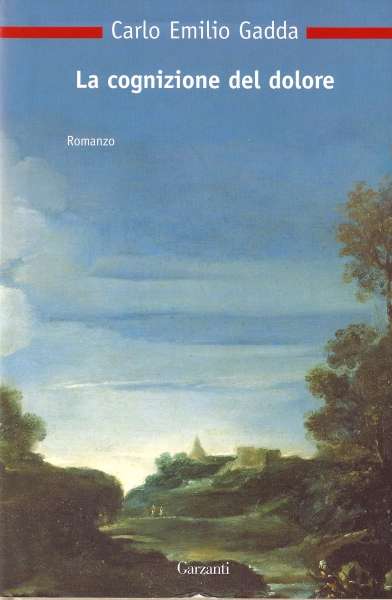
Il problema è quanto della propria nevrosi, delle proprie fratture, dei propri vuoti uno riversi nella propria opera e ciò non è necessariamente detto che sia un male. Chi impone che l'impersonalità e il distanziamento siano degli obblighi della narrazione? E la narrazione di Gadda può essere forse presa di esempio? Bisogna sempre stare attenti quando si cita a non farlo a sproposito, a non strumentalizzare la fobia dell'io di Gadda (capisco che ognuno voglia portare acqua al suo mulino). Qui non si tratta di canoni della letterarietà, ma di una difesa a oltranza di quel poco che resta del soggetto freudiano (visto e considerato che il soggetto cartesiano è stato distrutto dai maestri del sospetto e del cogito, ergo sum resta solo il coito, ergo sum). A ogni modo ognuno è sempre circondato da sé stesso, come scriveva Sartre, indipendentemente dagli escamotage narrativi. A proposito di io e scrittura, oltre al celebre detto "Conosci te stesso", Gramsci in un articolo citava Novalis, che a sua volta scriveva: «Il supremo problema della cultura è di impadronirsi del proprio io trascendentale, di essere nello stesso tempo l’io del proprio io. Perciò sorprende poco la mancanza di senso e intelligenza completa degli altri. Senza una perfetta comprensione di noi, non si potranno veramente conoscere gli altri». Mi sembra che questa citazione sia appropriata e di non tirare per la giacchetta nessuno. Insomma sono necessarie anche l'autoconoscenza, l'autodeterminazione. Per decenni l'intimismo ha fatto da padrone nella cosiddetta poesia lirica. Attualmente in Italia alcuni letterati vogliono rimuovere l'io lirico e demonizzano l'io in senso lato. Voler rimuovere l'io lirico significa non poter scrivere in prima persona nelle poesie, essendo costretti a trattare gli altri che possono essere proiezioni del proprio io o riproposizione delle solite figure parentali. Insomma la psicoanalisi ci insegna a ragione che è lecito diffidare anche di chi parla troppo degli altri e che talvolta così facendo finisce per deformarli troppo con la sua lente o per rispecchiare sé stesso. Un'obiezione alla rimozione dell'io lirico: talvolta è difficile dire quanto io ci sia negli altri e quanto gli altri siano nell'io tra identificazioni, proiezioni, interiorizzazioni. Altra obiezione: in poesia come scriveva Zanzotto vige l'eterogenesi dei fini; si cerca una cosa e se ne trova un'altra; così chi cerca l'io trova talvolta il mondo e viceversa. Alcuni sostengono che i poeti contemporanei siano affetti da egolatria. È difficile dire quale sia il discrimine tra normalità e patologia. E poi si pensi al fatto che anche Stendhal scrisse "Ricordi di egotismo". La stessa poesia moderna americana è un continuum ai cui poli opposti ci sono la schiva Emily Dickinson e il titanico Walt Whitman.

(Nella foto Gadda)
Da una parte l'introversione e dall'altra l'estroversione. Prima ancora che un atteggiamento intellettuale, filosofico, letterario, conoscitivo scegliere uno o l'altro di questi poli è questione di personalità. Ci sono introversi ed estroversi. Non c'è niente di giusto o sbagliato. Ci sono pro e contro di entrambe le condizioni esistenziali. Queste due diverse modalità di approcciare la realtà sono frutto prima di tutto questione di personalità. Dalla personalità consegue il modo di interfacciarsi al reale. Come esiste un orientamento sessuale, politico, valoriale esistono anche varie tipologie di personalità. Ma i critici letterari non dovrebbero giudicare il modo in cui gli autori si volgono alla conoscenza. C'è chi sceglie insomma prevalentemente l'interno e chi l'esterno. In alcuni autori gli altri si riflettono in loro stessi e in alcuni autori l'io si riflette negli altri. Si tratta pur sempre di rimandi continui, di un perenne gioco di specchi. Partire dagli altri e finire nell'io o viceversa è solo un punto di partenza. Privilegiare l'io o il mondo non deve essere una posa, basata su premesse teoriche. Ogni autore dovrebbe scegliere in base a ciò che sente, a ciò che ritiene più consono. Trovo che esimersi dal tranciare giudizi approssimativi sia senza dubbio un atto di onestà intellettuale. Trovo anche fuori luogo il fatto che a seconda dello spirito dei tempi sia di moda quando l'intimismo e quando invece gli altri. Un'altra cosa che mi fa sorridere è che alcuni autori postulino la rimozione dell'io e poi scrivano dei romanzi o delle raccolte poetiche autobiografiche. Evidentemente egoriferiti sono sempre gli altri. Non ho mai letto di nessuno che considerava sé stesso egoriferito. In questi ultimi anni in poesia nelle polemiche letterarie evidentemente vince chi dà per primo dell'egoriferito all'altro. È una moda come un'altra. Non è frutto di un'evoluzione stilistica o letteraria. Non è un punto di arrivo della letteratura come vorrebbero far credere alcuni. Un tempo c'era la vecchia disputa molto divisiva tra realisti e idealisti. Il vero atteggiamento conoscitivo equilibrato sarebbe trovare un equilibrio tra io e mondo e questo trascendendo i propri tratti di personalità. Ma ciò è quasi impossibile perché l'io o il mondo sono come calamite. C'è chi è attratto dall'uno e chi dall'altro, molto probabilmente più per attitudine che per scelta, più per natura che per cultura. Kafka sosteneva che tra io e mondo si dovesse scegliere il mondo, ma fece davvero così? Cosa sarebbe dei capolavori di Kafka senza il suo io? Quanto io e quante proiezioni ci sono nelle opere di Kafka?

(Nella foto Kafka)
Un interrogativo che sorge spontaneo è se la propria personalità di base sia un nucleo costante e inalterabile o se invece oggi come oggi sia modificabile. La cosa si complica perché sembra che le vecchie teorie sulla personalità come i tipi psicologici di Jung siano oggi inadeguate per decifrare il Sé così sfuggente dell'uomo contemporaneo. Sembra che entrino in gioco in ognuno di noi anche le cosiddette subpersonalità. Anche gli altri sono però sfuggenti. In ogni caso è vero che cresciamo e maturiamo grazie all'immagine che gli altri hanno di noi, ma è altrettanto vero che per conoscere bene gli altri bisogna conoscere bene sé stessi. È un circolo ermeneutico che dura tutta la vita. Sia la conoscenza di noi stessi che del mondo è sporadica, superficiale, discontinua. Di noi stessi conosciamo la nostra voce interiore, il discorrere tra sé e sé. Degli altri conosciamo una minima parte dei loro comportamenti e delle loro espressioni verbali. Uno dei problemi filosofici ancora irrisolti è come, nonostante i nostri limiti intrinseci, riusciamo a conoscere tutto quello che conosciamo. Avrete capito che la questione dell'io in letteratura è un intreccio inestricabile di letterarietà e psicologia. Non può essere altrimenti e le persone ponderate dovrebbero riconoscerlo senza tacciare chi la pensa diversamente di psicologismo. Non vi preoccupate comunque poeti introversi e intimisti: l'io tornerà di nuovo in auge. E poi perché estrovertirsi è necessariamente un bene e concentrarsi su di sé è necessariamente un male? La preghiera, il raccoglimento interiore, la meditazione (senza fare del moralismo) dovrebbero essere allora un male?
giu 172022

(Nella foto Davide Morelli a Marina di Cecina)
"Il poeta sei tu che leggi” si trova scritto dappertutto ormai. È scritto anche sul Lungotevere Vaticano. Lo scrivono in tanti sul web. Sembra che la paternità sia da attribuirsi al poeta di strada Ivan Tresoldi, certamente un personaggio creativo. Il vero autore sarebbe quindi il lettore. Sarebbe lui il maggior costruttore di significato, il vero responsabile del senso ultimo del testo. Di fronte all'ambiguità semantica è proprio il lettore che decide cosa significhi questa o quell'opera. Una parola, una frase, un intero testo possono avere significati diversi a seconda del contesto (inteso in senso lato) e della sensibilità individuale. Ogni testo in un certo qual modo è polisemico. La stessa connotazione, quella che Umberto Eco definiva come la coloritura emotiva di ogni parola, di ogni frase varia da persona a persona. La denotazione non è oggettiva (nel senso che non è oggettuale come le cose nella scienza), ma è certa perché convenzionale. La denotazione è decisa dalla comunità linguistica. La connotazione è incerta perché soggettiva. Ogni testo quindi dipende anche, forse soprattutto, dallo stato mentale, dall'umore, dallo stato d'animo del lettore in quel particolare frangente. Era questo il punto debole dello strutturalismo, prima ancora che Chomsky parlasse di psicolinguistica. Possiamo perciò anche essere d'accordo. Gli artisti inoltre non esistono senza pubblico. I poeti non esistono senza lettori. Adam Smith ne "La ricchezza delle nazioni" considerava gli artisti degli assistiti. In quell'epoca la maggioranza erano cortigiani oppure secoli prima per esempio pittori e scultori venivano finanziati da dei mecenati o avevano come committente la Chiesa. Oggi gli artisti sono assistiti dai loro ammiratori, estimatori, seguaci. Aveva capito tutto il cantautore Claudio Rocchi quando gli chiedevano l'autografo, lui chiedeva le generalità del richiedente e poi firmava con il nome e cognome del suo fan. Senza il pubblico l'artista non ha modo di esistere. Oggi è poeta chi legge. Al bando quindi il copyright, i diritti di autore, l'autorialità. In questo modo nessuno è più autore e tutti sono autori. Ma io mi domando: se uno non legge cosa è? Molto probabilmente molti non vogliono leggere perché non vogliono essere poeti. Di solito comunque leggono poesia soprattutto gli aspiranti poeti, coloro che vogliono diventare poeti. Come esistono le preghiere interessate anche queste sono letture interessate in un certo modo. Tuttavia "il poeta sei tu che leggi" significa senza ombra di dubbio che non si può essere poeti senza essere lettori forti. Ma la situazione è a ogni modo desolante in Italia. Certamente i giornali non aiutano. La cosiddetta terza pagina viene sempre messa in ennesima pagina. Sono anche scomparsi e non più sostituiti grandi maestri dell'elzeviro. Non scrivono più ormai Luca Goldoni, Alberto Arbasino, Pier Francesco Listri, Luigi Maria Personè. Mi ricordo che anni fa mi incuriosivano molto gli aneddoti letterari di quest'ultimo, morto centenario, grande letterato, che aveva conosciuto tutti i più grandi letterati del Novecento italiano e non. Poi le terze pagine dei quotidiani trattano di società, mondo dello spettacolo, tendenze. Trattano spesso di cose futili, leggere, tanto per intrattenere più che per acculturare, se va bene per informare più che per formare. Ma i direttori dei giornali sono messi alle strette e loro, se interpellati a riguardo, direbbero prontamente: i quotidiani vendono sempre meno copie e bisogna dare ai lettori ciò che vogliono. Il potere in questo modo si deresponsabilizza tramite la presunzione di ignoranza del popolo. Così facendo il popolo non si accultura. Inoltre come ho sempre avuto modo di dire: oggi tutto è cultura tranne la cultura. C'è spazio per tutti in televisione tranne che per la letteratura, la poesia, la scrittura. Eppure la fruizione culturale è aumentata notevolmente in questi anni. Ma la cultura è noiosa, soporifera. La scuola non aiuta. I programmi ministeriali sono quelli che sono. Poi con la vecchia retorica che non bisogna dare la pappa pronta diversi critici letterari si sono dimostrati criptici, oscuri, allontanando di fatto le persone dalla cultura. Diversi letterati non vogliono correre il rischio della banalizzazione, della volgarizzazione, neanche quando di tratta di un'utile semplificazione. Anche in letteratura bisognerebbe utilizzare il rasoio di Occam, ovvero non moltiplicare gli enti inutili. Invece sembra che diversi letterati abbiano a cuore il loro gergo specialistico e allora usano grecismi, latinismi, inglesismi, francesismi. La cultura diventa talvolta perciò un fardello pesante. Ci sono ancora oggi diversi letterati, che pur essendo politicamente progressisti, hanno una concezione elitaria e snobistica della letteratura, nutrendo talvolta dei pregiudizi nei confronti della cosiddetta gente. Insomma secondo costoro la letteratura deve essere difficile, non alla portata di tutti. Un tempo il preside della facoltà di ingegneria di Pisa, Piero Villaggio, amava dire "ingegneria deve essere difficile" agli studenti che si lamentavano della severità dei docenti. Ogni ingegnere ha delle responsabilità civili, sociali, etiche, umane. Deve saper fare bene i calcoli per non far crollare i ponti o se è un ingegnere gestionale deve saper fare i conti per non far fallire un'impresa. Ma un letterato ha soprattutto il dovere di farsi capire ai più. Così scriveva Claudio Chieffo: "Dicevano gli antichi che non c'è nulla di peggio di un popolo che dimentica i suoi poeti; e invece c'è di peggio: un poeta che dimentica il suo popolo". In un certo qual modo diversi letterati complicano le cose; sono esoterici, nel senso più deteriore del termine. Ma a questo proposito secondo una scuola di pensiero nessun uomo è depositario di grandi verità. Le cose della vita sono sempre quelle trite e ritrite. I letterati sono uomini come gli altri. Invece secondo un'altra scuola di pensiero non si può spolpare la letteratura perché poi alla fine ci resta un torsolo di mela. Secondo questi pensatori aveva ragione Cioran quando scriveva che se togliessimo il belletto alla letteratura non resterebbe niente. La domanda da un milione di dollari è la seguente: si può rappresentare la vita anche in modo comprensibile ai più oppure bisogna riprodurla fedelmente nella sua complessità? E ancora i letterati devono abbassarsi al livello del pubblico o devono cercare di elevarlo? Meglio arrivare a tutti o invece essere per pochi eletti? Nel frattempo la poesia è di nicchia. Di solito le espressioni "nicchia di mercato" o "mercato di nicchia" possono avere anche molti risvolti positivi. Si sente dire che nel mondo economico c'è parecchia crisi, ma tizio e caio hanno trovato una bella nicchia di mercato e si sono arricchiti. Non fatevi illusioni: la poesia è una nicchia di mercato che non vende, non arricchisce, se non interiormente. Eppure le facoltà umanistiche sono sovraffollate. Mai tarpare le ali. Mai uccidere i sogni. Ci penserà poi la realtà a disilludere, a deludere, a disincantare. Un altro problema è che oggi tutti sono poeti tranne i poeti. Sono poeti i cuochi, i cantanti, gli influencer, i lestofanti, i piacioni, gli addetti alle pubbliche relazioni, i latin lover e gli arrivisti vari. La poesia sembra essere di tutti, tranne che dei poeti. E i veri poeti? Non pervenuti. Lasciano poche tracce di sé. Disseminano i loro versi in angoli remoti del web. Pubblicano libricini che vendono poco o addirittura pochissimo. La poesia d'altronde è di tutti o di nessuno. Parafrasando un celebre detto, la poesia è quella cosa che tutti pensano di sapere che cosa sia. In tutta onestà penso che valga la regola opposta e inversa: nessuno può sapere con certezza che cosa sia la poesia. Quindi, concludendo, è vero: il poeta sei tu che leggi, a patto che tu legga e legga roba buona.
giu 172022

Ungaretti dovrebbe essere un modello per i poeti contemporanei spesso illeggibili perché incomprensibili. Ognuno, dopo aver finito di scrivere una raccolta poetica, dovrebbe rileggere "Allegria", che si caratterizza per i versicoli immediati. Dovrebbe essere la prova del nove per tutti i poeti. Allo stesso modo ogni romanziere dovrebbe, dopo ogni sua fatica letteraria, rileggere "Se questo è un uomo" e "Una giornata di Ivan Denisovič" perché questi due capolavori riescono a coniugare anche essi sostanzialità e testimonianza. Poi magari ogni scrittore potrebbe decidere se pubblicare o rivedere di nuovo il lavoro. Ma ritorniamo a Ungaretti. Sono talmente dirette e spontanee le sue liriche, che riescono a spiazzare e a colpire favorevolmente anche i lettori più snob, abituati alla poesia del Novecento che si distingue per essere così intellettuale! Ungaretti è agli antipodi di poeti così ricercati come Eliot e Pound. Riesce a semplificare il linguaggio e a essere scarno ed essenziale. Nei suoi versi troviamo tutta la sua vita di esule che si forma culturalmente a Parigi (conoscendo Apollinaire e Picasso) e che combatte sul Carso. Queste sue poesie sono testimonianza ineguagliabile della guerra. Sono prive delle descrizioni e dell'eloquenza della lirica di quegli anni. Non vi sono leziosismi. Sono frutto di un'ispirazione, che trascende la metrica, la retorica e l'estetica. Non vi venga in mente che le sue poesie scaturissero solo da intuizioni, seppure formidabili. C'era del lavoro alle spalle. Erano state molte le varianti e le revisioni prima delle versioni definitive. A onor del vero bisogna anche ricordare che il poeta distrusse le tradizionali forme poetiche nelle prime liriche, ma successivamente dimostrò di saper utilizzare anche versi canonici come novenari ed endecasillabi. Forse oseremmo troppo a scrivere che fu una sorta di cubista della poesia nella sua prima fase. Come ebbe a scrivere Ungaretti per essere poeti è necessaria non solo la pazienza, la conoscenza della tradizione, l'intelletto. Bisogna anche saper fare i conti con il mistero che alberga in ogni animo: soltanto così una poesia può diventare unica come la sua. Ungaretti, quando scrisse i suoi primi innovativi versicoli, aveva appreso la lezione dei simbolisti francesi. Ma Ungaretti era completamente originale. Aveva subito saputo distinguersi dai suoi illustri predecessori. Era un predestinato della poesia. Lo stesso Thomas Merton scrisse che Ungaretti era sconvolgente e che la sua intensità annientava. Alcuni suoi versi rimarranno per sempre nella memoria di molti: "m'illumino d'immenso", "è il mio cuore il paese più straziato", "si sta/come d'autunno/ sugli alberi/ le foglie", "Di che reggimento siete/ fratelli?", "Non sono mai stato/ tanto/ attaccato alla vita", "tra un fiore colto e l'altro donato/ l'inesprimibile nulla". Queste illuminazioni esprimono in modo impareggiabile la precarietà e la fragilità proprie di chi combatte in una guerra assurda. Ungaretti aveva combattuto la grande guerra e per capire quanto fu devastante la prima guerra mondiale non bisogna andare molto lontano: basta andare a visitare Asiago, che fu completamente rasa al suolo in quegli anni. Ungaretti viaggiò molto. Visse molto. Soffrì molto. Non soltanto per l'esperienza della guerra ma anche per la morte del figlioletto di nove anni a cui dedicò la raccolta "Giorno per giorno". Il poeta si chiedeva come era possibile continuare a vivere e a fare le cose di ogni giorno quando non poteva più vedere il suo bambino, la cui voce non avrebbe udito più. Scrisse Ungaretti: "E t'amo, t'amo, ed è continuo schianto!...". Nella sua vita il poeta sperimentò i dolori più terribili: gli orrori della guerra e la scomparsa del figlioletto. Ma Ungaretti riuscì a non lasciarsi mai sopraffare dalle avversità e dai tristi eventi. Riuscì sempre a superare questi periodi di crisi, testimoniando con i suoi versi le tragedie vissute. La follia della guerra riuscì a vincerla confidando nell'uomo: credendo nella fraternità. Il dolore atroce per la perdita del figlio lo sconfisse non solo con la terapia della scrittura ma anche con la religiosità. Non auguro a nessuno di provare i dolori di Ungaretti. Dovrebbe però essere preso di esempio per la sua semplicità, che è mai scontata e non scade mai in banalità. Il Nostro scrisse in modo apparentemente semplice ed è comprensibile a tutti. Ma non lasciatevi ingannare. Ungaretti era anche un profondo conoscitore della lingua e della poesia. C'è chi potrebbe pensare che molti sarebbero in grado di scrivere come Ungaretti ma è un giudizio affrettato dovuto a pura superficialità e faciloneria: pensarla così è pura ingratitudine nei confronti di uno dei più grandi poeti del Novecento. Comunque Ungaretti fu il primo a scrivere in quel modo così breve e coinciso. Nel peggiore dei casi gli vanno riconosciute in tutta onestà sia la bravura che la grande originalità.
giu 172022

Quasimodo, nonostante le sue sperimentazioni e le sue revisioni stilistiche, fu sempre legato alla tradizione, grazie alla musicalità dei suoi versi e al suo classicismo (non a caso tradusse i lirici greci). Inizialmente il poeta cantò il mito della Sicilia, la nostalgia e lo sradicamento dalla sua terra; nelle sue prime raccolte rievocò l'infanzia e i paesaggi che lo avevano visto nascere e crescere. In quegli anni fu ermetico. Alcuni lo hanno considerato un caposcuola, mentre altri solo un fiancheggiatore di questa corrente letteraria. Coloro che lo criticano negativamente per questa sua adesione dovrebbero però ricordarsi che erano gli anni della formazione del suo immaginario e del suo apprendistato poetico: non era ancora nella fase della maturità.
L'ermetismo aveva il grande pregio di proporre "la letteratura come vita" e di opporsi all'autoesaltazione, all'enfasi, alla megalomania di D'Annunzio. Alcuni critici però hanno sempre accusato gli ermetici di essere oscuri e di utilizzare un linguaggio allusivo. Ma Quasimodo anche in questo suo periodo non fece mai un utilizzo eccessivo dell'analogia. Poteva sembrare di primo acchito non totalmente originale, eppure successivamente si dimostrò unico sia dal punto di vista espressivo che per quel che riguarda la visione del mondo.
Il poeta seppe distaccarsi dalla retorica di Carducci, dall'estetismo e dall'irrazionalismo di D'Annunzio, dall'intimismo e dalla stanchezza di vivere dei crepuscolari, dall'esaltazione del progresso dei futuristi, dal nazionalismo di altri artisti; il poeta siciliano non scavò mai nella parola e non distrusse il verso come fece Ungaretti; non distrusse mai le strutture logiche e sintattiche; non si abbandonò all'estetismo; non si lasciò corrodere dall'autodistruzione e dalla nevrosi; non fu mai preda dell'intellettualismo e ricordo che per esempio per Croce l'autentica poesia era priva di sovrastrutture ideologiche, di allegorie, di tematiche filosofiche e teologiche. Quindi secondo i canoni estetici crociani i suoi componimenti erano poesia. Il grande critico letterario Oreste Macrì scrisse un saggio sulla "poetica della parola" di Quasimodo. Come poeta sono pochissimi coloro che lo giudicano in modo negativo. Come uomo all'epoca alcuni lo criticarono per non aver partecipato alla Resistenza. Ma come scrisse lo stesso Quasimodo "il poeta modifica il mondo" e non è detto che lo possa fare soltanto con l'impegno politico-sociale, ma lo può fare anche con i suoi versi. Dopo la fase ermetica non scrisse più dell'Eden perduto ma trattò della sofferenza dell'uomo in guerra. Quasimodo dimostrò di saper compiere un'evoluzione dal punto di vista umano, affrontando nuove tematiche. Aveva sempre nostalgia di casa, ma non era più il paesaggio siciliano a avere la meglio: era piuttosto la coscienza civile ad essere presente in ogni lirica. Il poeta non poteva stare nella sua torre eburnea, ma doveva esprimere sentimenti come solidarietà, partecipazione emotiva, fraternità. Evitò così di descrivere l'incomunicabilità e divenne forse il più comunicativo dei poeti del Novecento, addirittura forse più di Ungaretti: sicuramente uno dei più semplici e più comprensibili a leggersi, il più efficace a descrivere la crisi esistenziale dell'uomo moderno conseguente alla tragedia e all'orrore della guerra. I suoi messaggi erano chiari ed espliciti.
Come non ricordare la lirica "Uomo del mio tempo", in cui scrive che l'uomo è sempre lo stesso di quando usava la pietra e la fionda e che ora utilizza le sue scienze esatte per sterminare i suoi simili? Oppure come scordarsi "Alle fronde dei salici" che necessita di una parafrasi solo se letta da un bambino delle elementari o al massimo delle scuole medie inferiori? Oppure come non ricordarsi la lirica "Quasi un epigramma" in cui definisce la società moderna come "la civiltà dell'atomo"? Non era forse questa poesia civile? Non era questo un lirismo fatto da parole semplici che potevano arrivare a tutti? Ancora memorabili i versi di "Lamento per il Sud" in cui descrive un Sud dove si moriva di stenti e nonostante ciò ancora bello e incontaminato, a differenza di un Nord industrializzato e già inquinato. La lirica più celebre di tutte è senza ombra di dubbio "Ed è subito sera" perché in pochissimi versi sono rappresentate sia la solitudine dell'uomo contemporaneo che la brevità della vita e lo scorrere inesorabile del tempo. A mio modesto avviso il poeta cercò sempre di descrivere l'enigmaticità e il non senso di un mondo sfuggente e colmo di brutture: una società di massa desacralizzata ("senza Cristo") in preda alla barbarie. Da ricordare anche che dopo la fine del conflitto mondiale si avvicinò al neorealismo e si mostrò critico nei confronti del boom economico e del consumismo. Con queste poche righe non voglio assolutamente spiegare Quasimodo. Posso solo interpretare i suoi versi e voglio farlo da dilettante senza seguire le regole, i criteri e i metodi dei critici di professione. Comunque per avere più chiara la sua poetica ricordo che fu proprio Quasimodo nel suo saggio "Discorso sulla poesia" a scrivere che "la poesia si trasforma in etica, proprio per la sua resa di bellezza".
giu 172022

Montale nacque nel 1896 a Genova e morì a Milano nel 1981. Nell'adolescenza e nella giovinezza trascorse le estati a Monterosso, dove faceva bagni e gite con Anna degli Uberti, che forse si può identificare con Annetta, la prima presenza femminile della sua poesia.
È proprio a Monterosso (alle Cinque Terre) che si formò come poeta autodidatta e fu proprio questo paese a essere fondamentale nel suo immaginario. La critica ormai ha sistemato Montale assieme a Ungaretti (la poesia pura) e Saba (la poesia onesta). Oppure talvolta ha proposto una nuova triade: Montale, Ungaretti, Quasimodo (caposcuola dell'ermetismo).
A mio modesto avviso, queste collocazioni lasciano il tempo che trovano. Gli stessi critici un tempo proponevano la triade Carducci, Pascoli, D'Annunzio. Comunque Montale non fu mai legato a alcuna scuola o ad alcun ismo letterario. Possiamo solo affermare con certezza che in gioventù i suoi modelli di riferimento furono Foscolo, Leopardi, Manzoni. Gli Ossi di seppia furono pubblicati da Gobetti nel 1925 e dimostrano una grande originalità perché si distanziano dall'opera dannunziana Alcyone.
Lo stesso Montale definì la poesia degli Ossi controeloquente e per nulla aulica. Il premio Nobel non a caso predilige i limoni ai bossi ligustri dei poeti laureati. La poesia degli Ossi permette di dire soltanto "ciò che non siamo, ciò che non vogliamo". Nella sua prima raccolta poetica troviamo come protagonista l'aridità del paesaggio ligure: non troviamo neanche sullo sfondo i grandi eventi storici o le ideologie, anche se Montale firmò in seguito il manifesto degli intellettuali antifascisti e si oppose quindi alle "stalle di Augia". Gli stessi Ossi di seppia, che sono detriti in balia della corrente e che poi restano inermi sulla spiaggia, non simboleggiano altro che la condizione umana. L'agave abbarbicata allo scoglio in fondo non rappresenta altro che l'isolamento del poeta. La natura soffre; lo stesso essere umano soffre e non può far altro che testimoniare la propria sofferenza ("il male di vivere").
La poesia montaliana si contraddistingue per il descrittivismo, la capacità di creare oggetti-emblemi e di mitizzare i luoghi della sua giovinezza. Ma è allo stesso tempo anche una poesia che rappresenta la crisi esistenziale di Montale, le sue disarmonie, il suo disagio, la precarietà della vita, l'inautenticità dell'esistenza: in definitiva il suo rapporto problematico con la realtà. La sua poetica non consiste quindi in una pura nominazione e i suoi componimenti non sono semplici esercizi di stile, nonostante la sua giovane età. Montale inoltre non ha e non offre mai speranze, illusioni e neanche metafisiche consolatorie (i morti per Montale perdurano soltanto nella memoria dei vivi. Non c'è alcun aldilà): "è della razza di chi rimane a terra", anche se è alla ricerca di un varco (alcuni critici hanno considerato per tale ragione il poeta comunque pervaso da un'ansia metafisica). Forse anche per questo è stato accusato di immobilismo esistenziale (è lui stesso Arsenio) nel corso della sua carriera poetica, oltre al fatto che è sempre stato etichettato come il poeta borghese per antonomasia. Per alcuni critici era non credente e borghese: perciò incapace di evolversi e destinato a ripetere le stesse tematiche.
Comunque gli Ossi di seppia forse restano il vertice della poesia montaliana: l'esito più alto.
Non voglio trattare delle innovazioni metriche ed espressive della poesia di Montale. Sono state scritte molte pagine di critica letteraria riguardanti la metafisica montaliana dell’ “anello che non tiene” e del “male di vivere”. Sono stati versati fiumi di inchiostro sul fatto che non ebbe certezza della realtà né dell’esistenza e che non riuscì mai a conciliarsi con sé stesso. Forse per queste ragioni la sua poesia è un’interrogazione delle cose ed è costituita da oggetti che divengono simboli. Ma non è mai puro esercizio di nominazione né vano tentativo di giungere alla soglia del dicibile. Il poeta è teso verso l’essenziale, evita inutili orpelli. Non a caso il poeta degli “Ossi di seppia” nel 1946 aveva sostenuto in “Intervista immaginaria” che la poesia era apporto di conoscenza e non più mera rappresentazione. Questa sua affermazione si può considerare una dichiarazione di intenti a cui seppe rimanere fedele e coerente negli anni successivi. Montale aveva intuito che gli oggetti potevano inviare dei segnali da decifrare e che in essi ci fossero dei significati profondi da cogliere, evitando di cacciarsi in zone inesplorate ai più e di dare forma alla materia informe e indifferenziata dell’inconscio. Ecco allora che Montale cerca la verità nel dettaglio. La cerca nella traccia di lumaca, nello smeriglio di vetro. Non esclude dalla sua indagine nemmeno lo stuzzicadenti e la briciola, perché anche queste “possono dirci qualcosa”. La verità è sotto ai nostri occhi, nelle nostre mani. E’ come una cosa che non riusciamo a trovare, l’abbiamo cercata in tutti gli angoli tranne che nelle nostre mani. Ma allo stesso tempo Montale ci dice che “è inafferrabile e sguscia come un’anguilla”. Esistono però delle persone che sono in grado di aiutarci nella ricerca della verità. E’ il caso di Esterina, che salva dal “delirio di immobilità” Arsenio e tutti coloro che appartengono alla “razza di chi rimane a terra”. Nel lessico poetico di Montale compare in più occasioni il termine “agnizione”, che significa riconoscimento. Grazie ad Esterina il poeta giunge all’agnizione, alla rivelazione esistenziale, all'illuminazione interiore. Tramite quelle che Holderlin definiva “divinità terrestri” Montale giunge alle sue formule poetiche, alle sue celebri sentenze. Queste “divinità terrestri” sono state naturalmente persone in carne ed ossa, ma hanno incontrato un grande poeta che è riuscito a vagheggiarle e trasfigurarle. Forse idealizzandole. Alcune di queste celebri epifanie montaliane furono vissute a Monterosso. Recentemente, naturalmente prima della pandemia, sono stato a visitare le Cinque Terre, che dal 1997 sono diventate patrimonio dell'umanità. Sono rimasto deluso perché i borghi erano sovraffollati. Era pieno di turisti stranieri, che erano in gran parte arrivati con il traghetto da La Spezia. I parcheggi erano tutti a pagamento e nonostante questo non si trovava un posto. I ristoranti erano affollati. I negozi alimentari, i bar, le pizzerie a taglio erano prese d'assalto. Il turismo di massa arricchisce i liguri ma salvaguarda forse il territorio? Un tempo forse era un'ingiustizia che tale natura incontaminata fosse privilegio di pochi (quando non c'erano ancora le autostrade, i traghetti, le ferrovie). Quando ci sono andato era una calca, un caos. Non esiste una via di mezzo? Il consumismo e il turismo mordi e fuggi forse finiranno per deturpare anche le Cinque Terre. Per la tutela di quei borghi dovrebbe essere preferito un turismo di qualità a un turismo di quantità. Il rischio è che i vandali oppure più probabilmente i maleducati rovinino tutto.
giu 162022

"Forse un mattino andando in un’aria di vetro,
arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo:
il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro
di me, con un terrore di ubriaco.
Poi come su uno schermo, s’accamperanno di gatto
alberi, case, colli per l’inganno consueto.
Ma sarà troppo tardi; ed io me n’andrò zitto
tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.”
Il poeta immagina di camminare al mattino in un’aria cristallina, rarefatta. Tutto a un tratto immagina di volgersi e vedere il nulla. Lo scrittore Italo Calvino, in occasione della celebrazione degli ottanta anni di Montale, ha fornito una spiegazione originale, a tratti alquanto suggestiva di questa poesia. Per Calvino il cardine della lirica è l’espressione “Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me”. Calvino scrive che la mancanza di un occhio dietro la nuca è sempre stato un limite percettivo per l’uomo. Sostiene però che una delle invenzioni più strabilianti della tecnologia moderna sia lo specchietto retrovisore delle automobili perché permette di vedere il campo posteriore, prima di allora invisibile. Eppure nonostante queste argomentazioni scrive che il poeta anche con uno specchietto retrovisore vedrebbe alle sue spalle “una voragine vuota senza limiti”. Calvino cita un animaletto mitologico nella zoologia fantastica di Borges: l’hyde-behind. Nei boschi i taglialegna per quanto possono voltarsi velocemente non potranno mai vedere davvero l’hyde-behind. Secondo Calvino nella poesia il protagonista riuscirebbe a scorgere l’hyde-behind nella sua vera essenza, ovvero il nulla. Per quanto questa analisi sia creativa e suggestiva, ritengo che non corrisponda assolutamente al vero. Secondo l’interpretazione di Calvino il tema principale della lirica sarebbe percettivo-conoscitivo. Intendiamoci: se fosse unicamente un problema percettivo si tratterebbe di una zona morta della percezione, di quella che gli esperti del settore chiamano macchia cieca. Il tema principale di “Forse un mattino andando” secondo Calvino è come possa esistere una porzione di reale inconoscibile o almeno sconosciuta ai propri occhi e infine alla propria coscienza. “L’uomo che si volta” e vede il nulla alle sue spalle, riesce forse a girarsi più rapidamente della messa a fuoco del suo campo visivo, che per questo motivo in quel determinato frangente non è ancora abbastanza nitido ed esteso da fornire immagini dell’ambiente circostante. Percepisce il nulla o meglio “il nulla che c’è”. Quel vuoto sarebbe quindi la risultante di un suo corto circuito mentale, di cui è cosciente, così come è consapevole qualsiasi persona, quando chiude gli occhi abbacinati dal sole, che i fosfeni sono barlumi causati da una reazione chimica delle pupille, quindi da un atto individuale, soggettivo. Secondo l’interpretazione di Calvino l’uomo che si volta non lascia il tempo alle immagini di accamparsi sulla superficie bidimensionale delle retine, oppure il suo voltarsi repentino è più veloce dell’impulso nervoso (ma quando mai?), che trasporta l’input sensoriale tramite il nervo ottico alla corteccia visiva. Comunque sia l’interpretazione di Calvino della poesia porta a concludere che “l’uomo che si volta” ha scoperto un’antinomia della percezione, una fallacia ottica, che arresta in quel momento il desiderio di conoscere e di esperire, infatti si ritrae e si ripiega su sé stesso, nel suo segreto. Tutto questo è basato su un presupposto: ogni uomo nel corso della sua vita servendosi di inferenze visive riesce a creare delle invarianti percettive, e insieme a queste un mondo fenomenologico completo e coerente. La certezza soggettiva della coerenza di questo mondo va in frantumi nella poesia di Montale. Ma Calvino non ne fa solo una questione percettiva, ma anche conoscitiva. Infatti scrive che quel qualcosa che avviene non riguarda il nervo ottico, bensì il cervello umano. Invece io penso che la vera tematica di questo “Osso di seppia” sia esistenziale e metafisica, non percettivo-conoscitiva. A mio avviso “il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me” riveste la stessa connotazione esistenziale di altre espressioni montaliane come “la maglia rotta nella rete” e “l’anello che non tiene”. A mio avviso Montale in questa poesia rifiuta “l’inganno consueto” della molteplicità fenomenica. Rifiuta qualsiasi rappresentazione gnoseologica del mondo. A favore di questa mia presa di posizione cito un’intervista radiofonica di Montale del 1976 in cui dichiarava: “avendo sentito fin dalla nascita una totale disarmonia con la realtà che mi circondava, la materia della mia ispirazione non poteva essere che quella disarmonia…..Ritengo che si tratti di un inadattamento…”. Il critico Contini scrive a proposito della condizione esistenziale di Montale: “la differenza costitutitva fra Montale e i suoi coetanei sta in ciò che questi sono in pace con la realtà, mentre Montale non ha certezza del reale”. Il critico A.Jacomuzzi invece scrive: “mentre nell’ambito e nella tradizione della poesia pura la condizione metafisica è essenzialmente un dato acquisito, una ipotesi non verificata, in Montale essa si atteggia come problema, come un dato da interrogare, un significato da cogliere”. Il senso di questa poesia di Montale per me è la sua disillusione, il suo disincanto nei confronti della realtà fenomenica. Montale non è certo dell’esistenza delle cose, fino a quando non coglie uno slancio vitale nelle sue muse. La sola immanenza non gli è affatto sufficiente. Ecco perché crede ciecamente - come dichiarò in una sua intervista - che “immanenza e trascendenza non sono separabili”. Questo incontro tra immanenza e trascendenza riesce ad esperirlo solo in rari momenti, quando riesce a trasfigurare una figura femminile, a vedere nella donna la personificazione di una cifra sovrasensibile. Ma se questa agnizione da un lato lo gratifica, dall’altro si accorge di non possedere quello slancio vitale della figura femminile e di appartenere alla “razza idiota degli eletti” (“Ti guardiamo noi della razza/ di chi rimane a terra”). In mancanza di questa idealizzazione della donna, di questa epifania fulminea Montale vedrebbe “il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me”. A controprova di questa mia supposizione esiste una poesia di Satura II, intitolata “Gli uomini che si voltano” in cui è scritto:”non apparirai più dal portello/ dall’aliscafo o da fondali d’alghe,/ sommozzatrice di fangose rapide/ per dare un senso al nulla. Scenderai/ sulle scale automatiche dei templi di Mercurio/ tra cadaveri in maschera,/ tu la sola vivente,/ e non ti chiederai se fu inganno”. Nel seguito di questa lirica Montale scrive: “Sono colui/ che ha veduto un istante e tanto basta….”. Montale quindi non cerca in modo categorico la descrizione della complessità del mondo. Non cerca di creare un modello in miniatura dello scibile umano. Non ha mai inteso la letteratura come fonte di Conoscenza razionale. Nel poeta ha sempre prevalso lo scetticismo nei confronti di qualsivoglia raffigurazione della realtà. Da questo punto di vista ha sempre abbandonato ogni minima speranza di certezza e ha sempre navigato nel mare aperto del dubbio. A mio avviso il suo interesse esclusivo è stato quello di trovare il punto d’incontro tra immanenza e trascendenza nella donna. Verrebbe ora da chiedersi: come mai Montale non ha mai idealizzato la Mosca, ovvero sua moglie? Probabilmente perché ricercare in lei l’anello di congiunzione tra umano e divino, avrebbe comportato considerarla una sorta di divinità. Montale scrive sulla Mosca, solo al momento della sua scomparsa. Per dirla alla Klein scrive per rielaborare il lutto. Secondo la Klein infatti ogni artista crea perché avverte il senso d’angoscia di una separazione (reale o fittizia), vissuta come perdita di sé e dell’altra persona. Nel discorso amoroso R.Barthes ci ricorda che “c’è sempre una persona a cui ci si rivolge, anche se questa persona è solo allo stato di fantasma”. Gli Xenia e i Mottetti di Montale possono allora essere considerati una sorta di surrogato dell'”oggetto transizionale” - per usare il termine di Winnicott - perché permettono al poeta di riappropriarsi di una immagine a lui cara, pur vivendo al contempo in modo cosciente e realistico la perdita terrena della mosca. Petrarca e Dante hanno angelicato Laura e Beatrice. I loro amori non corrisposti hanno fatto soffrire loro le pene dell’inferno. Ma nonostante ciò nei brevi componimenti dedicati alla consorte scomparsa non esiste traccia di idealizzazione della donna e neanche di compiacimento del dolore. Le muse di Montale non sono donne irraggiungibili e neanche la propria donna. Le sue muse sono amiche (Arletta, Clizia) e diventano muse solo in determinati e rari istanti. E senza queste muse “intermittenti”, da cui è sentimentalmente distaccato, Montale vedrebbe il nulla alle sue spalle ed il vuoto dietro di sé. Sono queste presenze raramente angelicate, che lo salvano dal nichilismo e dalla negazione del reale.