mag 032024
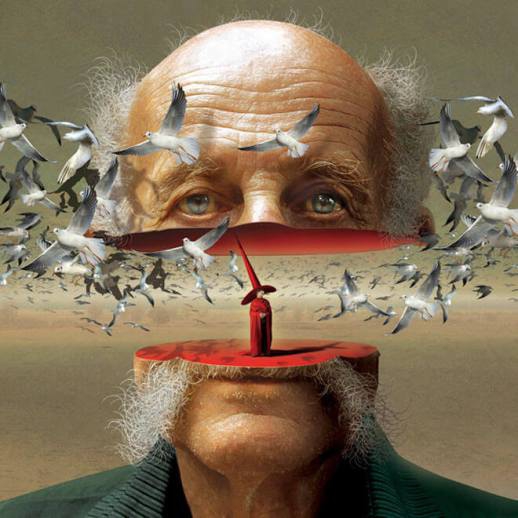
Secondo alcuni grandi autori (Freud, secondo alcuni aspetti Jung, Mieli, etc) in natura l'umanità sarebbe bisessuale. Freud definisce il bambino “perverso polimorfo”. Jung parla di Anima e Animus. Per Mieli nei primi anni siamo tutti pansessuali e poi è l'educazione che ci determina e ci inibisce. Ma è un'ipotesi, anche se accreditata, dato che questi autori hanno analizzato migliaia di casi e al mondo siamo 8 miliardi. Secondo la condotta Kinsey solo il 10% degli uomini avevano avuto rapporti omosessuali. Per i biologi ci sono circa 1500 specie animali che hanno comportamenti omosessuali. Ci sono alcuni studiosi che pensano che noi in natura siamo come i Bonobo kissing. Quindi è del tutto errata la convinzione che l'omosessualità sia contro natura. Ungaretti, intervistato a riguardo da Pasolini, sosteneva (e io ora semplifico) che la cosiddetta diversità, se esiste, non è contro natura, ma è prevista dalla natura. C'è chi sostiene che gli antichi greci e i latini erano tutti bisessuali e l'omofobia è arrivata con l'avvento del cristianesimo. Attualmente la Chiesa considera la sessualità omosessuale un peccato, ma, ammesso e non concesso che lo sia, non è reato, mentre per molto tempo è stato considerata tale: si ricordi a tal proposito Oscar Wilde e Turing, tanto per fare due nomi! Ancora oggi c'è uno stigma sociale nei confronti delle persone Lgbt. Secondo la scienza l'omosessualità è una variante assolutamente non patologica del comportamento sessuale umano. Ma probabilmente questa definizione è limitante. Potrebbero essere diverse le ipotesi: potremmo essere in natura tutti eterosessuali, tutti omosessuali oppure eterosessuali e omosessuali oppure ancora eterosessuali, omosessuali e bisessuali oppure di nuovo tutti bisessuali. E poi alcuni ipotizzano un continuum eterosessuale versus omosessuale, altri pensano che tutto sia "dicotomico". Le cose poi si complicano ulteriormente perché esistono i metrosexual, la fluidità sessuale, la transessualità, etc etc. La teoria del gender farà dei danni? Qualsiasi tipo di educazione può fare dei danni, anche l'educazione vittoriana, il metodo Montessori, lo stesso cattolicesimo: dipende chi e in che modo insegna, dipende il tipo di sensibilità e personalità degli allievi. I bambini dati in affidamento agli omosessuali possono subire gravi danni? Non è scientificamente accertato, molto probabilmente è una grande panzanata. Inoltre quei bambini cresciuti nella povertà avrebbero danni maggiori rispetto a essere adottati da dei genitori civili e omosessuali (ammesso e non concesso che subiscano del danni, crescendo con genitori omosessuali). Per quanto mi riguarda conosco coppie eterosessuali molto più disfunzionali delle coppie omosesssuali! Al di là di cosa siamo in natura, dell'interazione tra natura e cultura, della costruzione sociale dell'identità di genere ognuno ha diritto a essere come vuole e come si sente: importante è che non faccia del male agli altri. Ognuno ha anche diritto a vivere il suo orientamento sessuale e la sua sessualità, esibendosi oppure vivendo con discrezione, sempre considerando che l'outing è più che legittimo e il coming out molto spesso è una forzatura illegittima, una violenza psicosociale. Rivedevo in questi giorni “Salò o le 120 giornate di Sodoma” di Pasolini. Non entro nel merito dell'anarchia del potere, del fascismo, del film “disturbante”, ma mi ha colpito la domanda di un personaggio: a cosa può portare un desiderio frustrato? Se un desiderio frustrato può portare alla deriva psicologica, a cosa può portare una sessualità totalmente repressa o nascosta? Non dimentichiamoci che gli omosessuali nei secoli, almeno qui in Italia, sono stati, per così dire, “castrati”, costretti a non vivere la loro sessualità e i loro sentimenti. Chi non è eterosessuale deve far valere i suoi diritti. È chiaro però che ognuno dovrebbe vivere la propria sessualità come meglio crede e il resto del mondo non dovrebbe etichettare, spettegolare, calunniare, diffamare e giudicare. Se tutti si guardassero bene dentro, decidessero come vivere la loro vita senza cercare di rovinarla agli altri (mi riferisco agli omofobi, ai transfobi) questo sarebbe un grande passo in avanti per la civiltà occidentale: la libertà di sspressione non è solo libertà di dire la propria opinione, ma di esprimere sé stessi secondo le proprie inclinazioni e i propri gusti. La sostanza di questo articolo qual è? Che essendo certi di poco o niente riguardo la sessualità non dovremmo giudicare ed essere giudicati, così di primo acchito, ma solo per comportamenti assolutamente gravi ed eticamente riprovevoli, che non riguardano assolutamente le scelte e l'orientamento sessuale. E qui il cerchio si chiude.
apr 222024

Ho dei momenti non dico di obnubilamento totale, ma di lieve rassegnazione, di sconforto leggero, pervaso dal nichilismo. Cammino per le strade, guardo la gente e penso. Mi dico che ognuno porta a giro sé stesso, che ognuno gira a vuoto, che ognuno parla a vuoto ma mai del suo vuoto, che ognuno è preda della noia, che ognuno non è alla fine sicuro di niente, anche se si convince di avere certezze. Come si dice in Toscana, l'unica certezza è la morte, se si escludono le verità della scienza e le ovvietà. Ma a livello esistenziale e metafisico non c'è nulla di certo… parlo di certezze assolute. E le persone fanno gruppo per passare il tempo, ammazzare la noia e talvolta si amano, talvolta si detestano. Annotava Pavese nel suo diario che le persone si incontrano, fanno l'amore, si amano e che anche lui avrebbe voluto fare come loro. Forse l'unica via di uscita, l'unica ancora di salvezza è proprio l'amore, anche una parvenza o l'illusione dell'amore. Leggevo qualche giorno fa che degli studenti avevano chiesto a un grande antropologo qual era il primo segno di civiltà della specie umana. Tutti pensavano all'opponibilità del pollice, alla stele, alla ruota, alla scoperta del fuoco, allo sviluppo della corteccia frontale, al culto dei morti, alla fabbricazione dei primi utensili. No. Lui rispose che il primo segno di civiltà era un femore rotto e poi guarito. Quindi essere curati e curarsi delle persone: questa è l'essenza della civiltà umana. E però io non amo, né sono amato da una donna. La mia vita sociale è prossima allo zero. E io sono out, fuori dal giro. Sono solo, ma mi perdo qualcosa o qualcuna veramente? Sarà questo il senso di sfinimento di cui parla Franco Arminio? Eppure lui ha successo, case, moglie, figli, fan. Oppure è solo una posa la sua? Mi dico che qui e ora l'importante è fare soldi, apparire, scopare: il soggetto cartesiano è stato spodestato e ora dal cogito ergo sum siamo passati al coito ergo sum. E io, sia ben inteso, non faccio soldi, non appaio, non scopo. Non ho nemmeno un ruolo definito. Vogliamo tutti possedere, consideriamo tutto e tutti come merce, guardiamo alla praticità e all'utilità di ogni cosa, di ogni persona e finiamo per essere impossessati dal vuoto, dalla noia, dal non senso. Come ben nota Andrea Inglese su Nazione Indiana per Freud pulsione di morte e coazione a ripetere sono strettamente connessi. Tutti fanno, sono sempre in azione, senza capire che questa società è intrisa dal cupio dissolvi. C'era il mio professore di storia della filosofia, Accame, che scriveva in un suo libro, già negli anni ‘90, che tutti avevano sempre da fare, che anche chi non aveva niente da fare sembrava indaffarato. Non è forse questo il modo migliore per riempire il vuoto esistenziale e non pensare? Mi chiedo io: ma dove correte? Per arrivare dove? Dove correte, se vi aspetta la morte? Eppure l'etologo e scrittore Giorgio Celli, che aveva fatto anche parte del gruppo '63, ci aveva già avvertito: "Il cervello ha tradito la specie umana". L'ingegno e la scienza sono al servizio di governi che fanno guerre sanguinarie. Al progresso scientifico non è seguito lo sviluppo storico ed etico. Gli scienziati hanno recentemente stabilito che non siamo nell'Antropocene, ma siamo ancora nell'Olocene. Ma, al di là di ciò, in questa prossima, possibile apocalisse non c'è forse la mano dell'uomo, non ha forse una causa antropica questo disastro? Lo so. Questo è un ottimo sito letterario e io dovrei trattare seriamente di letteratura e poesia. Ho sempre cercato di farlo. Però questa volta voglio essere sincero e parlare di me, anche se talvolta parlando d'altro si finisce per parlare di sé stessi e viceversa, in una incomprensibile eterogenesi dei fini. A volte mi chiedo: i libri che leggo mi servono davvero per vivere meglio? I libri che ho letto e che leggo mi riguardano veramente oppure sono solo un accumulo di nozioni, utili soltanto a fare i cruciverba della Settimana enigmistica, che poi non compro neanche più? Leopardi scriveva che la poesia vera accresce la vitalità. Ma davvero le poesie lette e quelle che ho scritto hanno accresciuto la mia vitalità? Sartre scriveva che ogni uomo è sempre circondato da sé stesso. È questo il problema? Oppure ognuno vive con i suoi sofismi, i suoi piccoli rancori quotidiani, “scordando che tutti avremo due metri di terreno”, come cantava tempo fa Guccini? Mi dico che la miglior cosa è vivere in superficie, abolire la profondità, lo spirito, il pensiero. Ma questo basta? L'importante è avere una scopamica. Questo è l'obbligo sociale per un uomo rispettabile, per un maschio che si rispetti. A volte mi chiedo cosa sono disposto a fare per rompere la mia solitudine e non trovo una risposta. Mi chiedo che senso ha leggere e scrivere. Mi chiedo che senso abbia tutto questo e se sono io che non so dare un senso. Ma forse sono solo i problemi pseudoesistenziali di un cinquantenne che ha tempo da perdere. Intendiamoci: non sono questi i drammi. La cosa migliore però è non pensare. Alcuni mi potrebbero rispondere: “ma cosa vuoi? La vita è questa. È sempre fatta dalle solite cose. Quando si arriva a una certa età si mette famiglia oppure si sopporta la solitudine”. Oppure mi potrebbero dire: “pensa a chi muore sul lavoro e alle tragedie dei familiari “. E avrebbero ragione. Ogni giorno ha il suo segreto e naturalmente mi sfugge. Ma forse il senso delle cose è più vicino e tangibile di quel che penso.
mar 262024
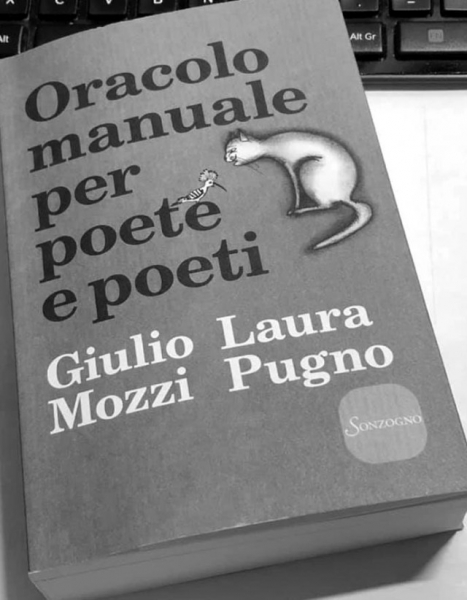
Conoscendo almeno virtualmente la comunità poetica da anni, mi viene naturale talvolta analizzare le dinamiche psicologiche di essa, spesso soggiacenti. La prima cosa che mi salta subito all'occhio non è il cosiddetto amichettismo (termine coniato dallo scrittore Fulvio Abbate), ma la ricerca spasmodica ossessiva di consenso critico e legittimazione culturale. L'amichettismo, se esiste, è strumentale, è finalizzato a ottenere la gloria. Che vengano ottenuti o meno dei risultati, i poeti (veri, aspiranti, sedicenti) ricercano un maestro e/o dei sodalizi artistici. Intendiamoci bene: c'è chi si atteggia a maestro senza esserlo e c'è chi si finge sodale senza esserlo! Tutto ciò ha sempre dei secondi fini, sono frequentazioni “interessate”: un do ut des, perché nessuno fa niente per niente. Poi per dirla alla Montale “ognuno riconosce i suoi”: questo l'hanno già detto e scritto tanti a riguardo. C'è chi parla di cricche, chi addirittura di clan, di gruppi di potere. A volte penso che per comprendere adeguatamente i poeti e la comunità poetica sia necessario ricorrere ai principi basilari della psicologia dinamica, sociale e addirittura clinica, perché c'è una quota parte ineludibile di psicopatologia. A questo proposito apro una parentesi sulla scrittura del trauma sempre più diffusa. Va bene l'arteterapia, ma i traumi si superano sotto la guida di esperti della psiche e con gli psicofarmaci. Alcuni si affidano unicamente alla scrittura e talvolta fanno naufragio. Poi se tutto è trauma, niente è trauma e sappiamo dalla psicologia quali sono veramente i traumi. Inoltre sappiamo che l'incidenza nella popolazione del disturbo post-traumatico da stress è del 7,5%. Che moltissime persone, facenti parte di questa piccola percentuale, scrivano poesia oppure è anche una moda, addirittura una posa quella del trauma, pur essendoci grandi poeti e grandi poetesse, che ne hanno fatto il loro tema principale? Insomma tutta la poesia è dolore e trauma? Non ci si può esentare da ciò? Chiusa parentesi. A ogni modo chi ha vero potere editoriale è amato/invidiato/odiato senza mezze misure. Ma poi è vero potere quello poetico? O è solo un contentino, un palliativo, una valvola di sfogo, una piccola concessione che il vero potere dà ad alcuni individui? C’è chi è dentro e chi è fuori. Chi è dentro guarda con aria di superiorità e con paternalismo chi è fuori. Chi è out a volta sfoga la rabbia in velenosi post su blog, siti, riviste online. C’è chi aspira, più o meno legittimamente, e non trovando riconoscimento diventa frustrato/depresso e talvolta ciò si tramuta in smania di grandezza, in un ingigantimento smisurato dell'ego, dovuto a una ferita narcisistica non rimarginabile. Ma non esiste comunque una linea di demarcazione netta, un limite invalicabile tra chi è in e chi è out: sono dei vasi comunicanti, ci sono delle cooptazioni, delle inclusioni, tenendo ben presente le dinamiche di gruppo (dell'ingroup e dell'outgroup in questi casi). Diciamo che il potere poetico e il contropotere si studiano vicendevolmente. Io, essendo ormai un misero recensore, sto tra l'incudine e il martello, possibile vittima dei due fuochi. Ma tra gruppi poetici di solito nessuno pesta i piedi a nessuno, le critiche alle altre scuole di pensiero sono sempre circostanziate ma vaghe, generiche: di solito nessuno fa nomi e cognomi, gli attacchi ad personam vengono evitati per quieto vivere. Scusate la citazione scontata, abusata, ma “la poesia non cerca seguaci, cerca amanti”, come scriveva Lorca. Solo che talvolta certe logiche di potere fanno passare la voglia di amare la poesia e i poeti. Ad esempio ogni volta che viene fatta un'antologia di poesia pregevole alcuni esclusi fanno delle critiche al vetriolo. Ma come sottolinea il poeta Andrea Temporelli le logiche di potere sono le stesse identiche per tutti: gli esclusi si comporterebbero allo stesso modo, se avessero potere. I contestatori non sognano altro di essere riconosciuti. Non chiedono altro! E intanto stringono alleanze per arrivare al cosiddetto potere, aspettando che muoiano tutti i grandi vecchi. Se un difetto, un limite intrinseco si può trovare ai grandi critici e ai grandi poeti, è quello di passare spesso dalla selettività giusta e sacrosanta all'essere snob ed esclusivi fuori di maniera. E questo snobismo viene ricambiato dagli appassionati di poesia, dagli aspiranti poeti, che non comprano i loro libri, non vanno alle loro presentazioni e conferenze, etc etc. Insomma snobbami che ti risnobbo! Finisce così che i grandi poeti hanno poco seguito e predicano quasi nel deserto, mentre i poeti non riconosciuti cercano consenso nella loro bolla social. Tutto questo è asfittico, claustrofobico e ognuno se le dice e se le canta da solo. Per pura consolazione allora c'è chi ripete “meglio pochi ma buoni” oppure “la poesia non può che essere di nicchia”. In un gioco di snobismi reciproci, di piccoli favori, di attese vane, di idiosincrasie, di dispetti e ripicche, di invidie vivacchia la poesia italiana, in attesa della catastrofe o di una rinascita.
feb 242024

Carpe diem? Tutti dicono di cogliere l'attimo. Vige il carpe diem, insomma, in questa società. Ma quale attimo va colto? Va scelto con cura o ponderatezza l'attimo oppure bisogna cogliere qualsiasi attimo? E bisognerebbe stare tutta la vita a cogliere l'attimo oppure ogni tanto si può riposarci, mettersi in disparte ad osservare gli altri che colgono gli attimi? Ognuno colga il suo attimo perché ognuno ha le sue opportunità, ma cogliere l'attimo da antico e saggio consiglio di vita è diventato oggi un fattore imprescindibile di ogni esistenza. Che poi l'attimo è fuggente e bisognerebbe prendere l'eternità di quell'attimo! Le neuroscienze ad esempio ci insegnano che non viviamo mai pienamente il presente, che al massimo viviamo in un passato molto prossimo. Essere meditativi non paga. Bisogna essere attivi e vitali, a costo di perdersi in un vortice di vitalismo disperato, che sfugge a ogni logica. Gli artisti o aspiranti tali però devono anche cogliere il ricordo, l'immagine, il pensiero, il senso dell'attimo vissuto. L'arte consiste nell'eternare, nell'immortalare gli istanti vissuti, che poi è un modo di cogliere e vivere nuovamente l'attimo. Ma vivere pienamente e scrivere dignitosamente sono per alcuni due cose inconciliabili. Vivere e scrivere sembrano agli antipodi. Carpe diem? C'è chi dice che prima bisogna vivere, quindi scrivere. Secondo questa scuola di pensiero bisognerebbe scrivere ciò che si vive. Ma ci sono molti artisti schivi e riservati che fuggono dalla vita quotidiana (perché la quotidianità è alienata, è inautentica, è non vita), si rifugiano in un angolo tutto loro, si mettono al riparo dalle offese e dagli orrori del mondo per concentrarsi meglio, per meditare a lungo proprio sull'esistenza. Questi artisti scrivono per provare l'epifania, ovvero l'illuminazione interiore. Scrivono per vivere e per loro l'essenza della vita è la scrittura: scrivere quindi è la fonte sorgiva della gioia. Carpe diem? Eliot scriveva che si impara sia per esperienza pratica che per conoscenza teorica. Gli artisti corrono il rischio di eternare più la vita immaginata che quella reale, ma poi qual è la vera vita? Perché l'attimo immaginato non va bene? Perché non va bene cogliere anche quello? E poi perché cercare un confine tra sogno e realtà? Sono comunque istanti immortalati, selezionati dagli artisti, dal caso o da Dio? Questo non lo sapremo mai. Cammino sui lungarni e poi sotto i loggiati di Pisa. Prendo dei vicoli, assorto nei pensieri. Vago senza meta. Pioviggina e non ho l'ombrello. Poi viene fuori il sole. Cosa significa ora cogliere l'attimo per me in questo momento? Cercare di approcciare una passante o una barista, nel 99,9% dei casi prendendomi un due di picche? Bermi una birra a un bar? Telefonare a un amico? Continuare a cercare una bancarella di libri usati? Continuare a camminare fino a Piazza dei miracoli? Continuare a vagare e poi ritornare alla stazione senza assentarmi da me stesso? Cogliere l'attimo vuole solo significare divertirsi come fanno tutti? Comunque molti artisti si ritirano nella loro stanza oppure guardano per ore dalla finestra o si mettono a osservare la vita circostante a un tavolino di un bar in attesa non di cogliere l'attimo ma che l'attimo li colga. Montale aveva delle muse e delle agnizioni. Certe donne erano viste come “divinità terrestri” che lo ispiravano; solo loro erano capaci di cogliere l'attimo ma anche di farlo sognare, pensare, meditare, scrivere: “Ti guardiamo noi della razza di chi rimane a terra”. Carpe diem? Pensiamo all’atteggiamento mentale di chi fa meditazione o si mette a riflettere sul letto nel silenzio e nella penombra. Si dice che queste persone rimangono in ascolto del mondo e di sé stessi. Carpe diem? È un atteggiamento apparentemente passivo. È l'ozio in attesa di diventare fertile, produttivo. È l'attesa dell'ispirazione o che quantomeno affiori un'idea. Per gli antichi l'ozio anche etimologicamente veniva prima del negotium, ovvero del lavoro. Oggi l'ozio è condannato da tutti, è considerato totalmente improduttivo. L'unico tempo libero non condannabile è quello dei pensionati, come premio di una vita di lavoro. Il disoccupato è visto principalmente come uno che non ha voglia di lavorare o che è incapace di lavorare. I frutti dell'ozio postmoderno possono essere anche pregevoli artisticamente o culturalmente, ma sono visti come semplice espressione di dilettantismo e di hobby, se non diventano business. Eppure i grandi creativi hanno avuto lunghi periodi di ozio infecondo spesso prima di creare o scoprire cose memorabili. La psicologia del pensiero ci insegna che in ogni fase creativa è necessario un periodo d'incubazione, preceduto dalla preparazione e seguito dall'intuizione felice. Spesso per riuscire ad avere un'idea originale, uno spunto interessante bisogna stare per giorni a non fare apparentemente niente, mentre in realtà i pensieri vengono rimuginati, si rielaborano inconsciamente i contenuti, si approccia un problema a 360 gradi, magari anche infruttuosamente. Sono pensieri sottotraccia che si affollano, fino a quando uno emerge, fa chiarezza, ristruttura cognitivamente il compito da risolvere. Per l'ozio ci vuole un silenzio preparatorio e una stanza tutta per sé. Pascal non aveva torto quando scriveva che molti mali dell'umanità derivano dall'incapacità degli uomini di starsene chiusi da soli nella loro stanza. Per stare bene con gli altri e per non creare danni agli altri bisogna stare prima di tutto bene con sé stessi. Carpe diem? E poi l'attimo non si può cogliere anche da soli con sé stessi? Perché bisogna per forza cogliere l'attimo con gli altri, magari perdendosi nella frenesia e nella superficialità della vita sociale? Perché bisogna per forza essere socievoli e mondani per cogliere l'attimo? Perché poi cogliere l'attimo deve essere un obbligo sociale e perché le occasioni bisogna cogliere sempre insieme agli altri? Carpe diem? Bisogna amare occasionalmente, divertirsi in modo sfrenato e va bene anche sballarsi, fino ad autodistruggersi. Ho chiesto una volta molti anni fa a un amico dopo una storia d'amore finita male con una donna: preferisci che lei ti abbia lasciato, scomparendo per sempre, dopo averla amata anche carnalmente, oppure preferivi che lei fosse una tua amica per tutta la vita senza mai andarci a letto? La risposta è stata che era meglio la prima cosa, perché per come siamo fatti noi uomini occidentali e per come è fatta la società bisogna agire, amare, concludere, finalizzare, avere un'altra conquista nel carnet degli amori. In definitiva l'importante è aver vissuto, anche se a larghi tratti in certe persone gli automatismi psicologici e il volere altrui sembrano fare da padrone. Invece bisognerebbe fare, pensare, volere ciò che più ci aggrada. A volte sembra che la vita vada da sé autonomamente, indipendentemente dalla nostra volontà. Carpe diem? Sembra che in questa continua ricerca della felicità più effimera e banale possibile dell'uomo occidentale la cosa peggiore è non aver vissuto pienamente, non aver colto la palla al balzo, aver sprecato tempo, avere dei rimpianti. Secondo la nostra mentalità comune è meglio sbagliare molto e vivere nel disordine, nel caos invece di isolarsi a riflettere, a diventare esseri più spirituali. L'estroflessione sociale è un dovere. Ho la vaga impressione che vivere troppo intensamente a lungo possa portare a un senso di vuoto, di smarrimento, di esaurimento, di noia. Una vita troppo mondana può arricchire ma anche logorare e abbruttire. La leggerezza può tramutarsi in pesantezza insostenibile. Poi ci si guarda indietro, si fa un bilancio esistenziale e la coscienza rimorde, perché sono troppi gli errori commessi, troppe le cose e le persone importanti lasciate e perdute per sempre, irrimediabilmente. Carpe diem? E poi a tutta questa retorica del carpe diem è sottesa implicitamente la concezione che il tempo è denaro e che non bisogna mai perdere tempo, ovvero il fatto che bisogna consumare tutto e tutti, anche la propria vita, anche sé stessi, fino all'ultima fibra. Carpe diem?
gen 032024
Alcuni sostengono che scrivere aforismi sia semplice, addirittura facile. In realtà è un'arte. Si potrebbe discutere se sia un'arte minore o meno. Se i proverbi sono saggezza popolare, gli aforismi racchiudono la cultura e la saggezza degli autori. Ci sono autori che devono esclusivamente la loro fama agli aforismi, come ad esempio Morandotti. Ma il punto debole degli aforismi non è che chiunque può crearli, ma che esprimono spesso una certa soggettività e che la verità è un poligono con tanti lati quanti sono gli uomini, come scriveva Gioberti. Forse l'inganno degli aforismi è che promettono leggi generali, insomma oggettività e tutto ciò viene deluso, disatteso talvolta.
Indro Montanelli creava degli aforismi. Poi nelle conversazioni li citava e li attribuiva a grandi scrittori. Nessuno contestava o aveva da ridire. Ma si potrebbe fare anche il contrario: prendere degli aforismi di pensatori famosi e poi dire che sono nostri. Non tutti si accorgerebbero della truffa. Questo significa che l'aforisma è una massima, una sentenza, un pensiero, una battuta: insomma un'opinione spesso e dipende perciò non dalla logica ma dall'autorevolezza di chi ha creato la frase. L'aforisma non è un sillogismo. Con buona pace di Karl Kraus che vedeva in esso "una mezza verità" oppure "una verità e mezzo". Era solo una battuta. Una provocazione. Sempre a tal proposito si deve ricordare che si possono trovare aforismi che affermano una cosa e altri l'esatto contrario. Celebre è l'aforisma di Longanesi a tal proposito: "Eppure, è sempre vero anche il contrario". Ad esempio Pittigrilli nel "Dizionario antiballistico" invertiva gli aforismi. Umberto Eco a riguardo ha definito questo genere di aforismi cancrizzabili, cioè reversibili. Altre volte l'aforisma si rivela una generalizzazione indebita, per cui oltre ad una piccola verità contiene una piccola bugia. L'oggettività lasciamola a quelle che un tempo venivano chiamate scienze esatte. Alcuni potrebbero definire l'aforisma un'osservazione acuta. Ma anche in questo caso potremmo ricordare Popper, secondo cui prima di ogni osservazione ci sono sempre delle aspettative inconsce (e soggettive). Non parliamo poi delle frasi motivazionali, che spesso sono delle ipersemplificazioni di quella branca della psicologia spicciola, che è chiamata crescita personale. Nessuno è depositario di verità: neanche di mezze verità. E la verità umana è sempre provvisoria. Ecco il punto debole degli aforismi, che è anche quello di tutta la cultura umanistica.
dic 222023

Ho guardato le varie definizioni di posizionamento nei più importanti vocabolari. Ebbene nessun vocabolario menzionava il significato di posizionamento in letteratura. Con questo termine si intende l'orientamento di uno/a studioso/a, insomma di un/a letterato/a in base all'ismo, ai maestri che ha avuto, alla scuola a cui appartiene, alla linea di ricerca, alla prospettiva di carriera, etc etc. Quindi è una sorta di orientamento culturale/letterario, secondo cui un/a studioso/a sceglie di studiare un genere, degli autori, un filone invece che altri. Dal conflitto delle interpretazioni scaturiscono i vari posizionamenti, che a loro volta generano ulteriori conflitti delle interpretazioni in una sorta di circolo vizioso o virtuoso illimitato. Tutto ciò è lecito, legittimo, anzi fisiologico, naturale, perché appartiene ontologicamente alla letteratura, che grazie a Dio risente di una certa opinabilità e di una certa discrezionalità per ogni giudizio critico. L'mportante è che il posizionamento e il conflitto delle interpretazioni, che si richiamano a vicenda e che sono strettamente connessi, non vengano strumentalizzati per favori, vendette, simpatie, idiosincrasie o per fini commerciali. In ogni giudizio critico sarebbe richiesto il massimo dell'obiettività e dell'imparzialità, per quel che è umanamente possibile. Insomma un critico si dovrebbe astrarre dalle meschinerie e dalle piccinerie, dovrebbe volare alto e dimostrare onestà intellettuale. Ma probabilmente queste erano probabilmente problematiche di un tempo, perché oggi i critici letterari hanno sempre meno importanza, meno potere nella formazione del gusto dei lettori e sono proprio questi ultimi a decidere il canone. Quindi oggi la questione del nesso tra posizionamento e conflitto delle interpretazioni è secondaria, mentre la questione principale è quanto la scarsità di competenza e di buon gusto dominino il mercato editoriale e di conseguenza il successo. Così oggi il problema dei problemi non è il conflitto delle interpretazioni ma la sociologia, la fenomenologia del gusto letterario dei lettori.
ott 192023
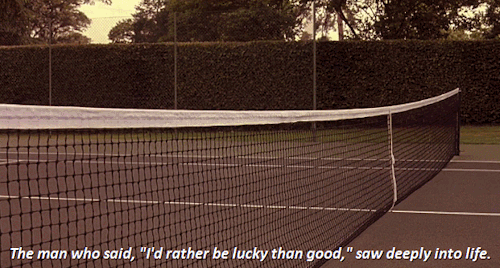
Victor Hugo parla di successo nel 1862 ne “I Miserabili”, volume I, cap. XII:
“Riuscire: ecco l’insegnamento che cade, a goccia a goccia, a strapiombo dalla corruzione. Sia detto di sfuggita, il successo è una cosa abbastanza odiosa. La sua falsa somiglianza con il merito inganna gli uomini. Per la folla, la riuscita ha quasi lo stesso profilo della supremazia. Il successo, questo sosia del talento, ha un solo zimbello: la storia. Ai nostri giorni una filosofia quasi ufficiale è entrata in dimestichezza con il successo. Riuscite: è teoria. Prosperità presuppone capacità. Vincete alla lotteria: siete un uomo abile. Chi trionfa è venerato. Nascete con la camicia: tutto vi sarà dato. Abbiate fortuna, avrete il resto; siate felice, vi crederanno grande. L'ammirazione contemporanea non è che miopia”.
Per gli indiani esiste il karma: se sei povero e malato, è semplicemente perché ti sei comportato male nelle vite precedenti. Per i calvinisti se hai denaro e successo, è perché sei in grazia di Dio, perché sei un eletto. Gli antichi greci credevano fermamente nel Fato, che sovrastava il volere e le capacità degli uomini.
Si pensi al valorosissimo Aiace che difese il cadavere di Achille, ma Ulisse con la sua furbizia riuscì ad avere le armi del defunto; Aiace impazzì e massacrò un gregge di pecore, credendole soldati nemici, e poi si suicidò per la vergogna. Roberto Vecchioni negli anni Settanta scrisse appunto un'ironica canzone su Aiace, di cui riporto il testo:
"E non sembravi più nemmeno quello
che dalle porte esce guardando il cielo
gridava a Dio con tutta la sua voce
"Sterminaci se vuoi, ma nella luce..."
E il mare grande quando vien la sera
e Dio è lontano per la tua preghiera
qui c'è chi parla troppo e c'è chi tace
tu sei di questi, e al popolo non piace
Chi ha vinto è là che che vomita il suo vino
e quel che conta in fondo è l'intestino
la la la la la la Aiace la la la la la la
la la la la la la Aiace la la la la la la
la la la la la la Aiace la la la la la la
la la la la la la Aiace la la la la la la
E il coro degli Achei che si diletta
hai perso e questo è il meno che ti aspetta
ti stanno canzonando mica male
vai un po' a spiegare quando un uomo vale
Dovevi vincer tu, lo sanno tutti
tu andavi per nemici e lui per gatti
ma il popolo è una pecora che bela
gli fai passar per fragola una mela
Chi ha vinto è là che che vomita il suo vino
e quel che conta in fondo è l'intestino
la la la la la la Aiace la la la la la la
la la la la la la Aiace la la la la la la
la la la la la la Aiace la la la la la la
la la la la la la Aiace la la la la la la
E tu fai fuori mezzo accampamento
ne volano di teste cento e cento
salvo far l'inventario e veder poi
che non sono i tuoi giudici, son buoi
Allora per un mondo che è un porcile
ti val bene la pena di morire
dimmi cosa si prova in quel momento
con la spada sul cuore ed intorno il vento
Fa grande sulla tenda le ombre il fuoco
ma dai, che è stato solamente un gioco
la la la la la la Aiace la la la la la la
la la la la la la Aiace la la la la la la
la la la la la la Aiace la la la la la la
la la la la la la Aiace la la la la la la"
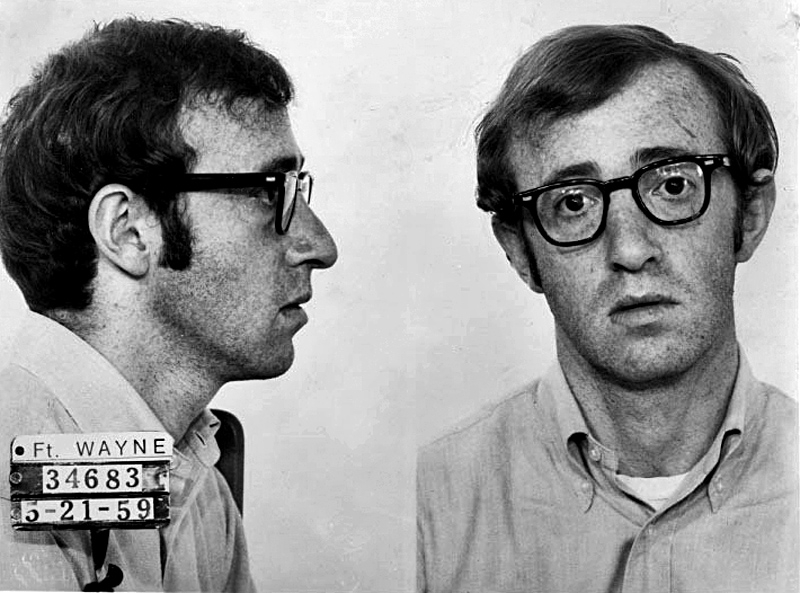
Si apre con questa riflessione il film del 2005 Match Point di Woody Allen: “Chi disse ‘Preferisco avere fortuna che talento’ percepì l’essenza della vita. La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna nella vita. Terrorizza pensare che sia così fuori controllo. A volte in una partita la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po’ di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no, e allora si perde.“
E ancora si pensi che avere talento è una dote innata, quindi una fortuna, anche se il talento va saputo coltivare. Ma bisogna che qualcuno valorizzi e riconosca il talento e qui rientra in gioco la fortuna!
Per Machiavelli il principe deve avere virtù e fortuna. Per alcuni cattolici secoli fa la peste era una punizione divina, un flagello di Dio! Ma quanto è importante la fortuna nella vita degli uomini? Alcuni credono così tanto nel libero arbitrio, nel merito, nel sacrificio, nell'impegno da sottovalutare il ruolo determinante della fortuna. Costoro non pensano a quanto siamo fortunati quando abbiamo salute. Non pensano che basta una cellula del corpo impazzita a scatenare un tumore. E non dipende da noi. Oh certo dipende anche dallo stile di vita!?! Ma ci sono persone che hanno un cattivo stile di vita e non si ammalano, mentre altre hanno un buon stile di vita e si ammalano! Non pensano costoro -chiamiamoli pure coloro che si credono padroni della loro sorte e artefici del loro destino- a quanto siano casuali gli incontri e gli avvenimenti di ogni vita. Non pensano che siamo insignificanti gocce nel mare. No. Non esistono i self made man. Oh certo bisogna saper sfruttare le occasioni! Non bisogna perdere i treni giusti!
Oh lo so?!! Le persone che si sentono arrivate non fanno che citare la frase di Seneca: "La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l’occasione”. Ma quante cose sono andate bene e che non dipendevano da lei nel destino di una persona di successo? Ai fattori esterni e la casualità queste persone così sicure di sé non si soffermano mai a pensare. In fondo nascere in un paese ricco invece di uno povero, nascere da genitori benestanti e che ti amano invece che da genitori poveri e che ti maltrattano, nascere sani invece che malati, nascere intelligenti invece che stupidi, incontrare le persone giuste nei primi anni di vita invece che le persone sbagliate, essere ricambiati dalla persona di cui si è innamorati o meno non sono tutte cose che rientrano nella fortuna? Purtroppo ci si accorge del ruolo determinante della fortuna solo quando ci manca. Ma questo non significa che esistano anche il merito, il sacrificio, l'impegno. C'è chi crede che tutto dipenda dalla fortuna o dal merito. I pareri sono spesso così polarizzati. No. Non esiste una dicotomia, un aut aut impietoso: non è questione di merito o fortuna, ma di merito e fortuna quando uno riesce. Le due cose non sono mutuamente esclusive. Spesso dipende da entrambe le cose, ma nessun uomo può valutare la vita propria o altrui obiettivamente: lo può fare solo Dio, se esiste. Spesso quando uno riesce nella vita è perché ha fatto tutto bene ma anche perché gli è andato tutto bene. È difficilissimo valutare quanto in ogni vita pesino il merito e la fortuna. Ci sono gli arrivati presuntuosi che pensano che tutto sia merito loro, ma ci sono anche invidiosi e maligni che pensano che un uomo abbia avuto successo solo perché fortunato. Per la psicologia chi ha un locus of control interno, cioè chi pensa che la vita dipenda dalla sua volontà più che da fattori esterni, ha una maggiore autoefficacia e raggiunge più frequentemente gli obiettivi prefissati. Ma la psicologia ha anche scoperto l'errore fondamentale di attribuzione, cioè la tendenza sistematica delle persone di attribuire la causa di un'azione all'individuo invece che a fattori esterni, anche quando oggettivamente non è così. Ci sono molte ricerche che lo confermano e sembra che l'errore fondamentale di attribuzione sia più frequente nelle culture individualistiche, come in quelle occidentali ad esempio. Ancora una volta abbiamo casualità versus causalità! Però dobbiamo smetterla di pensare che sia esclusivamente colpa sua se a qualcuno le cose nella vita vanno male! Insomma i fattori in gioco, sia interni che esterni, nella vita sono tanti. Ecco perché Darwin non era un darwinista socioeconomico a differenza di Galton e altri.
ott 042023

Torno di nuovo su “Il maestro di Vigevano” di Mastronardi, a cui ho accennato più volte nei miei scritti, ma che non ho mai trattato pienamente. Innanzitutto questo romanzo è potente perché tocca le corde del cuore, entra nel profondo dell’animo. È una disamina accurata, oserei dire uno studio chirurgico delle convenzioni, delle regole, della mentalità piccolo-borghese, che il protagonista, per l’appunto un maestro di provincia, chiama “catrame”. La questione principale è che per togliere il catrame si finisce per togliere la pelle, dato che la mentalità piccolo-borghese è l’essenza stessa di certe persone, che si identificavano e che ancora oggi si identificano in essa, al punto che il discostarsi un minimo da essa è considerata una minaccia alla loro identità psicosociale.
Viene da chiedersi se il protagonista del libro sia un alter ego di Mastronardi, anche lui maestro, che fu un tipo alquanto singolare, un caratteriale e venne addirittura condannato perché aveva offeso un ferroviere su un treno, dandogli del “terrone”. La trama del romanzo è nota a molti perché è stata fatta una trasposizione cinematografica dal regista Elio Petri, mentre Alberto Sordi impersonava il maestro Mombelli. Comunque in poche righe, il maestro ha una moglie e un bambino piccolo. Vive a Vigevano, dove c’è il boom economico e molti si arricchiscono a fare scarpe. La moglie quando i due vanno in paese elenca al marito tutti quelli che, partendo dal niente, si sono arricchiti.
Il meccanismo psicologico è quello della deprivazione relativa: moglie e marito pensano che gli altri abbiano ingiustamente un benessere che loro non hanno e ritengono che questi arricchiti non abbiano nessuna qualità interiore o intellettiva superiore a loro. Il grande scrittore fa la distinzione tra “chi sa” e “chi guadagna” e non sempre le due cose corrispondono, soprattutto se si ha una formazione culturale umanistica. Alla fine la moglie lo convince a mettersi in proprio. Così i due osano, come se mettersi in proprio fosse solo questione di avere una certa propensione al rischio. Lui si licenzia e coi soldi della buonuscita apre un’attività. Ma parla troppo a una cena con gli ex colleghi. Viene registrato, mentre parla delle irregolarità che commette in azienda.
Insomma ha spifferato tutto in piazza. I tre soci vengono convocati dall’avvocato e l’ex maestro deve andare a Canossa e cospargersi il capo di cenere. Insomma è tutta colpa sua. Lui che faceva l’impiegato nella sua ditta ora è costretto a ritornare di nuovo a scuola. Sua moglie muore e mentre sta morendo confessa di averlo sempre tradito, che quello che considerava suo figlio è di un altro. Il figlio inoltre viene sorpreso a commettere atti osceni in luogo pubblico con un pederasta e viene anche denunciato per aver percosso un anziano. Tutto va a rotoli. Il decoro di quest’uomo viene distrutto, annientato, annichilito. La genialità di Mastronardi si vede non solo per come mette in scena la borghesia di quegli anni (il libro uscì nel 1962, ma è ancora attuale), ma anche per come vengono descritte le passeggiate del maestro, le sue sensazioni, la descrizione del fiume Ticino.
Però questo romanzo non è solo il resoconto di un tracollo morale ed economico, è anche la rappresentazione di un uomo, un piccolo intellettuale di provincia, che è troppo lucido e disincantato; forse il suo dramma è tale non solo per la sua sconfitta sociale ma anche per la presenza di una coscienza sempre attenta e vigile. La fine del romanzo è probabilmente un nuovo inizio, più che l’inizio della fine, poiché il maestro è pronto a risposarsi e a ricadere, a ripiombare di nuovo nel mondo piccolo-borghese. Insomma non c’è via di uscita, dato che chi è borghese, a meno che non venga arrestato, resta borghese per tutta la vita. Quel mondo chiuso e angusto, diremmo oggi in modo più moderno, è troppo rassicurante, è una comfort zone, una sicurezza, a cui pochi vogliono rinunciare. Un libro da leggere assolutamente. Un capolavoro, senza se e senza ma.
ott 022023
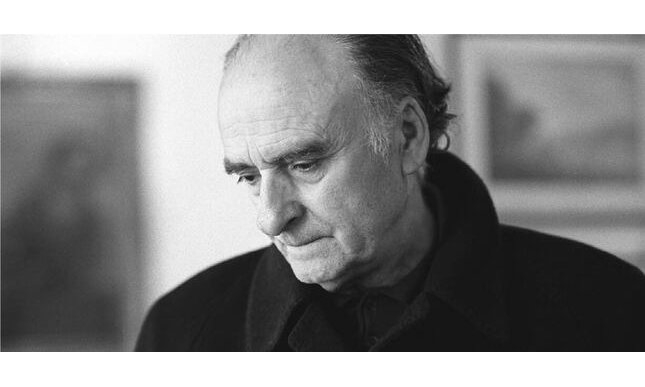
Innanzitutto non sappiamo neanche chi ha creato l’espressione Nord-Est: forse il giornalista Meccoli, forse lo scrittore Carlo Sgorlon. Insomma la paternità del termine è incerta! A livello letterario il Nord-Est è i Colli Euganei in cui vive i suoi ultimi anni Petrarca; è Goldoni; è "Le confessioni di un italiano" di Nievo, "Le ultime lettere di Jacopo Ortis" del Foscolo, la Trieste di Svevo, Joyce, Saba, i libri di Meneghello, Rigoni Stern, Parise, Berto, Commisso, Buzzati, David Maria Turoldo, Mauro Corona, Tiziano Scarpa, etc etc. Comunque il Nord-Est veniva definito anni fa come la locomotiva d’Italia, come il Giappone d’Italia. Alcuni intellettuali snob lo vedevano come un’area di arricchiti, che si erano dannati per il benessere. Alcuni vedevano questa zona, una delle più ricche della penisola, come una massa di alcolizzati ignoranti, che davano l’anima per la loro "fabbrichetta". È vero che questa zona è passata da essere una roccaforte democristiana a essere un feudo leghista dopo Tangentopoli. È vero che parte della popolazione del Nord-Est odia Roma e il meridione, che vede come una massa di assistiti e mangiapane a tradimento da cui si vorrebbe separare (alcuni gridavano anni fa: "Roma ladrona! Secessione!"), e l’antipatia è ricambiata. In realtà però oltre a un reddito pro capite elevato ad esempio i veneti possono vantare alti punteggi nelle prove Invalsi, molto superiori a quelli della media nazionale, e una percentuale di laureati del 32%, più alta, tanto per dire, del 4% della civile e colta Toscana. Inoltre il Nord-Est si contraddistingue per una grande mobilità sociale: qui meglio che da altre parti l’ascensore sociale esiste e vi sono pochi disoccupati. In quest’area il dipendente può licenziarsi e poi diventare imprenditore. I Benetton e i Del Vecchio sono solo la punta dell’iceberg, perché dietro c’è una realtà industriale consolidata di distretti, di piccole imprese, di artigiani. A onor del vero negli ultimi anni un poco di crisi economica ha investito anche il Nord-Est: si pensi ad esempio anni fa a piccoli imprenditori che scoperchiavano i loro capannoni per non pagare l’Imu. Come si spiega comunque questo miracolo economico? Per molti il lavoro duro dà i suoi frutti a lungo termine. Alcuni scrittori e saggisti, come Giuseppe Genna, ritengono che la Lombardia e il Veneto siano stati influenzati dalla dominazione asburgica e parlano di calvinismo per questa zona. Si riferiscono al legame tra etica protestante e capitalismo studiato da Max Weber. In parole povere le persone cercherebbero a tutti i costi di arricchirsi per sentirsi dei predestinati, degli eletti. Insomma uno lavora, guadagna e per questo si ritiene un prescelto, pensa di essere in grazia di Dio. Non a caso l’economista Giorgio Roverato ha definito l’industriale Pietro Marzotto un "imprenditore calvinista", considerando anche il suo senso di responsabilità e di etica negli affari. Il calvinismo però è una dimensione soggiacente, un influsso segreto e antico, secondo questa scuola di pensiero, che condiziona la mentalità dei veneti ad esempio. Secondo quest’ottica potremmo affermare che in queste zone la popolazione è inconsciamente calvinista per certi tratti, mentre si professa cattolica praticante. Non vi tragga in inganno il romanzo "Va’ dove ti porta il cuore" di Susanna Tamaro, che tratta anche della facoltà di psicologia di Padova negli anni Settanta: una realtà particolare e a sé stante nel mondo veneto. Non vi traggano in inganno le memorie di chi ha studiato a Padova: la realtà studentesca goliardica è una goccia nel mare del pragmatismo e dell’efficientismo veneto. Non vi traggano in inganno le feste dei ricchi di Cortina, né il microcosmo letterario del premio Campiello, né i nobili veneziani che vivono di rendita: il Nord-Est è lavoro duro, ricerca di guadagno a tutti i costi, è gente che fa il doppio e anche il triplo lavoro per arricchirsi! Il miracolo del Nord-Est è dato in gran parte dalla fatica e allo stesso tempo dall’odore di miseria, che veneti e friulani hanno sentito per secoli: basta ricordare che in passato è stato un popolo di emigranti, diffusi in tutto il mondo; basta ricordare le venete che facevano le balie nel Sud o a quante famiglie d’origine veneta ci siano a Latina! Basta ricordare le vicissitudini dei poveri contadini narrate dal Ruzzante! Per lo psichiatra Vittorino Andreoli bisogna però stare attenti, perché il benessere produce anche emarginazione, che a sua volta causa follia. Questo circolo vizioso benessere-emarginazione-follia, teorizzato nel saggio "La violenza", spiega perché nel Nord-Est ci sono tanti giovani fin dagli anni Novanta che muoiono all’alba dal ritorno delle discoteche per incidente stradale, di solito dopo essersi ubriacati e drogati, e spiega anche perché da trent’anni ci sono auto-pirata, che uccidono passanti. Ma perché i figli di industriali, di agiati commercianti e liberi professionisti si drogano? Il Nord-Est si è arricchito molto rapidamente, i genitori sono troppo indaffarati e troppo occupati sul lavoro per pensare ai figli, il brusco passaggio da una società contadina a una realtà industriale ha lasciato alcuni giovani senza valori. Il Nord-Est negli anni Novanta, nonostante fosse una delle zone più ricche d’Italia, era anche caratterizzata da un alto tasso di suicidi tra giovani. Perché giovani che apparentemente avevano tutto finivano per autodistruggersi? Perché nonostante avessero agi, macchine costose, immense comitive, amori facili si suicidavano? A cosa era dovuto questo smarrimento, questo disagio esistenziale, questo senso di vuoto? Il grande poeta Andrea Zanzotto parlava di "progresso scorsoio", di come la corsa agli schei abbia determinato la distruzione del paesaggio e abbia fatto scomparire quella comunità di persone propria della civiltà contadina.

Eppure il Nord-Est è anche cultura, tradizione; questa zona è anche un luogo dell’anima, un’entità metafisica. Altri profondi conoscitori di quest’area a ogni modo pongono l’accento sulla mancanza di solidarietà e sull’impoverimento delle relazioni umane di questi ultimi decenni. Per lo scrittore Massimo Carlotto, che tramite il noir affronta le problematiche della sua regione con crudo realismo, dietro il benessere del Nord-Est si cela anche la criminalità organizzata. Lo scrittore Vitaliano Trevisan in "Works" tratta anche lui della cruda realtà del Nord-Est, ci racconta dei tanti mestieri fatti per tirare avanti, tra cui anche quello dello spacciatore. Trevisan racconta di come sia stato mandato da suo padre da adolescente a lavorare in fabbrica per lavorare e guadagnare. Ci narra ancora una volta dell’illegalità diffusa. Sempre Trevisan ci spiega quanto sia difficile scegliere di fare lo scrittore in Veneto, mentre tutti pensano a produrre. Ancora una volta gli scrittori odierni dissacrano il sogno del Nord-Est e mettono in evidenza che qualcosa è stato perduto in questo sviluppo così rapido. Da ricordare anche il film di Antonio Padovan "Finché c’è prosecco c’è speranza" che scandaglia certe magagne, certe dinamiche economiche e psicosociali del ricco Veneto. Ah gli schei! Croce e delizia! L’arricchimento smodato e il capitalismo selvaggio in fondo sono un male antico di quest’area: basta vedere il grande monologo civile sul disastro del Vajont di Marco Paolini per farsene una ragione!
set 202023
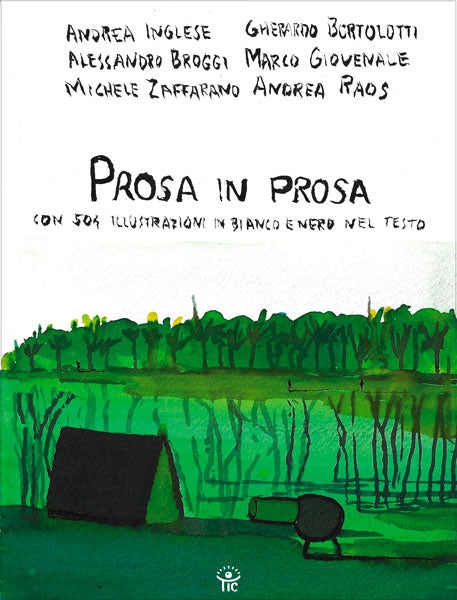
Per secoli e secoli i poeti seguivano gli stessi canoni estetici. Rispettavano le regole della metrica. Scrivevano endecasillabi canonici. Talvolta li alternavano con dei settenari. Da Lucini in poi ci fu la diffusione del verso libero. Oggi la stragrande maggioranza dei poeti scrive in versi liberi, va a capo quando vuole. Nel Novecento abbiamo visto molte rivoluzioni copernicane nell'ambito della lirica. Hanno creato nonsense, calligrammi, montaggi. È comparsa anche la poesia concreta (a sua volta suddivisibile in poesia visiva e poesia sonora). Poi nell'epoca del postmoderno hanno pensato anche a delle sperimentazioni multimediali come la poesia elettronica (videopoesia e computer poetry). Da un lato, qui in Toscana, sembrava esserci la riscoperta dell'oralità con l'organizzazione di serate di poesia estemporanea, dove i poeti improvvisavano in ottava rima. Si sono diffusi, in tutta la penisola, anche gli slam poetry, importati in Italia dal poeta Lello Voce. Dall'altro lato sembrava che il virtuale avesse preso il sopravvento sui media tradizionali. Negli ultimi tempi sembra che sia sempre più difficile incasellare la poesia in una definizione, visto e considerato che ogni decennio nasce una nuova forma di poesia.
I poeti di ricerca sperimentano. Uno dei padri nobili di questa sperimentazione fu Burroughs con il cut-up, che consisteva nel tagliare parole dai quotidiani, mischiare e creare poesie. Oggi i poeti di ricerca utilizzano l'eavesdropping, cioè l'intercettazione di una frase di una conversazione origliata. In questo caso non c'è alcuna autorità autoriale. I poeti di ricerca italiani si rifanno spesso al Flarf, movimento di avanguardia, creato da Gary Sullivan. Quest'ultimo utilizzava Google per scrivere poesie, assemblava i materiali verbali più eterogenei e definiva infatti il Flarf "un PC fuori controllo". Anche i poeti di ricerca nostrani si dilettano nel googlism, cioè nel comporre poesie, assemblando i risultati su un determinato argomento, chiedendo quindi a Google. In questo caso utilizzano l'intelligenza collettiva del web. Ricordo che il primo ad utilizzare il computer, un IBM della Cariplo, fu Nanni Balestrini nel 1962. Il poeta ideò un algoritmo e il computer generò una poesia, che sembra scritta da un poeta umano[1]. I poeti di ricerca si cimentano anche nel New Sentence, ovvero in frasi "paradossali", spesso pseudoaforismi, pseudosentenze. All'estero alcuni autori creano poesie con i messaggi spam di posta elettronica. Sempre all'estero è diffuso il "found poem", che nasce prelevando materiali da varie fonti (discorsi di politici, frasi di film, discorsi di star, eccetera eccetera), talvolta elaborandoli e altre volte no, e mischiandoli assieme. Esistono anche la micropoesia, ovvero un tipo di poesia brevissima al massimo di 140 parole, come i cinguettii su Twitter, e la poesia captcha, in cui estrapolano il testo scaturito dall'omonimo software. Recentemente in Italia il fotografo Silvio Belloni ha ideato la poesia dorsale, che consiste nel creare liriche, connettendo i titoli dei libri. Però la poesia dorsale, per ora, è praticata a livello, diciamo così, dilettantesco. Qualcuno ha sollevato dei dubbi sulla correttezza di questi metodi. Si tratterebbe di parole prese in prestito. D'altronde non esistono regole ferree nella "Fantastica" della poesia: è ammessa qualsiasi tecnica in quella che Rodari chiamava "Grammatica della fantasia".
Il gruppo 63 voleva ridurre l'io, ma non eliminarlo perché è impossibile. Alfredo Giuliani scriveva nel 1961, introducendo l’antologia de Novissimi, che “La ‘riduzione dell’io’ è la mia ultima possibilità storica di esprimermi soggettivamente“. I motivi di questa riduzioni erano plausibili. Infatti Giuliani continuava così: "Io credo si debba interpretare la ‘novità’ anzitutto come un risoluto allontanamento da quei modi alquanto frusti e spesso gravati di pedagogia i quali perpetuano il cosiddetto Novecento mentre ritengono di rovesciarlo con la meccanica dei ‘contenuti’. Ciò che molta poesia di questi anni ha finito col proporci non è altro che una forma di neo-crepuscolarismo, una ricaduta nella ‘realtà matrigna’ cui si tenta di sfuggire mediante schemi di un razionalismo parenetico e velleitario, con la sociologia, magari col carduccianesimo". I futuristi volevano eliminare l'io lirico[2], usando i verbi all'infinito. La poesia di ricerca[3] vorrebbe escludere l'io lirico. Alcuni autori si lasciano scappare la frase "va eliminato l'io". Siamo sicuri che si tratti solo dell'io lirico? Nutro dei seri dubbi e in questo mio scritto esporrò tutte le mie perplessità. Mi auguro di sbagliarmi. Voglio spiegare i potenziali danni di una eliminazione non solo dell'io lirico ma dell'io freudiano: questo è il grande rischio. Forse alcuni rimarranno delusi per il razionalismo e le verità "lapalissiane" di questo scritto. Mi scuso quindi per le volgarizzazioni e le semplificazioni. D'altronde non sono un addetto ai lavori. La premessa implicita di questo saggio breve è che a mio avviso i poeti di ricerca potrebbero fare meglio, vista e considerata la loro levatura intellettuale e la loro ricchezza di contenuti. In queste righe cercherò di valutare le loro dichiarazioni di intenti e alcuni aspetti della loro poetica. Forse per alcuni filosofeggerò troppo, ma la poesia contemporanea è caratterizzata dall'estrema concettualizzazione. Sicuramente va preso atto che questi autori hanno trovato un nuovo modo di fare poesia. Ma andiamo al nocciolo della questione. Franco Fortini in "Verifica dei poteri" parlava di "mare dell'oggettività" per Calvino e di "cosismo" per Vittorini. Gli stessi termini, a mio avviso, si potrebbero adoprare per la poesia di ricerca, che riduce ai minimi termini la soggettività autoriale. L'io però è una metafora, alla fine: è un contenitore che contiene molte voci. Anche questo bisogna tenerlo presente. La poesia italiana degli ultimi secoli, secondo Guido Mazzoni[4], è figlia dell'egocentrismo, a causa dell'individualismo borghese. Insomma c'è troppo io. Non discuto dell'autorevolezza e della grande competenza del Mazzoni, ma non fidiamoci troppo però di chi usa pronomi diversi dall'io in poesia. Gli altri, il mondo possono essere frutto delle capacità allucinatorie, anche se l'autore può sembrare di primo acchito aperto al mondo. Oppure la narrazione degli altri può essere influenzata in modo determinante da proiezioni ed essere quindi un meccanismo di difesa di un io in crisi.
Per Marx l'io è determinato dalla formazione economico-sociale, ovvero dalle relazioni sociali, dalla struttura economica, dalla sovrastruttura ideologica. Per Freud l'io ha la centralità nell'adulto, anche se "non è padrone a casa propria" perché subisce l'influsso dell'inconscio e del Super-Ego: è tra l'incudine e il martello. Esiste anche la psicologia dell'io, che è una branca della psicanalisi. Più recentemente è nata anche la psicologia del Sé[5]. Non cito le moderne neuroscienze perché come scrisse Maurice Merleau-Ponty: "L'intero mondo della scienza è costruito sulla vita, eppure la scienza non è stata per nulla capace di illuminare la natura dell'esperienza soggettiva"[6].
La poesia di ricerca addirittura tenta con l'asemico[7] di azzerare il significato e di estendere paradossalmente il polisemico. Diciamo che la scrittura asemica è Test di Rorschach per antonomasia. Regna l'inconscio. La coscienza, l'io viene relegato ai margini. Un'altra caratteristica della poesia di ricerca è quella di considerare impoetica l'assertività. Ma ciò non è forse anche esso assertivo? I poeti di ricerca - mi si scusi il gioco di parole - sostengono di non essere assertivi, ma affermando ciò lo sono: si verifica quindi il paradosso del mentitore. Diciamo, più seriamente, che non saranno assertivi nelle loro poesie, ma lo sono troppo nella loro poetica. Inoltre mi sembra che un'altra caratteristica di questo genere di poesia sia la ricerca di provocare lo shock, lo straniamento nel lettore. A mio modesto avviso il pregio della poesia di ricerca è quello di essere un fattore di rottura rispetto alla tradizione, ma non si può imporre come paradigma dominante. Un altro pregio è quello di aver gettato un poco di scompiglio nel panorama asfittico della poesia italiana. Un altro pregio ancora di questi autori è il gusto del divertissement. Mi auguro quindi che non si prendano troppo sul serio e non finiscano nell'accademismo. Il problema è che resta poco, quando prevale il gioco combinatorio dell'autore e scompare l'autore: resta solo l'arte combinatoria e forse è ben poco per rinnovare la poesia contemporanea.
Apro una parentesi. A Firenze nel 2010 è nata una nuova comunità artistica o aspirante tale: il mep (movimento di emancipazione della poesia). Hanno un loro sito internet e una loro pagina facebook. Fanno volantinaggio. Affiggono le loro poesie sui muri dei vicoli dei centri storici di diverse città. Il mep non sporca i monumenti e gli edifici storici. Per il resto lascia le poesie nei posti più disparati: sui cofani delle macchine, nelle biblioteche, nei bar. Nessuno si firma. Tutti utilizzano un codice sia perché vogliono una poesia spersonalizzata sia perché le affissioni sono abusive. Perciò l'anonimato è un obbligo. Il movimento è formato da universitari, ma non mancano gli studenti delle scuole medie superiori e giovani post-universitari. È nato a Firenze, ma si sta diffondendo in molte città italiane. Staremo a vedere in futuro come si evolverà questo movimento. I giovani del mep non si firmano. In questo caso viene eliminato l'io empirico. Sono anche loro i poeti-massa di cui scrive Ennio Abate.
Torniamo ai poeti di ricerca, che non si contano certo sulle dita di una mano. In questa definizione possono essere compresi tutti coloro che fanno poesia sperimentale. Sono il contropotere rispetto agli autori Einaudi o Mondadori, ma non è detto che domani siano loro il potere. Sono quindi molti di più di quelli che sono stati canonizzati, ovvero antologizzati dai critici. I migliori in Italia sono quelli antologizzati dal volume "Prosa in prosa", che è un libro divertente, ironico, autoironico, spassoso, caratterizzato da un notevole spessore culturale. Consiglio a tutti di acquistarlo per farsene una idea. Il merito maggiore di questi autori è di aver trasceso lo storytelling così in voga in Italia, come ha evidenziato Paolo Giovannetti[8]. Ma cosa è "la prosa in prosa"? Potremmo, semplificando un poco, definirla come una scrittura che non va a capo e che viene percepita lo stesso da gran parte dei critici e dei lettori come poesia. Tra questi artisti sperimentali ci sono sicuramente delle eccellenze, ma qui vorrei trattare delle loro premesse teoriche. Non voglio lodare nessuno (è innegabile comunque che la qualità letteraria di questa corrente è molto elevata, anche se talvolta di nicchia. I capiscuola di questa corrente sono talentuosi e scrivono magistralmente. Entreranno a pieno diritto nella storia della letteratura) e neanche stroncare nessuno; non ne avrei l'autorità. Vorrei ad ogni modo disquisire sui presupposti teorici senza fare un processo alle intenzioni. D’altronde riflettere su di essi è legittimo, perché nell’arte bisogna sempre valutare la poetica, anche se è la gestalt finale che conta. Vorrei quindi analizzare concettualmente questo tipo di poesia.
A mio avviso i poeti in questione hanno almeno tre cose in comune: il voler sminuire l’io, l’essere raffinati letterati e il raro pregio di essere intellettuali non cortigiani, ma spesso militanti. Direi che questi nuovi poeti cercano un rimodernamento in seno alla “tradizione del nuovo”. Per alcuni la maggior parte della poesia italiana di questi anni è caratterizzata dall'”epigonismo lirico”, ma anche tra i poeti di ricerca e la neoavanguardia c'è una parentela. Anche per il gruppo 63 si parlò di neooggettualismo, ma questo gruppo considerò anche l’arte come “fabbrica di antislogan” e demifistificò la civiltà consumistica, ritenuta alienante e mercificante. Non solo: la Neoavanguardia rifletteva la crisi della società neocapitalista e la crisi dell’uomo moderno. Tutto ciò allora era innovativo. Una cosa che non mi convince nella poesia di ricerca è la considerazione negativa della poesia lirica, in quanto espressione dell’io. A mio avviso la poesia lirica è anche ricerca di corrispondenze, uso di figure retoriche, ritmo e immagini. È possibile che i poeti di ricerca vogliano delegittimare le impressioni, le sensazioni e i sentimenti? Uno scrive poesie per cercare un poco di libertà e invece a conti fatti non ha nemmeno più la libertà di scrivere il pronome “io”! Personalmente trovo del tutto legittima la poesia come espressione dell’io: anche quella più incentrata tutta sulla capacità introspettiva, a costo che non sia troppo egocentrica e troppo prigioniera dell'io. La lirica può essere considerata conoscenza anche per la descrizione degli stati interiori dell’individuo. La poesia lirica può avere come limite quello di riguardare una dimensione privata e risentire troppo della personalità dell’autore. È ovvio che bisogna guardarsi bene dagli eccessi del lirismo, come il narcisismo e il compiacimento. Su questo hanno ragione i poeti di ricerca, che sono salutari quando contrastano l'ipertrofia dell'io di diversi poeti lirici. Però, secondo il più recente approccio post-razionalista, ogni individuo, tramite la propria esperienza, cerca di dare un senso al mondo. Nessun autore può giungere a una rappresentazione oggettiva perché nessuno è privo di condizionamenti e pregiudizi. L'oggettività è sempre pretesa. Ogni poeta ha un suo sguardo sul mondo e come sostiene Vittorio Sgarbi “la bellezza è oggettiva. La visione è soggettiva”[9]. Il rispecchiamento fedele e imparziale non esiste. Direi che nella poesia lirica prevale l'io, invece nella poesia di ricerca gli oggetti e l'inconscio. E del noi chi se ne occupa?
C’è chi rispetto alla poesia di ricerca ha parlato di “annichilimento dell’io”. Forse è per raggiungere l'oggettività? Mi sembra quasi che questi nuovi poeti vogliano riprendere l’impersonalità del naturalismo francese e del verismo di Verga. Oggettivare il mondo è solo un’espressione. Si può anche dire “oggettivare uno stato d’animo”, che significa solo esprimere uno stato di coscienza. La realtà è la nostra costruzione logica e non solo: dipende anche da fattori psichici ed esistenziali. Per gli esistenzialisti ognuno ha la sua intuizione del mondo.
Ho l’impressione che i poeti di ricerca non stimino coloro che vengono definiti poeti lirici. Eppure qualsiasi tipo di poesia è una interazione tra io e mondo. Bisogna ricordarsi a tale proposito del criticismo kantiano (si pensi allo schematismo trascendentale) e di Schopenhauer, secondo cui il mondo è sempre una rappresentazione del soggetto e quindi della coscienza. Per Schopenhauer tutto quello che conosciamo si trova nella coscienza. Qui non si tratta di ritornare a essere platonici o idealisti in senso assoluto. Il soggetto non può determinare tutta la realtà. Non si tratta neanche di subordinare l’oggetto al soggetto o viceversa. Si tratta invece di considerare la continua correlazione tra soggetto e oggetto. L’oggettività in poesia è solo supposta. Possono certamente criticare l’introspezione e la ricerca di interiorità perché possono ritenere che uno in questo modo guardi il proprio ombelico. Però il mondo è una nostra percezione. Niente altro. Un tempo si diceva che l’idealista pensa e il realista conosce. Oggi invece in ambito scientifico si sta sempre più affermando il costruttivismo[10]. Non si può essere realisti a tal punto da mettere tra parentesi l’io. Il mondo là fuori non ci viene dato in base alle proprietà intrinseche dei fenomeni. Noi conosciamo le cose sia perché abbiamo una coscienza, sia perché esse sono intellegibili.
Potremmo affermare filosoficamente che la ricerca della verità umana è basata sulla compartecipazione di soggetto e oggetto. In psicologia si usano altri termini e si dice che esiste una interdipendenza tra osservatore e realtà osservata. Il concetto comunque è lo stesso. Naturalmente bisogna considerare che l’osservatore modifica sempre ciò che osserva e che l’osservatore fa a sua volta parte di quel che osserva. La poesia di ricerca quindi, al di là del talento dei suoi rappresentanti, mi sembra fondata su presupposti e su premesse errate. La realtà sensibile non può essere una cosa a sé stante. La coscienza è un flusso continuo, una continua interconnessione tra soggetto e realtà. Non si può fare a meno dell'io nella poesia.
La poesia, anche oggi, può essere sperimentale, può cercare di rinnovare il linguaggio come le avanguardie; può essere satirica, didascalica, religiosa (come fu quella di Turoldo, Rebora), aforistica, spirituale; può essere poesia sociale, può descrivere epifanie, può ricercare “corrispondenze”, può esprimere un sentimento amoroso; un poeta può scrivere anche metapoesia. In caso di metapoesia o poesia didascalica non mi sembra che un poeta esprima solo sentimento, come si intende per la poesia lirica. Trovo in molti giovani poeti la ricerca di originalità a tutti i costi. Spesso l’innovazione è cercata utilizzando l’inconscio o una cosiddetta poesia degli oggetti. Per la Neoavanguardia bisognava compiere “una riduzione dell’io”. Molti allora pensarono che essere “oggettuali” significasse essere oggettivi. A mio avviso c’è il rischio di fare una elencazione di oggetti più che scrivere una poesia. Non si può far parlare solo l’inconscio che si relaziona agli oggetti. Anche in Sanguineti l’io è presente. Il professor Romano Luperini in “Il Novecento (apparati ideologici ceto intellettuale sistemi formali nella letteratura italiana contemporanea)” riguardo a Sanguineti parla di “autocommiserazione ironico-patetica” (pagina 838). Nemmeno Sanguineti è riuscito a “destituire l’io”. A mio modesto avviso sarebbe meglio se molti cercassero un equilibrio tra conscio e inconscio, tra io e oggetti. Infine manca forse qualcosa alla poesia di questi ultimi anni: il Noi, gli altri soggetti, gli altri insomma a cui relazionarsi. Manca anche la capacità di vivere la poesia in modo totalizzante, come fecero Adriano Spatola e Giulia Niccolai negli anni Settanta al mulino di Bazzano, fondando "la Repubblica dei poeti"[11]. Il problema, a mio modesto avviso, è che viviamo in una società asociale. I nostri io sono quasi delle monadi. Eppure la psicologia insegna che nelle prime fasi della vita l'interpsichico determina l'intrapsichico. Dimostrazione di questo è il fatto che i bambini che crescono nei primi anni di vita nella foresta, in modo selvaggio, senza altri umani, non riescono più a parlare e non sanno più interagire dignitosamente con altri, anche se vengono educati successivamente da degli scienziati[12]. Ritornando a questa società, da una parte c'è l'omologazione descritta da Pasolini, ovvero l'uniformazione dei modi di essere, di pensare e dei gusti. Ogni mutazione avviene tramite variazione (stabilita ad esempio nei consigli di amministrazione delle multinazionali) e fissazione (tramite l'affermazione della novità con la pubblicità). Non a caso Pasolini aveva mutuato il termine dalla biologia. L'omologazione avviene in gran parte, per ora, tramite la TV. Dall'altra parte c'è la bolla di filtraggio su internet, la cosiddetta filter bubble. Ognuno è chiuso quindi nella sua storia, nella sua bolla. La tecnologia ci isola. Ognuno appena ha un momento di tempo libero si isola e sta a smanettare al telefonino. Oppure in casa ogni familiare sta chiuso nella sua camera a guardare la TV. Insomma siamo sempre più isolati. Ma questo non significa che si è in grado di essere autenticamente sé stessi. La risultante di queste due forze (omologazione e bolla di filtraggio), apparentemente contrapposte, è l'immobilismo sociale. Abbiamo individualismo e "de-individuazione" (qui da intendersi come perdita della propria identità ed interiorità. Non come la intendeva Zimbardo) allo stesso tempo. La società di massa è spersonalizzante e ci condanna all'anonimato, all'appiattimento, al livellamento. Abbiamo tutte le libertà tranne quella di pensare, come cantava Gaber. Siamo liberi, ma dobbiamo muoverci in un certo raggio di azione. Non possiamo deragliare dai binari stabiliti. Altrimenti diventiamo devianti! Ad ogni modo essere noi è sempre più difficile. Per dirla in termini sociologici siamo in una società con uno scarso senso della comunità. È avvenuto un netto depotenziamento dell'io. È avvenuta la disgregazione dell'io. Siamo quasi tutti prodotti in serie. È avvenuta anche la disgregazione sociale. È avvenuta anche la disgregazione del noi. Si guardi ai giovani. Gli unici luoghi di aggregazione sono i vari divertimentifici, che talvolta stordiscono. Abbiamo quindi anche il tempo libero "alienato". L'interpsichico è ridotto ai minimi termini. È sempre più arduo pensarsi, dirsi ed essere noi. Ma è altrettanto difficile riappropriarsi dell'io ed essere veramente sé stessi. La poesia, in mancanza del noi, dovrebbe almeno essere espressione autentica dell'io. Dovrebbe affermare la nostra unicità e irripetibilità. Ma spesso questo non avviene.
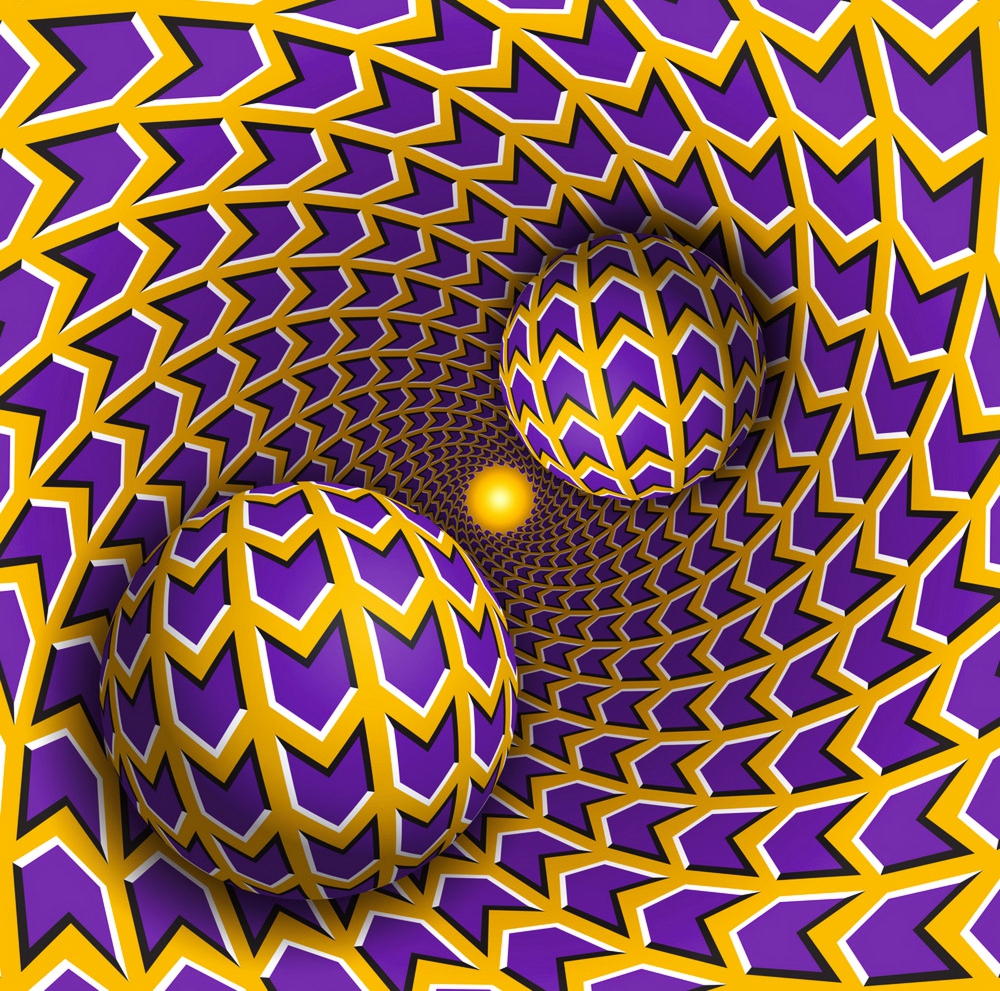
Inoltre cosa è veramente l'io? Cosa è la coscienza[13]? L’io per Freud è quella parte della psiche che media tra le pulsioni dell’Es e il Super-Ego. Senza l’io non c’è quindi oggettività, ma un essere in balia delle altre due forze. Ridurre l’io significa sottrarre una parte a noi stessi. Forse ridurre l’io significa eliminare qualche problema, ma aggiungerne molti altri in più. Per secoli si voleva rimuovere l'inconscio. Un tempo in poesia si voleva rimuovere il Super-Ego (poeti maledetti, Scapigliati) . Ora si vuole rimuovere l’io. Invece non bisogna cercare di rimuovere nessuna di queste tre istanze psichiche. Queste istanze psichiche vanno tutte affrontate. Se non affrontiamo noi stessi non possiamo affrontare degnamente neanche gli altri. A mio avviso il rischio della poesia di ricerca è quello di iniziare con l'eliminazione dell'io lirico e di finire quasi con l'eliminare l'io freudiano. Secondo alcuni bisognerebbe scegliere tra l’io e il mondo e lo dicono/scrivono come se non si dovesse privilegiare l’uno piuttosto che l’altro, ma come se ci si trovasse di fronte ad un aut aut impietoso. In realtà l’uno non esclude mai l’altro. Non si tratta di giocare a biliardo e mandare in buca l’io, come vorrebbero in molti oggi in poesia, anche se capisco il disprezzo di fronte all’ipertrofia dell’io e alle persone egoriferite. Ad onor del vero la realtà umana è un quadro di riferimento, che include sia l’io che il mondo. L’io e il mondo fanno parte del medesimo circuito. C’è una interazione continua tra io e mondo. Ogni io, anche quello più alienato, si specchia nel mondo. Il mondo ritorna sempre in ogni io. Ci sono dei dati oggettivi nella percezione del mondo, che fanno in modo che possiamo condividere la realtà e comunicare tra di noi. Ci sono verità evidenti per i sensi (quella è una sedia, quella è una mela); altre apodittiche a livello logico; altre basate su delle convenzioni e sul senso comune; altre invece sono attendibili, come ad esempio le informazioni che formano la conoscenza scientifica e sono inconfutabili fino a quando degli esperimenti non le falsificano[14]. Non tutto comunque è opinabile e in questa realtà siamo provvisti di alcune certezze. C’è ad ogni modo un significato condiviso e comune del mondo. Ci sono anche molti altri elementi particolari che costituiscono l’unicità e l’irripetibilità della visione del mondo di ognuno. Come si suol dire, siamo per certe cose tutti uguali e per certe altre tutti diversi. Inoltre, come sosteneva Popper[15], osservare non è un verbo intransitivo. Si osserva sempre qualcosa e questo qualcosa lo si sceglie in base a delle aspettative precedenti. Ognuno conosce in base alla sua esperienza. Nessuno è tabula rasa. Ciò può essere un pregio o un difetto a seconda dei casi: più semplicemente è così che siamo fatti. Ognuno, ancora una volta, conosce a modo suo. È per questa ragione che in poesia chi aspira all’oggettività può ottenere soltanto l’oggettualità. In realtà ognuno ha la sua visione del mondo, formata anche da una quota parte imprescindibile di soggettività.
Secondo il filosofo Goodman[16] i modi di “fare” (interpretare/rappresentare/descrivere) il mondo sono tanti quanti gli uomini. Sono tanti quante le menti umane perché ogni mente è diversa: i gemelli omozigoti sono uguali in tutto, ma le loro menti invece sono diverse. Secondo lo psicologo George Kelly noi adattiamo continuamente il mondo alla nostra personalità e ai nostri schemi cognitivi. Questa raffigurazione/testualizzazione del mondo avviene ogni giorno ed è quindi dinamica. Neanche chi delira è fuori da questo circolo ermeneutico perché secondo gli psichiatri il delirio è una interpretazione del mondo, anche se errata o meglio non condivisa/condivisibile (si pensi soltanto alla pericolosità sociale e alla desiderabilità sociale). La comunità si dà quindi delle regole e delle restrizioni nell’interpretazione. Secondo Nietzsche “non esistono fatti ma solo interpretazioni”. Ognuno ad onor del vero ha la sua “versione” del mondo e nessuna è onnicomprensiva; nessuno può dire l’ultima parola sul mondo: ecco perché abbiamo sempre bisogno di scambiarci informazioni, parlarci, relazionarci. Ognuno aggiunge una tessera al mosaico dell’altro. Noi interagiamo con il mondo di fuori e alcune cose le percepiamo esattamente, come tutti gli altri esseri umani, mentre invece altre le percepiamo soggettivamente. Ci sono alcuni elementi in comune con il modo con cui le altre menti percepiscono il mondo. Altre cose invece le vediamo in modo diverso. Descrivere come percepiamo il mondo è estremamente complesso. Ci poniamo mille domande, ma non abbiamo nessuna certezza. Il mondo naturalmente esisterebbe anche senza di noi (sostengono i realisti). La realtà non è prodotta dalla mente cosciente, ma l’io è l’unica modalità in grado di distinguere io e non io, di percepire, di descrivere e nominare il mondo. Senza l’io il mondo non sarebbe più oggetto di indagine. Non ci sarebbe più nessuna indagine. Ecco perché l'io, ovvero la coscienza è importante!
Ma passiamo ad altro. Cito testualmente: "La prosa in prosa è letteralmente letterale vuol dire quello che dice nel momento in cui lo dice dopo averlo detto e la prosa in prosa come poesia dopo la poesia se esistesse avrebbe letteralmente, propriamente, l'unico stupidissima senso che sta dicendo cos'è." (Jean-Marie Gleize. La traduzione è di Michele Zafferano. Da" Prosa in prosa"). Gli autori di "Prosa in prosa", come sottolineato da Paolo Giovannetti, vogliono raggiungere "il grado zero della connotazione", teorizzato da T. Todorov. Per i poeti di ricerca molto probabilmente "una rosa, è una rosa, è una rosa"[17], come scriveva Gertrude Stein. A mio modesto avviso invece in poesia una rosa non è solo una rosa perché può avere diverse connotazioni (che possono essere anche considerate delle sfumature emotive. Anche la nominazione più precisa può avere quindi una sua vaghezza), può provocare le più svariate “corrispondenze” tra l’io e l’oggetto (più banalmente risonanze interiori). Inoltre ogni oggetto può essere suggestivo, può ispirare l’artista. Joyce ha insegnato che qualsiasi cosa può essere rivelatrice e chiarire l’esistenza. L’arte anche per questo motivo dimostra di essere ineffabile. Le “corrispondenze” tra gli stati d’animo e il mondo non solo variano da individuo a individuo ma anche di giorno in giorno e di istante in istante. Cambiamo continuamente noi. Cambia continuamente il mondo. Di conseguenza cambiano continuamente le corrispondenze. Ogni artista quindi deve sempre cogliere le occasioni perché le corrispondenze hanno carattere episodico. I pensieri sono casuali, come le gocce di pioggia sull’asfalto. Sta al poeta mettere ordine tra i suoi pensieri. Una rosa non solo può suscitare diverse sensazioni, ma anche portare ai più svariati simbolismi. A essere più puntigliosi il poeta rappresenta più che descrivere e ogni rappresentazione possiede deformazioni e approssimazioni. Eludere l’io, occultarlo per avere uno sguardo diretto ed oggettivo è impresa impossibile. Tutto ciò è paradossale. Invece bisogna considerare che esiste sempre una componente emotiva dell’artista: la sua soggettività. C’è sempre un quid mentale e parziale, così come è innegabile che esiste una realtà in certa parte comune e condivisibile. Spesso viene stimato grande poeta colui che riesce a descrivere sensazioni, emozioni o pensieri, che la maggioranza delle persone fino ad allora non vedevano, come il fanciullino del Pascoli. Cercare di eludere l’io per vedere meglio le cose, per distanziarle, per vederci più chiaro è impresa vana a mio avviso. In questo senso nessun artista può registrare oggettivamente il suo inconscio. È impossibile. Deve esserci sempre la mediazione della coscienza. Inoltre l’inconscio è per gran parte inattingibile e la coscienza non può accedere totalmente ad esso: molte zone restano inesplorate. Infine Gian Luca Picconi ha parlato di "soggettivazione di gruppo" per gli autori di "Prosa in prosa". Questa "soggettivazione di gruppo" può andare bene in una antologia, ma di che cosa se ne fa un lettore comune, quando legge la silloge di uno di questi poeti? Forse ben poco. Ogni poeta in definitiva, grazie alla sua soggettività, è unico. È anche grazie alla soggettività che un poeta inventa un linguaggio o rinnova il linguaggio. Ognuno, anche il più mediocre, ha la sua angolatura e da questa scaturisce la sua particolare prospettiva. Si usa dire che un artista apre un mondo quando trova un nuovo filone di cose, ovvero rappresenta un mondo che fino ad allora non era stato rappresentato[18]. Per Claudio Magris il poeta è “un nessuno che parla per tutti”[19]. Un poeta lavora per intuizioni verbali, piccole rivelazioni gnomiche, illuminazioni liriche. È efficace quando le sue parole riescono ad essere evocative, quando riesce a esprimere il fluire di immagini nella sua mente e anche quando riesce ad accostare cose lontane tra di loro. Un artista può rappresentare una nuova realtà oppure se è della Neoavanguardia può cercare di trovare un nuovo linguaggio, cercando di dare forma all’informe. L’artista è tale quando fa diventare universali i suoi pensieri e le sue percezioni.
Note
[1] Ecco la poesia in questione:
NANNI BALESTRINI
(Da Almanacco Letterario Bompiani – Bompiani, 1962)
TAPE MARK I
La testa premuta sulla spalla, trenta volte
più luminoso del sole, io contemplo il loro ritorno
finché non mosse le dita lentamente e, mentre la moltitudine
delle cose accade, alla sommità della nuvola
esse tornano tutte, alla loro radice, e assumono
la ben nota forma di fungo cercando di afferrare.
I capelli tra le labbra, esse tornano tutte
alla loro radice, nell’accecante globo di fuoco
io contemplo il loro ritorno, finché non muove le dita
lentamente, e malgrado che le cose fioriscano
assume la ben nota forma di fungo, cercando
di afferrare mentre la moltitudine delle cose accade.
Nell’accecante globo di fuoco io contemplo
il loro ritorno quando raggiunge la stratosfera mentre la moltitudine
delle cose accade, la testa premuta
sulla spalla: trenta volte più luminose del sole
esse tornano tutte alla loro radice, i capelli
tra le labbra assumono la ben nota forma di fungo.
Giacquero immobili senza parlare, trenta volte
più luminosi del sole essi tornano tutti
alla loro radice, la testa premuta sulla spalla
assumono la ben nota forma di fungo cercando
di afferrare, e malgrado che le cose fioriscano
si espandono rapidamente, i capelli tra le labbra.
Mentre la moltitudine delle cose accade nell’accecante
globo di fuoco, esse tornano tutte
alla loro radice, si espandono rapidamente, finché non mosse
le dita lentamente quando raggiunse la stratosfera
e giacque immobile senza parlare, trenta volte
più luminoso del sole, cercando di afferrare.
Io contemplo il loro ritorno, finché non mosse le dita
lentamente nell’accecante globo di fuoco:
esse tornano tutte alla loro radice, i capelli
tra le labbra e trenta volte più luminosi del sole
giacquero immobili senza parlare, si espandono
rapidamente cercando di afferrare la sommità.
[2] L'io lirico è la voce interiore nella poesia. Non è detto che coincida sempre con l'io empirico, ovvero con l'autore in carne ed ossa. L'io lirico può essere anche in un certo qual modo fittizio. Si veda ad esempio Pessoa ed i suoi eteronimi. L'io lirico può essere anche un alter ego.
Un saggio sull'io lirico: http://www.leparoleelecose.it/?p=20689
[3] Sulla poesia di ricerca: http://www.leparoleelecose.it/?p=34663
https://www.glistatigenerali.com/letteratura/mappa-poesia-italiana-26082017/
https://www.versanteripido.it/prosa-o-poesia-di-francesco-di-lorenzo/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/08/21/humpty-dumpty-e-poesia-di-ricerca-in-italia/688793/
[4] "Sulla poesia moderna" di Guido Mazzoni (Il Mulino, Bologna, 2005)
[5]https://www.treccani.it/enciclopedia/io-se_(Enciclopedia-Italiana)/#:~:text=Il%20concetto%20di%20Io%20diviene,cio%C3%A8%20psicologia%20dell'Io)
[6] "Fenomenologia della percezione" di Merleau-Ponty (Bompiani, Milano, 2003)
[7] https://www.alfabeta2.it/tag/enciclopedia-asemica/
[8] "Prosa in prosa" (Tic edizioni, Roma, 2020)
[9] "Lezioni private 2" di Vittorio Sgarbi (Mondadori, Milano, 1997)
[10]https://it.m.wikipedia.org/wiki/Costruttivismo_(psicologia)
[11] "La repubblica dei poeti. Gli anni del mulino di Bazzano. Con DVD" di D. Rossi (cur.) e E. Minarelli (cur.) (Campanotto, Udine, 2010)
[12]https://www.focus.it/ambiente/animali/le-vere-storie-dei-ragazzi-selvaggi
[13] In letteratura esiste il flusso di coscienza. Basta leggere la Woolf, H. James, W. Faulkner, Joyce. Gli scrittori inseguivano i loro pensieri senza punteggiatura. La loro scrittura registrava i dati psicologici, la loro interiorità; descriveva la loro mente, che vagava da una idea all'altra. Allora la mente non era ancora considerata esclusivamente un insieme di processi fisico-chimici. Naturalmente da allora è innegabile che siano stati fatti dei passi in avanti perché non si parla più di spirito e sappiamo che, privati del sistema limbico, non sapremmo più provare emozioni. Secondo la psicologia la coscienza è innanzitutto autoconsapevolezza. È allo stesso tempo consapevolezza del vissuto e responsabilità delle proprie azioni. Per Jaspers è "la vita psichica di un dato momento". È autoriconoscimento, memoria di sé, percezione di sé, conoscenza di sé, senso di sé; recentemente i neuroscienziati hanno parlato di sé autobiografico, ovvero conoscenza del proprio passato e presente. Coscienza significa accorgersi anche degli stimoli esterni. Coscienza è attenzione. È consapevolezza della propria identità. È organizzazione psichica di attenzione, memoria, linguaggio, desideri, intenzioni, emozioni, valori, stati mentali. Secondo il cognitivismo è anche metacognizione, ovvero conoscenza delle proprie operazioni mentali. Tutto ciò risulta in parte labile ed ineffabile. A tal riguardo dobbiamo ricordarci che il Sé è sempre sfuggente ed elusivo. Molte cose che sappiamo della coscienza le sappiamo grazie all'introspezione. La coscienza è ancora oggi un mistero.
[14] Dopo il principio di complementarietà di Bohr e il principio di indeterminazione di Heisenberg la scienza dipende non più da un rapporto di causa-effetto, ma da leggi di tipo statistico-probabilistico.
[15] "Congetture e confutazioni" di K. Popper (Il Mulino, Bologna, 2009)
[16] "Vedere e costruire il mondo" di Nelson Goodman (Laterza, Bari 2008)
[17]https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rose_is_a_rose_is_a_rose_is_a_rose
[18] La rappresentazione non è mai totalmente fedele. La realtà è una commistione di drammaticità, tragedia, comicità, erotismo, mistero, etc etc. Noi non possiamo immagazzinare tutti gli stimoli del reale e ne selezioniamo solo alcuni per un puro fatto di economia cognitiva e per i nostri limiti mentali. Nella rappresentazione ne scegliamo solo alcuni da mostrare. La realtà ha moltissime sfaccettature e noi ne evidenziamo solo alcuni aspetti salienti. Sono illimitati i rapporti che un fatto, una cosa o un soggetto può avere con altri fatti, cose o soggetti. È impossibile prendere in esame l'immensa eterogeneità del reale e l'enorme casistica degli eventi. Gadda scriveva dello "gnommero". Montale a tal riguardo scrisse della "matassa da disbrogliare". Per Vincenzo Gioberti la verità è "un immenso poligono" dai lati infiniti. L'immaginazione umana è anche essa un immenso poligono dai lati infiniti. Quindi anche i più alti ingegni umani non possono che rappresentare tutto ciò in modo parziale. La realtà è un enorme caos. Noi possiamo solo cercare di fare dei modelli del reale. Possiamo solo dare una forma al caos. Ogni opera subisce perciò una deformazione in base al punto di vista e alla prospettiva dell'autore. La realtà umana è costituita da una illimitata molteplicità di eventi e di stati mentali. La realtà umana in fondo è una continua interazione tra io e mondo. È un continuo feedback. La realtà non esisterebbe senza i fenomeni neurochimici del nostro cervello, che ci permettono di rappresentarla. Quella che alcuni chiamano oggettività è solo una conoscenza condivisa. L'arte è un impasto di oggettività e soggettività. Anche gli artisti più realisti, che vogliono dare una visione il più possibile impersonale e distaccata della realtà, non possono mai essere totalmente oggettivi. In definitiva l'arte non dipende solo dalla verosimiglianza e dal realismo raggiunti. Una scoria di soggettività resta sempre. Per Picasso in fondo "l'arte è la menzogna che ci permette di conoscere la verità".
[19] "Alfabeti" di Claudio Magris (Garzanti, Milano, 2008)
set 092023

(Nella foto io a sinistra con l'amico Emanuele Morelli)
Quando si è giovani si vive un dramma per una storia d'amore finita male o per un innamoramento non corrisposto. Ci sembrano così importanti i nostri amori, fortunati o meno, quando sono fattarelli inessenziali per il resto del mondo. Spesso la nostra ragione e la nostra memoria funzionano in modo molto "fazioso": pensiamo e ricordiamo per molto più tempo quando siamo stati lasciati, traditi o non corrisposti rispetto a quando noi abbiamo lasciato, tradito e rifiutato. La nostra mente - almeno nella giovinezza - è masochista. Così una ragazza comune, che gli ha detto "no", diventa la musa di un aspirante poeta. Molti giovani vogliono rendere partecipi tutti del loro amore, delle qualità, della bellezza della loro amata e allora lo scrivono su tutti i muri della loro città. Non è forse così? Non trovate che sia così? Qualcuno dirà che sono solo generalizzazioni. Io rispondo che senza generalizzazioni non ci sarebbe conoscenza e nemmeno si camperebbe! Ogni giorno facciamo delle generalizzazioni. Continuiamo allora con le generalizzazioni. Da giovani si vuole cambiare il mondo. È più difficile invece trovare persone mature che vogliano farlo. La giovinezza, secondo statistiche e ricerche, è anche la fase più creativa della vita; i geni hanno fatto scoperte o creato capolavori spesso da giovani. Ciò nonostante la maggioranza dei giovani non sfrutta queste potenzialità perché affaccendata in tutt'altro. A ogni modo nella giovinezza si è maniaco-depressivi, come non mai. Basta poco per toccare il cielo o vivere in un inferno terreno. Ci sono degli errori giovanili che determinano, decidono il resto della nostra vita e che finiamo per pagare vita natural durante, come scrive Mario Luzi. Ci sono persone che immolano la giovinezza sull'altare dello studio o del successo e finiscono per rimpiangerla per tutta la vita. Beato è chi ha vissuto la giovinezza da giovane e non chi ha avuto una giovinezza posticcia in là con gli anni! Di alcuni si dice non a caso: "non è mai stato giovane". Bisogna essere giovani da giovani, che non è una tautologia, come potrebbe sembrare. Gli studenti non vedono l'ora di laurearsi e lavorare. I fidanzati non vedono l'ora di sposarsi e fare figli. E non sanno che quello è il periodo migliore della loro vita! È molto difficile vivere pienamente la giovinezza, ma quasi impossibile è saperla apprezzare proprio quando si è giovani. Le Nazioni Unite hanno stabilito che si è giovani dai 15 ai 24 anni, ma la giovinezza oggi è una fase che si protrae spesso più a lungo. Se chiediamo quando hai smesso di essere giovane, i più non rispondono a una certa età ma pensando a quando è finito un amore, a quando hanno iniziato a lavorare, a quando è morta una persona cara. La giovinezza è quindi percepita soprattutto interiormente più che anagraficamente, ma ciò non toglie che possa essere una percezione errata. Un altro problema, anche se è vero che non si può essere giovani per tutta la vita, è che si invecchia troppo presto. La maturità comunque è anche l'approdo di equilibrio e di un minimo di stabilità per i più. Alcuni sostengono che la gioventù è il periodo più bello della vita. Altri come lo scrittore Nizan sostengono l'esatto contrario. Io ritengo che sia una stagione molto altalenante dal punto di vista degli umori. Comunque nella giovinezza diamo un'importanza esclusiva a quel che chiamano amore sia per una questione ormonale che per la nostra insofferenza alla solitudine. Dobbiamo accoppiarci e non possiamo stare soli. Nella giovinezza possiamo vivere sia gli amori platonici che il sesso sfrenato. La giovinezza è una mistura esplosiva di idealismo, materialismo, sentimentalismo, spesso mal assortiti e mal combinati. Da giovani si è innamorati delle idee, dell'amore e si è dipendenti dal sesso. La nostra psiche e il nostro organismo difficilmente ci consentono di ripetere queste cose in altre stagioni della nostra vita. Con l'avvento della maturità non è che ristrutturiamo cognitivamente ed emotivamente tutto ciò: è solo che abbiamo meno energie, siamo più esperti e pensiamo molto meno alle nostre questioni sentimentali perché incombono altri problemi più pratici come i soldi, la salute, la famiglia, etc etc. Nella maturità non abbiamo più la forza, la fantasia e l'ingenuità di idealizzare una donna. Alcuni potrebbero obiettare e sostenere che non è vero e che ci sono milioni di anziani nel mondo che si innamorano di donne molto più giovani. La maturità però non è solo un fatto anagrafico. La maturità è anche rassegnazione e accettazione; è anche assennatezza. Non si può vivere in un ridicolo infantilismo cronico. C'è scritto anche nell'Ecclesiaste che esiste per ogni cosa un suo momento. Ogni stagione della vita ha la sua bellezza e tutto sta a saperla cogliere. A mio avviso è un'illusione quella di sentirsi "forever young" per tutta la vita. No. Non si può fare i giovanotti a vita. Eppure, come si suol dire, al cuore non si comanda. Innamorarsi, almeno inizialmente, è un vero toccasana a tutte le età: è il miglior antidepressivo naturale, ma ha anch'esso le sue controindicazioni e le sue ripercussioni negative, perché è bello finché dura, fino a quando si spera di essere corrisposti o fino a quando si è corrisposti, ma poi? Poi bisogna raccogliere i cocci e farlo a cinquant'anni o a sessanta è molto più difficile e più gravoso. A una certa età è più difficile riprendersi da una delusione; è più impegnativo recuperare le forze. In più innamorarsi significa talvolta lasciarsi con la moglie e sorbirsi la separazione con addebito: non tutti possono permettersi la separazione o il divorzio, perché rischiano di diventare padri poveri. Inoltre si potrebbe vedere tutto da un'altra ottica: Hölderlin ad esempio sosteneva che solo quando è passata amiamo e rimpiangiamo la giovinezza. È molto meglio rassegnarsi perché a mio avviso è la miglior forma d'amor proprio e di rispetto per sé stessi piuttosto che inseguire elisir di eterna giovinezza. La maturità, almeno quella interiore, è consapevolezza dei nostri limiti e rinuncia. Lo so. Molti storceranno il naso, perché nella nostra società domina incontrastato il giovanilismo. E a questo punto come non fare una citazione abusata e ricordare della Magnani, che diceva ai truccatori: "Non toccare le mie rughe. Le ho pagate care". La presa di coscienza di qualcosa che volge al termine è espressa magistralmente in questi versi della grande poetessa Lamarque: "A vacanza conclusa dal treno vedere/ chi ancora sulla spiaggia gioca si bagna/ la loro vacanza non è ancora finita:/ sarà così sarà così/ lasciare la vita ?"
Non sono versi illuminanti?
set 012023
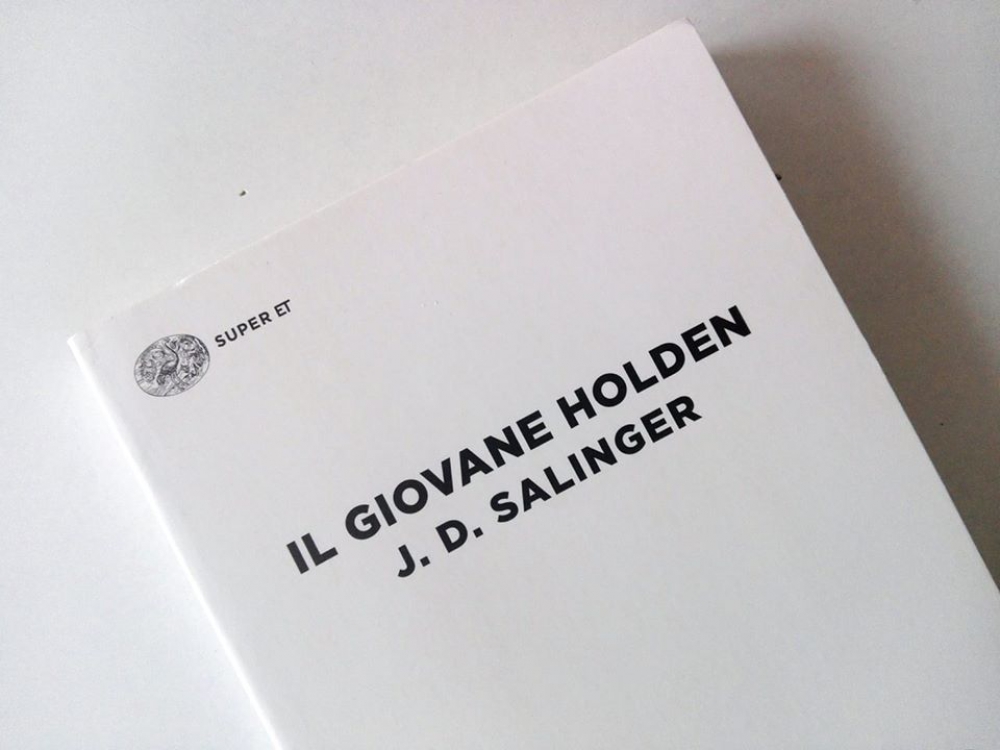
Quel lunatico e schivo di Salinger ha piazzato uno dei più grandi romanzi americani con “Il giovane Holden”. Di sé ha sempre fatto sapere poco al mondo. Ha sempre fatto vita ritirata ed appartata. E’ sicuramente il più schivo e riservato dei grandi scrittori americani del ‘900. Tempo fa su un settimanale vidi una sua foto, o meglio un suo mancato ritratto fotografico: infatti il fotografo era riuscito a riprendere la sua figura, ma Salinger era riuscito a tapparsi il volto con la mano. La foto quindi non permetteva una completa lettura del suo viso. Ma veniamo al romanzo. Il giovane Holden innanzitutto è innovativo per la continuità impressionante del gergo giovanile. Dall’inizio alla fine del romanzo Salinger utilizza sapientemente un linguaggio nuovo, che realizza uno scarto significativo con la tradizione letteraria americana. L’originalità di questo suo linguaggio è sbalorditiva, se si pensa che fu scritto negli anni ’50. Un’altra caratteristica saliente del libro è la sincerità allarmante del protagonista nei confronti di sé stesso e degli altri. Di solito chi scrive cerca sempre di dare una buona impressione ai lettori. Un’alta percentuale delle persone che scrivono infatti per dare un’ottima immagine di sé stessi agli altri cadono nel sentimentalismo, nella retorica, oppure in leziosismi e virtuosismi. Salinger invece mette in gioco tutto sé stesso. Si cala in Holden, suo alter ego, e scrive nello stile più essenziale possibile per arrivare al nocciolo della questione. Questa sua sincerità, questa incessante ricerca di un brandello di verità umana, che a tratti sconfina nel disincanto e nel cinismo, permette a Salinger di riportare alla luce quella parte di ognuno di noi, che prima di questo romanzo non era mai stata scandagliata a dovere. Salinger infatti riesce a mettere sulla pagina bianca tutte quelle piccole idee banali e superficiali, che vengono in mente a tutti; tutti quei pensieri brevi e sconnessi, che releghiamo nel subconscio. Ci sono ad esempio operazioni cognitive, come quelle per guidare una macchina, talmente automatiche e ripetitive, che dopo un minimo di esperienza non raggiungono più la soglia di coscienza. Salinger è riuscito a far venire fuori dalla sua testa queste piccole idee quotidiane, talvolta banali, qualche volta addirittura assurde. Ad esempio di fronte a un laghetto Holden si chiede dove vadano i cigni, quando il lago è gelato. A leggere questo libro si rimane stupefatti, se si è letto qualche libro di filosofia di tanto in tanto. Non c’era bisogno di quelli che Ricouer chiama “i maestri del sospetto” (ovvero Marx, Nietzsche, Freud) per dimostrare al mondo la fallacia della ragione umana e i limiti del razionalismo. Era sufficiente soltanto saper cogliere questi piccoli pensieri banali, automatici, quotidiani. Infine un altro aspetto fondamentale del libro è la messa a fuoco del disagio giovanile. Holden è il classico bravo ragazzo, che frequenta un collegio con regole ferree. E’ il classico ragazzo della borghesia americana. Ma non si trova a suo agio nei suoi panni. A scuola è svogliato. Non gli vanno i professori. Non gli vanno i suoi compagni di scuola. Non gli va bene nessuna delle cricche e delle comitive del suo collegio. Non trova un senso in quel che fa. E’ diffidente nei confronti degli altri. E’ insofferente verso le regole e i paletti imposti dal mondo dei grandi. E’ spietato verso il grigiore della quotidianità. Il rapporto del protagonista con gli altri è sempre problematico, conflittuale, ambivalente. Holden vuole ripagarli con la stessa moneta dell’indifferenza con cui pensa che gli altri lo paghino. La sua è una sensibilità offesa. Quando si ha questo disagio nei confronti degli altri e della società una persona può reagire in tre modi differenti: diventare asociale, misantropo o addirittura antisociale (è forse una coincidenza il fatto che l’assassino di Lennon aveva in tasca una copia di questo libro? Forse si identificava con Holden? Apprezzava forse la sua apparente anaffettività?). Per tutto il romanzo qualsiasi sentimento e qualsiasi tipo di affetto nei confronti delle persone a lui vicine è rimosso. Ma Holden non può rimuovere totalmente ogni emozione. Deve pure investire affettivamnte su qualcuno o su qualcosa. Ecco allora che si innamora del linguaggio. Schifato dal mondo esterno e perfino dai suoi schemi mentali si aggrappa ingenuamente alle parole. Così utilizza le sue parole per mentire. Infatti di sé stesso dice:” Io sono il più fenomenale bugiardo che abbiate mai incontrato in vita vostra”. Alle menzogne e alle falsità del mondo degli adulti quindi contrappone le sue menzogne ingenue, mai dannose per gli altri. Ad esempio quando incontra la madre di un suo compagno di scuola in treno mente spudoratamente, ma lo fa a fin di bene e per quieto vivere. Dice alla madre quello che vuole sentirsi dire di suo figlio. Holden dice alla madre che quel collegio è un’ottima scuola, anche se in realtà gli fa schifo: ma d’altra parte cosa dovrebbe dire a una madre, che paga una retta salata per mantenere suo figlio in collegio? Dice alla madre che suo figlio è un ragazzo sensibile, quando invece pensa che sia il più grande bastardo della scuola. Mente anche sulla sua vera identità, tant’è che, quando si presenta, usa il nome e il cognome del bidello della scuola, per non mettersi a raccontarle la sua vera storia. Ma d’altronde perché non dovrebbe mentire? La conversazione avviene in un contesto sociale, che i sociologi moderni definirebbero “un non-luogo”. E nel non-luogo di uno scompartimento di un treno si possono raccontare tutte le balle che si vogliono. Poi la madre del suo compagno di collegio è una bella donna e il dialogo tra i due è infarcito di luoghi comuni. Perché mai non dovrebbe mentire? Solo alla fine del romanzo Salinger si concilia con gli altri e con il mondo esterno. Infatti scrive: “Io, supergiù, so soltanto che sento un pò la mancanza di tutti quelli di cui ho parlato. Perfino del vecchio Stradlater e del vecchio Ackley, per esempio. Credo di sentire la mancanza perfino di quel maledetto Maurice. E’ buffo. Non raccontate mai niente a nessuno. Se lo fate, finisce che sentite la mancanza di tutti”. Il senso di questo libro di Salinger sta tutto nel titolo originale. Il titolo originale è “The catcher in the rye”, che si potrebbe tradurre “il pescatore nella segale”. Il titolo deriva da un’espressione modificata di una poesia di Robert Burns. La poesia in verità dice: “se scendi tra i campi di segale e ti viene incontro qualcuno”. Invece Holden crede che dica: “E ti prende al volo qualcuno”. E quando se ne accorge capisce anche il motivo per cui ha modificato questo verso della poesia. Lui infatti si è immaginato migliaia di ragazzi, che giocano in un immenso campo di segale. Ma questi ragazzi sono incoscienti ed ingenui, non tengono affatto conto che esiste un dirupo in cui possono cadere. Holden-Salinger scrive allora che la cosa che gli piacerebbe fare di più è quella di acchiapparli e di salvare coloro che inavvertitamente stanno per cadere nel dirupo. Fuor di metafora: il giovane Holden può ancora salvarsi e tramite le sue parole salvare altri adolescenti dalle brutture e dalle ipocrisie del mondo dei grandi. Quell’assurdità e quello squallore del mondo degli adulti se non vengono affrontati nell’adolescenza possono portare al gesto estremo più avanti, come il protagonista del racconto “Un giorno ideale per i pesci banana” dell’opera successiva di Salinger “I nove racconti”, che si spara un colpo alla tempia. Infatti lo scrittore americano nel giovane Holden è cinico nei confronti degli altri, perché il disagio deve affrontare brutalmente lo schifo. Invece ne “I nove racconti”, in cui prende in esame il mondo degli adulti, usa la pietà umana: oramai non può fare più niente per loro, le loro vite sono già compiute, le loro persone sono già gestalt finale. “Il giovane Holden” è stato terapeutico per lo scrittore americano. Salinger è riuscito a fare i conti con il proprio disagio. Ed è proprio per questo motivo che questo libro è stato letto da generazioni di giovani americani. E’ per questo motivo che Salinger è diventato una sorta di compagno di strada dei giovani americani e non solo. E se oggi pochi lo leggono, non sanno che cosa si perdono, perché questo libro diverte e fa riflettere.
ago 222023

Uno degli indagati per lo stupro di gruppo di Palermo così scriveva nella chat: "Eravamo cento cani su una gatta, ma la carne è carne". Nel 2022 in Italia gli omicidi sono stati 314 e ci sono stati 126 femminicidi. Fino al 18 agosto i femminicidi nel 2023 erano 75. Che cosa non ha funzionato e non funziona? La responsabilità è individuale, ma la cultura dell'odio ha la meglio sugli agenti di socializzazione (famiglia, parrocchia, scuola). E cosa può la letteratura su questi giovani? Al bando le belle parole da anime belle, i giri di parole, le elucubrazioni mentali degli intellettuali! No. Cari e care insegnanti, la vostra letteratura impartita come un obbligo, un'imposizione può fare davvero pochissimo per i giovani. Forse ha una ricaduta positiva solo per un'esigua minoranza, una ristrettissima cerchia, per cui l'umanesimo diventa una passione. L'umanesimo è troppo inattuale, troppo antiquato. No. Insegnare il dolce stil novo, la donna angelicata, Dante e Petrarca non ha più presa sui giovani. I giovani non sentono questa grandezza e la avvertono come troppo lontana. No. Cari insegnanti, non vi illudete per dei bei temi, perché la maggioranza ripete come pappagalli le nozioni, ma non assimila i valori che cercate di trasmettere loro. Non vi illudete: anche l'educazione civica e l'educazione sessuale potrebbero pochissimo o nulla. Forse alcuni di voi diranno: "cerchiamo di fare poco per quei pochi che è già molto. Non essere apocalittico. Non essere catastrofico". Ma la sottocultura che viviamo ogni giorno ha sempre la meglio. Per assimilare un poco di cultura ci vuole un minimo di sforzo e di sacrificio. Assimilare sottocultura è facile e automatico. Non richiede sforzi. Poi il bombardamento della sottocultura è ripetitivo, ossessivo, ossessionante. La sottocultura usa a meraviglia il condizionamento classico e anche quello operante. La maggioranza silenziosa approva e dà ricompense a chi assimila sottocultura, perché essa stessa è sottocultura diffusa. E poi è sempre più difficile distinguere la cultura dalla sottocultura! Una maggiore scolarizzazione non necessariamente comporta una maggiore educazione. C'è però sempre meno rispetto per la dignità umana e le regole del vivere civile. No. Cari filosofi e care filosofe, Kant, Spinoza, etc etc non servono più. No. Cari poeti e care poetesse, non potete nulla contro questo mondo e discutete pure di assertività, rimozione dell'io lirico, oggettività, sentimentalismo, giusta distanza e giusto distacco da cose e persone. Non potete nulla contro la massa omologata e informe. Forse è chiedere troppo alla letteratura, alla poesia, considerate dai più sempre più ornamentali, accessorie, pleonastiche, insomma inutili. La mentalità comune, quella la fanno una televisione generalista per nulla pedagogica, i mass media sempre più bombardanti, sensazionalistici e qualunquisti, il porno di massa, il gruppo dei cosiddetti pari, i bar, le discoteche, le curve degli stadi. Niente ci può salvare da questo bestiario. La poesia che rispecchia un mondo troppo impoetico non è vera poesia e la vera poesia è cosa da folli. Il rischio è troppo elevato. Potreste rimetterci reputazione, salute, forse la pelle.
Sventolate bandiera bianca, anzi ammainatela proprio la bandiera. La sconfitta è inesorabile. La letteratura non è più incisiva. Non plasma più le coscienze della maggioranza e se è sempre stata elitaria, oggi lo è molto di più. La letteratura non è più formativa. Educa il gusto di pochissimi. Un tempo gli stessi poeti maledetti vivevano la letteratura e la poesia come degli anticorpi contro la barbarie diffusa. Dario Bellezza in "Invettive e licenze" scriveva: "Ignoro il corso della storia. So solo/ la bestia che è in me e latra". La poesia era quindi autoconoscenza della propria Ombra, della parte più oscura e rimossa. Prenderne consapevolezza era già un primo passo importante per migliorare, per evolvere. No. Cari umanisti, non siete più assediati. Arrendetevi. Non potete niente all'atto pratico. Rischiereste solo la vostra incolumità per niente. La Fortezza Bastiani è stata già conquistata. Il nemico ha così vinto che è dentro ognuno di noi e noi siamo nemici di noi stessi. La colpa è della società? E allora è anche nostra. La barbarie si è già annidata ovunque. Noi stessi siamo i Tartari e non sappiamo neanche riconoscerci come tali.
lug 282023
Alain Elkann qualche giorno fa ha scritto un racconto sul suo viaggio in treno verso Foggia. L'ha pubblicato su "la Repubblica". Ha dato dei lanzichenecchi (soldati mercenari, barbari e feroci, responsabili del sacco di Roma) a dei ragazzi settentrionali che parlavano di ragazze e di dove e come rimorchiare (al night oppure sulla spiaggia). È diventato il tormentone di questo luglio. Sui social si sono sbizzarriti con le offese allo scrittore, con i meme, etc etc. I quotidiani sono andati a nozze con le polemiche. Il racconto è stato divisivo: alcuni giornalisti l'hanno difeso a spada tratta, dicendo che la maleducazione oggi dilaga, mentre altri opinionisti l'hanno definito snob, elitario, classista. Alcuni hanno fatto da avvocati difensori, perché lui è un giornalista e uno scrittore affermato, oltre al fatto di essere il padre dell'editore. Altri lo hanno attaccato per invidia sociale. Insomma c'è stata poca obiettività e su tutto ha prevalso l'emotività. C'è chi si è identificato in Elkann e chi nei "lanzichenecchi". Certo a passare da intellettuale raffinato a radical chic con la puzza sotto il naso il passo è breve. Elkann ha delle scusanti: 1) probabilmente non si mischia con gli italiani. Non è avvezzo. Vive nell'alta società 2) i letterati sono spesso snob.
Inoltre va dato merito a Elkann di averci messo la faccia e di aver avuto il coraggio di manifestare la sua insofferenza. Certe cose molti le pensano ma non le dicono! Elkann ha avuto il coraggio di risultare impopolare. Però mi chiedo io: su "la Repubblica" uno può scrivere tutto ciò che gli passa per la testa? Classista poi? Quei ragazzi, come lui del resto, erano in business class. Io che faccio parte del volgo non ho mai viaggiato in business class. Quei ragazzi erano quindi di buona famiglia e con molti soldi; erano agiati, forse ricchi. Certo forse un pochino classista lo scrittore a ogni modo lo è stato e oltre che essere una cosa di cattivo gusto è anche anacronistico, dato che oggi le classi sociali non esistono più; esistono le differenze culturali, di istruzione; esistono le varie fasce di reddito e le differenze di patrimonio, ma le classi sociali oggi non più. E poi erano nordici! Che dire allora delle esternazioni antisiciliane di anni fa del pur bravo, meritevole e umano Roberto Vecchioni? Certo viene da chiedersi cosa avrebbe scritto e quali strali sarebbero venuti fuori se Elkann si fosse trovato a viaggiare sul treno rapido Taranto-Ancona in seconda classe nel bel mezzo degli anni Settanta come Rino Gaetano (mi riferisco a "Mio fratello è figlio unico").
Cosa sarebbe successo se Elkann si fosse imbattuto la mattina dell'ultimo dell'anno sul diretto Pisa-Firenze negli anni Novanta in gruppi di giovani ubriachi che offendevano tutti e molestavano le ragazze, totalmente ubriachi e fumati? Cosa avrebbe scritto Elkann se si fosse trovato nello scompartimento un gruppo di ultras facinorosi in trasferta, che spaccavano mezzo treno, pronti a menare le mani, comportandosi come fossero impuniti e intoccabili? Posso dire che a Elkann è andata bene, perché non era solo, aveva dei compagni di viaggio e su certi treni quasi deserti in Italia le ragazze vengono anche stuprate e i viaggiatori possono essere aggrediti e rapinati. Ci sono stati addirittura dei casi di controllori feriti con l'accetta o con il coltello solo perché volevano far pagare la multa a chi non aveva biglietto! E poi quei giovani che hanno passato tutto il tempo a parlare di ragazze e di calcio avevano un grande pregio: parlavano di cose futili, ma non se ne stavano per tutto il viaggio con i telefonini, immersi totalmente nel mondo virtuale. E poi mi chiedo io cosa ha trovato di così grossolano nei discorsi di quei ragazzi? È una topica degli italiani di tutte le età parlare delle donne, raccontandosi fin nei minimi dettagli in modo boccaccesco le avventure. Dottor Alain (so bene che non mi leggerà) ma lei in quale mondo edulcorato e ovattato vive? Un conto è vivere nell'Iperuranio o quantomeno in una torre eburnea e un altro è la realtà quotidiana di molti! Oh lo so in casa sua i suoi figli non hanno mai parlato di ragazze in quel modo, anche perché essendo milionari (o forse miliardari) le ragazze cadono ai loro piedi e non devono certo conquistarsele. Ah come sono volgari dottor Elkann questi nostri (non suoi) "amori ancillari" per dirla alla Guccini! E poi sarà vero che le cose sono andate veramente come raccontate? Se dei ragazzi si mettessero a parlare di ragazze, oggi che a 11 anni iniziano a guardare Youporn, ebbene lo farebbero in modo molto osceno. Insomma lo scrittore si è scandalizzato davvero per poco, se così sono andate le cose, e si dovrebbe scandalizzare per ben altro, ma gli stessi italiani dovrebbero scandalizzarsi per gli incendi dolosi, la cattiva gestione del dissesto idrogeologico, della cosa pubblica, etc etc. Un grande critico e italianista ha difeso Elkann scrivendo che non sempre l'io lirico coincide con l'autore. E allora è pura finzione? È tutto uno scherzetto? Non c'è niente di autobiografico? Su…via…non nascondiamoci dietro a un dito! E poi in letteratura non esistono opere molto più "sboccate" di quei discorsi di quei lanzichenecchi? Se quei ragazzi erano lanzichenecchi, vorrei sapere cosa ne pensa Elkann de "I ragionamenti" dell'Aretino? Non dico di fare come Pasolini che viveva gomito a gomito con i ragazzi di borgata, ma ogni tanto al Nostro scrittore famoso stare in mezzo alla gente, quella vera e che non arriva alla terza settimana del mese, farebbe bene! Certo ho guardato da ragazzo molto spesso la trasmissione televisiva condotta da Elkann e mi sarei aspettato qualcosa di meglio da una persona sobria, elegante, intellettuale, educata come lei. Mi sarei aspettato un altro aplomb. E poi "la Repubblica" non è uno sfogatoio. Ma a onor del vero oggi noi nip (not important person) possiamo scrivere ogni fesseria sui social, quasi impuniti, e al contempo i vip, che non hanno più paura di nessuno, possono dire, scrivere, fare ciò che vogliono (salvo poi bollare noi, il popolo come degli hater patologici). In definitiva oggi, nip o vip, si prendono licenze poetiche, che decenni fa sarebbero state impensabili.
Io porrei l'accento comunque sul fatto che lo scrittore sia ipersensibile e abbia un limite di sopportazione molto basso. E poi vorrei far ricordare a tutti che stare in società significa sopportarsi a vicenda. Invece di leggere il Financial Time consiglierei allo scrittore di rileggere "Il trattato sulla tolleranza" di Voltaire e poi anche quello di Locke. Bisognerebbe prima di misurare la disumanità e l'ignoranza altrui fare i conti con la propria: discorso valido per tutti. Inoltre bisognerebbe ricordare il concetto di non-luogo di Augè. Il treno è un non-luogo, dove per alcune ore bisogna convivere forzatamente con degli sconosciuti, nostro malgrado. Ma essendo un non-luogo ha anche dei vantaggi, specialmente se il viaggio è a lunga percorrenza: si può conoscere gente nuova, si può raccontare a sconosciuti la nostra vita, confidandoci totalmente, oppure si può inventare vite immaginarie. E vorrei concludere scrivendo a coloro che danno addosso a Elkann che chiunque nella sua vita ha apostrofato il prossimo con brutte parole (non siamo ipocriti), attribuendogli gli epiteti di gentaglia, rozzo, incivile, troglodita e peggio ancora. Anzi dare del lanzichenecco non è una grave offesa, non è troppo volgare e dispregiativa. Ma allo stesso tempo bisogna ricordare che siamo sempre i lanzichenecchi di qualcuno, come ha ricordato lo scrittore Paolo Di Paolo. E chissà…forse lo stesso Elkann era un lanzichenecco per il suocero Gianni Agnelli!
lug 212023

Non bisognerebbe mai stroncare libri di poesia italiana
PERCHÉ …
se vendono come i libri di Andrew Faber, Guido Catalano, Franco Arminio, Gio Evan, allora sono manna per le case editrici che possono fare cassa. Quindi non bisogna rompere gli zebedei, anche se forse quella non è vera poesia.
se non vendono certi libri, non bisogna far "piovere sul bagnato", per usare un'espressione di Montale.
i poeti, veri, aspiranti, sedicenti se la prenderanno personalmente con voi, in quanto la stroncatura è per loro una ferita narcisistica.
molto raramente una stroncatura insegna davvero qualcosa a un poeta o ai lettori.
stroncando si suscita timore reverenziale ma non si cucca.
tra tutta la poesia pubblicata solo una minuscola parte raggiunge il livello minimo di decenza. Se si dovesse stroncare tutto ciò che non è decente, non si finirebbe più. Stroncare solo qualcuno significa avercela con lui o fare comunque un'operazione faziosa o ingiusta. O si stronca tutti i pessimi poeti o non si stronca nessuno. Portare uno sfortunato come exemplum è ingiusto.
bisogna considerare la buona fede e la buona volontà di chi scrive versi. Ci vuole pazienza, umana comprensione, un minimo di sopportazione.
in quest'epoca dominano incontrastati il narcisismo e l'esibizionismo. I poeti non sono da meno. Quindi bisogna tollerare questi disturbi psicologici, che il nostro tempo slatentizza.
anche scrivere brutti versi è una passione innocente. Che male vi hanno fatto i cattivi poeti in fondo?
si rischia sempre più spesso di stroncare per puro gusto personale.
i poeti, veri o presunti, credono molto in quello che scrivono. Lasciamoli credere in ciò che vogliono. Anche nelle loro pessime cose.
non è colpa dei poeti se le persone in genere considerano grandi poeti coloro che sanno semplicemente andare a capo.
anche chi stronca si può sbagliare.
stroncare è una pessima azione.
stroncando si fa del male al poeta più che del bene.
ogni poeta ha bisogno di essere incoraggiato e non demoralizzato.
stroncando si uccide un sogno.
si può sempre criticare i punti deboli e i difetti di un libro in modo privato, comunicandoli solo al poeta.
non vale la pena di stroncare.
una stroncatura potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso di un poeta depresso e indurlo al suicidio.
stroncare è un modo letterario di menare le mani.
solo pochi hanno davvero l'autorevolezza per stroncare.
ma non vi fanno un poco di tenerezza i pessimi poeti?
oggi l'epiteto di poeta è un contentino che danno a molti.
i poeti, veri o presunti, nella maggioranza dei casi pubblicano a pagamento e criticarli negativamente dopo che si sono accollati certe spese editoriali è un piccolo atto sadico, di cattiveria, questa volta gratuita.
la stroncatura non cambia il mondo della comunità poetica, né il mondo editoriale.
la stroncatura è un genere datato, ormai finito.
la stroncatura in Italia non è quasi mai obiettiva, è sempre faziosa. Il critico prende di mira i suoi nemici giurati e poi osanna i suoi amichetti, i suoi sodali e naturalmente ha un occhio di riguardo per gli amici degli amici. Purtroppo, diciamocelo francamente, è davvero così.
la critica letteraria non può essere per niente obiettiva, perché mancano canoni estetici, metri di giudizio con cui valutare e ismi in cui incanalare gli autori, come un tempo.
la stroncatura è un opinione molto discutibile, che viene presentata come un dogma o quantomeno come una certezza assoluta.
bisogna valutare anche le conseguenze psicologiche e la sofferenza interiore di chi viene stroncato.
chi stronca si mette su un piedistallo e si considera superiore.
non è detto che il critico abbia ragione a tutti i costi.
siamo tutti fallibili, sia chi scrive versi, sia chi li critica.
ci vuole bonaria indulgenza, poiché siamo tutti esseri umani.
la letteratura non è una scienza esatta. Nemmeno nessuna scienza oggi è esatta.
per quieto vivere è meglio non stroncare. Stroncare significa farsi dei nemici.
alcuni poeti sono convinti di essere grandi poeti. Lasciateli pure vivere delle loro albagie, delle loro illusioni.
alcuni estimatori di questi poeti si sentirebbero feriti o considerati degli idioti.
il mondo poetico italiano è già in una condizione desolante. Non affossiamolo ulteriormente.
i poeti italiani hanno già tantissimi detrattori.
ci penseranno i posteri, se ci saranno, a distinguere il grano dal loglio.
la poesia è marginale e stroncando a ogni modo non si desta l'interesse.
stroncare è pura partigianeria, intesa nel senso più deteriore del termine, spacciata spesso per militanza.
stroncando si dà troppa importanza alla vittima.
la vittima potrebbe farvi una causa civile.
meglio il silenzio, l'indifferenza al clamore che suscita una stroncatura.
al mondo d'oggi chiunque trova il diritto di replica e finirebbe tutto con una rissa sui social o sui blog letterari senza esclusione di colpi o quasi.
stroncare non è più pedagogico
stroncare è una perdita di tempo.
la poesia italiana è una piccolissima torta in cui troppe persone vogliono una fetta.
ci possono essere poeti, veri o presunti, che potranno perseguitarvi e diventare vostri troll, hater, stalker.
stroncare può essere considerato un atto di bullismo o cyberbullismo.
stroncare spesso significa partire lancia in resta, accusare per partito preso senza ragionare con equanimità.
stroncare è manifestazione di puro livore.
dei punti di forza ci sono in ogni libro e nella stroncatura vengono omessi, dimenticati, totalmente rimossi.
chi lo dice che dietro a una stroncatura ci sia dietro una questione personale, una ripicca, un'antipatia, un'idiosincrasia, una vendetta?
nessuno sa più stroncare come una volta.
uno si fa terra bruciata nella comunità poetica.
dietro a ogni libro c'è una persona che merita rispetto della sua dignità umana.
anche la pubblicità negativa è pur sempre pubblicità.
si rischia di essere divisivi.
si rischia di non finirla più. Il poeta stroncato passerà alla controffensiva. Alcuni lettori commenteranno, dicendo che non sono d'accordo. La discussione potrebbe tirare per le lunghe.
stroncando non si controbilancia la moltitudine di elogi e di endorsement fatta da tanti recensori ai poeti.
la stroncatura viene ritenuta un atto di lesa maestà.
ci sono cose molto peggiori di scrivere brutti versi: ad esempio criticare malamente brutti versi, sentendosi superiori.
una bugia innocente è meglio di una verità amara.
anche i migliori intellettuali e le migliori menti possono scrivere brutti versi. Nessuno ne è immune.
tanto i poeti comunque continueranno a scrivere ostinati e non si autocensureranno.
spesso il critico, giunto a una certa età, intraprende l'attività poetica e allora le stroncature potrebbero ritorcerglisi contro.
la comunità poetica potrebbe esercitare una damnatio memoriae da morti.
certi pessimi libri di poesia sono davvero sotto la soglia del giudizio critico di un qualsiasi recensore onesto e allora non bisogna scriverne.
chiunque al mondo d'oggi pensa di avere diritto a una buona reputazione di poeta.
la stroncatura suscita gli stessi bassi istinti sadici e voyeuristici di chi guardava bruciare Giovanna d'Arco.
chi lo dice che in futuro quei brutti versi non saranno ritenuti dei capolavori?
le stroncature non vanno più di moda.
le agenzie letterarie non vi pagano se scrivete stroncature.
una stroncatura tira l'altra e troppe stroncature creano il deserto.
prima di stroncare i libri di poesia gli stessi critici dovrebbero fare molte denunce sociali per questioni molto più importanti.
è meglio parlare bene dei migliori che male dei peggiori.
facendo un'analisi costi/benefici, uno ci guadagna di più a non stroncare.
lug 142023
L'Innamoramento è qualcosa che proviamo tutti nella vita. Lo hanno provato anche santi e assassini, orgiastici e casti, papi, milionari e barboni. Hanno un bel dire certi/e che dicono agli altri: "tu non sai cos'è l'amore", come se fosse qualcosa di esclusivo, qualcosa che riguarda solo loro, perchè hanno nobiltà d'animo, perché gli altri sono incapaci d'amare. In realtà è un sentimento universale, la cui fisiologia (si pensi alla descrizione che ne fa Stendhal) e la cui neurochimica sono ben noti (l'ho già scritto in un altro articolo, ma lo ribadisco, dato che tanti faticano ad accettare questa cosa). Secondo studi recenti sappiamo che negli innamorati si registra un aumento di dopamina e una diminuzione di serotonina. Ogni innamorato è euforico, ossessivo e se viene rifiutato cade spesso in una fase depressiva. Ogni innamorato "impazzisce". Non a caso nella letteratura Tristano e Isotta bevono un filtro d'amore che fa loro trasgredire le regole sociali e l'Orlando furioso perde il suo senno sulla luna. Ma se qualcuno vi dice che non avete mai provato la comunione delle anime, la fusione dei corpi, perché non siete mai stati ricambiati quando eravate innamorati, voi canticchiategli la canzone di Madame "Il bene nel male", dove dice: "L'amore è di chi prova amore e non di chi lo riceve". Ma perché ci innamoriamo sempre dello stesso tipo di persone oppure sempre di persone diverse? C'è chi dice che cerchiamo sempre una persona opposta per completarci meglio e quindi spiega tutto con la complementarità, mentre altri dicono che cerchiamo una persona simile ("chi si somiglia, si piglia"). In realtà la questione è mal posta. Secondo Freud ci sono solo due tipi di innamoramento, ovvero due tipi di scelta dell'oggetto "pulsionale": l'innamoramento narcisistico (in cui si proietta spesso la miglior parte di noi sull'altra persona, idealizzandola) oppure l'innamoramento anaclitico (deriva dal greco, significa appoggiarsi a, in cui si fa riferimento agli archetipi parentali, ovvero alle figure genitoriali, ci si appoggia quindi a una figura genitoriale; ci si ricordi ad esempio del complesso di Edipo, in cui il bambino si innamora della madre).

(tramonto alla Sozzifanti. Foto di Emanuele Morelli)
Secondo Freud quando scegliamo un (s)oggetto d'amore lo possiamo fare solo in due modi: trovando il nostro io nell'altra persona (innamoramento narcisistico) o trovando una figura genitoriale nell'altra persona (tipico è l'esempio della donna che cerca il padre negli uomini). Ma a mio avviso, e qui vado contro Freud, esistono anche uomini che si innamorano molto anti-edipicamente di donne che sono opposte e inverse rispetto alle caratteristiche della madre. Può accadere comunque che una persona abbia nella sua vita tre innamoramenti narcistici e cinque innamoramenti anaclitici oppure dieci innamoramenti narcisistici oppure dieci innamoramenti anaclitici e questo spiegherebbe di volta in volta la grande somiglianza o la grande varietà delle persone amate: capite che non è proprio la stessa cosa della complementarità, mentre è vero che nell'innamoramento narcistico troviamo una persona che ha dei tratti simili a noi, anche e soprattutto perché ci siamo rispecchiati in lei. Invece chi ha sofferto di depressione anaclitica nell'infanzia, dovuta alla perdita di un genitore, di entrambi oppure dell'abbandono di uno o entrambi tenderà ad avere da adulto/a degli innamoramenti anaclitici. A ogni modo di solito le persone nella vita tendono a innamorarsi solo in un modo (narcisistico o anaclitico). Che tipi di innamoramenti erano quelli di Dante e Petrarca? Forse narcisistici, ma nessuno può dirlo con esattezza. Inoltre esistono anche altre due teorie: ci sono psicologi che ritengono che l'innamoramento sia dovuto a una scelta autonoma, quasi razionale, non credendo al colpo di fulmine, e ci sono studiosi che riprendono il concetto di desiderio mimetico di R.Girard, secondo cui i nostri desideri prendono come riferimento i desideri altrui e noi imitiamo gli altri anche nel desiderio, detto in parole povere, noi desideriamo, secondo questa teoria, ciò che desiderano gli altri. In questi tempi di omologazione di massa e di conseguenza di omologazione dei gusti il concetto di desiderio mimetico è sempre più importante. Comunque la scelta del (s)oggetto d'amore in buona parte dei casi è eterodiretta, anche se si dice che si è liberi d'amare. Come vedete la faccenda è complicata, articolata, controversa, di non facile interpretazione.
lug 052023

Lo scriveva già Schopenhauer: "La vita è un pendolo che oscilla tra il dolore e la noia". E Leopardi scriveva che la morte "ogni gran dolore, ogni gran male annulla". Una delle più importanti domande che si fa la filosofia dalla notte dei tempi è la seguente: "Perché l'uomo soffre?"
La prima domanda della teodicea (cosa si può dire di Dio) è la seguente: "perché, se esiste Dio, esiste anche il male?", cioè ci si chiede quale sia il senso ultimo, escatologico, finale del male. In medicina ci sono state diverse teorie del dolore: dal localizzazionismo, alla teoria del cancello (che, nonostante alcune lacune, aveva il merito di dare la priorità della percezione del dolore al midollo spinale e al sistema nervoso centrale), ad altre più recenti. Si usa distinguere il dolore fisico da quello esistenziale. Ogni volta che proviamo dolore ci chiediamo: "perché proprio a me?"
Spesso non riusciamo a trovare un senso, una ragione. Consideriamo quasi sempre il nostro dolore di primo acchito un'ingiustizia o una cosa assurda, che sfugge alla nostra comprensione. Ma dovremmo chiederci anche "perché proprio a me?" quando ci toccano delle cose belle nella vita.
Noi esistiamo anche per assorbire, comprendere il dolore altrui. Gli altri sono importanti per noi non solo perché ci possono aiutare a ridurre o a eliminare il nostro dolore, ma perché con gli altri possiamo condividerlo e gli altri possono capirlo, rincuorandoci, sollevandoci. Stare in società significa anche alleviare le pene altrui e farsi alleviare le pene proprie. In una società decente il dolore si rispetta e si condivide. In una società un minimo umana la partecipazione al dolore supera l'indifferenza generale. C'è chi sostiene che esista il dolore perché esiste il male. Eppure si cerca sempre di trovare un senso al dolore, una sua utilità, un insegnamento e mille risvolti positivi. Insomma non tutto viene per nuocere. Eppure molto spesso quando soffriamo ci chiediamo che ce ne facciamo del nostro dolore, in definitiva a quale pro? La risposta non sempre è facile e immediata, spesso non è portata di mano. Il fatto che il dolore non venga distribuito equamente lo consideriamo una grande ingiustizia e viene subito da pensare che a molte brave persone vengono date sofferenze atroci, mentre noti farabutti se la spassano e si godono una bella, lunga vita. Insomma la constatazione che non è uguale per tutti è sempre molto amara, a volte rabbiosa. I moralisti e la Chiesa, stessa secoli fa, pensavano che la peste fosse una punizione divina. Eppure la Bibbia con la storia di Giobbe ci avverte che anche gli uomini giusti possono avere tutte le sfortune e le afflizioni di questo mondo. La stessa Chiesa ha considerato spesso più tardi il dolore come un'espiazione su questa Terra dei propri peccati. Questa nostra società è edonista, ovvero c'è una ricerca smodata di ricerca del piacere, ed è anche biopolitica, come ci insegna Foucault, ovvero cerca di eliminare il dolore e rimandare sempre più in là la morte di ognuno. Eppure c'è in ognuno di noi un lato sadomasochistico, più o meno pronunciato, che ci fa provare piacere a causare dolore agli altri e a noi stessi (si pensi ai comportamenti autodistruttivi, agli atti autolesionistici, ai cattivi stili di vita). A onor del vero nessuno sa con certezza se il dolore è maestro di vita. Secondo la psicologia consideriamo il dolore una fonte inesauribile di insegnamento per ridurre la nostra dissonanza cognitiva. Eschilo e i tragici greci erano dell'idea che il dolore aumentasse la conoscenza, la consapevolezza esistenziale. Cristianamente parlando il dolore è una prova a cui ci sottopone Dio e che ci fa crescere e maturare. A leggere attentamente Epicuro ci accorgiamo che riteneva già l'assenza di dolore un piacere. A conti fatti potremmo pensare che, una volta passato un dolore, non provarlo più è già un grande piacere, un grande sollievo, un'enorme fortuna. Ma purtroppo l'uomo, ogni uomo, dà per scontato il fatto di stare bene, non si rende conto che l'assenza di dolore è una manna dal cielo, a meno che non incappi nel dolore fisico, esistenziale, nel lutto, nella malattia, in un trauma, in una perdita affettiva. Nel dolore si scoprono le cose veramente importanti e prioritarie della vita, si eliminano quelle superflue: il dolore probabilmente ci rende davvero più umani, più saggi, più veri. Il dolore è il più efficace rasoio di Occam: ci fa vedere gli altri sotto una luce nuova, ci fa tagliare molti rami secchi inutili della nostra vita. Per Leopardi il patimento, ovvero soprattutto il dolore fisico, rende l'uomo più umano e meno insensibile ai problemi altrui. L'uomo però non accetta il dolore, soprattutto il proprio, perché siamo tutti biologicamente e ontologicamente molto egoisti nel nostro intimo. E perché? Perché, come ha scoperto la psicanalisi il dolore è l'anticamera della morte e l'uomo inconsciamente si ritiene immortale. Il nostro inconscio si considera immortale e questo è il motivo per cui ci svegliamo di soprassalto ogni volta che sogniamo di morire. Noi inconsciamente non accettiamo il dolore non solo per un fatto di sopportazione e di resistenza fisica e/o psicologica ma perché non accettiamo la nostra morte. Da giovani il nostro inconscio ha il predominio sulla rassegnazione della ragionevolezza: si considera la morte un evento talmente improbabile da pensarci immortali. Emblematico è il capolavoro "La morte di Ivan Il'ič" di Tolstoj. Il protagonista, il sillogismo "Cesare è un uomo. Tutti gli uomini sono mortali. Cesare è mortale" poteva accettarlo e capirlo perfettamente ma non riferito a sé stesso. Per Heidegger l'esistenza dell'uomo contemporaneo è inautentica, perché si perde nella curiosità, nell'equivoco, nella chiacchiera, nel "si dice". Ecco allora che per il filosofo tedesco l'unico modo per essere autentici è essere per la morte, cioè pensare alla morte come "possibilità di non esserci". Eppure l'uomo secondo Pascal trova qualsiasi escamotage, qualsiasi divertissement per non pensare alla morte. Rimuovere il dolore e la morte fanno parte della natura umana, perché fanno molta paura sotto ogni punto di vista. Vivere in superficie, con grande leggerezza ci viene così spontaneo e immediato. Oggi molto più che in passato. L'ars moriendi di conseguenza è ormai oggi scomparsa.
giu 072023Vorrei prendere in rassegna alcuni diari di scrittori e fare una considerazione a largo raggio. Ho scelto dei diari perché per me sono al contempo sguardi di dentro, testimonianza e memento mori.

"Il mestiere di vivere":
I più conoscono Pavese per essere stato l'autore di romanzi come "La luna e i falò", "Il compagno", "La bella Estate". Meno conosciute invece le sue riflessioni sulla vita, sulla poesia, sulla letteratura, presenti nel suo diario, costituito da annotazioni che vanno dal 1935 al 1950. Nemmeno i colleghi dell'Einaudi si immaginavano la sua disperazione, il suo feroce senso di solitudine. Questi aspetti li conobbero con la pubblicazione postuma di questo diario, dopo il suo suicidio nel 1950 a Torino in una camera d'albergo. Solo allora ebbero modo di leggere attentamente nelle pieghe più scure del suo animo e comprendere la sua paura di vivere, il suo terrore per il sesso e per le donne. Italo Calvino, che era uno degli amici, non aveva mai presentito nulla a riguardo. Quest'opera è permeata da un pessimismo di fondo, da una sfiducia continua verso gli altri. L'uomo Pavese non coltivava la speranza e questo si legge a chiare lettere. Forse la speranza la perse definitivamente dopo essersi innamorato, senza essere corrisposto, dell'attrice americana Costance Dowling. Però l'intellettuale -come ha intuito felicemente Sergio Solmi- si ribellava all'uomo e con questo diario si difendeva dall'idea del suicidio. Infatti pochi giorni prima di uccidersi scriveva sul suo diario: "Tutto questo fa schifo. Non parole. Un gesto. Non scriverò più". Questa è l'ultima frase di Pavese ed è una grande testimonianza del valore terapeutico della scrittura. Leggendo questo diario, si possono trovare considerazioni illuminanti sulla letteratura. Ne riporto alcune. Il 10 novembre 1938 annota: "La letteratura è una difesa contro le offese della vita". Il 22 marzo 1947 scrive a riguardo dei grandi temi della letteratura moderna: "Hemingway ha la morte violenta, Levi il confino, Conrad la perplessità dei mari del Sud, Joyce lo stereoscopio delle parole-sensazione, Proust l'inafferrabilità degli istanti, Kafka la cifra dell'assurdo, Mann il ripetersi mitico dei fatti". Allo stesso tempo si possono trovare riflessioni cariche di delusione, massime pervase da un sentimento di estraneità nei confronti della vita. Il 17 novembre del 1937 scrive: "È incredibile che la donna adorata venga a dire che i suoi giorni sono vuoti e tormentosi ma che di noi non vuole saperne". Il 21 novembre dello stesso anno troviamo: "No, non sono pazzi questa gente che si diverte, che gode, che viaggia, che fotte, che combatte, tanto è vero che vorremmo farlo anche noi".
"Il diario degli errori":
Nel “Diario degli errori” ci troviamo di fronte a una raccolta di scritti, che vanno dal 1950 ai primi anni settanta. Flaiano dipinge quell’Italia con pennellate colorate di ironia e pessimismo. Per capire di più dello scrittore bisogna ricordare che i rapporti con Fellini non erano sempre idilliaci e che l’unica figlia Luisa soffriva di problemi mentali, dovuti a una grave encefalite. Apparentemente il tema predominante di questi scritti è il viaggio. Ma questo può andare bene solo a chi vuole restare in superficie. In realtà Flaiano lo scrive subito, all’inizio del libro, che la noia e la malinconia ci perseguitano, ovunque andiamo. Ce lo dice subito che è meglio non viaggiare. I viaggi sono solo un pretesto per pensare ai paradossi dell’Italia. Flaiano elimina le mezze bugie e ci presenta mezze verità intaccate di scetticismo. Nei suoi scritti riflette totalmente l’essenza della sua personalità. È polemico, sarcastico, a tratti cinico, sempre disincantato. È un individualista, al di fuori di ogni logica di partito. È avverso al conformismo e all’impegno politico, in cui intravede sempre scaltro opportunismo. Intendiamoci: ha un orientamento politico, è antifascista ed anticomunista allo stesso tempo. Però non si schiera. Le sue annotazioni, i suoi divertenti calembour mettono alla gogna i malcostumi diffusi dell’epoca, svelano la pochezza dei falsi miti e delle false coscienze. L’Italia è un Paese in cui prevale l’idealismo. I politici non parlano chiaro. Gli intellettuali scrivono spesso libri poco comprensibili per chi non ha un bagaglio umanistico. Le leggi possono essere decifrate solo dagli avvocati. E Flaiano riassume questo atteggiamento culturale scrivendo che in Italia non esiste la verità perché la linea più breve tra due punti è l’arabesco. Non c'è speranza. Non c'è via di fuga. Non c'è ancora di salvezza. Flaiano non salva nessuno, neanche se stesso. Il suo pessimismo a mio avviso è sintomatico di una sua crisi interiore. Ma ecco un suo pensiero di questo “Diario degli errori”: “Italia, paese di porci e di mascalzoni. Il paese delle mistificazioni alimentari, della fede utilitaria (l’attesa del miracolo a tutti i livelli), della mancanza di senso civico (le città distrutte, la speculazione edilizia portata al limite), della protesta teppistica……”. Infine Flaiano ci ricorda che "vivere è una serie ininterrotta di errori, ognuno dei quali sostiene il precedente e si appoggia sul seguente. Finiti gli errori, finisce tutto”.
"L'età del Jazz":
Avevo letto la raccolta di saggi di Cioran, intitolata “Esercizi di ammirazione”, ed ero rimasto favorevolmente colpito dal commento che il filosofo aveva fatto su “The crack up” (in italiano"Il crollo") di Fitzgerald. All’improvviso una sera in una libreria mi imbatto in un Oscar Mondadori, intitolato “L’età del Jazz”. Mi metto a sfogliarlo e lo compro subito. Questo libro raccoglie annotazioni di diario, lettere, taccuini e quel che mi interessava più di tutto “La trilogia del fallimento”, tre saggi brevi in cui il grande scrittore descrive la sua condizione esistenziale e svela i suoi fallimenti. Fitzgerald aveva subito bruciato le tappe, raggiungendo il successo con “Di qua dal Paradiso” e con “Il grande Gatsby”. Negli anni '20 con la moglie Zelda era nel vortice della mondanità di New York. Stanchi della vita frenetica di New York, andarono a vivere sette anni in Costa Azzurra. Tuttavia non approdarono alla serenità. Fitzgerald diventò alcolizzato; alla moglie Zelda venne diagnosticata la schizofrenia. La parola Jazz è stata sinonimo di tre cose in quegli anni: sessualità, danza e musica. Erano gli anni del proibizionismo. Le ragazze si tagliavano i capelli e andavano a bere alcol nei locali clandestini insieme ai ragazzi. Ma alla fine Fitzgerald scopre che è stato tutto vano, che niente è restato di quegli anni. Le illusioni sono crollate. Il grande sogno è stato perduto per sempre. Questi li definisce i colpi che vengono dall’esterno. Ma esistono - come lo scrittore sa - anche i colpi che vengono dall’interno ed è questo lato Freud, che personalmente ritengo interessante. Alla base di tutto c'è un blocco psicologico, una sensazione di scacco matto esistenziale. Ho avuto l'impressione netta che tante conoscenze e tante amicizie con personaggi importanti, ricchi e colti non l'abbiano arricchito interiormente ma svuotato. Fitzgerald ritorna in sé. Scrive della propria inettitudine, del proprio torpore, della propria apatia. Con la mondanità aveva cercato di costruirsi invano un’ampia rete sociale, ma alla fine si accorge della perdita della sua identità. Si rende conto di non aver mai fatto scelte autentiche. Con questi scritti riconosce il fallimento e descrive addirittura che il proprio mondo interiore si è decostruito. Tutto inizia con l’insonnia. Ma la notte insonne diventa successivamente metafora della sua condizione esistenziale perché – secondo lo scrittore - nella notte dell’anima sono sempre le tre del mattino. L’autore chiarisce a sé stesso ed al pubblico la sua crisi, paragonando la sua esistenza a un piatto incrinato. Racconta di essersi ritirato dal mondo per due anni allo scopo di catturare silenzi interiori. Per due anni non ha vissuto nel mondo comune, ma in un mondo strettamente intimo e privato. La sofferenza interiore lo costringe a pensare e a scavare dentro sé stesso. Nonostante la crisi, Fitzgerald si interroga e cerca nessi logici, ma la cosa più interessante è che lo scrittore all’improvviso scopre il lato oscuro della sua personalità. Lì scorge contraddizioni ed enigmi: in una parola sola intravede l’abisso.

(Nella foto Morselli)
"Diario" di Guido Morselli:
Morselli proveniva da una famiglia agiata. Si laureò in legge. Lavorò per un breve periodo come impiegato. Fece la guerra. Poi scelse di non lavorare. Il padre, obtorto collo, accettò il volere del figlio e gli dette una modesta rendita. Per tutta la vita fu "un eterno dilettante". Tutte le case editrici rifiutarono i suoi romanzi. Eppure oggi è riconosciuto come un grande scrittore e un maestro di ucronie[1]! Anche Italo Calvino rifiutò i suoi lavori[2]. Eppure Calvino è stato anche un talent scout di scrittori come Daniele Del Giudice e Andrea De Carlo! Dopo il suicidio Calasso ebbe il merito di pubblicare le sue opere con Adelphi. Attualmente Morselli è letto dalla comunità letteraria. Diciamo che è un autore di nicchia. Giovani studiosi come Gilda Policastro, Alessandro Gaudio e Linda Terziroli si sono occupati di lui. Nel suo diario si dimostra un intellettuale a tutto tondo, capace di spaziare su vari rami dello scibile. Troviamo speculazioni filosofiche, considerazioni letterarie, riflessioni sulla vita. Riporto fedelmente una annotazione del suo diario, datata 6 novembre 1959: "Tutto è inutile. Ho lavorato senza mai un risultato; ho oziato, la mia vita si è svolta nella medesima maniera. Ho pregato, non ho ottenuto nulla. Sono stato egoista, sino a dimenticarmi dell'esistenza degli altri; nulla è cambiato né in me né attorno a me. Ho amato, sino a dimenticarmi di me stesso; nulla è cambiato né in me né attorno a me. Ho fatto qualche poco di bene, non sono stato compensato; ho fatto del male, non sono stato punito. Tutto è ugualmente inutile". Qualcuno potrebbe pensare che Morselli vedesse Dio come una entità suprema lontana, che si interessava pochissimo dell'uomo. In realtà lo scrittore, a onor del vero, considerava Dio addirittura "una psicosi". Tuttavia, seppur schivo e appartato, non era misantropo. Come scrive il 22 febbraio 1947: "Ieri sera prima di dormire ho riveduto me stesso (...), tornando a casa. Non avevo mai sentito così profonda pietà degli uomini come rivivendo l'immagine di quest'uomo che attraversava piazza del Mercato". Morselli alla fine non scriveva che per pochi amici intellettuali. Non ebbe mai il riscontro del pubblico. Il suo dramma era quello di non avere un ruolo. Per il mondo non era niente e non si occupava di niente. Per i suoi concittadini era solo un tipo stravagante e bislacco. Forse si suicidò perché sentì che tutto era "vanità di vanità", come scritto nell' "Ecclesiaste", oppure per "troppo amore della vita", come ebbe modo di scrivere. Nel mondo di oggi (in cui esistono una comunità letteraria online, i lit-blog, gli ebook e l'editoria a pagamento) ci saranno altri Morselli? Oppure il talento è destinato ad emergere sempre? Lo sapranno solo i nostri posteri.
Conclusioni:
"Le confessioni" di Sant'Agostino e "Le confessioni" di Rousseau sono opere di autoanalisi salvifiche per gli autori, dato che sono espiatorie. I "Saggi" di Montaigne hanno il merito di scoprire l'io dinamico e si contraddistinguono per il relativismo culturale, per il rispetto della dignità della propria persona oltre che di quella altrui. Invece le opere di Pavese, Fitzgerald, Morselli, Flaiano sono testimonianze della crisi di coscienza, ma non la risolvono. I loro autori sono messi alla prova e fanno naufragio. A mio avviso erano tutti troppo orgogliosi per chiedere aiuto. Accenno solo brevemente a "L'ombra e la grazia" di Simone Weil. In questi pensieri, estratti dal suo diario, la mistica dichiara che bisogna "accettare il vuoto", "distruggere l'io", "desiderare senza oggetto": obiettivi quasi impossibili per raggiungere alla fine la grazia di Dio. Mi chiedo se non c'è salvezza allora per coloro che non hanno la fede. Nelle opere di Pavese, Fitzgerald, Flaiano, Morselli c'è "l'ombra" senza "la grazia". Forse è per questo motivo che i loro nodi non si sciolgono e noi li sentiamo "nostri fratelli" per dirla alla Baudelaire. Simone Weil e Sant'Agostino sono encomiabili, ma quasi inarrivabili. Allo stesso tempo viene da chiedermi se si può rinsavire e salvarsi solo grazie all'altro, come vi riesce Pirsig grazie al figlio[3]? Ma quale è poi la causa della crisi di questi scrittori? Era solo la loro vita inautentica o quella di tutti? La loro crisi era psichicamente endogena oppure sintomo del declino della civiltà occidentale? Dipendeva da una interazione? Era esclusivamente loro il cupio dissolvi o era rappresentativo di una intera società? Difficile dirlo. Le loro crisi a mio avviso sono emblematiche riguardo alla condizione umana. A livello esistenziale siamo tutti unici e irripetibili. Dal punto di vista ontologico siamo una infinitesima parte del tutto. L'uomo nei secoli dei secoli è rimasto in conflitto tra queste due forze antagoniste, tra la sua grandezza e la sua miseria, tra il considerarsi un miracolo oppure una nullità. Con la contemporaneità le cose sono ulteriormente peggiorate. Le tragedie delle due guerre mondiali, la recente massificazione e burocratizzazione, una società consumistica e tecnologica hanno spersonalizzato ancora di più l'uomo contemporaneo, facendolo sentire sempre di più una nullità. Si è compiuta oggi la disantropomorfizzazione. Sono state molte le critiche al nostro mondo occidentale, definito "società opulenta" (da J. K. Galbraith), civiltà dell'immagine, società dei consumi, società di massa, "società dello spettacolo" (da Debord), etc etc. Per Marx la causa di tutti i mali è il capitalismo, per Nietzsche e i suoi epigoni il nichilismo, per Max Weber la razionalizzazione, per i cattolici la secolarizzazione, per Husserl "la crisi delle scienze europee"[4], per gli esistenzialisti l'angoscia della scelta, per gli anarchici lo Stato e l'autorità, per Freud la repressione degli istinti, per Camus l'assurdo, per positivismo e neopositivismo la metafisica, per McLuhan i condizionamenti dei mass media, per Jonas la mancanza di un'etica della responsabilità[5], per altri l'individualismo, per altri ancora la tecnocrazia, etc etc. Inoltre per Fromm nella contemporaneità è aumentata l' "aggressività maligna"[6] dell'uomo. Allo stesso tempo l'uomo occidentale ha sempre vissuto una grande conflittualità tra carnalità e spiritualità. Ci si ricordi del mito dell'auriga di Platone. Spesso l'uomo occidentale è un mistico bloccato, come Cioran, e allo stesso tempo un "pornografo inibito"[7], come si definiva in una sua poesia Sanguineti. Sono queste le concause che hanno portato alla crisi Pavese, Fitzgerald, Morselli, Flaiano? Forse avevano avvertito tutto questo? Difficile stabilirlo. Psichiatri come Krapelin, K. Jamison, L. Bretagna, Cassano, P. Duke, G. Hochman hanno stabilito un legame tra nevrosi e creatività. Ma se ciò fosse dovuto ad una causa esogena? In questa sorta di Repubblica di Licurgo è forse più probabile che gli artisti sviluppino delle nevrosi? Forse la stessa razionalità tecnologica ha complicato le cose agli scrittori. Tutto al mondo d'oggi deve essere fatto in nome dell’efficienza e del progresso.Tutti devono avere una utilità pratica. Non a caso due importanti scuole di pensiero americane contemporanee sono il pragmatismo e l'utilitarismo. Per dirla alla Moravia l'uomo oggi è un mezzo e non più un fine. La civiltà vuole costruire strade dovunque e fabbricare macchine sempre più veloci. Dell’evoluzione civile, etica, artistica e spirituale poco importa. Però Jung dichiarò che era più facile andare su Marte o sulla luna che penetrare nel proprio io. La scuola non può permettersi il lusso di educare all’autonomia di pensiero. Eppure è stata proprio l'obbedienza acritica all'autorità, lo spirito gregario, l'eseguire ordini imposti dall'alto a fare diventare molti tedeschi dei criminali nazisti (gli psichiatri la chiamano "sindrome di Norimberga" e la Arendt la chiamava "banalità del male")! Insomma gli umanisti sono dei falliti. In fondo sono sempre più coloro che disprezzano l'arte e la poesia come Bazarov in "Padri e figli". Vince in questo sistema antiumanista chi guadagna soldi. Vince chi si integra socialmente, chi arriva e si adegua al conformismo. Però anche chi scrive libri di successo e si realizza come artista non è detto che si realizzi come uomo: lo dimostrano Pavese, Fitzgerald, Flaiano. Oggi le cose sono degenerate; molti bestseller (la maggioranza sono bestseller di consumo) sono frutto di un mix di furbizia, marketing, ricerca grossolana di intrattenimento. Ci sono anche molti lettori, che pensano che i libri di Fabio Volo, Moccia, Susanna Tamaro siano dei capolavori. I lettori sono in fondo consumatori come altri. Seguono le mode e molto spesso fanno scelte eterodirette perché come sosteneva Gillo Dorfles si è ridotto l'elemento proiaretico[8]. Forse però, oggi come non mai, si può assistere al superamento di concezioni come quelle di cultura alta e di cultura bassa. Forse oggi anche gli intellettuali più raffinati sono Midcult[9]. Forse anche loro sono contaminati dalla cultura di massa. Quindi forse non c'è alternativa. Oggi sono pochi contro il sistema e l'ideologia del mercato, l'unica che è rimasta. Spesso con la scusa che il sistema si combatte dall'interno si finisce per accettare qualsiasi compromesso. Scrivere oggi significa adeguarsi ai dettami della società, cioè diventare commerciali, oppure fallire. Non c'è niente di nuovo sotto il sole: Eco aveva già distinto tra apocalittici ed integrati. Cercare di approdare al cosiddetto nervo delle cose, a una verità umana, per quanto parziale, significa fallire. Per la filosofia l'arte contemporanea dovrebbe provocare shock, straniamento, spaesamento: insomma un rovesciamento di prospettiva nei lettori. Spesso però gli scrittori di oggi non sono più impegnati. Ho sempre pensato che attualmente un'opera d'arte per essere tale richieda la presa di coscienza di una problematica e debba fornire una nuova chiave interpretativa del mondo. Però anche i creatori di opere d'arte non è detto che si affermino commercialmente né che si realizzino come uomini. Inoltre quanto dolore c'è talvolta anche nell'integrarsi socialmente! L'argomento viene trattato anche nel romanzo "Fiorirà l'aspidistra" di Orwell. Ogni artista dovrebbe scegliere idealisticamente se essere in o out dallo show-business. Invece oggi molti scelgono opportunisticamente, ma c'è sempre un prezzo da pagare quando si vende l'anima al successo o alla gloria postuma. Pavese, Fitzgerald, Flaiano non sembravano avere bisogno di niente ed invece non riuscivano a rapportarsi al mondo. Si adattavano al mondo, snaturandosi. Scrivevano capolavori e avevano successo, ma non riuscivano a trovare un senso. Come scriveva Pavese: "In genere è per mestiere disposto a sacrificarsi chi non sa altrimenti dare un senso alla propria vita". Ognuno in gioventù idealizza persone, mitizza luoghi e si pone aspirazioni irrealizzabili. Vivere significa spesso anche resistere e continuare, prima del definitivo rien ne va plus. Perdere significa talvolta maturare, crescere. Come scrive Guccini in "Canzone di notte n°3" anche "perdere ogni tanto ci ha il suo miele". Forse per uno neuropsichiatra riduzionista[10] questi scrittori erano solo depressi. Forse oggi psicofarmaci efficaci riducono l'ideazione di molti artisti, ma li salvano dal suicidio. Oppure i veri artisti sono destinati comunque a fallire a livello esistenziale, metafisico, commerciale. In fondo l'editoria fa parte anche essa dell'industria culturale e non guarda in faccia nessuno; non riserva un trattamento di favore a nessuno, neanche ai più talentuosi. Forse è sempre stato così. Forse la caratteristica precipua e intrinseca dello scrivere oggi è il fallimento. L. F. Celine era molto lucido a riguardo ed affermò: "I posteri saranno i cinesi e quelli se ne fregheranno altamente della mia letteratura fessa”. Sono memorabili anche le parole di Beckett, che valgono in senso lato: "Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio"[11].
Note
[1] Ucronia è un'opera di fantasia, spesso di fantascienza, in cui l'autore si immagina un fatto immaginario e lo sostituisce a un reale fatto storico. Gli autori di ucronie si chiedono cosa sarebbe successo se la storia fosse andata diversamente. Ogni ucronia si basa su una ipotesi controfattuale. Morselli ne scrisse due. In "Contro-passato prossimo" si immagina che la prima guerra mondiale sia stata vinta dagli Imperi centrali. In "Roma senza Papa" si immagina che il Papa si ritiri a Zagarolo.
[2] Potete trovare la corrispondenza tra Calvino e Morselli al seguente indirizzo:
http://mvl-monteverdelegge.blogspot.com/2013/03/caro-morselli-caro-calvino-il-no-di.html
[3] "Lo Zen e l'arte della manutenzione della bicicletta", Milano, Adelphi, 1988. Non è un diario ma un romanzo in parte autobiografico. Il figlio di Pirsig morì accoltellato a 23 anni.
[4] Per Husserl la società occidentale è in crisi perché le scienze oggettivano e quantificano tutto. In fondo già Galileo aveva stabilito la matematizzazione delle scienze. Husserl è stato profetico, se si pensa al fatto che il dottor Duncan MacDougall ha pesato l'anima. Secondo quest'ultimo le persone, morendo, perderebbero 21 grammi.
[5] Per Jonas dovremmo agire, mostrando responsabilità anche verso i posteri e l'ambiente.
[6] Fromm in "Anatomia della distruttività umana" scrive che l' "aggressività benigna" è quella necessaria per la sopravvivenza ed è quindi biofila. Invece l' "aggressività maligna" è quella ad esempio del sadico, finalizzata al piacere di opprimere l'altro, ed è necrofila. Secondo Fromm la competizione esasperata, la ricerca ossessiva di produttività, le frustrazioni della società hanno aumentato la distruttività umana. L'uomo in fondo è l'unico primate che non uccide i propri simili per sopravvivenza ma per altri motivi.
[7] Sanguineti usa questa espressione in "Reisebilder 16", pubblicata in "Wirrwarr", Milano, Feltrinelli, 1972.
[8] proiaretico, ovvero in estetica che riguarda una scelta autonoma, fatta in base alla propria inclinazione e al proprio gusto. È sempre attuale "La ballata della moda" di Tenco, che è morto nel 1967.
[9] Mi riferisco al libro "Masscult e Midcult" del sociologo Macdonald. Per quest'ultimo, il Midcult era "un terzo livello [...], una cultura media rappresentata da prodotti d'intrattenimento che prendevano a prestito anche stilemi dell'avanguardia, ma che era fondamentalmente Kitsch".
[10] Secondo il riduzionismo delle neuroscienze i disturbi dell'umore e i nostri stati mentali sono determinati dalla quantità di neurotrasmettitori. La depressione sarebbe causata esclusivamente da un deficit di serotonina. Saremmo quindi molto più determinati biologicamente di quello che si riteneva un tempo. Secondo la fenomenologia invece è l'esperienza vissuta che determina la visione del mondo di un individuo. Secondo la psicanalisi gli psicofarmaci inibiscono i sintomi, ma non possono niente sul disagio interiore di cui sono espressione.
[11] Citazione tratta dalla novella "Worstward Ho" (1983), che in un’edizione italiana è stato tradotta con il titolo "Peggio tutta", pubblicata in "In nessun modo ancora", Torino, Einaudi, 2008.
giu 052023
_0_o.jpg)
(Nella foto Sanguineti)
Si diceva e si scriveva anni fa che i bestseller erano fatti di "sesso e/o sangue e/o soldi". Difficile dire quali siano gli ingredienti o il filone giusto per fare un bestseller. Più si va avanti e più mi accorgo che sta prendendo piede il sentimentalismo. È vero che ci sono i gialli che vanno sempre di moda (Carlo Lucarelli, Maurizio De Giovanni, Loriano Macchiavelli, etc etc). Ma domina su tutto la retorica dei buoni sentimenti, che non ha a niente a che vedere col sentimentalismo etico, che permette la sana empatia, l'immedesimazione nella sofferenza e nel dolore altrui. Prevale su tutto un sentimentalismo deteriore e ricattatorio, che istiga alla lacrima facile. Il sentimentalismo è la via più facile per avere successo. È in voga quello che definirei un neosentimentalismo, raramente condito con un poco di dandismo estetizzante, talvolta condito con un certo neocrepuscolarismo alla buona. È di moda sia in prosa con ottimi successi di vendite, sia in poesia, dove prevalgono soprattutto soggettività e l'emotività. D'altronde cosa volete sperare? Negli anni di piombo sparavano e mettevano bombe, ma poi si commuovevano per le canzoni amore/cuore. La canzone italiana del secolo è "Piccolo grande amore" di Baglioni e non "Rimmel" di De Gregori. Oggi se guardi i profili social dei più ci sono le frasi sdolcinate d'amore, le foto degli animali domestici, i video youtube di canzonette sentimentali acchiappa like. È il modo più semplice per avere seguaci e consenso quello di essere sdolcinati, anche se falsi e ipocriti come Giuda. Il sentimentalismo è da sempre un tratto stilistico, definiamolo così, socialmente accettato. È quello più socialmente accettato di tutti. Le Liale vincono sempre. Ma ci sono anche degli intellettuali che vedono del sentimentalismo anche dove non c'è. Mi dispiace dirlo ma questo fu il caso anche del grande Sanguineti che vide in Bassani e Cassola delle "Liale del nostro tempo" e fu una critica a mio avviso troppo negativa e fuori luogo. Ma Sanguineti era un genio a cui molto si poteva perdonare e infatti lo stesso Cassola andava a braccetto con lui ed era suo amico. La filosofa Ilaria Gaspari è controcorrente e su "Domani" scrive un articolo riabilitando il romance, i romanzi rosa, affermando che finalmente ci siamo liberati dei pregiudizi su di essi. Un conto a mio avviso è oggettivare un sentimento. Un conto è sfruttare commercialmente l'ingenuità delle persone. Un conto è disprezzare ogni moto del cuore. Un conto è essere strappalacrime. Un conto è con la giusta motivazione di mettere distanza tra sé stessi e le passioni eliminare ogni residuo di emozione. Un conto è oggettivare un sentimento. Un conto è cercare di rimuovere dalla poesia e dalla letteratura ogni traccia di sentimento. Un conto è disapprovare e criticare a ragion veduta il sentimentalismo e un altro è avere una reazione spropositata, fare un fallo di reazione, che nel calcio porta spesso all'espulsione. In questo caso alcuni letterati vengono espulsi dal mercato. Ci sono ancora oggi dei critici che se vogliono attaccare qualcuno per partito preso o idiosincrasia, scrivono che è un sentimentale. È vero che chi è sentimentale di solito non è impegnato politicamente, socialmente, culturalmente. È vero che spesso chi scrive di sentimenti lo fa per non scrivere d'altro, perché scrivere d'altro è più problematico, scomodo, difficile e meno remunerativo. È vero che De Amicis insegnava qualcosa, formava le coscienze e oggi questo neosentimentalismo non è affatto didascalico, educativo, propedeutico. Insomma il neosentimentalismo di oggi non porta a niente, non è istruttivo, è fine a sé stesso. Così da un lato c'è chi vende molto con il neosentimentalismo e dall'altro c'è chi utilizza come discrimine per stabilire cosa è o non letteratura l'assenza o meno di sentimento. Sono due scuole contrapposte: da una parte questo neosentimentalismo commerciale, dall'altra l'intellettualismo freddo ed elitario. Non ci sono mezze misure, pochissimi trovano un'armonia, un connubio tra ragione e sentimento, tra intelletto e passione. Ecco così facendo una narrativa e una poesia a compartimenti stagni. Nei primi anni del duemila ci avevano provato a rompere gli schemi le cosiddette pornoromantiche, ovvero Carolina Cutolo (un suo libro per l'appunto si intitolava "Pornoromantica"), Pulsatilla ("La ballata delle prugne secche"), Gisela Scerman ("La ragazza definitiva"), ma oggi pochi parlano di queste scrittrici: allora c'era chi puntava sulla grande novità di ragazze che scrivevano sia dei loro sentimenti che delle loro esperienze sessuali, come le vecchie generazioni non avevano mai fatto, ma poi sono arrivati youporn, la diffusione del porno di massa, anche amatoriale, e sono molte le ragazze che fanno sesso e parlano di sesso, cosicché oggi è stato abbattuto qualsiasi senso del pudore. Insomma le pornoromantiche non fanno più scalpore. Così abbiamo romanzi commerciali che emozionano ma non sono letteratura e opere che sono letteratura ma non emozionano più i lettori. Abbiamo così romanzi di intrattenimento che fanno piangere e una letteratura che è troppo fredda, che non sa interessare più, se non gli addetti ai lavori. Così finiamo per avere degli scrittori facili che vendono molto e pretendono che le loro cose vengano ritenute letteratura per il solo fatto che vendono molto e dei letterati che non vendono e si arrogano il diritto di ritenere ciò che è letteratura e ciò che non lo è. Con questo non voglio criticare totalmente chi scrive bestseller sentimentali, perché non è semplice, altrimenti molti professori di letteratura scriverebbero, come si suol dire, bestseller sotto pseudonimo e i più non ne sono capaci (è anche vero che i più non vogliono arricchirsi in questo modo perché lo considerano una furbata scorretta). Insomma anche per scrivere dei bestseller sentimentali bisogna essere in sintonia con i gusti nazionalpopolari degli italiani o saper intercettare il pubblico, studiando tutto a tavolino. Bisogna cioè essere nazionalpopolari o fingere bene di esserlo. D'altronde anche un grandissimo scrittore come Flaubert, che voleva scrivere un romanzo sentimentale, finì per scrivere "L'educazione sentimentale", che è tutto, fuorché un romanzo sentimentale.
mag 202023

Nel mondo letterario si parla tanto di mafia culturale ed è a mio avviso un termine inappropriato perché la vera mafia si spartisce grandi quantità di soldi e tanto potere, mentre la comunità letteraria ad esempio si spartisce solo le briciole e sono tantissimi i galli nel pollaio. Non è quindi tanto la modalità o la tipologia ma lo scarso giro di affari e il mercato di vacche magre a rendere la cultura poco mafiosa. A essere malevoli si può parlare di mafia culturale, intendendo una mafia con la m minuscola (che non uccide le persone ma la vera cultura), quella dei favoritismi, degli abusi di potere, delle ingiustizie, dei privilegi, delle cattedre per nepotismo, clientelismo, etc etc. Insomma la mafia culturale è una mafia non solo da colletti bianchi ma anche da innocui dilettanti, che però dovrebbero dare per primi il buon esempio e invece non lo danno. Non solo ma il circolo virtuoso d'un tempo non esiste più, perché non necessariamente il prestigio culturale dà prestigio sociale e il prestigio sociale dà soldi. C'è chi sostiene che l'amicizia tra poeti o tra letterati, quella vera, non esista, ma esista solo quella interessata (insomma scambi di favori, do ut des, etc etc). I letterati dovrebbero stimarsi e poi diventare amici, mentre accade spesso che prima diventano amici e poi si stimano, ma poi è vera stima? Ancora una volta viene da chiedersi se esiste la stima disinteressata o soltanto nell'Iperuranio. L'importante, realisticamente parlando, non è la stima effettiva ma quella percepita: ricordate l'immanentismo di Berkeley, ovvero l'essere è essere percepito? Anche qui la stima è la stima percepita e così l'amicizia. Che poi si può stimare chi non si dimostra amico veramente? Si può stimare chi non ci stima e nutre un'idiosincrasia nei nostri confronti? Quanto sforzo ci vuole? Ci vorrebbe un'invidiabile obiettività e imperturbabilità d'animo, che pochissimi hanno francamente. Allo stesso tempo ci vuole imperturbabilità d'animo, stoicismo, grande correttezza nello stroncare un amico o dirgli anche solo privatamente che non ci piace il suo libro. Di solito uno non stronca e non esprime giudizi negativi per quieto vivere, per evitare rappresaglie e vendette. Poi ci sono le alleanze non solo tra sodali apparentemente disinteressati, ma anche tra letterati della stessa città, della stessa casa editrice, dello stesso partito, della stessa università. Quanti attestati di stima sono falsi e inautentici? Quanta disistima viene taciuta per interessi di ordine superiore, per cause di forza maggiore? Viene naturale per amor proprio stimare chi dimostra di stimarci, ma è molto difficile, quasi impossibile il contrario. Se qualcuno ci dimostra stima, finiamo per vedere di primo acchito solo i suoi punti di forza e i suoi lati positivi. Allo stesso modo se un genio ti critica finisci per cercare difetti, per trovare il pelo nell'uovo e sminuirlo. Ci vuole molta umiltà, assennatezza, modestia per accettare serenamente delle critiche, anche perché purtroppo anche nel mondo letterario a pensare male si fa peccato ma ci si indovina sempre e dietro a delle critiche o a delle stroncature c'è quasi sempre un motivo personale o ideologico, perché di solito i letterati non cercano guai e hanno un atteggiamento conciliante. Di solito il meccanismo è semplice. Queste sono le tattiche messe in atto dai letterati: se tu mi stimi, io ti stimo; se tu non mi stimi, io non ti stimo; se tu mi attacchi, io ti attacco; se tu non mi pesti i piedi, io non ti pesto i piedi. Di solito viene evitato l'attacco fine a sé stesso, la polemica sterile. Al contempo nessuno fa niente per niente, quasi niente viene fatto gratuitamente, a meno che a uno non gli importi niente di fare carriera letteraria (come me del resto), e chi fa un piccolo favore vuole essere ricompensato prima o poi. Esiste inoltre la polemica a distanza senza fare i nomi (si dice il peccato ma non il peccatore e anche si dice a nuora perché intenda suocera). Come se non bastasse l'amore e il sesso complicano tutto terribilmente. È tutto semplice fino a quando un genio come Giovanni Raboni si mette con un genio come Patrizia Valduga e scrivono poesie immortali, ma come la mettiamo con i compromessi sessuali o anche con le aspiranti poetesse sopravvalutate, proprio perché amate da un grande letterato? Come saggiamente cantano i Baustelle: "Perché l'amore rende ciechi se c'è e non distingui Sylvia Plath da un parassita". Tutte queste cose facevano dire alla Merini che il mondo dei poeti non è poi così male, ma è terribile il sottobosco poetico. Concludendo, sono due le scuole di pensiero a riguardo della mafia culturale: 1) c'è sempre stata, c'è, ci sarà ed è universale 2) è un male, un malcostume prettamente italico.
Nel frattempo la psicologia e la sociologia di poeti, scrittori, letterati italiani è molto semplice, quasi elementare, a tratti pavloviana procede per riflessi condizionati, a tratti risente del condizionamento operante con rinforzi positivi e negativi, e soprattutto è fatta di una buona dose di egocentrismo, vanagloria e meschinità, ma qualcuno obietterà che funziona così in tutti i settori e fa parte della natura umana. Basta lisciare il pelo o infastidire il letterato per vedere reazioni spropositate. L'ego dei poeti infine è ipertrofico, vuoi spesso per disturbo di personalità di base, vuoi per per troppe frustrazioni; basta davvero poco per essere amati oppure odiati, con l'aggiunta di un piccolo particolare da tener presente: se lodi un poeta lo ritiene un atto dovuto e dopo qualche giorno si scorderà di te, se invece lo critichi negativamente ti odierà a vita e se la legherà per sempre al dito (basta togliere un'amicizia o bloccare qualcuno su Facebook per essere odiati a vita per lesa maestà e queste ragioni prettamente personali non hanno niente a che vedere con la poesia né con la letteratura). Che poi niente è certo nel mondo letterario. Chi può davvero stabilire con certezza se tizio o caio è un poeta? Lo stabiliranno solo i posteri. In matematica di un un insieme si può stabilire con certezza se un certo elemento ne fa parte oppure no. In letteratura è men che meno in poesia questa certezza non c'è. Ogni autore, ogni poeta subisce un processo. Ai contemporanei spettano solo le indagini preliminari, ma la vera corte di cassazione sono i posteri, se i posteri ci saranno.
mag 092023

Oggi è il 9 maggio. 45 anni fa venne ritrovato il corpo dello statista Aldo Moro. Vorrei fare una breve riflessione...
In un Paese come il nostro in cui c'è stato un connubio tra materialismo spicciolo e un idealismo deteriore il terrorismo è stato vinto dai partiti, dalle istituzioni, dai sindacati, dal popolo, ma soprattutto dalla fine della guerra fredda (ammettiamolo pure). Qualcuno violento e fuori dalla storia è pur rimasto nella foresta a combattere una guerra già persa, ma nessuno oggi può far leva sul disagio sociale e trasformarlo in barbarie. Il terrorismo nero è stato subito vinto perché non c'è stata da anni alcuna possibilità da parte di nessuno di sfruttare lo spontaneismo armato (nato per esempio dai fatti di via Acca Larentia). Quella contrapposizione di forze (gli opposti estremismi) non esiste più. Quello che è accaduto un anno fa al circolo Arci di Reggio Emilia con cretini incappucciati che cantavano inneggiando alle Br però dimostra che c'è più indulgenza per il terrorismo rosso. C'è da decenni un pregiudizio negativo nei confronti delle vittime delle br ("se la sono cercata", "erano colpevoli", "erano imperialisti", "erano servi dello Stato") e un pregiudizio positivo nei confronti dei brigatisti rossi ("hanno le loro ragioni", "sono intellettuali", etc etc). Gli intellettuali dell'epoca non hanno aiutato il popolo, coniando perfino lo slogan "né con lo Stato, né con le Br" (frase erroneamente attribuita a Sciascia che non l'ha mai detta né scritta), ma non c'è da stupirsi perché erano gli stessi che ce l'avevano a morte con Luigi Calabresi e lo lasciarono solo al suo destino. Le Brigate Rosse sono finite quando hanno ammazzato un operaio sindacalista (Guido Rossa) e un antennista fratello di un pentito delle Br (Roberto Peci). Non potevano più avere un consenso popolare (poco tempo prima se le Brigate Rosse avessero potuto presentarsi come partito avrebbero preso 200000 voti secondo i sondaggisti dell'epoca). Bisognerebbe considerare che Aldo Moro era innocente come la povera Maria Fresu (una vittima della strage di Bologna), anche se il suo lavoro comportava più responsabilità e quindi più rischi. Sicuramente il terrorismo nero colpiva nel mucchio la povera gente in modo efferato, faceva delle carneficine, ma non bisogna mai giustificare o addirittura quasi assolvere i brigatisti rossi, la cui versione di comodo è che la loro violenza organizzata nasceva solo ed esclusivamente come reazioni alle stragi, mentre colpiva a freddo e a tradimento onesti lavoratori e padri di famiglia. Bisognerebbe considerare che i veri colpevoli dell'estremismo rosso non sono i giovanotti autoesaltati e ubriacati ideologicamente che uccidevano, ma i cattivi maestri che li hanno indottrinati e armati: ancora non è stata fatta piena luce su questo e i cattivi maestri non hanno pagato del tutto, sicuramente hanno pagato troppo poco; sono stati proprio quei professorini freddi e spietati come Senzani che hanno armato giovani che stravedevano per loro. Così questi terroristi hanno distrutto vite altrui e le loro. Ma ora possiamo dirlo serenamente che, salvo improbabili colpi di coda, tutto è finito, ma ciò deve servire da lezione. Non deve finire nel dimenticatoio. Infine riporto a memoria una dichiarazione del terrorista nero Giuseppe Fioravanti, che in un'intervista dichiarava che quelli della sua generazione si erano scannati tanto per poi fare anni di galera e ritrovarsi certa gente al governo. Era l'amara constatazione del proprio fallimento umano e politico, nonché di una parte della sua generazione. Basta avere una visione un minimo (ma un minimo) approfondita per sapere che le Brigate Rosse erano infiltrate per quanto riguarda la base ed erano infiltrate ai vertici, pur non trattandosi solo di "sedicenti Brigate Rosse", mentre il terrorismo nero era diretto dalla P2 e dai servizi segreti deviati (o a essere più precisi dalle deviazioni dei servizi segreti, perché non tutta l'intelligence era coinvolta ma solo una parte, seppur consistente): c'era la guerra fredda, l'Italia era sotto la Nato e allo stesso tempo nel nostro Paese c'era il più grande partito comunista occidentale; diciamocela tutta: se Aldo Moro non fosse stato ammazzato dalle Br, c'erano i terroristi neri che volevano probabilmente fargli un attentato, perché in questa contrapposizione brutale di forze politiche molti non volevano il compromesso tra Dc e comunisti e invece i dorotei lo volevano, alcuni perché pensavano, a torto o a ragione, che il marxismo fosse una dottrina ideologica e scientifica superiore e che con i suoi rappresentanti bisognasse allearsi, anche perché in quel particolare periodo storico esprimevano meglio le istanze sociali del popolo. A ogni modo ognuno deve mettersi contro i figli di buona donna (con tutto il rispetto per le loro madri; è solo un modo di dire) del suo tempo. Terroristi rossi e neri ormai sono di un altro tempo. Così si spera.
mag 012023
(Nella foto il poeta Leonardo Sinisgalli)
Nel 1959 lo scrittore e scienziato Snow pubblica "Le due culture", in cui tratta delle incomprensioni, delle divergenze, addirittura dell'incomunicabilità tra umanisti e scienziati. Scriveva che gli umanisti sapevano pochissimo di scienza, che gli scienziati sapevano pochissimo di arte e che quando si ritrovavano non avevano argomenti di conversazione. Insomma non parlavano più la stessa lingua. Le cose a mio avviso sono peggiorate in questi ultimi anni. Oggi c'è ormai una sola cultura, quella tecnologica-scientifica. Io affermerei che non esiste più la cultura umanistica in un mondo in cui tutto è cultura, in cui qualsiasi cazzata viene riconosciuta come elemento culturale. Oggi a onor del vero non è cultura ciò che un tempo era cultura, ma viene ritenuto cultura tutto ciò che è e porta business. Sono finiti i tempi in cui per diventare ragionieri o periti bisognava sapere abbastanza Pascoli e Montale. È finita l'epoca del latinorum! Purtroppo e per fortuna allo stesso tempo! Oggi basta qualche nozione umanistica raffazzonata, approssimativa ed en passant anche nei licei per andare avanti. Oggi c'è più tecnologia e i giovani sono più informatizzati, ma qualcosa abbiamo perso per strada, per esempio le giovani leve hanno perso senso critico e competenze linguistiche (prendendo con beneficio di inventario la tanto citata ricerca di Tullio De Mauro sul numero di parole conosciute dai ginnasiali). Sono finiti anche i medici di un tempo, che avevano una buona formazione umanistica, non solo perché magari avevano fatto il Classico ma perché leggevano molti romanzi, molti libri di poesie, molti saggi e andavano a vedere le mostre, etc etc. Oggi i professionisti e le persone di cultura versate in un campo specifico non sono curiose e onnivore come un tempo, perché pensano, a torto o a ragione, di togliere parte del loro tempo allo studio e all'aggiornamento della loro disciplina. Oggi la vita scorre frenetica, non c'è più tempo e poi in fondo decenni fa, nel secolo scorso, per una persona di buona cultura era un imperativo informarsi e rimanere aggiornata su tutto. Oggi nessuno lo esige più. Oggi ci sono anche laureati in discipline umanistiche disoccupati, precari o sottoccupati, mentre ci sono tecnici che non hanno studiato affatto e che guadagnano molto bene, addirittura sono così richiesti che non si trovano mai, spesso si dimostrano tronfi e maleducati (al limite della nostra capacità di sopportazione spesso). Qualcuno dirà che è la legge della domanda e dell'offerta. C'è inoltre nella mentalità comune l'affermarsi della supremazia degli ingegneri sugli umanisti. È la solita tiritera: ingegneria è necessaria, diventare ingegneri è più difficile. Sono gli stessi che considerano gli umanisti dei cretini per aver scelto quel corso di studi e li rispettano raramente, ovvero solo se si affermano culturalmente, anzi spesso solo economicamente. È vero che le facoltà umanistiche sono più facili di quelle scientifiche (a Pisa ad esempio il preside di ingegneria Villaggio aveva lasciato un cartello sulla sua porta dove era scritto "ingegneria deve essere difficile" e in quella facoltà i professori agli studenti impreparati tiravano il libretto universitario fuori dalla finestra). È vero che ci sono nelle facoltà umanistiche alcuni (non tutti) professori sessantottini, che dispensano buoni voti a molti. Ma è disonesto intellettualmente oltre che falso far passare il messaggio che tutti o quasi riuscirebbero, se si iscrivessero, a laurearsi in una disciplina umanistica, perché anche in queste facoltà esistono a onor del vero i ritiri. Che poi le nostre facoltà umanistiche sono più facili anche perché tutte le nostre scuole elementari, medie, superiori sono più umanistiche che scientifiche e Leopardi viene già fatto alle elementari, mentre le derivate e gli integrali vengono fatti in modo decente solo nell'ultimo anno del liceo scientifico! Che poi un conto è laurearsi in lettere e un conto è diventare letterati perché per fare la prima cosa bisogna studiare un centinaio o poco più di libri di testo, mentre per fare i letterati bisogna leggerne qualche migliaio! Che poi a ben vedere ci sono ingegneri e matematici tedeschi, inglesi, americani, cinesi, giapponesi, indiani che sono più preparati dei nostri italiani, mentre gli umanisti italiani sono rispettati e stimati in ogni parte del mondo, pur avendo lo svantaggio di scrivere in italiano, così poco diffuso nel mondo! Insomma bisognerebbe stare a vedere e considerare saggiamente in cosa consista veramente l'eccellenza. A onor del vero a ogni modo secondo la mentalità comune vale il detto "conta l'articolo quinto, ovvero chi ha i soldi ha vinto". Importante è fare soldi e non pensarci più, come cantava Angela Baraldi negli anni '90. Inoltre qualcuno dirà che ci sono troppi laureati in Italia (quando i dati dimostrano l'esatto contrario) o che comunque ci sono troppi laureati nelle discipline umanistiche, mentre invece le facoltà universitarie non formano tecnici. Obiezione fondamentale a questo tipo di discorso: l'Italia non eccelle nel mondo per gli ingegneri, i matematici o gli scienziati (ci sono nazioni che ci surclassano, come ho precisato prima), ma per la grande presenza di artisti, poeti, scrittori, per le bellezze naturali e artistiche, che non sappiamo valorizzare ancora. Ci sono nazioni con molte meno bellezze e molti meno capolavori che ci passano di gran lunga avanti nel turismo e soprattutto nel turismo culturale. Vengono chiamate città d'arte Firenze e Venezia, mentre molte più città italiane dovrebbero essere considerate città d'arte. Se borghi e città italiani venissero fatti veramente conoscere agli stranieri quanti alberghi, bed and breakfast, guide turistiche, bar, ristoranti, etc etc ci sarebbero in più rispetto a oggi? L'Italia potrebbe vivere quasi di rendita grazie al turismo culturale internazionale, senza inquinare e senza bisogno di industrializzarsi di più. Invece ogni governo spreca molte risorse economiche in spese militari e investe poco nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico, del paesaggio, dell'ambiente. Invece vogliamo seguire l'onda. Vogliamo essere conformisti, seguire a tutti i costi gli altri Paesi più ricchi, senza renderci conto che non stiamo sfruttando adeguatamente le nostre risorse e specificità. Ma le controversie, le rivalità, gli antagonismi con il conseguente senso di superiorità, vero o presunto, non sono solo tra umanisti e persone con formazione scientifica. Che dire dei medici di condotta che non considerano i dentisti, dei medici che prendono in giro i veterinari, dei pedagoghi e dei sociologi che ce l'hanno con gli psicologi, degli psichiatri che non considerano minimamente gli psicologi, dei poeti che considerano incomprensibili e stupidi certi artisti concettuali, dei poeti che snobbano i cantautori, di certi pittori che considerano poco o niente i poeti contemporanei, dei normalisti della classe di scienze che si considerano superiori a quelli della classe di lettere e filosofia? Il rispetto reciproco spesso manca. Essendo assente il rispetto, spesso viene covato reciprocamente nell'animo di molti l'odio. Oggi la cultura è divisa più che mai e sempre più divisiva.
E dire che un tempo c'era il sapere unitario; c'erano nel Medioevo persone con una cultura enciclopedica come Dante. Nell'Umanesimo e nel Rinascimento c'erano artisti e scienziati come Leonardo da Vinci. E come non dimenticare Galileo che era un grande scienziato e secondo Calvino (lo scrive in "Lezioni americane") uno dei più grandi scrittori italiani di tutti i tempi? Nel 1600 in Toscana va ricordato anche Francesco Redi che fu medico e letterato. Bisogna ricordare che sempre nel corso del 1900 si poteva essere scientifici e umanisti allo stesso tempo; ci sono stati Primo Levi, Gadda (si veda su tutti "Meditazione milanese"), Sinisgalli (si veda il "Furor Mathematicus"). Oggi su tutto e su tutti prevale la specializzazione, anche se qualche voce inascoltata e fuori dal coro talvolta parla di interdisciplinarietà. Gli studiosi non vogliono essere tuttologi. Scelgono un ramo. Rinunciano alla globalità per eccellere in un campo. Non c'è niente di peggio al mondo d'oggi che invadere il campo di competenza altrui ed essere tacciato di essere un dilettante o un autodidatta ignorante! Ma oggi è anche molto difficile, quasi impossibile sapere tutto. In qualche ramo dello scibile si finisce sempre per essere analfabeti. Oggi è impossibile essere enciclopedici. Chi dice di sapere tutto è un illuso, un delirante o un impostore. Spesso è già difficile sapere tutto molto genericamente nel proprio ambito. Anzi mi correggo: spesso è già difficile avere un'infarinatura generale nel proprio ambito di competenza. Le persone che conoscevano, che sapevano tutto di tutto sono morte da tempo. Ci sono mille rami dello scibile; vengono pubblicati ogni anno tantissimi libri per ogni ramo del sapere. Neanche i critici letterari italiani riescono a stare dietro a tutte le novità poetiche ogni anno. È già molto difficile se non impossibile rimanere aggiornati nel proprio ambito di competenza. Figuriamoci sapere tutto!
apr 252023
"Malinconie discrete che non sanno star segrete,
le piccole modeste storie mie,
che non si son mai messe addosso il nome di poesie,
amiche mie di sempre, voi sapete!
Ebbrezze conosciute già forse troppe volte:
di giorno bevo l' acqua e faccio il saggio.
Per questo solo a notte ho quattro soldi di messaggio
da urlare in faccia a chi non lo raccoglie."
("Canzone delle situazioni differenti" di Francesco Guccini)
Ha più senso oggi scrivere? Ha più senso scrivere una silloge poetica, se la leggeranno solo pochi e per di più quasi solo aspiranti e sedicenti poeti? Ha più senso oggi scrivere romanzi o racconti quando pochi vogliono leggere storie e allo stesso tempo si registra uno scadimento generale, perché chiunque ha una storia da raccontare, magari quella della sua vita, e moltissimi si sentono in diritto, quasi in dovere di scriverla, visti e considerati l'aumento della scolarizzazione, la diffusione esponenziale di programmi di videoscrittura e l'università di massa? Probabilmente nella storia dell'umanità di libri ne sono già scritti troppi; i grandi capolavori sono già stati tutti scritti; nessuno uguaglierà o supererà Omero, Dante o Shakespeare. Da giovane un mio ex amico mi disse che trovava molto interessanti gli input di un manuale di psicologia sociale che gli avevo regalato, ma mi chiese anche a cosa servisse leggere i romanzi, ad esempio come quelli di Andrea De Carlo. Io rimasi un poco interdetto e poi mi arrampicai sugli specchi, risposi che De Carlo descriveva bene la Milano degli anni '90, la sua vita frenetica, la carambola degli incontri. Allora lui efficacemente controbattè che i personaggi dei romanzi di De Carlo erano tutti liberi professionisti, artisti, intellettuali, insomma borghesi. Io risposi che comunque era anche quello uno spaccato della realtà, che De Carlo non faceva sconti a nessuno, tanto meno alla sua classe sociale di appartenenza. Risposi che anche i personaggi di Moravia, tranne poche eccezioni come la ciociara, erano altoborghesi, eppure nei suoi libri c'era molta verità, anche se solo della verità dell'umano e della Roma da lui vista e vissuta. Aggiunsi che De Carlo era un bravo scrittore, a volte commerciale, ma comunque spesso criticato per invidia, per partito preso, perché ad alcuni non andava giù che avesse avuto successo. Continuai dicendo che leggendo letteratura o comunque narrativa si migliora il nostro italiano e si arricchisce il nostro vocabolario; gli spiegai cosa volesse dire Tondelli quando scriveva che la letteratura contemporanea serve per "ritestualizzare il mondo". Gli dissi che a volte ci sono scrittori che dicono cose nuove oppure che dicono le stesse cose in modo nuovo, che hanno una sorta di sguardo obliquo sul mondo. Ma lui mi riportò subito alla realtà concreta e non soddisfatto rispose che faceva l'operaio, che per lui certi romanzi erano una perdita di tempo. Insomma con poche parole voleva dirmi che non aggiungevano niente al suo mondo interiore, alle sue conoscenze pratiche, alla decifrazione e alla lettura del mondo circostante. E me lo diceva in modo molto franco e onesto, se vogliamo crudo. Si noti bene: quello di Andrea De Carlo era solo un esempio perché non sono un detrattore né un ammiratore dello scrittore milanese (l'ho rammentato perché molti lo conoscono). Estendendo il discorso, anche le scienze umane quale apporto danno in fondo alle nostre conoscenze, se dimostrano spesso delle ovvietà oppure se scoprono delle cose controintuitive, che a molti risultano opinabili? Non a torto alcuni scettici, disfattisti e nichilisti potrebbero ritenere che la conoscenza che deriva da ogni branca dell'umanesimo sia maieutica e quasi tautologica. Però io a tal riguardo obietto questo: che una cosa sia facile da capire non significa che sia facile da scoprire, che una realtà che hanno sotto gli occhi tutti solo pochi sono in grado di rappresentarla, descriverla e in questo mondo ci vuole anche chi descriva una realtà o racconti o si inventi una storia. In definitiva per me essere semplici o dire cose semplici non significa essere facili o dire cose facili. Fatta questa premessa, risultano sempre più fuori dal mondo e deliranti quei poeti, veri o presunti, aspiranti, sedicenti o effettivi, che pensano che la loro arte sia necessaria, addirittura un dono a un pubblico inesistente, a un popolo bue, che si ostina a non capirli. Può darsi invece che loro non abbiano niente di nuovo da dire sul mondo e al mondo. Può darsi che le loro parole non abbiano più forza eversiva o meglio non abbiano più forza alcuna. Non rallegri a questo proposito il fatto che ci siano molti blog di poesia e che alcuni vengano visitati: molto spesso vengono visitati solo da aspiranti poeti, che a loro volta li visitano solo per proporre i loro versi alle redazioni di quei siti. E poi ad aprire un blog di poesia, che spesso ha vita breve, non servono grandi competenze, grande talento, grandi curriculum, grandi referenze. È ammirevole lo sforzo profuso da molti, ma non andiamo oltre e voliamo basso, rasentando terra, come cantava Bob Dylan. Infine forse non ha alcun senso scrivere, se non si è pagati. Quelli capaci e/o furbi scrivono canzoni, per la televisione o per il cinema. Non ha alcun senso spedire quotidianamente il proprio messaggio nella bottiglia nel mare magnum del web. Gli italiani leggono solo libri di intrattenimento oppure testate giornalistiche online per aggiornarsi gratuitamente. A onor del vero non comprano neanche più quotidiani. E allora c'è poco da autoesaltarsi o da vantarsi per un libro pubblicato a pagamento o comunque presso una piccola casa editrice. Non tutti gli scrittori e non tutti i poeti hanno il coraggio e la capacità di trovare la verità dentro di sé e nel mondo circostante, a volte non la cercano neppure, e pochi lettori hanno la capacità e la voglia di raccoglierla questa verità. Chi vuole scrivere dovrebbe farlo, nonostante tutto, con un minimo di pragmatismo, di umiltà, a capo chino, soprattutto scribacchiando le sue cose nel web, quasi esclusivamente nel web. E non dovrebbe scrivere per vanità, per profitto o per personal branding. Con la letteratura è molto difficile campare. Campare facendo gli scrittori è quasi un'utopia. Non si dovrebbe scrivere per trovare un proprio posto nella società: si finirebbe disillusi, disperati e/o sul lastrico. Consiglio a tutti gli aspiranti o sedicenti scriventi che hanno troppe albagie di leggere o rileggere sempre "Fiorirà l'aspidistra" di Orwell e "Lettere a un giovane poeta" di Rilke. In quest'ultima opera il grande poeta scriveva che per scrivere e per trovare le vere ragioni, le vere motivazioni della nostra scrittura bisogna innanzitutto guardare dentro di noi. Questa è la più grande verità che sia stata scritta per coloro che vogliono fare arte.
apr 122023

Scriveva Bukowski che nessun uomo è forte come le sue idee. Ho appena passato mezzo secolo e conosco un minimo la natura umana per sapere quanto avesse ragione. Da giovani molti hanno grandi ideali, che puntualmente tradiscono con azioni riprovevoli. È così facile cadere e/o ricadere. Non parlo moralisticamente di peccati o vizi (non pensiamo solo al sesso, che è poca cosa, un peccato veniale, se non viene fatto male ad altri), ma di errori in senso lato nella vita e di come è facile ricadere nei soliti errori, insomma essere recidivi. Ho conosciuto persone che da giovani volevano condurre una vita irreprensibile e dopo hanno sconfessato totalmente i loro ideali. Vale sempre per tutti il detto: "Soldi e santità, la metà della metà". Ma conosco anche un poco la comunità poetica e a volte mi chiedo quanto sia difficile per un artista non solo non tradire i suoi valori, ma vivere all'altezza delle sue parole. Spesso anche i poeti, i sedicenti e aspiranti tali si rovinano il fegato in piccolezze (meschinità, grettezza d'animo, invidia, gelosia, frustrazione, complessi di superiorità dietro a cui si celano complessi di inferiorità come insegna Adler, vanagloria, presunzione, smania di grandezza, egocentrismo, etc etc). Insomma sembra una cosa banale, però non sempre c'è correttezza nei rapporti umani (dallo scambio di favori, al compromesso sessuale, alla recensione pretesa come atto dovuto, alle alleanze interessate, all'arruffianamento, alla polemica sterile per ottenere visibilità). Che poi non si sa bene dove inizi e dove finisca la comunità poetica, né si sanno con certezza i criteri con cui si stabilisce che uno ne faccia parte o meno! Si ritorna al solito binomio arte e vita, letteratura e vita. Come faceva dire D'Annunzio ad Andrea Sperelli: «Bisogna fare la propria vita come si fa un’opera d’arte». Più recentemente anche il sociologo Bauman ha scritto che bisogna fare della nostra vita un'opera d'arte e lo scriveva senza alcuna traccia di superomismo. Ma spesso in passato si voleva che l'artista desse il buon esempio con la sua condotta di vita, che fosse di specchiata moralità. Se questa regola fosse valida per tutti allora avrebbero ragione quelli del politically correct e anche quelli della cancel culture a rimuovere opere e artisti discutibili. Ma ci sono molti casi limite. Lo stesso D'Annunzio e molti futuristi non erano forse dei guerrafondai? Caravaggio non era forse un assassino? Althusser non strangolò forse la moglie che voleva lasciarlo? Dovremmo cancellarli, rimuoverli? E la lista potrebbe continuare. Senza andare troppo indietro negli anni e limitandosi al mondo dello spettacolo italiano basta ricordare il presunto scandalo di Mina, che era incinta e non sposata. C'è vita nell'arte e arte nella vita. L'arte a onor del vero si dovrebbe occupare della vita. L'arte dovrebbe imitare la vita, riprodurla, tradurla, trasfigurarla, invece del contrario. Il grande Carlo Bo scrisse che la letteratura dovesse essere come la vita. Ma era giovane e non ne poteva più degli intellettuali succubi del fascismo. All'epoca si doveva prendere le distanze da certi compromessi e si doveva indicare una nuova strada maestra. Alcuni decenni più tardi lo stesso Bo scrisse invece: «Il critico deve tenere conto della vita dello scrittore oppure deve limitare la sua indagine soltanto ed esclusivamente all'opera? La questione è antica: per il maestro di tutti, Sainte Beuve, la conoscenza della vita era più che utile, insuperabile. Per altri, a cominciare da Croce e da Proust, se ne poteva fare a meno, anzi era bene stringere lo studio alla valutazione pura dell'opera». La critica biografica purtroppo sopravvaluta la vita e considera poco le opere di un artista. La critica biografica pone troppo l'accento sulla sessualità di un artista e alimenta la pruderie, se non addirittura cerca lo scandalo. Da Freud in poi questo filone della critica spiega le opere in base alla sessualità di uno scrittore, un poeta, un pittore. Ma è davvero necessario? Un poeta dovrebbe essere considerato soprattutto per la sua arte e invece spesso si finisce per ricordarlo solo per i dettagli scabrosi o anche solo piccanti della sua vita. A mio avviso la morale sessuale, a meno che uno non sia uno stupratore o un pedofilo, dovrebbe passare in secondo piano. Certamente si dovrebbe guardare più all'etica e meno alla moralità sessuale in senso stretto. C'è una scuola di pensiero, nata dai poeti maledetti, che basa tutto sulla distinzione tra borghese e artista: all'artista sono concessi certi eccessi, però perde la rispettabilità borghese, a meno che non si penta e ritorni nell'ovile come una pecorella smarrita. Un pregio della comunità poetica è che Pasolini è stato per nostra fortuna uno scandalo vivente e chi veniva dopo ha imparato a non scandalizzarsi mai. Almeno i poeti più avveduti e meno cretini si salvano così dal perbenismo moralistico, tanto presente nella mentalità comune. Vecchioni comunque in una canzone dedicata alla Merini scrive: "Basta un niente per essere felici. Basta vivere come le cose che dici". Ma quanti ci riescono veramente? Quasi nessun poeta, se conosciuto realmente, è all'altezza dei suoi versi, che sono la parte più pura di sé; il critico dovrebbe considerare quanta purezza c'è a suo avviso nella parte più pura di un poeta, ovvero in un'opera. La vita di un artista dovrebbe essere considerata spesso come materiale spurio, grezzo, addirittura in molti casi irrilevante. Invece si è giunti spesso all'eccesso opposto, ovvero a un eccessivo psicologismo, a considerare un'opera come un test proiettivo di personalità. Si ritorna alla celebre frase hegeliana che nessun eroe è tale per il suo cameriere. Oggi più che la vita di un autore interessa il personaggio che riesce a far credere di essere. Oggi uno scrittore deve crearsi un personaggio, diventare riconoscibile, adirittura inconfondibile più con la sua figura che con il suo stile. L'importante a ogni modo è salvare la faccia e le forme, dare un'ottima impressione di sé, fare una bella figura perché anche i poeti, veri o presunti, al mondo d'oggi vivono di apparenza e immagine. E allora avremo il poeta che si vanta delle sue conquiste femminili, dei suoi premi, dei suoi consensi, delle sue pubblicazioni. Avremo poeti che sminuiscono altri poeti per affermare sé stessi, che dicono di essere invidiati da tizio, che dicono che caio è un pazzo o che sempronio è un poveretto. Oppure avremo delle poetesse che scimmiottano le veline perché oggi per essere, per esistere, per essere accettati bisogna fare così e l'apparire diventa non più il mezzo ma il fine. Salvo poi di meschinità in meschinità, di snobismo in snobismo, di presunta selettività in presunta selettività, di pretesa esclusività in pretesa esclusività, di malcelato disprezzo in malcelato disprezzo ritrovarsi a non vendere i propri capolavori e maledire il popolo bue che non sa apprezzare cotanto talento e tanta originalità!
apr 012023

Prima arrivano le immagini e la musica, poi le parole scritte. Così forse in una frase si potrebbe riassumere quello che sta accadendo alla poesia contemporanea italiana. Ma è solo questo? Il celebre Vittorio Sgarbi nella sua prima apparizione al Maurizio Costanzo Show dichiarò che la stragrande maggioranza dei pittori non erano intellettuali. Disse che lui di solito spiegava a loro il significato dei quadri. Era come se la pittura trascendesse gli artisti. Era come se fossero ignari di quello che stavano facendo. Non so se sia vero. Lo prendo per buono, vista e considerata la grandissima competenza in materia di Sgarbi. Erano gli anni Ottanta. Forse oggi le cose sono cambiate, dato che ci sono nell'arte contemporanea molti artisti concettuali e molti registi che fanno installazioni. Ma ancora oggi possono esistere pittori naif, pittori per dirla alla buona tutti inconscio. La stessa cosa non può avvenire nella poesia contemporanea, dove ci deve essere una sintesi tra conscio e inconscio e dove talvolta si cerca di rimuovere l'inconscio. Nell'arte contemporanea l'intellettualità è lasciata in modo preponderante ai critici d'arte. Diciamo che un pittore o uno scultore possono conoscere e metabolizzare tutta l'arte passata, tutta la tradizione in modo inconscio, mentre i poeti devono apprendere e rielaborare soprattutto consciamente. La grande poesia del Novecento, ad iniziare da Eliot e Pound per finire con il gruppo 63, è stata tutta intellettuale. Difficile stabilire i motivi per cui la poesia è più mediata dalla ragione, dalla lucidità, dalla coscienza. Oserei affermare che conti di più la poetica della poesia. Forse è solo questione di Kunstvollen, ma è difficile fare il processo alle intenzioni, alla volontà, dato che esiste sempre l'eterogeneità dei fini anche nell'arte. Ho scritto all'inizio che le immagini arrivano prima, forse perché siamo nella cosiddetta civiltà delle immagini e quindi queste acquistano priorità assoluta, forse invece perché la cosiddetta "emozione retinica" di un quadro o di una scultura arrivano prima, colpiscono di più il fruitore. Forse la fruizione di un quadro o di una scultura è più diretta, più immediata, più accessibile a tutti. Anche se un fruitore ignorante di un quadro non può spiegare esattamente quello che prova a vederlo, comunque quell'opera gli suscita una emozione, gli smuove qualcosa dentro. La poesia contemporanea invece non provoca più shock, non disturba i lettori, né li incanta o li suggestiona più. Questo probabilmente perché il pubblico non è educato al gusto, non riesce a cogliere più la poesia autentica, ma solo i suoi surrogati. Oppure forse questo può accadere anche nell'arte contemporanea, dove un pubblicitario come Oliviero Toscani e un artista come Cattelan spesso sembrano scambiarsi i ruoli? Chissà?!? Ai poeti è chiesto di essere prima, durante e dopo l'atto della creazione degli intellettuali lucidi e sorvegliati. Finisce che non si lasciano più andare alle emozioni e così i più non emozionano gli altri. Sembra quasi che ci sia una regola scritta nella poesia contemporanea per cui non bisogna emozionarsi né emozionare. Come sembra un'altra regola non scritta quella di complicare le cose, scrivere in modo difficile e colmo di paroloni per apparire più intelligenti. Disse Picasso che tutti i bambini sono degli artisti nati, il problema è restarlo da grandi. I grandi pittori si sono saputi riscoprire bambini. Ciò non succede a buona parte dei poeti, troppo impostati, troppo assennati. I poeti nel corso del Novecento, parlo di quelli passati alla storia, sono forse troppo cerebrali. Nella lirica contemporanea la maggioranza degli stessi poeti a loro volta vestono i panni anche dei critici o dei saggisti: pontificano, spiegano, giudicano, ma non emozionano più il pubblico. Li ho definiti troppo cerebrali, come un tempo si definivano quei mariti, oggi etichettati come cuckold, che amavano guardare la moglie fare sesso con amanti occasionali. È come se la poesia avesse perso il senso delle cose, la vera dimensione dell'essere. La situazione in cui si vengono a trovare i poeti oggi è innaturale. Hanno perso il contatto con il pubblico o meglio l'unico pubblico che esiste è quello della comunità poetica, in cui tutti scrivono versi, indipendentemente dal fatto che siano aspiranti, sedicenti o poeti riconosciuti. Un altro problema più basilare è che spesso tra contemporanei e connazionali neanche ci si legge. Molti scrivono e pochi leggono. Ancor meno sono quelli che leggono, hanno gli strumenti per valutare e poi giudicano obiettivamente. Tutto ciò è asfittico, mancano spiragli, l'orizzonte è angusto. La poesia non ha pubblico né mercato. Questo significa che c'è assoluta libertà interiore e di azione (i più però non agiscono in libertà perché hanno paura di rovinarsi la reputazione), ma che allo stesso tempo non essendo mercificabile in questa società consumistica non ha alcun valore o quasi. Eppure oggi molte poetesse italiane e molti poeti italiani varrebbe la pena di leggerli e anche di rileggerli. Sicuramente c'è anche del buono, anche se gli italiani sembrano non accorgersene minimamente.
mar 252023

C'è chi scrive come gli dicono di dover scrivere. Ma c'è anche chi non si discosta dai suoi maestri, c'è chi volontariamente li imita pedantemente, c'è chi diventa talvolta senza volerlo un epigono, un manierista. Ci sono teorie della letteratura e scuole di scrittura che impongono stili e canoni. In fondo bisogna saper rispettare il cosiddetto spirito dei tempi. Per anni ad esempio sono andate per la maggiore la Neoavanguardia, l'autonomia del significante, la letteratura come menzogna. C'è chi scrive come vuole scrivere. È una libertà interiore che dovrebbe rivendicare ogni autore, al di là delle mode. È un modo inequivocabile per essere veramente sé stessi. Significa scrivere come ci piace e quello che ci piace, scegliendo deliberatamente modalità, stile e tematiche. C'è chi si accontenta di scrivere come sa. Alcuni finiscono perciò per essere troppo schematici e ripetitivi. Un poco come un bambino che disegna sempre un albero perché sa fare bene solo quello. Ciò nonostante ci sono sempre margini di miglioramento in ognuno di noi. Non poniamo limiti all'acculturazione, né alla plasticità neuronale. Tutti abbiamo dei limiti e delle possibilità, ma è difficile stabilire quali. Alcuni hanno delle potenzialità inespresse che non riescono a tirar fuori, a concretizzare. I test attitudinali possono dire ben poco sulla creatività umana, che rimane un mistero inenarrabile. C'è chi giunge ad un compromesso tra queste tre istanze (dovere, volere, potere scrivere). Bisogna sempre scegliere cosa scrivere e come scrivere. Ma siamo davvero sicuri di scegliere? E se fossero invece le parole, le idee, le immagini a scegliere noi? Scrivere è sempre un'attesa e al contempo una scoperta, una sorpresa. Non sai mai cosa può uscire fuori. Viene da chiedersi quanto ci sia di cosciente, razionale e quanto invece di inconscio. Anche in un ambito apparentemente razionale e logico come il giornalismo la scelta di scrivere di un argomento piuttosto che un altro, la selezione delle informazioni, la formazione delle opinioni spesso derivano da attività e aspettative inconsce. In fondo aveva ragione Popper quando diceva ai suoi allievi che osservare non è un verbo intransitivo (lui disse: "osservate" e loro gli chiesero "cosa?") e si osserva soprattutto in base all'esperienza pregressa. C'è quindi di mezzo in ogni scrittura che si rispetti l'inconscio collettivo, individuale, cognitivo, istintuale. C'è poi chi sostiene come Lukacs che l'arte debba rispecchiare la realtà. C'è chi sostiene che debba rovesciare la prospettiva ordinaria con lo straniamento. C'è chi ritiene che l'arte debba trasfigurare la realtà e che quindi una componente immaginativa, soggettiva, se vogliamo ludica e carnevalesca, ci debba essere, debba essere messa in conto. C'è chi pensa che l'arte debba creare un altro mondo, seppur fittizio. Scriveva Heidegger che l'arte è la messa in opera della verità e che la vera creazione artistica debba aprire a nuovi mondi. È sempre difficile scegliere tra oggetto e soggetto, tra esterno e interno. Esplorando la realtà ci si imbatte nell'inconoscibilità della cosa in sé, ma scavando dentro ci si accorge dell'inconoscibilità dell'uomo in sé (così potremmo definire l'insondabilità dell'animo umano). Ma poi ancora una volta siamo noi a scegliere io o mondo oppure sono la nostra personalità di base, le nostre caratteristiche intrinseche, le nostre qualità interiori? Ogni volta che si parla di creazione il mistero si infittisce, spunta l'enigma. Da giovane pensavo che ci fossero due tipi di persone che avessero toccato Dio: gli artisti ispirati da Dio, che testimoniavano la sua esistenza con delle creazioni, e le persone che ricevevano le stimmate e quindi una parte della sofferenza divina. Ma siamo sicuri che l'arte metta in comunione con Dio? A seconda dei casi può tuttavia avvicinarci, soprattutto quando proviamo stupore, rimaniamo affascinati e ammaliati dalla bravura di certi artisti. Qualche volta ci chiediamo se quella straordinario talento possa essere solo frutto dell'ingegno, del lavoro, dell'arbitrio umano. Così scrive Borges: "Una volta chiesero a Bernard Shaw se credeva che lo Spirito Santo avesse scritto la Bibbia. E rispose: «Ogni libro che valga la pena di essere riletto è stato scritto dallo Spirito». Ossia, un libro deve spingersi oltre le intenzioni del suo stesso autore. L’intenzione dell’autore è una povera cosa umana, fallibile, ma nel libro deve esserci di più". Però in fondo l'ingegno, la possibilità di potenziarlo ed esercitare sono a loro volta sempre sottomessi al volere di Dio. Quindi anche se l'arte non fosse frutto di ispirazione divina sarebbe se non opera di Dio quantomeno concessione e volontà di Dio. Viene da chiedersi se ci sia Qualcuno che ispira certi artisti. Da dove provengono le parole, i pensieri, le immagini? E se il subconscio fosse divino? Esiste l'ispirazione? Ogni cosa può essere fonte di ispirazione? Può arrivare dovunque, in qualsiasi momento, a chiunque? Esistono delle persone ispirate o quelle ritenute tali in fondo si sono prese la briga o hanno avuto il lusso di restare in ascolto di sé stesse? Naturalmente dietro questi interrogativi legittimi ci può essere sempre qualcuno che abusa della credulità popolare e si arroga il diritto di parlare in nome di Dio. Ecco quindi spuntare i santoni, gli illuminati, i nuovi profeti, gli unti del Signore. Eppure non c'è niente di oggettivo. Nessun santo sa con certezza se ha ricevuto veramente un segno divino o se ciò è una allucinazione. Dio o chi per lui non dà certezze assolute a questo mondo. Tutto deve essere sempre verificato, messo in discussione. Chi non si mette in discussione è perduto. Nessuno psichiatra può oggettivamente trovare un discrimine tra santità e follia. A questo riguardo consiglio di leggere "Benedetta follia. Dai padri del deserto ai mistici di oggi" di Andreoli. Solo la Chiesa dopo uno studio attento delle opere e delle testimonianze fatte in vita può beatificare. Inoltre affermare che la propria ispirazione sia divina molto spesso è un grande atto di presunzione oltre che di ingenuità. E se poi non fosse un tratto distintivo di certi artisti, ma se tutti gli uomini fossero ispirati da Dio e se si trattasse solo di essere disposti ad accogliere? Allo stesso tempo penso a tutti gli artisti che hanno trasgredito i comandamenti, hanno commesso peccati mortali e non dovrebbero essersi salvati. Eppure sono artisti maledetti che hanno avuto gloria postuma. Mi chiedo se non possa esserci anche una arte ispirata dal demonio. Esiste forse un'arte che fa bene e una che fa male? Non dimentichiamoci che un tempo hanno messo i libri all'indice, il nazismo ha bruciato dei libri, nel corso della storia ci sono state troppe censure. Pretendere di stabilire quali opere sono da condannare e quali no è rischioso. Non si può fare come Hitler che considerava arte degenerata quella che si opponeva alla sua dittatura. Mi chiedo se con l'arte si può raggiungere la salvezza ultraterrena, se si possa espiare con essa le colpe e i peccati. Hegel sosteneva che la lettura del giornale il mattino fosse la preghiera laica dell'uomo contemporaneo. Io mi chiedo se anche la creazione e la fruizione artistiche possano essere intese come preghiere laiche. Forse chi è veramente religioso e fedele non chiede lumi all'arte, ma talvolta certi artisti dimostrano tutta la loro religiosità nelle loro opere artistiche. Inoltre mi chiedo anche quanto valga acculturarsi ed esprimersi artisticamente. Mi chiedo non solo se sia necessario per salvarsi l'anima, ma anche se sia necessario al mondo reale e concreto. Cosa può fare l'arte per la giustizia di questo mondo, per combattere la povertà? Forse niente, realisticamente parlando. E allora vale la pena sacrificare la propria vita e sé stessi in nome dell'arte? Quanto un artista è disposto a dare di sé in nome dell'arte? Qualcuno potrebbe ironizzare dicendo: "non libri, non opere d'arte, ma opere di bene".
mar 242023

In fondo che mi manca? Un tetto sotto cui dormire ce l'ho. Così come ho 4 mura che mi riscaldano d'inverno e mi tengono al fresco d'estate. Ho da mangiare e da bere. Ho un bagno in cui cacare. Ho i miei genitori e mia sorella. Ho un cane che mi fa i complimenti. Ho una zona molto tranquilla in cui camminare. Ho un bar in cui prendere i caffè e in cui conosco qualcuno per fare due chiacchiere. Ho una biblioteca comunale in cui prendere dei bei libri usati a 1 euro, mezzo euro o 2 euro. Ho una camerina tutta mia in cui posso leggere, raccogliermi, meditare sulla vita e sul mondo. Ho un posticino in cui mangiare una pizza con il mio migliore amico. In fondo sono fortunato perché altrove si muore di fame o di guerra. E inoltre godo di buona salute. Che me ne importa del sesso, dell'amore? Oh certo…tutto l'amore che ho provato e che non è stato ricambiato!?! Oh certo l'imperativo sociale qui è avere una scopamica! Oh certo ora è primavera e quei due ragazzi davanti a me si scambiano effusioni e io sono solo. No. Non posso considerare solo questo. Certamente ho dei momenti di crisi ogni tanto, ma sono più le cose che ho di quelle che non ho ed è a queste che devo guardare, non mi devo crucciare troppo, fissare troppo su ciò che non ho avuto, su ciò che non ho. Ci sono cose che la letteratura e le scienze umane non sempre ti insegnano. Ci sono cose che a scuola non ti insegnano. Puoi solo impararle dalla vita vera. E infine nessuno è solo a primavera. Siamo tutti partecipi del creato. E poi fuori è primavera e c'è il cielo sgombro, il tepore del sole, la vita, anche per chi non ha un amore.
mar 082023

Se dovessi consigliare una poesia sui migranti, dovrei per forza di cose parlarvi di “Home” della giovane e bravissima autrice somala Warsan Shire. Ma vorrei rimanere in Italia e a dire il vero tra i poeti riconosciuti nostrani non c'è l'imbarazzo della scelta, anzi non c'è possibilità di scelta, visto e considerato che trovo scialba e scontata, insomma di maniera, la lirica rinomata di Erri De Luca. Tra tutti gli aspiranti, sedicenti, effettivi poeti nostrani molti si sono cimentati nell'impresa di scrivere poesie sui migranti, che compiono viaggi della speranza, ammassati in barconi. E a onor del vero nel 99,9% dei casi non hanno saputo andare oltre la retorica, il sentimentalismo, il pietismo, il buonismo imperanti. Insomma luoghi comuni e basta, senza se e senza ma. Pose e modi di atteggiarsi per farsi belli agli occhi del mondo, per rientrare nel novero del politicamente e dell'eticamente corretto. Ammiccamenti al lettore e niente di più. Anzi dovrebbe essere severamente proibito scrivere poesie su temi così scottanti e delicati. Che poi si sa come sono sensibili oppure sciocchi i poeti nostrani, aspiranti e non, che appena c'è un naufragio oppure un terremoto sono subito pronti a verseggiare per la tragedia che ha appena colpito i loro animi nobili! No. Bisognerebbe mettere una legge in cui non si potrebbe speculare su tragedie nazionali o internazionali, scrivendo poesie ad hoc. Inoltre non è assolutamente detto che certe poesie a tema riescano a sensibilizzare le persone. Ma a volte osservo sia tutta una gara di buoni sentimenti. No. Un poeta con un minimo di buon senso e di dirittura morale dovrebbe evitare di scrivere su certi argomenti, su cui sarebbe meglio soprassedere. Sarebbe meglio il silenzio, la pagina bianca, il non detto. A dire il vero di poesie italiane sui migranti e le loro tragedie è pieno il web. Vanno di moda. Il primo premio in qualche concorso letterario è garantito, anche se il linguaggio è desueto, arcaico, stantio. Ma c'è un'eccezione: da tanta mediocrità si salva a mio avviso Sergio Guttilla, Capo Scout Agesci nel gruppo Bolognetta1, che ogni tanto scrive poesie e canzoni, suonicchia chitarra e pianoforte. Così afferma lui. Con la sua freschezza e genuinità riesce in questa sua lirica a trascendere il paludamento di tanta poesia ufficiale e non. Riesce a dirci qualcosa di nuovo in modo semplice e chiaro. Guttilla non è nelle sabbie mobili, non è nelle catacombe come alcuni suoi colleghi poeti più illustri. E noi capiamo che di queste sue parole avevamo bisogno perché sono parole veramente "migratorie", veramente spiazzanti, che ci fanno vedere quel tragico spaccato della realtà in modo nuovo. Dirò di più: questi suoi versi così originali capovolgono la visione ottusa di tanti benpensanti, che pensano di avere la verità in tasca, che dicono che i migranti non dovrebbero partire, che i flussi migratori andrebbero a tutti i costi regolamentati, che la colpa delle tragedie in mare è esclusivamente degli scafisti, etc etc. Qualche maligno potrebbe dire che questa poesia è un pezzo facile, che non è letteraria, che non ha dignità letteraria, che è enfatica, che stuzzica troppo il cuore, etc, etc. No. Sono tutte critiche pretestuose. Questa lirica è bella e veramente ispirata. Non è colpa di nessuno se a volte l'ispirazione va a trovare coloro che non sono reputati dei "poeti laureati" e che si dimostrano a onor del vero molto più poeti dei poeti ufficiali. Non è colpa di nessuno se questi versi sono veramente umani e se l'autore è veramente umano, a differenza di tanti piccoli geni incompresi, che fingono di sprizzare umanità da tutti i pori. Questa lirica è da antologia senza ombra di dubbio. Diffondete anche voi questi versi, citando l'autore, perché sia queste parole che il poeta in questione meritano di essere noti tra tanti impostori delle patrie lettere, tra tanti facitori di versi ormai patentati e celebrati. Sergio Guttilla riesce a emozionare e riesce nello straniamento; coglie nel segno, a differenza di tanti letterati nostrani, professionisti dell'intellettualismo radical chic. Questa lirica ci dimostra una cosa: che per scrivere di qualcosa bisogna aver visto una realtà da vicino in presa diretta. Ma ci dimostra anche che per scrivere di argomenti così sensibili bisogna essere non conformisti ma con un animo puro e uno sguardo lucido sul mondo. Ecco la poesia, che sta diventando meritatamente virale nel web:
Sergio Guttilla
29 giugno 2018
Dedicata a i 100 morti in mare, morti affogati
in attesa di una nave che li salvasse.
"Se fosse tuo figlio
riempiresti il mare di navi
di qualsiasi bandiera.
Vorresti che tutte insieme
a milioni
facessero da ponte
per farlo passare.
Premuroso,
non lo lasceresti mai da solo
faresti ombra
per non far bruciare i suoi occhi,
lo copriresti
per non farlo bagnare
dagli schizzi d’acqua salata.
Se fosse tuo figlio ti getteresti in mare,
uccideresti il pescatore che non presta la barca,
urleresti per chiedere aiuto,
busseresti alle porte dei governi
per rivendicare la vita.
Se fosse tuo figlio oggi saresti a lutto,
odieresti il mondo, odieresti i porti
pieni di navi attraccate.
Odieresti chi le tiene ferme e lontane
Da chi, nel frattempo
sostituisce le urla
Con acqua di mare.
Se fosse tuo figlio li chiameresti
vigliacchi disumani, gli sputeresti addosso.
Dovrebbero fermarti, tenerti, bloccarti
vorresti spaccargli la faccia,
annegarli tutti nello stesso mare.
Ma stai tranquillo, nella tua tiepida casa
non è tuo figlio, non è tuo figlio.
Puoi dormire tranquillo
E sopratutto sicuro.
Non è tuo figlio.
È solo un figlio dell’umanità perduta,
dell’umanità sporca, che non fa rumore.
Non è tuo figlio, non è tuo figlio.
Dormi tranquillo, certamente
non è il tuo."
gen 132023
Il limite può essere inteso come mancanza, difetto oppure come confine. Ai tempi dell'università pensavo ingenuamente che uno dei modi di superare il nichilismo fosse creare una metafisica dei limiti, che io avevo chiamato limitismo, ovvero riconoscimento dei limiti fisici, ontologici, conoscitivi, esistenziali della specie umana. D'accordo ci sono senza ombra di dubbio dei modi più efficaci per sconfiggere il nichilismo, per combattere quello che Junger e Heidegger chiamavano il "Leviatano": una letteratura mitopoietica, ritornare a Parmenide, credere in Dio. La verità è che allo stato attuale delle conoscenze nessuno può stabilire con esattezza questi limiti. L'uomo ha dei limiti? Nessuno lo sa con certezza. C'è un limite nell'aspettativa di vita? Non si può campare più di 120 anni? Oppure può essere sconfitto l'invecchiamento e si può diventare immortali? Nessuno sa cosa sarà la vita umana e cosa sarà l'uomo in futuro. La scienza ha dei limiti? Forse oggi si può stabilire con maggiore accuratezza i limiti metodologici di una disciplina, ma anche questa è una conoscenza provvisoria. Chomsky sostiene che se nessuno ha mai dimostrato in modo semplice l'ultimo teorema di Fermat, come pensava di aver fatto il celebre matematico, vuol dire che forse la mente umana non è fatta per questo ma significa anche che sappiamo risolvere altri problemi. Esiste quindi una sorta di meccanismo di compensazione. Può benissimo darsi -scrive Chomsky- che un extraterrestre con una struttura mentale diversa dimostri subito l'ultimo teorema di Fermat senza alcuna difficoltà. Non esiste una stima oggettiva e certa delle capacità intellettive. Kant originariamente aveva chiamato la Critica della Ragion Pura “Limiti della Sensibilità e dell’Intelletto”. Non per criticare il grande genio di Kant ma nessuno sa stabilire il sostrato noumenico, irraggiungibile per la mente umana. Sappiamo che la nostra mente ha dei limiti empirici nel percepire il nulla e l'infinito, gli "interminati spazi", i "sovrumani silenzi" leopardiani. Sempre per riprendere "L'infinito" di Leopardi noi miseri esseri umani possiamo percepire l'indefinito e mai cogliere pienamente l'infinito. La differenza nel celebre capolavoro sta tutta nel pronome dimostrativo: l'infinito è "di là di quella" (siepe), mentre l'indefinito viene nominato con "questo mare", "quest'uomo colle", "queste piante". Perfino "quest'immensità" deve intendersi come percepita soggettivamente e non come ciò che è illimitato in modo assoluto, come al di là di un confine oggettivo ad esempio. Abbiamo quindi dei limiti certi oppure possiamo sempre superarci? Forse la vita umana è come la dialettica hegeliana e consiste tutta in una serie progressiva di autosuperamenti nel migliore dei casi. Una cosa è certa: nessuno sa definire i limiti propri, mentre è assolutamente certo di identificare quelli altrui. A tutti sembra così facile dire quali sono i limiti mentali altrui. La verità è che nessuno può stabilirlo.

Un tempo gli psicologi ritenevano che le attitudini fossero stabili per tutta la vita. Ma è una concezione datata. Non è assolutamente così. Si può perdere dei punti o acquistarli, intellettivamente parlando. Un tempo pensavano che il Q.I fosse stabile. Un tempo nei "Cinque libri del sapere" trovai un grafico in cui per ogni professione c'era il Q.I necessario per esercitarla. Non è così semplice. È una concezione retrograda. È vero che esistono delle professioni cosiddette intellettuali, ma è difficile stabilire il livello intellettivo: si può solo stabilire approssimativamente il livello culturale. Esistono i falsi positivi e i falsi negativi in ogni test che si rispetti, anche nei test d'intelligenza. Come ne "Il cavaliere inesistente" di Calvino esistono dei Gurdulù che dovrebbero avere tutti i requisiti per essere validi, non essendolo, e degli Agilulfo, che non avrebbero modo di esistere e invece sono validi. L'intelligenza di una persona può migliorare o peggiorare, ammesso e non concesso che si riesca a definire in modo univoco che cosa sia l'intelligenza umana. I neurologi e i neuropsicologi hanno scoperto recentemente molte prove della neuroplasticità umana. Tutto sta nell'applicarsi con costanza e impegno, nel versarsi in una materia. Stabilire dei limiti così come cercare di rintracciare delle potenzialità inespresse talvolta è cosa soggettiva. Se non capisci una cosa oggi puoi sempre capirla domani, se spiegata o approcciata in modo diverso. Alcune cose non è assolutamente necessario saperle. Se non sei un fisico non è importante sapere come funziona l'interferometro. Importante è che tu sappia per un minimo di cultura generale che con esso sia stato dimostrato che l'etere non esisteva, che la relatività galileiana non valeva per la luce e che da quell'esperimento fallimentare Einstein capì che la luce aveva velocità costante, uno dei capisaldi della sua teoria della relatività. A volte basta sapere l'abc. Altre volte però è necessario approfondire. A volte la mancanza di apprendimento sta nel discente che non capisce ma talvolta anche nel docente che non si sa spiegare bene, che salta dei passaggi, che dà alcune nozioni per scontate. Se uno è genitore non deve credere in modo totale agli insegnanti che dicono che suo figlio è un genio oppure uno duro di comprendonio. Valutare le capacità cognitive è una cosa molto difficile e probabilmente i test di intelligenza non è detto che misurino l'intelligenza, come pensava alla fine della vita Cattell. Poi il giudizio degli insegnanti può essere errato e basato su delle distorsioni cognitive. Ci possono essere allievi sottostimati e altri sovrastimati. Però molti insegnanti spesso in perfetta buona fede credono di poter stabilire con certezza assoluta le capacità dei loro allievi. Sempre in perfetta buona fede alcuni insegnanti decidono in modo negativo il futuro dei loro allievi o almeno li condizionano in modo negativo. Alcuni insegnanti pensano di poter valutare l'intelligenza dei loro alunni in base alle competenze acquisite e in base all'esperienza. Tutto ciò può invece portare a formulare giudizi totalmente errati. Un insegnante non può stabilire con esattezza le abilità, l'impegno, la motivazione, il grado di sviluppo fisico e cerebrale di un adolescente ad esempio. Basarsi sull'esperienza può essere fallace. I test di intelligenza prima di essere validati ufficialmente vengono prima sottoposti a decine e a volte a centinaia di migliaia di soggetti. Nonostante questa standardizzazione di massa i test sono ancora criticabili e considerati perfettibili. Immaginiamoci quanto è poco attendibile l'esperienza di un insegnante, basata su un numero limitato di casi! Lo studio delle capacità intellettive è forse ancora agli albori. Il grande psicologo comportamentista Watson sosteneva che tutto dipendeva dall'ambiente e che se gli avessero dato da educare dei bambini li avrebbe fatti diventare quel che lui volesse: scienziati, scrittori, impiegati, operai, eccetera eccetera. Mi fanno ridere alcuni che credono di non avere limiti. Ma mi fanno ridere anche alcuni che fanno la predica a altri, dicendo che devono riconoscere i propri limiti. Se una cosa non ti riesce ora può darsi che ti riesca domani. Nessuno può stabilire con esattezza il motivo per cui non ti riesce: può essere ansia, mancanza di capacità, mancanza di interesse, mancanza di impegno, inesperienza oppure un insieme di tutti questi fattori. Non porsi limiti significa proiettarsi all'infinito, avere una fiducia smisurata delle proprie qualità: questo è troppo, bisogna sapersi fermare, bisogna saper circoscrivere la nostra sfera di competenza, nessuno può diventare onnisciente. Ma è sbagliato anche rinunciare a molto, dire troppi no, non provarci, dire troppe volte "non posso", "non ci riesco", "non ce la farò mai". Esiste un settore della psicologia chiamato "crescita personale" in cui i coach propongono ai clienti/pazienti di superare ogni tipo di limite mentale, da loro stessi definito "blocco mentale". Diffidate di questo tipo di psicologia troppo spicciola e motivazionale: non è tutto così facile, spesso è solo un modo per spillare soldi e fare business. Ritornando alle abilità, se un compito non ci riesce la prima volta che ci viene presentato può diventare più facile le volte dopo perché più familiare. Spesso l'esperienza e l'abitudine giocano un ruolo fondamentale. Tutto sta nel non abbattersi e nel non mollare troppo presto la spugna. A ogni modo nel valutare le capacità proprie e altrui bisogna essere sempre possibilisti.
dic 272022

Queste riflessioni sono scontate. Sono i piccoli pensieri quotidiani di un umarell, che giorno dopo giorno guarda come procedono i lavori della ristrutturazione dell'ecomostro davanti casa. Questi lavori sono fatti a circa duecento metri da casa mia e non mi disturbano per niente. Non sento i rumori. Non ho problemi con la polvere. Prendo il caffè in cucina e mi metto a riflettere. Guardo fuori dalla finestra. Anche questo è un modo di passare il tempo. Ogni cosa ha il suo tempo e ogni tempo ha le sue cose, secondo l'Ecclesiaste. Non sono più giovane. Esco raramente, il minimo indispensabile. Telefono pochissimo. Una telefonata ogni settimana. Eppure da giovane avevo tante amicizie. Ora resta qualche ricordo sbiadito. Gli amici di un tempo li ho persi per strada. Ognuno ha la sua vita. Non voglio essere malinconico. È una semplice constatazione di fatto. Ci sono gli impegni lavorativi, familiari per molti amici. Il tempo libero a disposizione è poco. Ma forse siamo troppo cambiati e non ci sapremmo più veramente riconoscere. Forse le mie sono nostalgie di uno che ha molto tempo da perdere. Forse come dicono banalmente alcuni il senso della vita è vivere. Forse ogni elucubrazione è qualcosa che ci allontana dalla vita stessa. Forse la vita e Dio scelgono come prediletti persone molto semplici e perciò innocenti. Forse molti ragionamenti sono intellettualismi vuoti; sono ciò che Freud chiamava razionalizzazioni, ovvero dei meccanismi di difesa dell'io. Da giovani comunque si cerca di vincere la morte con l'amore, con il sesso. Dirò di più: la morte molto spesso resta sottotraccia. Non ci si pensa. Da adulti avviene una scissione nella psiche. Da una parte il desiderio biogrammatico di immortalità, che alcuni vogliono soddisfare facendo figli oppure cercando la posteritå.

Dall'altra parte come scrisse Totò nella sua celebre 'A livella "Nuje simmo serie, appartenimmo à morte!". Dall'altra parte la rassegnazione che tutti gli uomini appartengono alla morte, per quanto cerchino di divincolarsi invano dalla sua morsa. L'amore sembra vincere la morte, ma anch'esso è destinato a finire. Scrive in una sua poesia Sanguineti: "ho insegnato ai miei figli che mio padre è stato un uomo straordinario:/ [( potranno/ raccontarlo, così, a qualcuno, volendo, nel tempo): e poi, che tutti/ gli uomini sono straordinari:/ e che di un uomo sopravvivono, non so,/ ma dieci frasi, forse ( mettendo tutto insieme: i tic,/ i detti memorabili, i lapsus):/ e questi sono i casi fortunati". Il grande poeta genovese ci ricorda che per quanto ci si sforzi di lasciare una traccia i posteri saranno dormienti, per dirla alla Eraclito. Mi ricordo del Caffè delle giubbe rosse, frequentato decenni fa da Montale, Luzi, Parronchi, Bigongiari, etc etc. Leggevo della Repubblica dei poeti al Mulino di Bazzano negli anni '70, ideata da Adriano Spatola, Corrado Costa, Giulia Niccolai. Leggevo di Pennabilli, un paese ad hoc per la poesia di Tonino Guerra. Cercavo notizie sulla rivista "Prato Pagano" negli anni '80, diretta da Gabriella Sica, a cui collaborarono Claudio Damiani, Arnaldo Colasanti, Silvia Bre. Ebbene alla fine tutto passa. Solo pochi studenti di lettere, pochi studiosi di letteratura, pochi appartenenti alla comunità poetica si ricorderanno di queste belle esperienze poetiche, che meriterebbero di essere ricordate dai più. Ma l'oblio è tiranno. L'oblio cala anche su molti protagonisti dello show-business, del cinema, della musica. C'è poco spazio per le commemorazioni veramente sentite, che non siano una mera passerella di personaggi in cerca di visibilità con i loro perenni "io l'ho conosciuto", "a me una volta confessò", "quando collaborammo assieme", scadendo spesso in un amarcord falso e melenso. Molto probabilmente saranno in tutt'altre faccende affaccendati i posteri, indipendentemente dal fatto che molti morti lascino una cospicua eredità morale, intellettuale, creativa. Da tempo ho accettato il dominio incontrastato dell'oblio. Che se ne fa uno della gloria postuma? E poi è una bella pretesa la posterità: per essere ricordati bisogna aver fatto qualcosa di memorabile. Non solo ma in Italia le culle sono vuote. Gli italiani fanno sempre meno figli. E allora in futuro chi leggerà poeti e scrittori italiani? Quando l'italiano sarà una lingua morta anche la letteratura italiana sarà definitivamente morta o quasi. Ma non siamo catastrofici e non poniamo limiti alla Provvidenza. Per ora in Italia solo nel 2021 sono 85.551 i titoli usciti (il 22% in più rispetto al 2020 e il 16% in più rispetto al 2019). Durante gli anni pandemici l'editoria ha fatturato di più. Certo ci sono moltissime pubblicazioni a pagamento, moltissime copie che finiscono al macero. Non tutti i libri avrebbero ragione di esistere, ma per ogni autore il suo libro deve essere stampato. In fondo la pubblicazione di un libro, seppure a pagamento, in alcuni piccoli paesi di provincia è una sorta di piccola promozione sociale oltre a essere quella che i letterati chiamano una "legittimazione culturale", ovvero se si vuole essere presi in seria considerazione dai critici ci vuole la pubblicazione cartacea. Riviste letterarie, literary blog spuntano come funghi. Certo quando si scrive per il web spesso ci si chiede se anche questo sia tutto inutile, destinato a scomparire nel mare magnum di Internet. Ci sono meno presentazioni di libri ma molte più dirette Facebook. C'è molto fermento. Tutto quindi lascia ben sperare. Roberto Vecchioni nella sua canzone "La stazione di Zima" (ricordando il poeta russo Evtusenko) scrive che "ci facciamo del male perché non ci capiamo niente". Siamo confusi, smarriti di fronte al mistero della vita, dell'amore, della morte. Come scrive in un suo aforisma Morandotti "tutto sarebbe più semplice se nascessimo con le istruzioni per l'uso e la data di scadenza". La vita è complessa perché fatta a strati molteplici come una cipolla (come Tommaso Landolfi definì la sua opera) e allo stesso tempo ci sono quelli che Guénon chiama gli "stati molteplici dell'essere". Senza pensare al fatto che è sempre ardimentoso prendere coscienza pienamente della nostra coscienza (mi si scusi il gioco di parole, ma rende bene l'idea). La vita è già molto difficile viverla. Capirla è quasi impossibile. Ci sono dei momenti in cui abbiamo delle epifanie e ci sembra di aver afferrato tutto. Ma un istante dopo ritorna l'opacità. Forse non siamo fatti per capire la vita. Eppure ognuno ha le sue certezze in tasca, ha le sue piccole verità, costruite sulla base delle sue conoscenze e della sua esperienza, sempre limitate rispetto alla materia infinita della vita. Sorgono spontanee dal basso delle domande, ma di difficile soluzione, visto che non c'è un comune accordo: alcuni dicono che esistono delle leggi generali nella vita e altri dicono che ognuno è fatto a modo suo e ha la sua storia. Ci chiediamo nel corso della vita che senso abbia tutto, se esista Dio, come relazionare carnalità e spiritualità, come rapportarsi con la morte, come vivere, cosa pensare, come espiare i nostri peccati, se siamo colpevoli, come essere pienamente consapevoli e risponsabili delle nostre azioni. E poi ci chiediamo cosa è rimasto del passato? Dove è finito il passato? Dove si è involato? Siamo qui in questo tempo intermedio e tutto si fa incerto. Abbiamo in testa molti interrogativi, dubbi ed ipotesi. L'amore non va tradotto in senso letterale e non bisogna lasciarsi sopraffare dal nonsenso della morte. Continuiamo però a sbagliare, nonostante avvertenze e controindicazioni sulla vita. Il tempo scorre inesorabile fino al guasto irreparabile per vizio, destino o logorio....Così sarà per quel poco che ci rimane....forse Dio sa solo giudicare e non spiegare le nostre scelte: siamo noi uomini, sospesi tra bisogni primari e cose ultime, il paradosso dei paradossi. Io ultimamente mi chiedo sempre più spesso se qualcosa veramente ci appartiene e se noi veramente apparteniamo a qualcosa di più grande. Non è un caso che per Gadda la realtà fosse uno gnommero e per Montale una matassa che lui non era mai riuscito a sbrogliare. Tutto è un grande mistero se si pensa che ogni vita è un segmento, che talvolta i segmenti si intersecano, che si incontrano oppure che corrono paralleli per sempre. A volte facciamo un tratto di strada assieme a certe persone che poi ci lasceranno o che poi noi lasceremo. Resta qualcosa alla fine? Qualcuno lascerà a noi il testimone? Noi lo lasceremo a qualcuno il testimone? Ci vuole anche del tempismo per saper raccogliere il testimone.

Come ebbi a scrivere in alcuni scarni versicoli qualche anno fa:
Recitiamo un copione o un canovaccio?
Si recita a soggetto? Si naviga a vista?
Oppure forse siamo dei bastoncini disuguali
di Shangai e non sappiamo chi ci ha mischiato
e neanche quali mani supreme ci muovono
e giocano con noi? Le nostre vite sono forse linee
che talvolta si intersecano, talvolta corrono parallele,
talvolta combaciano per tratti più o meno lunghi?
Dal punto di una linea non si può comprendere tutto
questo groviglio inestricabile, questo mondo di linee:
ecco perché forse non si può capire
mai il mistero della nostra vita e di quelle altrui.
Forse non c'è alcuna logica nei nostri istanti.
Troppe le variabili e le variazioni infinitesimali.
In ogni caso è impossibile cogliere tutti i nessi.
Anche se fossimo linee
(regolari, frastagliate o curve chissà?).
il disegno non è lineare e ci trascende.
Sappiamo veramente apprezzare gli altri e gli altri ci sanno veramente apprezzare? Oppure è tutta fatica sprecata? Oppure tutto è destinato a cadere nel vuoto, nel nulla? Qualche filosofo ci insegna che siamo esseri finiti educati all'infinito. Ma forse ogni congettura, ogni simbolo squadernato, ogni mito amato è inutile. Forse niente vince la morte. Forse ogni lavoro, ogni passione è un passatempo per non pensare alla morte, come intuì Pascal. Noi dobbiamo per forza pensare ad altro. Si finisce anche per pensare che il problema è sempre un altro. Allora molti per scongiurare la morte cercano di inebriarsi a più non posso della vita. Il loro è un vitalismo disperato. Spesso però il loro tentativo è goffo e ignari si gettano a capofitto tra le braccia della morte, finendo nel vortice dell'autodistruzione. Il loro più grande rimpianto è sempre quello di non aver vissuto pienamente, di non aver colto adeguatamente tutte le occasioni della vita. Alcuni vorrebbero essere tutto o almeno molto. Finiscono per fare e disfare troppo; finiscono col vivere di eccessi. È molto difficile trovare l'equilibrio tra tutte le istanze psichiche. È molto difficile sapersi accontentare perché bisogna anche sapersi accettare e anche saper rinunciare.
dic 202022

Qualche tempo fa 18 donne denunciarono pubblicamente di essere state molestate da Jean-Claude Arnault, marito dell'accademica Katarina Frostenson. Questo scandalo travolse il premio Nobel per la letteratura. Da allora il Nobel per la letteratura è meno considerato. Negli anni si è molto discusso delle scelte a dir poco opinabili dell'Accademia svedese. Qualcuno riteneva a torto o a ragione che alcuni accademici alzassero il gomito. Ma quale scrittore può vincere il Nobel? Quali sono i requisiti? Ebbene chiunque abbia dato in termini generici "considerevoli benefici all’umanità” e chi "si sia maggiormente distinto per le sue opere in una direzione ideale". Ci sono sempre molte diatribe e polemiche riguardo al Nobel per la letteratura. Fortunatamente per ora nessuno si può autocandidare, ma nonostante ciò ci sono molte associazioni culturali, molte accademie di paesini sperduti che candidano al Nobel i loro preferiti. Certe candidature non sono minimamente credibili, ma certi personaggi in questo modo possono fregiarsi dell'etichetta "candidato al Nobel per la letteratura". Sicuramente per alcuni autori il Nobel è un'ossessione. Non sempre la candidatura viene fatta con cognizione di causa, a ragion veduta. Lo stesso Licio Gelli venne candidato al Nobel per la letteratura. L'associazione in teoria deve essere rispettabile e riconosciuta. Detto in termini più appropriati, deve essere selezionata dal comitato del premio Nobel per la letteratura. In Italia l'istituzione più seria in questo senso è l'Accademia nazionale dei Lincei, ma va bene anche il Pen Club. Dopo che è stato reso noto il nome del vincitore nei circoli letterari scaturiscono molte polemiche. Quando l'autore è sconosciuto ci si chiede chi sia questo carneade e molti pensano che sia dovuto a una ragione prettamente politica: alcuni sterili polemisti dicono per esempio che lo hanno scelto perché africano oppure perché oppresso ed esiliato, non per merito o bravura. A onor del vero le minoranze sono sottorappresentate. Pochi africani hanno vinto. Per non parlare degli scrittori asiatici. In compenso l'Europa può vantare un grande numero di vittorie. Niente contro la letteratura francese, certamente di grande tradizione, ma che dire delle sue 15 vittorie? E che delle 12 vittorie degli Stati Uniti? E che dire delle 8 vittorie della Svezia? E che dire del fatto che i cinesi sono 1 miliardo e 400000 ma solo due scrittori cinesi hanno vinto? Ci sono molte controversie. Innanzitutto come ha avuto modo di interrogarsi il poeta Luca Alvino: come mai per altre discipline il Nobel può avere vari vincitori mentre in letteratura no? Forse premiare più scrittori nello stesso anno significherebbe scrivere più motivazioni e ciò potrebbe apparire paradossale? Oppure bisognerebbe scegliere più scrittori e motivare le scelte con la stessa motivazione? Ma esiste una motivazione valida per più premiati? Andiamo oltre. Due volte è stato rifiutato il premio: da Pasternàk e da Sartre. Ci furono polemiche anche per il Nobel attribuito a Bob Dylan. Qualcuno sostenne che avevano dato il premio a un cantante, come se il grande menestrello fosse un semplice cantante.

Polemiche tutte nostrane ci furono per il Nobel a Dario Fo. Allora alcuni dissero che era stato premiato un buffone, mentre il poeta fiorentino Mario Luzi aveva subito una grave ingiustizia. Luzi certamente era un professore universitario stimabilissimo e allora veniva considerato il più grande poeta del mondo. Il poeta fiorentino aveva scritto capolavori come "Nel magma". Evitando l'effimero e cercando l'eterno non scadeva mai nel patetico, come ebbe a scrivere Carlo Bo. Giuseppe De Robertis scriveva che le sue poesie erano "un continuo parlare a sé, all'anima, o a persona vicina e compagna di vita". Luzi spiccava per la sua espressività, per il suo simbolismo, per la sua vita interiore così ricca, infine per il suo spessore culturale. Le sue opere si contraddistinguevano per gli endecasillabi canonici, per le analogie mai scontate. Luzi diceva a tutti che c'era sempre qualcosa di ermetico nel reale, un quid enigmatico e sfuggente. La sua condizione esistenziale assumeva una forma universale. L'animo umano compenetrava il paesaggio e viceversa, non a caso "l'albero di dolore" scuoteva "i rami". Era tutto teso a cogliere i propri moti dell'animo e al contempo "l'immobilità del mutamento". "Nel magma" si poteva rintracciare la sua più alta espressione per i fitti dialoghi, per gli interrogativi esistenziali, per la commistione felice di percezione e filosofia, per essere un libro sapienziale, proprio come alcune opere dell'Antico Testamento. Per chi volesse approfondire la conoscenza del poeta fiorentino è consigliabile leggere "Saggio su Mario Luzi" di Anna Panicali (Garzanti editore). Però pochi leggono Luzi. È sempre stato di nicchia, come moltissimi poeti. Pochi avevano letto la sua opera omnia, come fecero Carlo Azeglio Ciampi e sua moglie Franca, che passarono una notte intera a rileggere i suoi versi prima di nominarlo senatore a vita. Ma anche il sottovalutato Dario Fo non era da meno: aveva utilizzato il Grammelot in "Mistero buffo", aveva portato in teatro e fatto conoscere ai più Ruzzante. Certo politicamente poteva essere divisivo: era un uomo schierato e aveva difeso a spada tratta Adriano Sofri, che la Corte di Cassazione aveva condannato come mandante dell'omicidio Calabresi. L'Italia era spaccata in due tra innocentisti e colpevolisti a riguardo. A ogni modo Fo aveva molti meriti e alcuni lo definivano un giullare di Dio. Chi ha una certa età si ricorderà che gli fu comunicata la vittoria quando era in macchina con Ambra Angiolini, con cui festeggiò. L'Italia, per quanto non sia una nazione importante politicamente e la cui lingua sia parlata relativamente da poche persone, ha vinto il premio ben 6 volte con Carducci, Deledda, Pirandello, Quasimodo, Montale, Fo. Certamente ci furono delle polemiche per i Nobel alla Deledda e a Quasimodo perché alcuni letterati non li consideravano meritevoli, non li ritenevano all'altezza. Invece un gigante come Ungaretti non lo vinse mai. Lo stesso vale per Pascoli.

Alda Merini fu candidata ma non lo vinse. Aveva descritto l'inferno dei manicomi, la povertà, il disagio psicologico come nessuno. Il suo genio fu ripagato con l'indifferenza: fu sempre senza lavoro e fu sempre a corto di soldi. Gli italiani dimostrarono di non avere gratitudine e non diedero alcuna solidarietà a una donna così straordinaria, che aveva grande sensibilità. Albino Pierro fu in lizza e la sua candidatura accese i riflettori sulla sua Tursi. Tonino Guerra era ben visto a Stoccolma perché eccellente poeta e inoltre sceneggiatore di Fellini. In un suo celebre componimento scriveva che c'erano persone che da generazioni facevano case e non possedevano una casa. In pochi ma memorabili versi c'era tutta l'ingiustizia capitalista, l'iniqua distribuzione della ricchezza. Anche Alberto Bevilacqua fu candidato, ma da alcuni era ritenuto troppo commerciale, troppo presenzialista in TV. Comunque forse la vera ragione era che non gli perdonavano libri come "La califfa", in cui un'operaia si innamora del padrone, e "La polvere sull'erba", in cui trattava degli omicidi nel triangolo della morte nell'immediato dopoguerra. Pasolini se non fosse stato massacrato sarebbe stato in lizza per il Nobel. Ma il potere gliela fece pagare per i suoi Scritti corsari. Non lo colpì per la sua diversità, ma tramite la sua diversità. Lo colpì nel suo punto debole in una delle sue notti brave. Anche Zanzotto probabilmente fu uno dei papabili per la vittoria. Tra i suoi meriti quello di aver diffuso il dialetto veneto, di aver creato quasi dal nulla un nuovo modo di fare poesia, di aver denunciato l'inquinamento e la perdita di identità della sua gente nel cosiddetto mitico Nord-Est. Zanzotto era un poeta estremamente lucido e brillante. Un suo detto memorabile che amava ripetere nelle sue interviste e spiegava tutto sulla sua lirica "Al mondo" era che nella vita bisogna fare come il barone di Munchausen, ovvero bisogna tirarsi fuori dalle sabbie mobili afferrandosi per i capelli. Aveva come difetto il fatto che la sua poesia metteva a dura prova anche i più preparati, ma era allo stesso tempo il segno inequivocabile che con lui si dovesse fare letterariamente i conti. Anche Dacia Maraini fu candidata e non vale la pena soffermarsi perché è una scrittrice davvero celebre. Più recentemente molti avanzarono la candidatura di Claudio Magris per la sua produzione saggistica di elevata qualità e per la sua promozione della letteratura mitteleuropea. Si parlò anche di Roberto Benigni per la divulgazione della Divina Commedia. Qualcuno a onor del vero considerò biasimevole questa scelta. I più esigenti ritenevano che l'esegesi di Benigni fosse inadeguata, approssimativa e in un certo modo improvvisata, se si confrontava alla smisurata preparazione di Vittorio Sermonti. Naturalmente non poteva mancare tra i papabili il grande Umberto Eco, uno dei pochi intellettuali noti in tutto il mondo grazie a "Il nome della rosa". Era uno dei fondatori del gruppo 63 e pochi sanno che fu anche uno degli ideatori del Dams. Oltre a essere un grande scrittore fu un professore universitario, un semiologo, un saggista a tutto tondo. Disquisì su tutto nelle sue Bustine di Minerva per decenni. Scrisse anche un saggio breve di poche pagine su Mike Bongiorno, citato a sproposito da molti che ritenevano avesse scritto un intero libro sul celebre conduttore. Faceva discutere sempre. Per molti era un obbligo culturale comprare il nuovo libro di Eco. Era considerato all'estero uno degli italiani più intelligenti. Per capire l'Italia all'estero chiedevano lumi, interpellevano Umberto Eco. Ma nessuno è perfetto. Anche a lui non vennero risparmiate critiche in patria. Dicevano e scrivevano che era troppo comunista, troppo fazioso. Secondo alcuni era un professore universitario come molti altri, che aveva saputo sfruttare il momento opportuno. Invece in ogni cosa che fece si dimostrò in modo incontestabile molto originale, profondo, estremamente colto. Si parlò anche della candidatura di Roberto Vecchioni, stimato professore, noto cantautore e poi scrittore di alcune opere, pubblicate da Einaudi. Le canzoni di Vecchioni avevano una cifra poetica innegabile, erano pregnanti e piene di riferimenti colti, di rimandi al mondo greco. Vecchioni cantava di Aiace come di Euridice. Fu memorabile un confronto molto acceso alla trasmissione di Lilli Gruber tra Vecchioni e il grande poeta Valerio Magrelli sulla vexata quaestio del Nobel a Dylan. Magrelli rivendicava la superiorità della poesia e sosteneva che la canzone non fosse minimamente paragonabile. Vecchioni ricordava che anticamente le poesie venissero cantate. La questione era già dibattuta e comunque sempre molto controversa. Ricordiamo che è stato candidato a Stoccolma anche il poeta marchigiano Umberto Piersanti, che è autore Einaudi, operatore culturale, saggista, vincitore di prestigiosi premi letterari. Più recentemente è stato candidato al Nobel il professore e poeta Francesco Benozzo, che ha pubblicato tutti i suoi libri con Kolibris edizioni e che suona magistralmente l'arpa mentre canta i suoi versi. Nel 2021 è stato candidato a Stoccolma anche il poeta Guido Oldani, padre del Realismo Terminale. Ma veniamo ai soldi: il premio Nobel ha un grande ritorno economico per la casa editrice con cui pubblica lo scrittore o il poeta premiato. Già il premio Strega è una grande fortuna per un editore. Tutti vogliono comprare i libri dell'autore premiato. Immaginiamoci il premio Nobel oltre al fatto non indifferente che la vincita consiste in circa un milione di euro! A ogni modo gli accademici svedesi hanno fatto molte ingiustizie a livello planetario, non solo per gli italiani. Joyce, Tolstoj, Virginia Woolf, Fitzgerald, Borges, Proust, Nabokov, Roth non vinsero mai il celebre premio. Scorrendo i nomi dei vincitori ci accorgiamo che non necessariamente tutti hanno fatto la storia della letteratura, che talvolta alcuni sono rimasti seminoti. Viene da chiedersi se questo premio possa davvero contribuire alla letteratura, se il prestigio di cui gode è veramente meritato. Probabilmente il Nobel ancora oggi è molto utile a promuovere un autore, una nazione, una causa.
dic 162022

Siamo animali sociali, ma talvolta abbiamo bisogno di stare da soli. La vita oscilla tra questi due poli: socialità e isolamento. Talvolta c'è bisogno di stare da soli, riflettere sulla nostra vita, cercare di capire in quale direzione stiamo andando, farsi un esame di coscienza, come insegnava Ignazio di Loyola. La cosa migliore sarebbe trovare un equilibrio interiore, fondato su una sana alternanza tra questi due poli. La solitudine come la castità è molto più sopportabile se è una libera scelta e non una costrizione, dovuta a ostracismo, a emarginazione sociale. Anche stare troppo a contatto con gli altri può essere snervante, può esaurire. Alcuni lavoratori, che svolgono professioni di aiuto, soffrono di burn out, a forza di stare troppo a contatto col pubblico. Il grande poeta Kavafis scriveva: "E se non hai la vita che desideri cerca di non sprecarla nel troppo commercio con la gente". Si può essere soli perché si ha un problema, si vive una determinata condizione esistenziale, si soffre di un certo disagio. Gli altri però possono essere terapeutici così come possono essere l'inferno secondo Sartre. Filosoficamente qualcuno potrebbe affermare che stare con gli altri ci dà solo l'illusione di sentirsi meno soli, ma anche questa parvenza di convivialità è necessaria. Secondo uno studio del 2013 della Ohio University chi vive solo ha più probabilità di avere anomalie cardiache, di soffrire di depressione, di avere un sistema immunitario meno efficiente.
Oggi viviamo in una società senza comunità nella maggioranza dei casi. Alcuni si sentono soli e dicono che la città in cui vivono non dà loro niente, ma al mondo di oggi forse una città può offrire solo servizi e non sconfiggere la solitudine dei cittadini. Durkheim aveva coniato il termine anomia per indicare il disordine morale, la sensazione di anonimato, la mancanza di solidarietà della civiltà moderna e aveva chiamato anomico il suicidio dovuto proprio a questi fattori. Oggi quindi si è più soli probabilmente di un tempo. Nel mantovano e in provincia di Padova comunque è stato replicato il caso di Villa del Conte per vincere l’isolamento delle persone. Sono stati creati degli assessorati alla solitudine. Nell'antichità la solitudine era ricercata più spesso. Alcuni poeti antichi avevano un ideale di vita solitaria e bucolica. "Beata solitudo" dicevano i latini. Oggi siamo molto più connessi e più soli di un tempo. Gli psicologi chiamano tutto ciò solitudine digitale. Il caso esemplare sono i giovanissimi Hikikomori giapponesi che si rinchiudono tutto il giorno nella loro stanza per stare al computer. Il ritiro sociale è uno dei sintomi della schizofrenia, ma non è assolutamente detto che sia sempre patologico. La propria psiche è come un contenitore che non si può unicamente riempire del mondo o del proprio io. Probabilmente propendere verso il mondo o l'io dipende anche dalla personalità di base, dalla estroversione o introversione di un individuo. Cosa è che può vincere la solitudine? L'amore innanzitutto, poi l'amicizia, il senso di appartenenza a una comunità oppure a una generazione. Ma oggi non esistono più i movimenti studenteschi. Un tempo esisteva una fauna studentesca che apparentemente era lì per il famigerato pezzo di carta da portare ai genitori e poi in realtà reclamava il sacrosanto diritto di divertirsi, acculturarsi al di fuori degli schemi precostituiti, scopare, viaggiare, ballare. Erano stati scritti tre romanzi sulla realtà studentesca rappresentativi delle varie epoche: "Porci con le ali" (anni '70), "Altri libertini" (anni '80) e "Jack Frusciante è uscito dal gruppo" (anni '90). Forse questi romanzi avevano detto tutto sul mondo studentesco italiano. Dopo l'università non era più stata un momento di discussione, che talvolta diventava di scontro ideologico esasperato, ma un vero e proprio esamificio. Dagli anni '90 in poi si avvertiva che l'unica cosa che accomunava la generazione era l'autodistruzione. Si intuiva perfettamente ciò con il libro della Santacroce "Rimini", il primo della serie. Coloro che invece cercano di vincere la solitudine con l'amore possono imbattersi nell'insoddisfazione sessuale, nelle carenze affettive, nella delusione sentimentale. È difficile essere veramente soddisfatti in amore su tutti i fronti. Ci sono amori platonici e rapporti occasionali caratterizzati dall'impersonalità e l'anaffettività. È difficile avere tutto, trovare una perfetta corrispondenza d'amorosi sensi. L'abbraccio è sconosciuto a molti. Non ci si abbraccia più. È sconveniente. Bisogna essere formali. Ogni dimostrazione di affetto, ogni prova di calore umano viene considerata inopportuna. Lo stesso Papa Bergoglio ha sostenuto che per accorgersi dell'umanità altrui oltre all'ascolto ci vuole il tatto, che secondo il Pontefice è il senso più importante. Una ricerca, condotta da pediatri coordinati da Siavash Beiranvand, docente di anestesiologia, ha coinvolto 120 bambini tra i 2 e i 6 mesi e ha dimostrato che coloro che venivano abbracciati dalla madre piangevano molto di meno dopo un'iniezione. C'è chi per ovviare a questa carenze affettive si compra un animale domestico. La solitudine viene però caldamente consigliata dai mistici. I Padri del deserto si ritirarono appunto nel deserto per fuggire dalle tentazioni del mondo e del diavolo, come fece Cristo per 40 giorni. Per San Giovanni della Croce bisogna meditare in solitudine, pregare per combattere i tre nemici dell'anima, ovvero il mondo, la carne, il demonio. Anche per Santa Teresa d'Avila l'autoperfezionamento passa attraverso la solitudine e la preghiera. Eckhart scriveva che non è necessario essere soli per raccogliersi interiormente e trovare Dio: il vero credente porterà Dio con sé in ogni luogo e con qualsiasi persona, nella chiesa, nella solitudine, perfino in prigione. Per Simone Weil la solitudine va preservata e cercare di sfuggire a essa è una vigliaccaggine. Il mondo quindi distrae, tenta, fa peccare, sporca l'anima. Per i Sufi il vero essere spirituale sa raccogliersi così tanto da essere solo in mezzo alla folla, da non prestare alcuna attenzione alle voci della folla. Secondo i buddisti non bisogna farsi prendere dallo sconforto della solitudine, che può essere anche ritemprante e rilassante. Monaci e suore di clausura, nonostante gli inviti della mistica cristiana alla solitudine, vivono però anch'essi in comunità. Gli stessi eremiti moderni accolgono visitatori e curiosi, pubblicano le loro meditazioni in gruppi Facebook. Secondo i mistici cristiani e non, nonostante le debolezze e le pecche umane, l'isolamento sociale conduce a Dio e Dio è tutto il contrario della solitudine: Dio è amore. Il mondo stesso è fondato sull'interdipendenza degli individui. In un racconto di Calvino un uomo non si sa allacciare le scarpe e fortunatamente trova un uomo che gli fa questo favore: perfino in Hegel è il padrone ad avere più bisogno del servo perché è quest'ultimo che sa fare delle cose che il padrone non sa fare più. Al di là di questo tutti abbiamo un bisogno psicologico degli altri, di avvertire le loro voci, di udire il rumore del mondo. La camera anecoica degli Orfield Labs di Minneapolis, Stati Uniti, è un luogo insopportabile: nessuno ci resiste per più di un'ora. È insopportabile il silenzio assoluto, scalfito solo dal battito del proprio cuore.
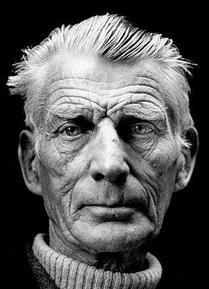
Una differenza fondamentale è quella tra essere soli e sentirsi soli. Ciò che fa veramente male spesso è la percezione soggettiva della solitudine più che il riscontro oggettivo. Ci sono situazioni limite in cui si è malati e ci si trova soli di fronte alla morte: allora si avverte più che mai il bisogno degli altri. Si ha bisogno del conforto. Ci si ricordi dei familiari al capezzale del morente. C'è anche chi prova la solitudine perché si sente incompreso. Bisogna essere molto forti e godere di buona salute per amare la solitudine, come scrisse Pasolini in una sua poesia. Per molti il problema è come rompere la solitudine. Alcuni non sanno comunicare la solitudine. Beckett, Ionesco, Michelangelo Antonioni esprimono questa inadeguatezza. Altri si vergognano di dire che sono soli. Altri ancora si ritengono troppo giovani o troppo vecchi per dire che sono soli. Per i più comunicare la propria solitudine è sinonimo di debolezza. Al contempo la società post-industriale si basa su due opposte polarità: individualismo e conformismo. Molto spesso le persone trovano un compromesso a queste due esigenze sociali accettando un'omologazione dalle varianti minimali, cioè seguono le mode ma si discostano da esse in modo infinitesimale, aggiungendo un piccolo tocco personale. È anch'esso un modo per non sentirsi soli, per identificarsi in qualcosa, per far parte di qualcosa, di essere con gli altri, anche se è un'illusione effimera e momentanea. La propria identità sociale si basa sull'appartenenza a dei gruppi, a delle categorie sociali. Non sentirsi pecora nera è anch'esso un modo per non sentirsi soli. In letteratura H.Hesse propone "Il lupo della steppa", ma alla fine Erminia la donna amata va con un altro e in un raptus di gelosia il protagonista la uccide: imparare a ballare il fox trot non basta per uscire da sé stessi. Sartre ne "La nausea" ci comunica che il mondo, l'esistenza non hanno alcun senso. La stessa cultura impersonificata dall'autodidatta è inutile, non soddisfa le aspettative perché anche quest'ultimo è sorpreso a molestare un adolescente e viene mandato via dalla biblioteca per questa ragione. Thomas Bernhard ne "L'origine" tratta di un collegio, in cui si mischiano sadicamente nazismo e cattolicesimo. L'unico modo per salvarsi dal suicidio, dovuto al disagio per questo microcosmo concentrazionario, è allora suonare il violino. Primo Levi si suicidò perché non seppe convivere con l'orrore inenarrabile e inesprimibile del lager. Pavese si sentiva padrone da solo al buio a meditare, ma sarà proprio "la mania di solitudine", che aveva spesso tramutato in ozio creativo a ucciderlo. Sempre Pavese e Carlo Levi sperimentarono la solitudine del confino. Bassani tratta dell'emarginazione ebraica ai tempi del fascismo e ne "Gli occhiali d'oro" determinata dall'omosessualità. Ne "Lo straniero" di Camus il protagonista prima non versa una lacrima alla notizia della morte della madre, quindi uccide per futili motivi sulla spiaggia un uomo, infine quando viene condannato a morte è impassibile. Siamo quindi tutti stranieri di fronte all'assurdo, che sfugge alla nostra logica. Anche Moravia porta tutto alle estreme conseguenze con il romanzo "1934". Il protagonista, un intellettuale, vuole compiere un suicidio a due con una donna. Ma alla fine sarà beffato perché due donne si prenderanno gioco di lui. Come a dire che la disperazione non si può condividere, che si finisce per essere beffati da chi dimostra avere più attitudine alla vita. Al protagonista non resta che continuare a vivere da solo con la sua disperazione. Ma ora veniamo alla poesia del' 900. Giuseppe Ungaretti scrive sulla tragedia della Prima Guerra Mondiale: “Di queste case / Non è rimasto / Che qualche / Brandello di muro / Di tanti / Che mi corrispondevano / Non è rimasto / Neppure tanto” in San Martino del Carso e finisce la poesia con “E’ il mio cuore / Il paese più straziato”. Pascoli si sente così abbandonato “come l’aratro in mezzo alla maggese”. Quasimodo scrive: “Ognuno sta solo sul cuor della terra / trafitto da un raggio di sole: / ed è subito sera”. Per Kenneth Patchen la solitudine è "un coltello sporco puntato alla gola". Si possono avere molte amicizie e l'amore ma per molti al cospetto della morte siamo tutti soli. Per altri non bisogna sentirsi soli perché non lo siamo mai: c'è sempre qualcuno a questo mondo che ci capisce e condivide quello che sentiamo e proviamo, basta solo cercarlo.

Infine chiudiamo con un poeta della musica come Claudio Lolli, che cantava negli anni Settanta questo brano sul suicidio:
"Quanto amore, quanto amore che ho cercato.
Quante ore, quante ore che ho passato,
Accanto a un termosifone per avere un poco di calore.
Quanto amore, quanto amore che ho cercato.
Quanti oggetti, quanti oggetti che ho rubato,
Mentre nessuno vedeva, mentre, nessuno mi guardava.
Quanto amore, quanto amore che ho cercato.
Dietro i vetri gialli e sporchi di una stanza,
Che aprono una città di ferro, senza voce, e senza una parola.
Quanto amore, quanto amore ho riversato.
Nelle cose più impensate e più banali,
Facendo collezione di farfalle o di vecchi giornali.
Le persone che ho fermato per la strada,
Sinceramente possono testimoniare,
Quanto amore ho cercato, ieri, prima, di essermi impiccato,
Ieri, prima di essermi impiccato.
Quanto amore, quanto amore, quanto amore, che ho cercato …"
dic 112022
Il verso libero:
Nel corso del' 900 si è diffuso il verso libero. Questo è avvenuto non solo tra quelli che vengono definiti dai cattedratici poeti dilettanti ma anche da grandi poeti stranieri e italiani. Laforgue fu il primo grande poeta ad adoprare il verso libero e a tal proposito scrisse: "mi dimentico di rimare, mi dimentico il numero delle sillabe, mi dimentico la distribuzione delle strofe". Anche Pound fece un uso moderato nelle proprie liriche del verso libero. I poeti dell'imagismo scrivevano tutti in versi liberi. E. Lee Masters nella celeberrima Antologia di Spoon River adoprò spesso nei suoi epitaffi versi liberi e non prestò molta attenzione al rispetto della metrica. Per quel che riguarda il nostro paese i crepuscolari Corazzini, Gozzano, Govoni, pur utilizzando anche forme metriche tradizionali, introdussero il verso libero nella poesia italiana. Anche il poeta simbolista Gian Pietro Lucini scriveva soprattutto versi liberi e dichiarò che al momento della creazione non cercava "misure prestabilite (versi), né sequenze numerate di misure (strofe)", né il posizionamento di accenti tonici. Inoltre bisogna ricordare che i poeti vociani Jahier e Boine scrissero solo prose poetiche. Infine i futuristi utilizzarono solo ed esclusivamente il verso libero. Se in poesia e in letteratura devono essere messe delle regole forse devono riguardare il rapporto tra l'arte e il tentativo di ideologizzazione dell'arte stessa. Ritornando al verso libero alcuni intellettuali ritengono che la vera libertà si acquisisca nell'ambito delle regole imposte e degli schemi precostituiti o almeno questa è la loro giustificazione alla loro concezione di una poesia, che per essere tale deve adoprare le forme metriche classiche. Altri intellettuali ritengono invece che nell'arte la libertà non esista, per cui devono essere accettate le regole imposte dalla tradizione. Per il poeta Robert Frost "scrivere versi liberi è come giocare a tennis senza rete».
Ma non è detto che chi scriva versi liberi e non rispetti la metrica tradizionale non si imponga altre regole riguardanti altri ambiti. Un tempo erano presenti dei canoni estetici. Oggi forse è più problematico valutare un poeta. Sono rari i casi di coloro che scrivono endecasillabi canonici. I più scrivono in versi liberi.
La crisi della poesia:
Comprendere le poesie non sempre è facile. Un testo può essere analizzato per il suo significato psicoanalitico, esistenziale, sociale, letterario, ideologico. Ogni testo può essere studiato valutando il contesto storico, la parafrasi, le figure retoriche, la metrica. Non solo ma va anche detto che ogni lirica può scaturire dal sentimento, dall'osservazione o dalla trasfigurazione. Inoltre non sempre un poeta si basa sulla realtà oggettiva ma spesso anche sulla vita segreta delle cose e della natura. Nel Novecento tutto diventa ancora più complesso. Basta pensare a Eliot e Pound con le loro citazioni colte e il loro montaggio. Nel secolo scorso sono stati molti gli ismi letterari. In Italia agli inizi del Novecento l'Ermetismo non era affatto di facile comprensione sia perché in esso era presente l'Orfismo (connotato dal valore sacrale della poesia e dalla ricerca costante di assoluto e infinito) sia perché i testi erano colmi di simboli, analogie e sinestesie. Negli anni Sessanta si registra un notevole cambiamento. Erano contro l'Ermetismo sia i poeti di Officina (Pasolini, Roversi, Volponi, Fortini, Leonetti) che i Novissimi (gruppo 63), ma anch'essi non erano di facile comprensione. Da un lato i poeti di Officina avevano buoni intenti: volevano il rinnovamento, erano contro l'intimismo degli ermetici, erano contro i reazionari. Dall'altro lato erano anche contro il Neorealismo, uno dei pochi ismi del Novecento (insieme ai crepuscolari) i cui autori si facevano capire da tutti. Forse nel Neosperimentalismo erano presenti troppe premesse teoriche. Anche la Neoavanguardia era ammirevole negli intenti perché contro il neocapitalismo, contro l'egemonia culturale e l'estetica dominante, contro la mercificazione dell'arte. Però spesso spiazzava i lettori per i suoi non sensi, il suo linguaggio multidisciplinare, i suoi shock verbali, la ricerca di essere originali a tutti i costi. Infine la poesia degli anni Settanta con il neo-orfismo cambia di nuovo le carte in tavola perché prende le distanze sia dalla neoavanguardia che dal neosperimentalismo, ma il linguaggio poetico è sempre oscuro e di non facile decifrazione. Per capirne di più basta leggere due antologie poetiche: "La parola innamorata" e "Il pubblico della poesia". Il poeta comunque da decenni non ha più alcun status e la poesia contemporanea è divenuta marginale. Molti scrivono. Pochi leggono. C'è anche troppa creazione ma è scarsa la fruizione. La poesia contemporanea è determinata talvolta dall'egocentrismo, dal narcisismo, dall'autobiografismo. È una poesia talvolta autoreferenziale e non comunicativa. I poeti sono sempre più appartati. Il loro messaggio talvolta non è chiaro. Il gradimento del pubblico è scarso. I giornali raramente recensiscono libri di poesia. Nelle Facoltà di Lettere i poeti contemporanei non trovano spazio. Il fatturato dei libri di poesia in Italia è inferiore all'1% del fatturato globale. I libri di poesia nella stragrande maggioranza dei casi finiscono al macero. I poeti sono stati sostituiti e rimpiazzati socialmente da cantanti e cantautori. Sono molteplici i motivi di questa situazione e non li analizzeremo ora. Comunque oggi i poeti viventi sono sconosciuti al grande pubblico. Come sono cambiati i tempi da quando Vico scriveva che i poeti sono i primi storici delle nazioni! Oggi è innegabile che la poesia di questi anni è in crisi e alcuni critici l'hanno definita minimalista. La lirica di questi tempi è talvolta illeggibile e non memorabile. Comunque non bisogna essere ottimisti né apocalittici.
Poesia e moralità:
È sempre difficile giudicare la qualità delle poesie. È vero che è improponibile il paragone tra la poesia di un bambino di prima elementare e una di Montale. Ma spesso le differenze non sono così marcate. Un tempo si consideravano la metrica e l'eufonia. Oggi non più. Decenni fa in Italia si considerava anche la persona del poeta, che doveva essere assennato e ponderato. Al poeta si richiedevano delle virtù come una certa moralità e la saggezza. Se era sregolato allora era solo un erudito e/o un immaturo. Non poteva considerarsi persona di cultura. Si guardava il comportamento. Si considerava soprattutto l'etica. Si giudicava la condotta. C'era molto moralismo. D'altronde anche la Neoavanguardia valutava la persona (che doveva essere schierata ideologicamente). Loro erano gli unici puri e onesti. Consideravano anche la poetica. Quindi il contenuto veniva giudicato in modo fazioso perché secondo loro il linguaggio era "ideologia". Insomma si doveva combattere. Erano in trincea. Bisognava condannare la borghesia. Quindi bisognava per forza di cose odiare i piccoli borghesi. È chiaro che la Neoavanguardia ha avuto anche dei meriti come quello di rinnovare il linguaggio, inventare il pluristilismo, etc etc. Le due "chiese" comunque si sono appropriate della cultura nella seconda metà del Novecento. La maggioranza della gente se ne fregava. Negli anni Settanta le nuove generazioni erano perse nella droga o nella politica. La letteratura era ritenuta cosa di poco conto e non incisiva. Addirittura era ritenuta evasione. Molti giovani di allora pensavano ad altro e si rovinavano con altro: l'eroina o il terrorismo. La stessa poesia da allora è stata relegata ai margini e non si è più ripresa. Giudicare le poesie è sempre impresa ardua e risente di una certa soggettività. Spesso è questione di gusto più che di criteri estetici.

Poesia e ideologia:
Quali qualità deve possedere un artista per essere tale? Sono sicuro che a questa domanda molti risponderebbero che deve avere talento. Ma forse questo è un prerequisito fondamentale ma non sufficiente. Vittorio Sgarbi in "Lezioni private" scrive che un artista deve avere uno stile. Per esempio un poeta deve avere una visione del mondo. Successivamente avrebbe una poetica (ovvero una dichiarazione di intenti) e uno stile. Un artista di conseguenza secondo tale concezione deve anche essere un intellettuale, che riflette sul mondo e che rappresenta una coscienza critica per gli altri. Secondo Sgarbi l'artista è tale innanzitutto per il proprio pensiero (che deve contraddistinguersi per una certa originalità) e questo è valido sia per chi appartiene alla tradizione che per chi appartiene ad una avanguardia. Secondo altri si può scrivere anche senza una piena consapevolezza di sé stessi e del mondo, ma in fondo sono un'esigua minoranza. Molti critici la pensano come Sgarbi. Altra cosa importante oltre al pensiero è quella che alcuni chiamano la posizione intellettuale. Un artista può esprimere dissenso, consenso o non schierarsi rispetto alla politica e al potere. Per Gramsci ogni artista doveva essere un intellettuale organico. Sartre nella presentazione a "I tempi moderni" proponeva l'engagement. Lo scrittore era da ritenersi sempre responsabile. Non doveva scrivere per i posteri ma per i contemporanei. Non doveva evadere dalla realtà ma essere sempre testimone. Però molti altri erano per una posizione intellettuale meno impegnata politicamente. Per Saba i poeti dovevano essere "sacerdoti dell'eros". Anche D'Annunzio faceva dire a Claudio Cantelmo ne "Le vergini delle rocce" che gli artisti dovevano soltanto difendere la bellezza. Ma in fondo era in buona compagnia. Lo stesso Dostoevskij scriveva che la bellezza avrebbe salvato il mondo. Chissà cosa avrebbero pensato oggi di questa epoca in cui l'arte è soprattutto ricerca del nuovo a tutti i costi e provocazione fine a sé stessa?
Lo stile comunque può essere giudicato subito dai critici letterari, mentre le scelte politiche devono essere comprese e interpretate almeno dopo qualche decennio. Il rischio infatti è quello di essere troppo faziosi e di confondere l'estetica con l'ideologia. In alcuni casi c'è la possibilità di confondere l'estetica con l'etica. Non ci scordiamo che in alcuni autori l'appartenenza politica è più che una presa di posizione politica una scelta dettata da idealismo. Per alcuni artisti il liberalismo, il comunismo, il socialismo, la socialdemocrazia, l'anarchia sono categorie dello spirito. Non dimentichiamoci neanche che furono pochi gli intellettuali a opporsi all'entrata in guerra e al fascismo. Condanniamo pure il loro fascismo ma bisogna anche considerare obiettivamente le loro opere artistiche. Lo stesso dicasi per altre ideologie e altri regimi. Facciamoli però processare dagli storici, anche se si può legittimamente mostrare una certa repulsione per i loro atteggiamenti e comportamenti. Condanniamoli pure come uomini ma non rimuoviamo totalmente gli artisti che sono stati e neanche quello che hanno rappresentato per gli uomini della loro epoca.

Poeti di ricerca e neolirici:
Forse è troppo riduttiva la distinzione tra poesia di ricerca (sperimentatori del verso) e poesia neolirica. Non è detto che tutto lo sperimentalismo porti per forza di cosa sempre al rinnovamento del linguaggio e al rovesciamento di prospettive. In fondo anche alcuni poeti lirici o neo-orfici possono essere originali ed innovativi: non è assolutamente detto che siano sempre dei manieristi o degli epigoni. Non è detto inoltre che questa distinzione tra i due generi di poesia possa racchiudere tutte le dicotomie concettuali ed espressive (comprensibile/difficile, tradizione/innovazione, impegnato/reazionario, etc. etc.). Per quanto riguarda la comprensibilità dei testi la Dickinson scriveva che si doveva dire la verità in modo criptico, mentre K. Popper sosteneva che niente è così facile che scrivere in modo difficile e che tutti coloro che scrivono devono porsi come dovere la chiarezza espositiva (però era un filosofo). La realtà in poesia è che i componimenti dovrebbero in teoria cercare sempre di raggiungere i vertici della significazione. Però i poeti spesso cercano termini ricercati, talvolta antiquati, perché li considerano più consoni. I poeti tra gambo e stelo scelgono sempre il secondo vocabolo, anche se non sarebbe necessario. Anche i poeti in fondo hanno il loro gergo. Mi sembra che Pasolini avesse dichiarato a riguardo che esistesse in poesia un codice classista del linguaggio. Ma non è forse riduttiva questa distinzione tra poesia di ricerca e neolirici? Non potrebbe essere considerata anche una poesia aforistica come quella dell'ultimo Montale, degli Shorts di Auden, dell'ultimo Cesare Viviani? Non sarebbe forse originale se questo genere di poesia aiutasse a chiarire i pensieri, portasse talvolta a "pensare contro sé stessi" per dirla alla Cioran (il riferimento è alla sua opera "La tentazione di esistere")? Naturalmente una scrittura aforistica rischia sempre di essere troppo didascalica oppure ostensiva. Ma in fondo anche gli sperimentatori o i neolirici rischiano anch'essi di perdersi in virtuosismi, di innamorarsi troppo delle parole. I rischi ci sono per tutti. Comunque la distinzione autentica che dovrebbe essere fatta è tra chi cerca di descrivere/raggiungere/ rendere tutta la complessità del reale (il rischio è quello di rendere ancora più complicato e di più difficile comprensione ciò che è già complesso) e tra chi cerca di semplificare la realtà (il rischio è quello di rendere tutto troppo semplicistico, di creare delle smagliature da cui evade il reale). Queste dovrebbero essere le due scuole di pensiero (ma forse sarebbe meglio dire due atteggiamenti esistenziali) di una poesia, che allora potrebbe essere veramente ricerca di senso. Ma forse è solo una utopia. Però la distinzione basilare è tra chi cerca di raggiungere la soglia del dicibile e chi cerca la sostanza delle cose, l'essenziale. Questi a mio modesto avviso sono i due modi di porsi in estrema sintesi. Poi a prescindere dal tipo di atteggiamento chiunque può essere o meno innovativo. Per cercare l'essenziale intendo l'estrema sintesi del reale. La soglia del dicibile non è detto che sia estrema sintesi. L'essenziale lo si raggiunge con il levare. È la caratteristica tipica della scrittura epigrammatica. La soglia del dicibile invece la si raggiunge con il battere, con l'accumulo: significa cercare di descrivere in modo esaustivo la realtà, di comprenderla in modo totalizzante.
dic 052022

Calvino e Pavese lavorarono per alcuni anni alla Einaudi. Fu lo stesso Pavese a scoprire il talento di Calvino. Questo ultimo però stroncò il romanzo "Tre donne sole" di Pavese, che poi rispose il 29 luglio 1949: “Ma tu – scoiattolo della penna – calcifichi l’organismo componendolo in fiaba e in trance de vie. Vergogna”. Pavese si suicidò nel 1950. La sua scomparsa fu dovuta alle delusioni sentimentali e alla sua depressione. Era uno scrittore riconosciuto. Aveva vinto anche il premio Strega. Pavese era una figura di riferimento per molti. L'Einaudi pubblicherà postume nel 1966 le sue Lettere 1945-1950, proprio a cura di Italo Calvino. I critici non si trovano minimamente d'accordo. C'è chi sostiene che Calvino considerò Pavese un suo maestro per tutta la vita; chi scrive che la Ginzburg e Calvino erano molto invidiosi di Pavese; chi ricorda l'affinità ideologica tra i due grandi scrittori, ma sostiene che avessero modi di intendere la letteratura diversi; c'è chi sostiene che Calvino era grato a Pavese e chi sostiene che in fondo non gli dimostrò molta riconoscenza in vita, ma solo a posteriori.
Nel 1953 Calvino ebbe modo di scrivere: "E posso dire che per me, […], l’insegnamento di Torino ha coinciso in larga parte con l'insegnamento di Pavese. La mia vita torinese porta tutta il suo segno; ogni pagina che scrivevo era lui il primo a leggerla; un mestiere fu lui a darmelo immettendomi in quell’attività editoriale per cui Torino è oggi ancora un centro culturale d’importanza più che nazionale; fu lui, infine, che m’insegnò a vedere la sua città, a gustarne le sottili bellezze, passeggiando per i corsi e le colline". C'era rivalità allora tra i due? C'era antagonismo? Oppure solo qualche incomprensione come succede anche tra sodali, tra migliori amici? Stilisticamente Calvino non sembra aver subito l'influsso di Pavese. La scrittura del primo era determinata dall'ossessione descrittiva e dalla completezza della resa della molteplicità fenomenica; quella del secondo dall'adesione alla vita, al flusso ininterrotto degli eventi e degli incontri: Calvino voleva descrivere il mondo, Pavese la vita dei suoi personaggi. Lo scrittore ligure era molto puntiglioso nel descrivere ambienti e personaggi. Pavese invece utilizzava un linguaggio meno esatto o comunque meno forbito, ma era sempre rigoroso ad ogni modo nella scelta dei vocaboli. Si potrebbe pensare che Calvino aveva un rapporto conflittuale con il linguaggio e che la sua scrittura fosse piena di revisioni e stesure. Invece Pavese aveva un rapporto più conflittuale con l'esistenza stessa, non riuscendo a venirne a capo. Pavese non riuscì a entrare nel pieno della vita, per tutto il suo tempo però fu un osservatore partecipe, come nei suoi romanzi. In Calvino tutto il suo intelletto era proteso verso il linguaggio, che doveva rappresentare in modo esatto le cose e le persone. In Pavese il linguaggio meno esatto ma pur sempre molto accurato doveva trovare l'essenza stessa della vita: entrambi si ponevano quindi degli obiettivi molto impegnativi, forse irrealizzabili. Se si analizza un singolo periodo potrebbe sembrare di primo acchito che chiunque possa scrivere come Pavese, ma lui fu il primo a scrivere in quel modo e al contempo va detto che ci voleva il retroterra culturale di un grande intellettuale per imbastire i suoi romanzi. Come ebbe modo di scrivere lo stesso Calvino c'era sempre qualcosa di sottinteso nei romanzi di Pavese; c'era sempre qualcosa di sottaciuto e fu definito per questo "reticente". Pavese quindi solo apparentemente poteva considerarsi uno scrittore semplice, anche se la lettura dei libri di Calvino per la loro ricchezza lessicale mette alla prova un lettore non letterato, richiede talvolta l'utilizzo del vocabolario. Il primo romanzo di Calvino, "Il sentiero dei nidi di ragno" in un certo qual modo da un punto di vista tematico, contenutistico, stilistico poteva avere dei punti in comune con le opere di Pavese, ma successivamente Calvino si dimostrò realista-favolistico, mentre Pavese un neorealista con il mito delle Langhe. Calvino fu creatore di miti e di archetipi, mentre Pavese li prese direttamente dalla sua realtà quotidiana per poi metterli sulla carta. Calvino dimostra tutta la sua creatività, pescando a piene mani dalla fantasia; Pavese attinge invece dalla quotidianità, è maestro impareggiabile nel descrivere la vita della sua epoca. In Pavese ci sono le Langhe e la Torino di quegli anni; talvolta sembra che invece dello sfondo siano dei veri protagonisti dei romanzi: comunque sono determinanti, hanno un ruolo non marginale nella sua narrativa. Forse è proprio per questo che il mondo di Pavese oggi può apparire più distante e meno attuale, mentre Calvino che ha scritto opere più scientifiche come "Palomar" e "Le cosmicomiche" sembra più attuale e per niente datato. Va ricordato a tal proposito che Calvino morì nel 1986, mentre Pavese solo nel 1950: lo scrittore ligure perciò ebbe modo di intuire e intravedere alcuni aspetti della nostra realtà odierna, mentre Pavese è ormai relegato in un'altra epoca più lontana. Forse Pavese ha meno da dirci oggi rispetto a Calvino e noi stessi possiamo capirlo di meno rispetto a Calvino.

Il successo attuale della narrativa di Calvino probabilmente è dovuto al fatto che insieme a Rodari venga considerato uno scrittore per bambini, a differenza di Pavese, che forse viene ritenuto più cupo e più drammatico, insomma meno adatto per gli studenti. Questo non rende pienamente giustizia a nessuno dei due: Calvino con la trilogia de I nostri antenati, che raccoglie i romanzi “il visconte dimezzato”, “Il barone rampante e “Il cavaliere inesistente”, compie delle riuscite metafore dell'intellettuale della sua epoca (e questi libri sono perciò a doppio fondo, hanno una doppia chiave di lettura), mentre lo stesso Pavese, seppur tragico e suicida, può essere un esempio per tutti come uomo, intellettuale e scrittore antifascista. Si potrebbe affermare che Calvino fu più gnoseologico e Pavese più esistenziale, pur essendo entrambi accomunati dalle stesse idee politiche. Il modo di approcciare la realtà fu quindi completamente differente. La scrittura di Calvino sembra inimitabile, inarrivabile, sembra sempre così difficile, irraggiungibile, quasi perfetta. La scrittura di Pavese sembra più sciatta, mai impreziosita con vocaboli non comuni, apparentemente a uso e consumo di tutti, mentre in realtà a un'analisi più attenta non è così perché anche lo stile pavesiano richiede molto talento, molto studio, molto impegno. Ci sembra di poter affermare che nell'epoca in cui vissero Pavese ebbe più successo, mentre oggi è caduto più nell'oblio, a differenza di Calvino che oggi è in auge, ormai di moda. Attualmente leggere i libri di Calvino è un must, è un dovere a cui non si deve sottrarre una persona dalle buone letture. Ma Calvino e Pavese si capirono? Calvino dichiarò che non aveva mai presagito niente delle volontà suicidarie dell'amico. Forse entrambi erano tutti presi a livello intellettuale da mettere da parte le vere ragioni di vita. Viene da chiedersi quanti anni bisogna frequentare e vivere fianco a fianco con una persona per capirla davvero. A volte nonostante una frequentazione assidua le persone sono mondi lontani che si sfiorano appena, ma che non si incontrano veramente. Forse Calvino scoprì veramente quel che covava segretamente nell'animo Pavese solo dopo aver pubblicato le sue opere postume. In “Sono nato in America…Interviste 1951 – 1985” (a cura di Luca Baranelli) lo scrittore ligure dichiarò: "Conobbi Pavese dal ’46 al ’50, anno della sua morte. Era lui il primo a leggere tutto quello che scrivevo. Finivo un racconto e correvo da lui a farglielo leggere. Quando morì mi pareva che non sarei più stato buono a scrivere, senza il punto di riferimento di quel lettore ideale. Prima che morisse, non sapevo quel che i suoi amici più vecchi avevano sempre saputo: che era un disperato cronico, dalle ripetute crisi suicide. Lo credevo un duro, uno che si fosse costruita una corazza sopra tutte le sue disperazioni e i suoi problemi, e tutta una serie di manie che erano tanti sistemi di difesa, e fosse perciò in una posizione di forza più di chiunque altro. Difatti era proprio così, per quegli anni in cui lo conobbi io, che forse furono gli anni migliori della sua vita, gli anni del suo lavoro creativo più fruttuoso e maturo, e d’elaborazione critica, e di diligentissimo lavoro editoriale". Il lascito intellettuale dei due fu molto differente non solo a livello narrativo ma anche per così dire saggistico; il testamento di Pavese fu "Il mestiere di vivere" fatto soprattutto da riflessioni esistenziali, mentre quello di Calvino fu "Lezioni americane", costituito da intuizioni letterarie e culturali.
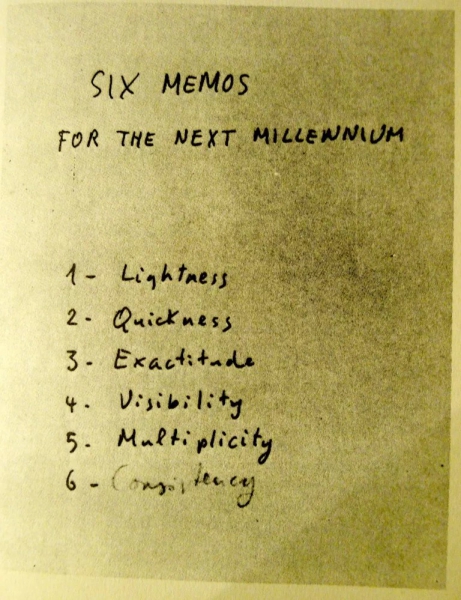
Comunque il critico letterario Guido Davico Bonino dichiarò, ricordando una conversazione avuta con Calvino: "Mi disse: io ho addosso ancora il rimorso pieno di non aver fatto quello che avrei dovuto per impedirgli di fare la scelta finale. C'era un affetto fortissimo di Pavese per Calvino. E schiettissimo". Calvino non aveva capito nel profondo Pavese. Forse si può affermare che la loro stima e la loro conoscenza fu soprattutto letteraria, intellettuale. Calvino non afferrò pienamente il tormento, il disagio esistenziale del suo maestro o presunto tale. Sempre su Calvino come critico letterario ci sono luci e ombre. Da una parte fu il talent scout di Daniele Del Giudice e Andrea De Carlo. Dall'altra dimostrò una idiosincrasia per il grande Guido Morselli, morto suicida e inedito (la cui scoperta fu dovuta a Calasso, che lo pubblicò postumo con Adelphi). Su Calvino poteva raccontarci qualcosa di interessante fino a poco tempo fa Eugenio Scalfari, suo compagno di liceo e amico. Sicuramente il grande scrittore ebbe una personalità complessa e ricca di sfaccettature. A ogni modo non bisogna mitizzare troppo gli scrittori e ciò non significa non apprezzarne il talento o la genialità. Sono esseri umani come tutti con i loro difetti, con le loro pecche e quindi ogni ritratto non deve essere una immaginetta votiva, come vogliono alcuni.
nov 302022

(Nella foto il parco della Sozzifanti a mezzanotte)
Pubblico un mio scritto del 2005. Come potete rendervi conto la situazione in Italia non è ancora cambiata:
SCRIVERE, OVVERO UN MODO PER ESPLORARE SE STESSI:
Si parte col cercare di scrivere l'imprevedibile, l'inafferrabile, l'ineffabile. Nessuno vuole rifarsi alla veggenza di un Rimbaud, alla divinazione del simbolismo e del decadentismo, ad un dannunzianesimo di ritorno, ma comunque si rimane in attesa di una rivelazione. Si cerca uno scarto dal senso comune e dal linguaggio convenzionale, un ribaltamento del senso, una parola che indaga, che testimonia l'incredulità di fronte all'assurdità del mondo e che insegue una parvenza di verità. Si spera di descrivere l'oscillazione dei propri umori e dei propri stati psichici, di trovare nel proprio stile un'armonia dei contrasti e dei dissidi. Si cerca anche la complementarità (e non l'antinomia) tra istinto e razionalità, l'espressione più autentica di se stessi. Si finisce spesso col fare della metapoesia e del metalinguaggio o per cadere nel poetichese più stucchevole e più ovvio (sentimentalismo, retorica, narcisismo, autocompiacimento). Si inizia a scrivere, facendo leva sulla propria spontaneità (leggi anche ingenuità) e si finisce per avere maggiore consapevolezza e perciò più inibizioni, che censurano e cestinano gli ultimi scritti. Si credeva inizialmente che la propria parola fosse realmente una "parola innamorata" e a conti fatti si finisce per ritenere che tutto ciò che è stato scritto è puro diarismo consolatorio e intimismo patetico. Si voleva originariamente esplorare il proprio sé e manifestare il dissenso nei confronti di una società paradossale e dopo alcuni anni ci si convince che questo tentativo era utopico. Si cercava, si cerca comunque di abitare le parole, ognuno nel modo più confacente alla sua individualità (e abitare le parole non significa affidarsi esclusivamente all'ispirazione. L'ispirazione è un falso mito. Prima che qualsiasi opera abbia una consistenza unitaria definitiva molte sono le revisioni:cancellature, aggiunte, tagli).
Si scrive e si continua a scrivere perché il mondo è vanità e la scrittura è terapia. La poesia fa intravedere l’inaccessibilità dell’essere al linguaggio e l’inconoscibilità dell’in sé. Esiste una profondità a cui non si può attingere. Mettere in conto questo non significa irrazionalismo, ma premessa che da sola la logica non è sufficiente. Non ha alcun valore e nessuna efficacia la creazione di freddi schemi concettuali, che catalogano la realtà. L’astrazione da sola resta sempre in superficie, genera continuamente illusioni e disillusioni. Esiste il mistero, l’enigma, l’ignoto, che ci irretisce e ci angoscia. Siamo tutti attanagliati dall'incertezza e dalla precarietà dell'esistenza. In questo percorso è facile perdersi e difficile ritrovarsi. Si cerca dei nessi logici e ci si ritrova da soli con le proprie interrogazioni metafisiche nel divenire incessante e dionisiaco, che continuamente crea e distrugge sé stesso. Si cerca un piccolo nucleo del vero e ci si accorge che soltanto il Nulla si è esplicitato. Si vorrebbe vivere totalmente, ma l'unificazione di pensieri, valori e vita è impossibile. Si finisce invece spesso per analizzare un valore con i valori, un pensiero con i pensieri, per non parlare poi dell'esistenza che rimane inafferrabile sia per il pensiero che per i valori. Ci si guarda dentro e ci si rende conto di essere sempre più incomprensibili a noi stessi. Ciascuno vorrebbe esistere pienamente, veramente, andare oltre il vissuto e trascendersi. Ma i tentativi risultano sempre goffi e allora ci si rifugia nella superficialità e si finisce per essere circondati dal vuoto. Per questo motivo molti si parlano addosso e chiacchierano in modo insulso su cose stupide, banali, risapute: divertirsi, scopare, spettegolare. Paura del divenire, dell’infinito e della morte. Il parlare comune è abuso perpetrato sulle parole, è rinuncia quotidiana alla particolarità, singolarità, irripetibilità insita in ciascuno. La poesia -anche quella meno riuscita- non è riproduzione della reale, ma emanazione, intuizione, rischiaramento. C’è un periodo in cui non si scrive niente e magari si incamera malumori. Anche questa fase apparentemente improduttiva è periodo di fermentazione, di gestazione. Poi all’improvviso qualcosa ci fa vibrare dentro come una corda. un’impressione, un dettaglio insignificante, un’idea che non si sa dove è nata, però sappiamo che deve essere fermata. Scrivere dunque e non per puro piacere, ma perché è un’attività che può significare l’inizio di una libertà interiore. Scrivere può significare prendere possesso di sé stessi gradualmente, scoprire sé stessi, conquistare sé stessi.
MARGINALITA' DELLA POESIA DI OGGI:
Secondo i recenti studi della psicopatologia dell'espressione le persone psicotiche sono più creative, nonostante le loro crisi dissociative, le loro distorsioni percettive, i loro vissuti fantasmatici ed i loro deliri. Quindi la follia è vicina alla poesia da sempre secondo queste analisi, però mai come ora la poesia è stata vicina alla follia. Se prima la follia talvolta poteva divenire espressione artistica, ora è la poesia vera talvolta a toccare in pieno la follia. Infatti mai come oggi i poeti hanno rischiato di impazzire veramente. Mai come ora il poeta ha rischiato di impazzire per il dominio del consumismo e della civiltà dell'immagine e al contempo per la scarsa considerazione della poesia. Ma procediamo con ordine. Il gruppo 93 in questi ultimi anni, accoppiando critica e poesia, ha analizzato in modo creativo le contraddizioni della scrittura in quest'epoca e ha proposto nuove possibili forme di sperimentazione/contestazione della società. Si è rifatto alle avanguardie senza una reiterazione meccanica e stereotipata di queste, ha rivalutato l'allegoria per la sua polisemia -riprendendo la definizione di W.Benjamin ("l'allegoria non è una tecnica giocosa per produrre immagini, bensì espressione, così com'è espressione il linguaggio, e, anzi: la scrittura" in "Sull'origine del dramma barocco tedesco")- e posto l'accento sulla marginalità della poesia in questa società massmediatica. E proprio da questa marginalità vorrei partire. E' amaro constatare che la poesia oggi in generale sia solo e soltanto un evento marginale, sia per quel che riguarda il consumo che la ricerca. La scuola non aiuta ad avvicinare i giovani alla poesia perché l'insegnamento di questa è troppo pedante e nozionistico. I programmi ministeriali delle superiori lasciano molto a desiderare perché i poeti contemporanei italiani che stranieri non vengono fatti leggere. La scuola italica così riesce ad essere una scuola umanistica (visto che il tempo dedicato all'insegnamento dell'italiano è cospicuo), però al contempo ad essere anche il primo agente di socializzazione, che allontana i giovani dalla letteratura. Non è quindi un caso che in un simile analfabetismo di ritorno generalizzato divengano best-seller i libri di Lara Cardella e di Melissa P. , oppure "Il codice da Vinci" di Dan Brown, che si basa su falsi storici (come il congiungimento carnale tra Cristo e la Maddalena, il viaggio di questa in Francia, etc, etc). Non è un caso nemmeno che allo stato attuale delle cose molti ingenuamente pensino che la canzone sia poesia. I cantanti quindi hanno preso il posto che spettava un tempo ai poeti. Poesia e canzone possono qualche volta essere simili, ma non si possono far equivalere innanzitutto per questioni stilistiche, sintattiche, verbali. Il linguaggio delle canzoni spesso è banale ed ovvio. Non solo, ma le canzoni difficilmente si occupano di descrivere la molteplicità del reale e il disagio esistenziale. La qualità e la quantità delle tematiche trattate nelle canzoni di oggi è nettamente inferiore a quelle della poesia. La canzone è soprattutto l’espressione dei propri sentimenti amorosi in tre-quattro minuti e la rima amore e cuore spadroneggia ancora oggi. I poeti invece anche quando parlano d’amore lo fanno cercando di innalzarsi dalle passioni, evitando le sdolcinatezze e i luoghi comuni. Questo naturalmente non significa che non esistano grandi cantautori, che trattino adeguatamente problematiche sociali o descrivano dignitosamente i loro sentimenti amorosi. La dimostrazione del fatto che la canzone e la poesia siano due attività davvero diverse è che grandi cantautori hanno scritto poesie con esiti non felici e che grandi poeti hanno scritto canzoni con risultati mediocri. In Italia l'unico grande poeta che si è dimostrato essere un valido autore di canzoni è solo Roberto Roversi, che ha scritto testi per Lucio Dalla. L’equivoco sempre più diffuso che la canzone sia poesia è dovuto a mio avviso non solo a una mancanza di conoscenza nei confronti della poesia, ma anche a precise scelte poetiche, che facendo equivalere ideologia e linguaggio, si contrapponevano al linguaggio ordinario per rifiutare il conformismo borghese. Un altro effetto di questa situazione è l'esterofilia dilagante, che regna nel cinema, nella musica, nella letteratura.
A mio modesto avviso non solo la poesia viene letta da pochi, ma la sua ricerca nella maggioranza dei casi è purtroppo vana perché per dirla alla Pound non riesce a mantenere in efficienza il linguaggio del nostro Paese. Infatti sono i mass-media della televisione e della carta stampata coloro che impongono i nuovi canoni linguistici. Ma bisogna ricordare anche la profezia di Pound: alla decadenza della letteratura di una nazione consegue la decadenza della nazione stessa. Viene da chiedersi se la colpa sia attribuibile ai poeti moderni, perché i loro idioletti sono talvolta anacronistici e incomprensibili. Lo snobismo e l'elitarismo della poesia moderna e della critica letteraria sono sempre stati presenti, tuttavia è impresa non da poco chiedere l'azzeramento totale, una parola cristallina e rarefatta, così lineare e chiara da giungere al grado zero della scrittura. Il rischio che il proprio idioletto divenga un linguaggio privato, un insieme di sottocodici connotativi ignoto alla maggioranza, esiste, ma non siamo naturalmente ai livelli del paradosso filosofico di Kripke-Wittgenstein. D'altro canto come pensava Yeats "la bellezza è difficile", anche se va sempre tenuto presente il carattere di intersoggettività della poesia. Questo non significa necessariamente la morte della poesia, perché se è vero che è marginale e non ha più un pubblico, è altrettanto vero -come sostiene Pasquale Vitagliano- che ha una sua comunità (si pensi alle riviste on line così come agli Slam Poetry del poeta Lello Voce). Certamente sono poche le possibilità per un giovane facitore di versi di avere visibilità, sia per la gerontocrazia letteraria che per la crescita esorbitante di casi editrici a pagamento, che non hanno nemmeno una rete di distribuzione. Altro discorso poi andrebbe fatto per le antologie considerate autorevoli dei poeti delle nuove generazioni. Spesso gli addetti ai lavori recensiscono superficialmente e non fanno un'analisi approfondita dei nodi tematici, delle affinità stilistiche, degli aspetti sincronici dei lavori dei prescelti. Molti esperti hanno parlato di morte della critica. Senz'altro quando si vuole dimostrare che la critica letteraria è morta o moribonda si fa sempre l'esempio facile della scomparsa delle stroncature, come quelle di Papini per intenderci. Io invece sono dell'idea che i critici letterari inizino con l'esegesi dei testi e finiscano per fare quasi esclusivamente i propagandisti, i divulgatori o i saggisti. La pecca maggiore di molti è il recensire in base a scambi di favore o in base ad interessi economici. Inoltre a mio avviso un'altra pecca è la loro mancanza di equilibrio e di serenità nel giudicare i più giovani. E' raro riscontrare dei critici letterari, che -tramite un processo di analisi e creazione- interpretino approfonditamente e con equanimità i nuovi autori. Per un nuovo autore sicuramente il modo più economico e più efficace per avere visibilità è farsi un sito internet, prendendo in esame le varie possibilità di hosting gratuito che offre la rete. Questa soluzione permette anche di entrare in contatto con altri appassionati di poesia moderna. La speranza è che questa comunità poetica non divenga un insieme di cricche faziose (che agiscono in base alla ricattabilità, al clientelismo, alle logiche di spartizione, ai timori reverenziali nei confronti degli autori di successo), altrimenti molti saranno propensi a credere che la poesia sia solo un genere in disuso per un'italianistica sempre più in crisi o un'abile operazione di marketing, che abbina saltuariamente i grandi poeti ai quotidiani. Lasciare la poesia al mondo del giornalismo e quindi del sensazionale significherebbe far cadere una parte della letteratura moderna nell'indistinto delle mistificazioni e delle iperboli, in fin dei conti del senso di vuoto globale, che ci circonda e ci attanaglia.

LA NUOVA LETTERATURA COME PROLIFERAZIONE DI UN RIZOMA:
Chi cerca di dare una definizione di poesia si trova sempre nella stessa medesima situazione paradossale del protagonista di un racconto del "Dialogo dei massimi sistemi" di Tommaso Landolfi, in cui si cerca di stabilire se possa essere veramente considerata poesia un componimento scritto in una lingua sconosciuta. Nessuno è depositario di una verità assoluta, più come mai oggi. Perfino per la scienza moderna non esistono previsioni infallibili né certezze assolute. La logica scientifica è divenuta ormai ipotetica e probabilistica. Se i neopositivisti sentenziavano che non esiste una sintesi a priori nell'arte e nella filosofia e nessuna cifra trascendente nella metafisica e nella mistica, Popper con il suo principio di falsificazione e la dimostrazione che la ricerca scientifica avviene per congetture e confutazioni ha fatto ritornare l'epistemologia al convenzionalismo o all'anarchismo metodologico. Anche in ambito scientifico quindi non è più tempo di determinismo e meccanicismo, ma più realisticamente è tempo di accettare che il rapporto con qualsiasi forma di oggettività e di verità è sempre più provvisorio, instabile e precario (cito ad esempio la teoria del caos). Questi fatti dovrebbero ricordarseli anche alcuni di coloro che ritengono di essere la Corte di Cassazione nell'ambito della letteratura di oggi. Benedetto Croce tempo addietro aveva fatto coincidere intuizione ed espressione, aveva considerato l'arte come un atto di creazione dello spirito, aveva posto l'accento sulla purezza dell'atto artistico, ma anche egli pur dichiarando una netta distinzione tra poetico e impoetico non era riuscito a fornire un metodo estetico rigoroso per distinguere ciò che era arte da ciò che non era arte. La poesia è spesso come la proliferazione imprevedibile di un rizoma. La conoscenza umana oggi è sempre più disomogenea, non lineare in questo passaggio inarrestabile dagli atomi ai bit, descritto da Negroponte. Si pensi ai nuovi artefatti tecnologici, al mondo del www e del link, alle nuove forme di ibridazione culturale da esso derivate. Il mondo dell'ipertestuale e dell'ipermediale non è lineare. Di conseguenza nemmeno la fruizione dell'editoria elettronica (riviste on line, e-book, biblioteche digitali) sarà lineare come gli antichi libri. Non solo, ma per dirla alla W. Benjamin l'hic et il nunc sarà svalutato completamente, la riproducibilità dell'opera d'arte sarà totale. Difficile perciò in questo frangente tracciare linee di demarcazione, catalogare, classificare, far rientrare l'universo letterario in categorie prestabilite. Naturalmente anche il mondo del web ha i suoi pregi ed i suoi difetti: se da un lato aumenta a dismisura le interconnessioni tra gli individui e la rapidità della comunicazione, dall'altro pone problemi non di poco conto riguardo al diritto d'autore e alla salvaguardia della proprietà intellettuale.

LA FUNZIONE SOCIALE DELLA POESIA IN UN MONDO PRAGMATICO:
Difficile anche stabilire oggi la funzione sociale della poesia. Gadda al commissario Ingravallo di "Quer pasticciaccio brutto de via Merulana" fa dire che la maggioranza delle azioni degli uomini sono compiute per "interesse ed erotia". Scrivere poesie o presunte tali significa porsi quindi al di fuori della logica comune e della stragrande maggioranza dell'agire umano. La poesia rispetto a questo mondo fatto di "interesse ed erotia" è inusuale, per i più sprovveduti qualcosa addirittura di inquietante, qualcosa che si colloca al di fuori dell'orizzonte materialista, pragmatico, utilitario, scientista dei nostri giorni. Questo naturalmente non significa che chi scrive componimenti poetici sia casto, moralista o non abbia qualche interesse economico (bisogna pur sempre mangiare). Chi si occupa di poesia e di letteratura non può essere moralista ad oltranza perché la sensibilità letteraria non è perbenismo. Non può essere moralista anche perché una sottile linea di confine divide il masochismo erotico dal masochismo morale di chi scrive in questa società dei consumi. Il masochista morale è colui che è destinato alla sconfitta per vocazione, è colui che si autodistrugge lentamente in un circolo vizioso di azioni autolesionistiche e tardivi sensi di colpa. Nonostante ciò ha anche un suo punto di forza: il masochista morale è dentro l'orizzonte della Legge, eppure è anche contro. E' colui che sceglie un'altra tirannia. E' colui che accetta la tirannia dell'umanesimo a scapito della tirannia del Potere. La scrittura può divenire eversiva, non solo per il contenuto espressamente dichiarato in un'opera, ma per ciò che è implicito e non è presente nel testo e a cui il testo rimanda. La scrittura può essere un contropotere, anche se esile rispetto alla forza immane delle multinazionali, indipendentemente dal fatto che la maggioranza la percepisca come una controcultura o una sottocultura. Ma per divenire effettivamente contropotere gli autori devono emanciparsi dal potere, essere indipendenti e autonomi dalle pressioni e dai condizionamenti occulti di esso; devono purificarsi dal potere e scarnificarsi; devono oltrepassare gli strati epidermici più superficiali, quelli che quotidianamente si sono assuefatti al potere. Autoflagellarsi interiormente e cerebralmente per purificarsi. Autoflagellarsi come esercizio di stile, come esercizio continuo per maturare uno stile, che sia efficace nel denunciare i soprusi del potere e le mille genealogie della morale, che ancora oggi nel 2000 ottundono le menti. In questo senso gli autori devono assolvere un duplice mandato: mettersi a nudo e dichiarare che il re è nudo. Ecco allora che questa duplice oscenità può divenire disarmante, in alcuni casi provocatoria, dissacrante, addirittura blasfema per i più sprovveduti. Scrittura è contropotere ed esercitare un contropotere ha i suoi rischi. Nel denunciare la logica perversa e le strategie occulte del dividi et impera del potere centralizzato l'autore si espone al rischio di essere considerato un buffone, oppure se considerato elemento di grave disturbo per le coscienze può rischiare la ghettizzazione, se non in alcuni casi l'incolumità e la vita (si pensi a Pasolini).
Spesso chi scrive viene messo in ridicolo o finisce per mettersi in ridicolo, come il poeta. In fondo già Baudelaire aveva parlato di perdita d'aureola del poeta. In Italia Gozzano si vergogna di essere poeta, Corazzini si definisce un piccolo fanciullo che piange, Palazzeschi invece più ludicamente un saltimbanco della propria anima e Vallini vuole vivere una vita tranquilla e meschina.
Mai come nel'900 il poeta è stato messo alla gogna. Viene considerato un buffone, però spesso non gli si concede la libertà di espressione. Il festival di poesia di Castel Porziano ne è l'esempio più lampante: fu un happening di 30000 persone, in cui poeti valenti furono contestati, denigrati, offesi e messi in ridicolo. Facendo zapping in una notte insonne anni fa ebbi modo di vedere su Rai 3 i documenti filmati di quel festival. Vidi una grande poetessa come Amelia Rosselli, contestata duramente da una ragazza -salita sul palco senza chiedere il permesso a nessuno- che le diceva in modo molto diretto che le sue poesie non significavano niente. Molti inoltre furono fischiati. Le loro performance poetiche furono spesso interrotte da urla e commenti volgari. Certamente va ricordato che in quegli anni il letterato era considerato un individuo sospetto, una persona che privilegiava l'isolamento alla partecipazione collettiva e all'impegno politico. C'era l'errata concezione che la poesia fosse un modo per evadere dalle grandi problematiche e una potenziale causa di isolamento e di separazione tra le persone. Però quei giovani non avevano il minimo rispetto per autori loro coetanei, che si mettevano così in gioco. Questa massa di giovani avevano un'altra scusa: non avevano capito i profondi mutamenti della poesia di quegli anni. La poesia non era più mera nominazione, piuttosto dalla seconda metà del '900 irrideva, demistificava, provocava, cercava lo shock: inventava. Per questa ragione le opere poetiche erano costellate da allitterazioni, nonsense, onomatopee, cortocircuiti verbali, lapsus, sillabazioni inusitate, ambiguità semantiche. Il poeta sembrava soffrire di disturbi del linguaggio, di strani tipi di afasie. La poesia non poteva più essere memorizzata, sembrava condurre all'amnesia delle parole. Ciò nonostante quella massa di giovani non cercava minimamente di capire, non chiedeva spiegazioni, ma giudicava senza sapere.
Pontedera, 2005
nov 182022

"Vivo nella fraternità / delle stelle // È soltanto ai solitari / che l’universo /spalanca le sue porte” (versi della poetessa lussemburghese Anise Koltz)
Il gruppo svolge funzioni psicologiche fondamentali per l'equilibrio dell'individuo come il mantenimento dell'autostima, il sostegno morale, la comprensione dei problemi. Almeno questo è vero per la psicologia. Durante il quarto congresso internazionale di psicoterapia di gruppo, svoltosi a Vienna nel 1968, il gruppo venne concepito come "difesa contro l'ansietà che ci viene dal pensiero dei miliardi di individui che vivono sul nostro pianeta". È argomento controverso stabilire quali possono essere i fattori che sono cause di emarginazione di una persona dal gruppo. Il motivo più facilmente rintracciabile è la diversità dell'individuo emarginato rispetto alla comunità. Una rassegna di studi ha rilevato infatti la contiguità tra somiglianza, credenze simili e amicizia. La diversità dell'emarginato può essere volontaria o involontaria. Nel primo caso il soggetto è spesso un deviante che non si conforma alle regole, alle idee, ai principi, ai valori del gruppo. Nella nostra società occidentale sono fondamentali i gruppi informali, che forniscono sostegno, solidarietà, rimozione dell'ansietà individuale grazie alla coesione di più persone. Il grande poeta e sociologo Danilo Dolci, famoso per i suoi libri-inchiesta, per la sua lotta alla mafia, per le sue marce, per i suoi digiuni, per la sua non violenza scriveva: "Così la vita di gruppo, la vita comunitaria, è pure un indispensabile strumento di verifica e di costruzione personale e collettiva. La vicinanza fisica con gente autentica può generare chiarezza morale"; ma non scordiamoci che lo stesso autore scriveva anche: "Dove c'è un vivo, lì, palese o no, nasce una comunità". La stragrande maggioranza di noi hanno bisogno di essere in coppia; molti non riescono a concepire sé stessi da soli. Il primo motivo è che non riescono a stare bene da soli. Il secondo motivo è che hanno bisogno di trovare un'altra persona per essere soddisfatti sessualmente, per non soffrire di carenze affettive, per trovare un dialogo continuo, una compagnia. Esiste anche la pressione sociale che spinge le persone a cercare la dolce metà. Molti cercano una persona che li completi perché da soli non si bastano. Abbiamo bisogno per natura o per cultura di altra pelle oltre la nostra, di un altro corpo oltre il nostro, di altre parole, di altro udito, di un altro sguardo, di altra umanità oltre la nostra. O almeno così ci sembra di primo acchito. Forse è proprio perché la società ci impone la rottura della solitudine che questa ci sembra così innaturale e ci sembra infelice chi non sa o non può amare o stare in mezzo agli altri. Da giovani chi non ha un partner sessuale si sente irrimediabilmente solo perché il bombardamento pornografico impone l'estroversione sessuale a ogni costo e a ogni modo. Poco più che ventenne ho lavorato per un anno in un collegio di salesiani e in un ambiente più casto mi sono accorto che alcuni miei impulsi sessuali erano socialmente indotti.
La verità comunaue è che la stragrande maggioranza di noi cercano un human touch (un tocco umano) per dirla alla Bruce Springsteen. Quello che mi sono sempre chiesto è se il voler rompere la solitudine sia dovuto alla natura o alla cultura. Mi sono sempre chiesto quanto la socialità sia socialmente costruita e quanto sia fisiologica. Ma io mi chiedo, dopo essere cresciuti socialmente, culturalmente, umanamente quanto abbiamo bisogno sempre socialmente, culturalmente, umanamente degli altri, se non si è malati e si è autosufficienti? Per Rousseau e per Freud gli uomini hanno creato una civiltà, barattando buona parte della loro libertà per la loro sicurezza.
Ogni test di personalità che si rispetti prevede la misurazione del grado di socievolezza del soggetto. Il MMPI prevede una scala che quantifica l'introversione sociale, che viene considerata negativamente, ovvero come difficoltà o meno a rapportarsi con gli altri. Il Big Five prevede la misurazione di due tratti di personalità a tal riguardo: l'estroversione e l'amicalità. Dietro a tutti questi costrutti psicologici c'è il retropensiero diffuso tra gli studiosi, che diventa molto spesso un postulato dato per certo, ovvero che l'uomo è un animale sociale. Sarà pure vero. Ma in me sorge spontanea una domanda: l'uomo può fare a meno degli altri, dopo che è stato istruito, educato e quindi gli altri li ha interiorizzati? Secondo la mistica cristiana e non solo l'uomo per cercare, pregare, trovare Dio sta meglio da solo e gli altri sarebbero una distrazione, addirittura un disturbo. Basta ricordarsi dei Padri del deserto oppure in epoca medievale degli stiliti. Talvolta ci si ritira dalla solitudine per fuggire dagli altri...
Così Petrarca scrive:
"Solo et pensoso i più deserti campi
vo mesurando a passi tardi et lenti,
et gli occhi porto per fuggire intenti
ove vestigio human l’arena stampi.
Altro schermo non trovo che mi scampi
dal manifesto accorger de le genti,
perché negli atti d’alegrezza spenti
di fuor si legge com’io dentro avampi:
sì ch’io mi credo omai che monti et piagge
et fiumi et selve sappian di che tempre
sia la mia vita, ch’è celata altrui.
Ma pur sì aspre vie né sì selvagge
cercar non so ch’Amor non venga sempre
ragionando con meco, et io co·llui."
Anche in letteratura e nell'arte ci sono tanti esempi di persone che hanno scelto l'introspezione, la ricerca interiore, considerandole quasi come una necessità dell'animo, per creare. Si pensi solo a Proust che per scrivere il suo capolavoro si isolò per anni in una stanza con pareti ricoperte di sughero e dalle finestre sbarrate. Alcuni psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, a torto o a ragione, ritengono che il bisogno di solitudine sia correlato significativamente con il livello di introversione dell'individuo. Ma alcuni artisti e religiosi si impongono la solitudine e il raccoglimento interiore per i loro scopi, mentre per altri la cosa è molto più spontanea e naturale. La realtà è che si potrebbe considerare patologico chi non sa stare da solo, ma, siccome il mondo va avanti grazie a chi fa figli (oggi il problema è casomai che stanno facendo troppi figli e la sovrappopolazione è un grave problema), viene molto spesso considerato patologico l'asociale, cioè colui che decide di non stare tra gli altri o colui che non sa stare tra gli altri.
nov 132022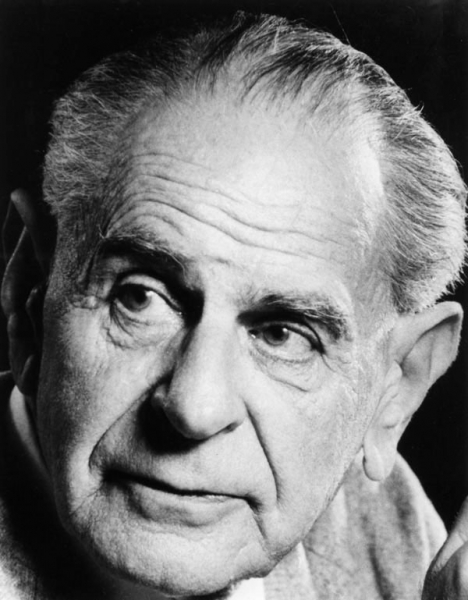
(Nella foto Karl Popper)
"Se Atene piange, Sparta non ride"
Un professore di mio padre diceva che è necessario almeno un secolo perché certi fatti storici vengano valutati con serenità di giudizio e imparzialità. Trovo che avesse ragione. Per valutare con obiettività e con equanimità i fatti spesso bisogna esserne distanti. La vera Storia la devono scrivere i posteri, naturalmente studiando fatti e documenti già raccolti. Naturalmente non voglio in questa sede fare una distinzione tra cronaca e Storia, tra Storia e storiografia, oppure rifarmi al distinguo degli antichi tra cronache e annali. Dico semplicemente che ad esempio oggi gli storici non sarebbero sufficientemente equipaggiati di obiettività nel valutare il conflitto tra Israele e Palestina. Inoltre il susseguirsi degli eventi è incalzante, inarrestabile. Il mondo moderno è caratterizzato da un dinamismo impressionante. Di punto in bianco ecco presentarsi -quando nessuno se lo aspetta- una svolta epocale, per cui al momento è difficile fare disamine o trovare modelli esplicativi adeguati. Si pensi all'11 settembre. Fino ad allora quanti occidentali sapevano le distinzioni tra sunniti e sciiti? Ci eravamo a mala pena "abituati" alle istigazioni al suicidio per uccidere gli infedeli da parte di Khomeini e degli Ayatollah, ma non pensavamo certo che Bin Laden colpisse al cuore l'America. Tutto a un tratto ecco presentarsi una contrapposizione inaspettata tra la solita America gendarme del mondo e gli uomini-kamikaze della Jihad. Ancora oggi questa è attualità, è cronaca. Quanto tempo ci vorrà per metabolizzare questi fatti e farli divenire Storia? Non è un caso quindi che ultimamente la ricerca storica sia in crisi. C'è addirittura chi propone la "microstoria", ovvero di restringere il campo d'indagine a dei fatti e delle situazioni particolari e più facilmente documentabili.
E' chiaro che la Storia non può essere mai totalmente obiettiva, ma lo storico può avvicinarsi asintoticamente all'obiettività. In questa sede non voglio nemmeno parlare dei libri sulla resistenza di Pansa. La Storia non la scrivono sempre i vincitori, come ad esempio Churcill. Erodoto e Tucidide sono stati dei grandi storici, eppure erano esuli. E' altrettanto vero che alcuni storici vincitori rimuovono le testimonianze dei vinti e nascondono gli orrori generati dalla loro parte. Ma la verità viene sempre fuori. Nonostante i negazionisti, che sono i peggiori storici. Niente di nuovo sotto il sole: sono sempre esistiti. Attualmente esistono i negazionisti dell'Olocausto, così come i negazionisti delle foibe; non voglio certo strumentalizzare; è vero che gli italiani fascisti non si erano comportati da "brava gente" in Jugoslavia, avevano commesso eccidi. Bisogna sempre saper contestualizzare ed è una regola che vale per tutti e per tutto. Però anni fa c'erano estremisti che non lasciavano parlare i familiari delle vittime delle foibe alle conferenze e per molti allora le foibe erano solo delle cavità carsiche e niente più. Tempo addietro in Turchia esistevano anche i negazionisti del genocidio armeno da parte dell'impero ottomano, che oggi è stato riconosciuto sia dall'Onu che dal Parlamento europeo. Ancora oggi ben poco sappiamo di tutti i morti che ci sono stati nella repressione del brigantaggio meridionale. Il potere ha sempre tenuto all'oscuro i cittadini per paura che l'effettiva conoscenza dei morti facesse aumentare la voglia di separatismo nel Sud. In tutto questo bailamme mi sembra assurda la domanda che si pone Spengler ne "Il tramonto dell'Occidente", ovvero se la Storia ha una sua logica. Non credo affatto che la Storia abbia una sua logica, semmai infinite contraddizioni, orrori e atrocità. Popper criticò la miseria dello storicismo, ovvero il determinismo secondo cui la Storia debba per forza avere un senso ed una direzione. Con buona pace di molti la Storia non può essere maestra di vita e grazie a essa non si possono fare previsioni. La Storia è piena di orrori, ma spesso non insegna niente. Si pensi che addirittura i nazisti hanno confezionato i paralumi con la pelle degli ebrei e i rivoluzionari francesi hanno conciato l'epidermide dei reazionari. Abbiamo forse imparato qualcosa da allora? È difficile imparare dagli errori e dagli orrori del passato. Nonostante tutto talvolta la Storia mostra i vichiani corsi e ricorsi. Spesso ci ritroviamo al solito punto di partenza. Secondo Fukuyama il mondo intero sarebbe dovuto arrivare alla "fine della Storia", cioè tutte le nazioni con la scomparsa del comunismo sovietico sarebbero giunte al livello dei Paesi occidentali. Ebbene questa profezia per il momento non si è avverata. Alcuni sostengono che non siamo alla fine della Storia, ma solo alla fine dell'Antropocene e forse non avremo futuro. Forse esiste solo il progresso scientifico ma non lo sviluppo storico. Se qualcosa può insegnare la Storia, perché conoscere il passato significa conoscere chi eravamo (anche se poco può dirci su chi saremo), di certo molti giovani non sono pronti a raccoglierne l'insegnamento, a causa della loro scarsa memoria storica.
nov 042022
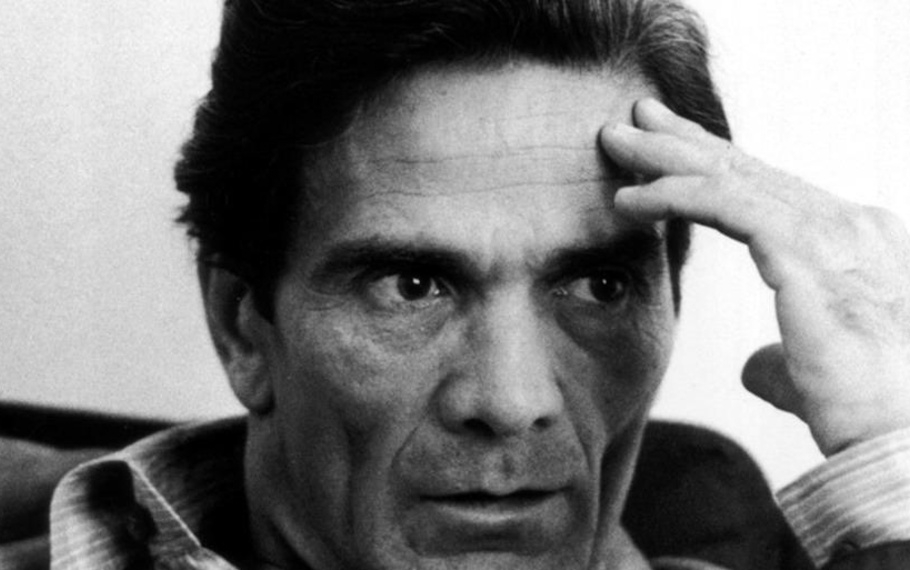
Il Cardinale Ravasi oggi in un'intervista al quotidiano La Nazione (che legge mio padre e io di tanto in tanto sfoglio) ha detto che stiamo vivendo in Italia un periodo di 'sottosviluppo culturale", che gli intellettuali sono dormienti, che ci vorrebbero altri Pasolini a "scuotere le coscienze". In un certo qual modo Ravasi, autore prolifico e di qualità, può anche permettersi queste critiche. Ne ha l'autorevolezza. I suoi libri sono pregevoli. Vi consiglio di leggerli. Sono davvero stimolanti. Si leggono bene. Ravasi sa scrivere per tutti, avendo il dono della chiarezza. Io stesso ho passato piacevoli giorni a immergermi nelle sue riflessioni. Ravasi prima ancora di essere un teologo e un uomo di Chiesa è un pensatore che non si risparmia e che spazia a 360 gradi. Il suo libro che mi è piaciuto di più è "Breviario laico". Bisogna però discutere nel merito se le osservazioni dell'intervista sono pertinenti a meno, se sono legittime o meno, visto anche il ruolo ecclesiastico che ricopre. Bisogna vedere se le sue argomentazioni centrano il bersaglio oppure no. Prima di tutto siamo sicuri del sottosviluppo culturale? Siamo sicuri che mancano le eccellenze o forse non vengono valorizzate? Probabilmente oggi un nuovo Pasolini lo si riconoscerebbe a ottant'anni oppure solo da morto, mentre ai suoi tempi Pasolini era riconosciuto fin dalla giovane età. Probabilmente i nuovi Pasolini sono sconosciuti o conosciuti solo a pochi addetti ai lavori. La realtà probabilmente è che oggi né al potere né a noi del popolo interessa scoprire dei nuovi Pasolini o dei nuovi Gadda, che altrettanto probabilmente verrebbero messi a tacere in ogni modo o si farebbe opera di convincimento per farli desistere dal rappresentare certe realtà italiche o dal fare certe polemiche. Non dico che siano lacrime di coccodrillo quelle di Ravasi, ma è senz'altro questo un riconoscimento molto tardivo per il poeta friulano, oltre al fatto che oggi è una moda culturale molto diffusa sostenere che come Pasolini non ce ne saranno più, che poi è anche un modo molto elegante per scoraggiare o non riconoscere i nuovi Pasolini, ammesso e non concesso che ce ne siano. A essere un poco maligni queste esternazioni di un teologo molto ponderato e saggio potrebbero sembrare di primo acchito un contentino per i pasoliniani di ogni risma, che ormai spuntano come funghi. Pasolini era scomodo intellettualmente (per "Scritti corsari" e "Petrolio"), ma era anche scomodo moralmente (""Orgia", "Porcile", etc etc). Pasolini non poteva essere fermato, minacciando di travolgerlo in uno scandalo perché lui creava scandalo, faceva già scandalo, era scandalo sia nelle opere che nella vita. Cercarono già allora di gettare fango su di lui, di perseguitarlo legalmente, ma lui continuava imperterrito. Era un vero masochista sessuale, ma freudianamente anche un masochista morale. Era martire ed eslege allo stesso tempo. Dopo i fatti di Ramuscello niente poteva fermarlo. Dopo quello scandalo e quello spubblicamento (con i danni conseguenti come l'espulsione dal partito comunista per "indegnità morale" e la disoccupazione romana) niente poteva fermarlo. Lo scandalo era già avvenuto. Per non rinunciare alla sua libertà di azione e di espressione preferì morire piuttosto che farsi frenare dal conformismo culturale. Che poi perché gli intellettuali di oggi dovrebbero rischiare la vita per "scuotere le coscienze"? Potrebbero finire per essere minacciati, vivere sotto scorta, essere come minimo diffamati per ottenere che cosa? Per le magnifiche sorti progressive di un Paese, che a stento e solo dopo molti anni li riconoscerebbe? Siamo sicuri che riuscirebbero davvero a scuotere le coscienze? Io ne dubito fortemente. Così molti pensatori si guardano le spalle e si limitano a fare il compitino. Pasolini docet, ma anche la sua fine docet. Pochissimi, forse nessuno è vocato al martirio. Che poi spetta davvero agli intellettuali formare e scuotere le coscienze in un Paese in cui il lavoro intellettuale è sottopagato o non pagato per niente e gli intellettuali non vengono riconosciuti o non viene riconosciuto niente? E poi cosa significa concretamente oggi "scuotere le coscienze"? Siamo sicuri che esistano realmente "le coscienze", come le si intendeva un tempo? Non è che così facendo si chiede troppo, addirittura l'impossibile agli intellettuali? Oppure probabilmente oggi nessun intellettuale è più capace di destare attenzione, di provocare, di far riflettere? A un certo punto anche gli intellettuali devono vivere o almeno sopravvivere e l'Italia probabilmente non è un Paese ideale per gli intellettuali, per i liberi pensatori, per i lettori forti, per gli artisti, veri o presunti. Gli intellettuali per colpa dell'audience, dei follower, dei mass media, della stessa industria culturale vengono relegati ai margini delle loro nicchie (di mercato e/o editoriali), se non addirittura delle loro bolle. Ai suoi tempi Pasolini era incisivo nella realtà ed era ritenuto importante. Oggi nessun intellettuale è importante. Oggi probabilmente niente e nessuno sono importanti. Oggi tutto fagocita tutto. Oggi il buco nero dell'oblio assorbe tutto. Oggi niente fa più scandalo e nessuno si accorge che questo è il vero scandalo. Non mi stupisce quindi che molti degli intellettuali facciano come gli struzzi, mettendo la testa sotto la sabbia e negando oppure non trattando dei problemi scottanti italiani. La verità è che siamo nella palude, anzi nelle sabbie mobili. E poi non dimentichiamoci che la mentalità di cui erano intrisi i mandanti e gli assassini di Pasolini era piccolo-borghese e pescava a piene mani in certa sottocultura pseudocattolica omofoba, arretrata e violenta, anche se Pasolini non fu ucciso perché era gay, ma perché dava noia al potere con articoli e saggi. Lo colpirono solo nel suo lato debole, in una sua notte brava a cercare "ragazzi di vita". E tutte quelle denunce a suo carico per i motivi più impensabili? Addirittura lo accusavano di essere anche un rapinatore. A cosa erano dovute quelle accuse fuori luogo, quelle violenze psicosociali ai suoi danni, se non a una mentalità comune, che prendeva a prestito certi dogmi della morale sessuale cattolica di quei tempi? Ma Ravasi naturalmente omette tutto ciò. Non approfondisce. Si limita alle brevi dichiarazioni, certo pregnanti, ma che lasciano in sospeso molte cose. Non dico che dovrebbe scusarsi, giustificarsi per l'omicidio pasoliniano a sfondo pseudocattolico/piccolo-borghese/fascista, ma dovrebbe perlomeno menzionare certe colpe della Chiesa in quei tempi. E io lo scrivo da ammiratore e da lettore di Ravasi.
ott 312022

Cantava decenni fa Piero Ciampi: "il Meridione rugge, il Nord non ha salite…". È passato molto tempo dai versi di questa canzone. Sono cambiate molte cose. L'Italia ha mutato faccia. Però ancora oggi il Meridione rugge, ma non tutti lo ascoltano, soprattutto in poesia. Ci sono diversi poeti meridionali validi, da ricordare, che non sono conosciuti come dovrebbero perché schivi, appartati. Alcuni poeti meridionali si sentono incompresi e forse hanno ragione. Pensano, soprattutto i più anziani, di essere testimoni o custodi preziosi di una realtà che gli altri non possono capire. Ma non ci sono solo quelli che quasi si autoescludono dalla vita. Ci sono anche quelli ostracizzati, emarginati, feriti nell'animo, esclusi dalla comunità poetica, apparentemente tanto accogliente ma talvolta faziosa, troppo esclusiva. La realtà è che le grandi case editrici, gli incontri letterari, le riunioni culturali che contano veramente sono a Roma, a Milano oppure nel Nord. Un poeta meridionale parte svantaggiato. L'industria culturale almeno nei decenni precedenti ha promosso tutt'altro, ma non la poesia meridionale. Prima di tutto per autopromuoversi poeticamente ci vogliono tempo, soldi, opportunità per creare sodalizi, incontrare letterati, partecipare a dei premi. Un poeta disoccupato siciliano è già di per sé escluso a livello logistico ed economico ad esempio. La realtà è che per molti anni in poesia ha prevalso la linea lombarda, mentre invece non ha avuto adeguata rilevanza culturale, editoriale, mediatica la poesia del Sud. Si pensi solo a tutto quel fiorire di riviste letterarie napoletane o campane che sono nate negli anni '70, '90, '90 e la critica letteraria che conta non ne ha mai capito l'importanza, non le ha mai considerate veramente. Sembra quasi che a un pregiudizio sottoculturale di stampo pseudoleghista si associ un pregiudizio puramente letterario nei confronti dei poeti del Sud. Tra poeti del Sud ci sono ottimi e buoni autodidatti, che però vengono snobbati dalle accademie e dalle università. Alcuni poeti del Sud non vengono stimati perché scrivono in dialetto e la critica letteraria neanche li considera degni di nota. Certamente cercare di rendere pan per focaccia e iniziare una guerra umana e letteraria tra Sud e Nord non ha senso, è estremamente dannoso e controproducente. Non porta a niente ricambiare l'odio da parte dei poeti del Sud nei confronti del Nord, né porta a niente l'autocommiserazione perenne. Non ha nemmeno senso crogiolarsi nella sofferenza interiore e/o trincerarsi in un complesso di inferiorità o superiorità. Non ha senso neanche mettersi a criticare quello che c'è di buono nella poesia del resto d'Italia oppure chiudersi a riccio e fare esclusivamente sette di poeti meridionali. Un rischio insito nella poesia meridionale è quello di fare cricca, di fare massoneria per difendersi, di considerarsi superiori, perché più puri e incontaminati, per sopravvivere. Il sistema chiuso invece non porta a niente. Ecco perché i poeti meridionali che l'hanno capito usano sempre più Internet e interagiscono con persone di ogni provenienza e cultura. Il sistema per forza di cose deve essere aperto. Non ha nemmeno senso pensare di essere troppo rancorosi, vendicativi, violenti e pensare di "menare le mani". Per quel che la conosco la poesia del Sud può rinnovare la tradizione poetica o continuarla egregiamente, può riprendere la tradizione del nuovo (ovvero la neoavanguardia), può essere ottima poesia visiva o comunque sperimentale. Una qualità dei poeti del Sud, per come li conosco io, è senz'altro che sono più refrattari a seguire le mode letterarie, culturali, poetiche e cercano di non farsele imporre. Un difetto a mio avviso presente in alcuni luoghi del Sud è che chi scrive quattro versi la domenica a tempo perso spesso viene considerato poeta, mentre invece poeta è una parola grossa, da usare con parsimonia e cautela. Un rischio per alcuni poeti meridionali è quello di farsi attanagliare però dal conformismo culturale, ma anche dal moralismo (questo vale per i più anziani, i cosiddetti boomers), insomma da quel decoro piccolo-borghese che Mastronardi chiamava "catrame", visto che il Sud è fatto soprattutto di borghi dove tutti sanno tutto di tutti. C'è bisogno dei poeti meridionali che cantano la bellezza del paesaggio e della terra del Sud, ma anche le contraddizioni e le difficoltà di quella realtà (e intendiamoci bene ogni realtà ha i suoi punti critici. Non siamo certamente più ai tempi di Carlo Levi). La letteratura italiana ha bisogno della poesia meridionale, che è un poco più defilata e marginale rispetto ad altre zone italiane. Inoltre i poeti meridionali devono lottare contro una realtà culturale più difficile. In alcune zone del Sud (e penso di poterlo scrivere senza alcuna ombra di pregiudizio... che poi io non sono mica del profondo Nord) fare cultura è più difficile. In alcune zone del Sud, dove la criminalità organizzata ha il controllo del territorio, scrivere poesia significa poter denunciare quello stato di cose, rompere gli schemi, andare contro la sottocultura. Per alcuni uomini di onore chi scrive poesia è un mezz'uomo, uno che rincorre farfalle, un poveretto, etc etc. In realtà scrivere anche poesia in certe realtà è pericoloso e chi scrive è ritenuto una persona scomoda. Viene guardato con sospetto, con molta diffidenza. Questo purtroppo è ancora un retropensiero diffuso. La politica meridionale dovrebbe valorizzare molto meglio la poesia del Sud con la creazione di premi e festival letterari, che potrebbero innescare un piccolo circolo virtuoso e aumentare in piccola parte il turismo culturale. Eppure Pirandello, Quasimodo e molti altri grandi letterati erano meridionali. La poesia italiana nasce con la scuola siciliana, se non erro. Quindi ogni pregiudizio contro la poesia del Sud contemporanea è infondato. Chi può a onor del vero cantare la bellezza del Mediterraneo, se non i poeti del Sud? Chi è troppo ingenuo o ignorante in letteratura pensa che il Sud sia un mondo a parte, un mondo lontano, un'altra realtà. Invece con la poesia meridionale bisogna fare i conti, non si può relegare ai margini. Lo so benissimo che alcuni penseranno che io deliri o sia totalmente fuori strada, che ormai queste sono cose antiche o inesistenti, ma basta leggere soltanto alcune pagine di qualche saggio del poeta Giorgio Moio per capire che anche recentemente la poesia meridionale non ha avuto l'attenzione che si meritava. Qualcuno potrebbe obiettare dicendo che nelle antologie scolastiche Alfonso Gatto, Sinisgalli, Scotellaro, Calogero, Pierro, etc etc ci sono tutti. Ma quanti vengono messi nei programmi scolastici e quanti poeti del Sud vengono fatti studiare? Proprio al Sud ci sono molti giovani che si laureano brillantemente in materie umanistiche e scrivono cose egregie. Proprio nel Sud ci sono delle isole felici, diverse associazioni culturali, diversi circoli culturali, che premiano i poeti, ancora più che in altre zone di Italia. Il Sud talvolta mi sembra quasi spaccato culturalmente, in precario equilibrio, a metà strada tra due fuochi: il fuoco della criminalità e quello del vero Rinascimento letterario. In questi ultimi anni si registra comunque una maggiore attenzione nei confronti della poesia meridionale e, diciamocelo francamente, Internet ha ridotto le distanze e le ingiustizie critiche, visto che oggi tutto viene pubblicato e reso noto al pubblico online.
ott 292022
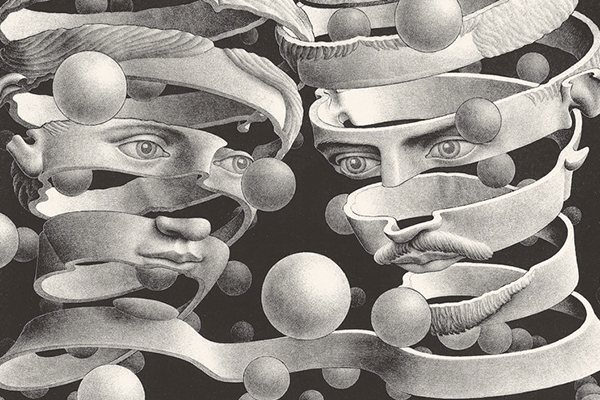
Cose da tener presente e regole di comportamento per un/a giovane per sopravvivere nella giungla della comunità poetica:
Ai poeti e naturalmente anche alle poetesse, veri/e, aspiranti, sedicenti dai sempre ragione, anche quando hanno torto marcio. Non te li inimicare mai. Possono cercare vendette, possono fartela pagare. Come? In ogni modo. Niente a loro è precluso. Sono pronti a calpestarti in ogni modo senza umanità e senza rispetto per la tua dignità. Al peggio non c'è fine. Se provi a ferirli minimamente nell'orgoglio possono diventare criminali. Una poetessa riconosciuta mi scriveva che alcuni letterati e poeti, che ce l'avevano con lei, la sottoponevano online ad esempio a delle vere e proprie shit storm, termine ormai comprensibile a tutti.
Per le poetesse e i poeti, veri e presunti, esistono solo dei libri importanti, necessari, prioritari: i loro. Oppure quelli dei loro maestri/mentori, ma possono ammettere ciò solo per pura formalità e perché non possono fare altrimenti, dato che i loro mentori sono un elemento imprescindibile della loro biografia.
Loro sono superiori agli altri. Devi naturalmente riconoscere la loro grandezza. È un atto dovuto. Se non lo fai diventi un loro nemico. Oppure sei un mentecatto ignorante e illetterato.
Alcuni poetesse e alcuni poeti, veri o presunti, hanno iniziato da così tanto tempo a scrivere che si sono veramente dimenticati/e la ragione per cui hanno iniziato. E ora non trovano il modo per smettere, anche se molte ragioni plausibili ce le avrebbero, ma loro non ne tengono mai di conto.
Secondo alcune testimonianze femminili il mondo della poesia italiana è un mondo di mani morte senza guardare in faccia nessuna e senza remore. Le ragazze devono stare attente a chi promette loro mari e monti in cambio di sesso. I lestofanti libidinosi sono sempre dietro l'angolo, ma in fondo non c'è niente di male a diventare l'amante ingenua di un poeta riconosciuto, anche se il talento poetico non c'entra nulla.
Ormai il sovrappiù del capitalista non è dato più dalla forza-lavoro dell'operaio ma anche dal marketing, dalla pubblicità, dell'ingegneria gestionale. La speculazione finanziaria in borsa domina sulla produttività industriale. Però molti letterati continuano a dirsi marxisti senza alcuna riserva. Abbracciano senza se e senza ma il determinismo economico marxiano di più di un secolo fa, condividendo totalmente l'analisi economica di una realtà, di un mondo che non c'è più. E se glielo scrivi si arrabbiano in modo furioso e cercano vendetta letteraria.
A meno che tu non sia di bell'aspetto, non sia ricco, non sia un professore universitario o un poeta affermato a scrivere poesie non si cucca. Se vuoi cuccare comprati a rate una bella macchina o passa molte ore del tuo tempo libero a farti il fisico in palestra.
Non ti fare spennare dalle case editrici a pagamento.
Capirai col tempo che più si accumulano le frustrazioni e più l'ego si gonfia. Come scriveva Adler dietro ogni complesso di superiorità si cela un complesso di inferiorità.
La poesia devi prenderla come una semplice passione. Non ti può guarire né ti può avvelenare, se hai i piedi ben saldi a terra. Probabilmente non sarà per te neanche un altro lavoro. Se avrai un lavoro al massimo sarà un dopolavoro.
La concezione del mondo di poetesse e poeti, veri o presunti, si basa sulla poesia che è superiore alla prosa, agli articoli, ai saggi brevi. Ti citano Bukowski quando scriveva: "La poesia dice troppo in pochissimo tempo, la prosa dice poco e ne impiega troppo". E naturalmente la loro poesia, vera o presunta, viene prima di tutto o di tutti.
Il mondo va in tutt'altra direzione. Tutto rema contro ai poeti. La cultura di massa sta fagocitando ogni giorno la poesia. Lo si vede anche dai quiz televisivi sempre più visti, dove per domande di cultura generale si intendono domande di sottocultura. Però l'importante per i poeti è crederci e volerlo.
Se sono riconosciuti considerano la comunità letteraria meritocratica e talentocratica. Si sentono in pace con il mondo. Se non sono riconosciuti allora sono dei geni incompresi e parlano di mafia letteraria. Ma nessuno si presenta come non riconosciuto. Questa cosa nessuno la ammette. Tutti si pavoneggiano per la pubblicazione di quel libro a pagamento, per la pubblicazione su quella rivista, per essere stati inseriti in quella antologia. Se leggi le note biografiche di poeti, veri o presunti, sono tutti riconosciuti. Alla vanagloria, al narcisismo non c'è fine, nel senso che non devi assolutamente mettere in dubbio la loro bravura e i loro consensi critici perché rischieresti l'incolumità fisica e la discussione non avrebbe termine.
Le poetesse e i poeti, veri o presunti, sono quasi tutti di sinistra, ma è meglio non dirlo per evitare guai.
Ogni poeta e poetessa se la suona e se la canta. Gli altri fingono di leggere e di capire. In realtà nessuno ascolta nessuno. Tutto è bello e insignificante al tempo stesso. Il tasso di incomunicabilità è elevato e l'ipocrisia, la finzione regnano sovrane.
Sembra talvolta che alcuni/e facciano di tutto per non farsi comprendere. Va bene che la poesia è nominazione pura, ma spesso usano termini desueti e ormai non familiari a nessuno perché così credono di impreziosire le loro poesie. Credono di essere tanto incomprensibili e oscuri quanto poetici. Oppure probabilmente sono solo legati troppo a canoni letteraria troppo antiquati. Oppure forse vogliono solo divertirsi e pensano che quando saranno morti gli italianisti non riusciranno a capire il senso delle loro liriche. In realtà gli italianisti tra un secolo forse non ci saranno più perché l'italiano sarà ormai una lingua morta e non studiata più da nessuno. E poi perché i posteri dovrebbero occuparsi di loro se ai contemporanei di loro non importa niente? Come mai ripongono tutta questa speranza nei posteri?
Devi tener presente che la poesia contemporanea italiana è una piccolissima fabbrica di illusioni per uno sparuto gruppo di persone, se lo si confronta con il resto della popolazione a cui non gliene importa davvero niente. Essere poeti o poetesse è del tutto legittimo, ma al resto del mondo non interessa minimamente e di questo bisogna che chi scrive versi ne prenda atto e coscienza.
Nessuno può parlare male dei poeti, nemmeno i poeti riconosciuti. Chi lo fa è un nemico, un invidioso, un poeta fallito, un disfattista qualunquista oppure tutte queste cose insieme. Di solito l'accusa principale è l'invidia. Siamo tutti invidiosi dei poeti, veri o presunti, che ormai li considerano davvero pochi, mentre il mondo è delle multinazionali, degli sceicchi, delle influencer, degli showman televisivi.
Le poetesse e i poeti, più presunti che veri, hanno spesso qualche disturbo psicologico o psichiatrico, ma non devi minimamente sospettarlo né dirlo. La "follia" è un fenomeno di proiezione, come l'amore del resto. Pazzi sono sempre gli altri. Se io ammetto che ho qualche problema psicologico, ma mi curo e sto molto bene loro mi considerano un individuo altamente problematico, un poveretto. Poi tra molti di loro c'è feeling, intesa, affinità elettiva e tutto ciò è una corrispondenza di amorosi sensi tra persone con problemi psicologici o psichiatrici che non si curano. Si sostengono a vicenda. Ci vuole un minimo di sopportazione e di acquiescenza di fronte a loro, ma non devi necessariamente improvvisarti terapeuta o improvvisarti sodale per risolvere le loro tare psicologiche/psichiatriche perché non la finiresti più. Cerca di assecondarli e di essere comprensivo.
I poeti e le poetesse sono tutti amici e amiche. Poi la realtà effettiva è un'altra. A onor del vero colpi bassi senza alcun complimento, appena uno si assenta.
Visto e considerato che tutte le isole sono state trovate (ricordando Gozzano), visto che è difficile lo straniamento o anche solo rinnovare il linguaggio, i poeti veri o presunti, non approdando a traguardi immaginifici, si trascinano stancamente a scrivere i loro versi. Il fine ultimo è la gloria postuma.
La poesia di ogni poeta in questione è immortale. Devi a ogni costo riconoscere che è memorabile. Magari certi versi te li scordi il giorno stesso averli letti, ma il postulato è che quei versi sono capolavori e se non lo senti o non lo pensi è perché non hai adeguata preparazione culturale, adeguata sensibilità artistica, sufficiente intelligenza, sufficiente gusto estetico.
I poeti, veri o presunti, ti cercano solo quando hanno bisogno o solo quando gli fa comodo.
Molte poetesse e molti poeti, veri o presunti, ti possono accettare solo come loro accolito. Devi andare a bottega da loro. Loro poi possono anche atteggiarsi a maestri di vita. Tu non puoi che essere un discepolo.
Non perdere tempo in lotte di potere tra cricche, scuole di pensiero, fazioni. Il vero potere di un poeta è quello di trasmettere emozioni sotto forma di bellezza letteraria a quante più persone. Molti cantanti sanno comunicare ed esprimere emozioni, ma non sotto forma di bellezza letteraria. Un problema insormontabile è quale sia, cosa sia la bellezza letteraria oggi.
Tutte le alleanze, gli amori, le antipatie, i litigi tra poeti, veri o presunti, non finiranno nella storia della letteratura. Sono praticamente ininfluenti. Non farti cattivo sangue. Nella storia della letteratura ci restano pochissimi.
Il mondo va alla malora e forse scrivere o leggere poesia è un passatempo come un altro. Non si fa del male al mondo e nemmeno lo si salva. Un minimo di realismo non guasterebbe. Meno smania di grandezza e meno manie di protagonismo non guasterebbero.
Ne vale veramente la pena di leggere o scrivere poesia? Senza ombra di dubbio. Basta leggere Apollinaire, Ginsberg, Montale, Pasolini, Zanzotto, Merini o la Rosselli. Non costa nulla partecipare e dare il proprio piccolissimo contributo, possibilmente in punta di piedi, con modestia, senza alzare la voce e senza essere molesti.
ott 252022
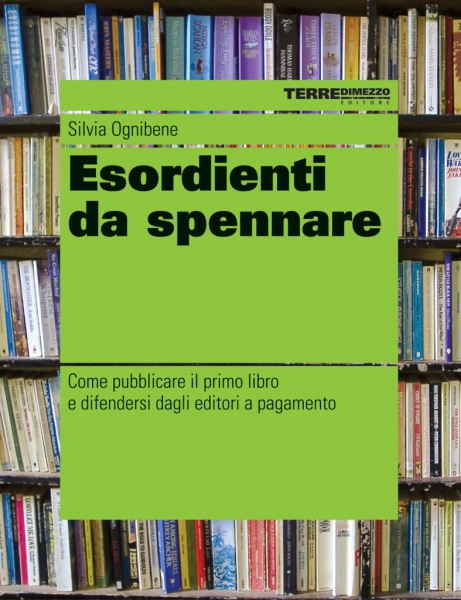
Ė la solita schermaglia. Alcuni critici e alcuni poeti "arrivati" dicono e scrivono che i giudizi sono oggettivi, quando i criteri di un tempo, i vecchi canoni come la metrica e l'eufonia sono stati abbandonati. Chi non si afferma poeticamente talvolta grida che è tutto un contendersi tra conventicole, che è tutta una cricca e si dichiara incompreso/a. Ad onor del vero esistono le amicizie, i favoritismi, le idiosincrasie: sarebbe disonesto non ammetterlo. Siamo in Italia insomma. Io non conosco personalmente nessun poeta o critico. Non ho amici o amiche nel settore. Lo scrivo a scanso di equivoci. Conosco poco l'ambiente della poesia. Osservo quello che accade su Internet. Naturalmente sono del tutto legittimi i rapporti di stima reciproci. Talvolta mi chiedo se c'è del marcio nella comunità poetica, ma non ho sufficienti elementi per rispondere. Alcuni letterati arrivati vogliono pontificare, legiferare. Alcuni non arrivati vogliono fare un quarantotto. Ci sono anche persone che vorrebbero affermarsi ancora di più, approdare alla grande editoria e accusano che è tutto un sistema che mistifica, che è ingiusto, che falsa i veri valori. La comunità letteraria sembra essere basata sul discrimine autorità/frustrazione. La domanda da porsi è se il talento o il genio attualmente in poesia siano oggettivamente riconosciuti e riconoscibili. Nutro dei dubbi. Alcuni che sono arrivati vorrebbero imporsi, quasi sopraffare, zittire il resto di quella che per loro è una ciurma. Gli aspiranti e i sedicenti poeti, coloro che non sono affermati si basano molto più sui contentini che gli vengono dati che sulle porte sbattute in faccia. Ma ancora una volta mi chiedo quanta obiettività ci sia nei giudizi critici odierni. L'ottima poetessa Maria Borio in un suo saggio breve parla di valutare un testo poetico in base allo stile, all'implicito e all'autenticità oggi. Ma anche così facendo si resta nell'ambito dell'opinabile.
Mi fanno un poco sorridere quegli autori che pagando una pubblicazione a proprie spese si vantano del giudizio elogiativo dell'editore, che ha tutti gli interessi di abbindolarli, di blandirli per convincerli a pubblicare altri libri a pagamento. Spesso il piccolo editore a pagamento li facilita, li mette sulla buona strada, li aiuta a pubblicare su riviste, li incanala nelle giuste conoscenze/binari poetici. Noto che un libro pubblicato a pagamento viehe più considerato di un ebook pubblicato gratis su una rivista online. È un falso prestigio basato su premesse errate. Innanzitutto spesso l'editoria a pagamento non è affatto selettiva, non distingue il grano dal loglio. Molto spesso anche il più improvvisato degli aspiranti poeti trova da pubblicare. Non nascondiamoci dietro ad un dito: spesso molte piccole case editrici a pagamento non premiano la qualità e sono come delle tipografie. Forse viene considerato di più un libro pubblicato a proprie spese perché si tiene conto dell'onere economico più o meno gravoso a cui ha dovuto far fronte. Forse si chiudono gli occhi e si fa finta di non vedere perché è una prassi troppo diffusa e così fan tutti/e. C'è gente che ha un curriculum poetico fatto da una caterva di pubblicazioni a pagamento. Ma che curriculum artistici sono? Bisognerebbe guardare solo la qualità degli scritti. Io non guardo se un libro è pubblicato con una piccola, media o grande casa editrice. Valuto se mi piace oppure no. C'è del buono, anzi dell'ottimo nell'editoria a pagamento. C'è una editoria a pagamento anche che sa scegliere il buono dal pessimo. Ma è meglio non vantarsi di una pubblicazione cartacea. Non c'è nessuna asticella superata nel pubblicare a proprie spese. Basta avere i soldi, essere disposti a spendere, poi un editore si trova. Spesso sarà un editore che obbligherà all'acquisto di cento copie, non si interesserà alla distribuzione, etc etc. Io considero una persona poeta o poetessa a prescindere delle pubblicazioni, ma solo in base a ciò che scrive. Mi sembra che questo modo di giudicare sia il più onesto intellettualmente, anche se di primo acchito può sembrare presuntuoso. Il mio giudizio però non è assolutamente interessato. Il giudizio di certi piccoli editori a pagamento invece è interessato.
ott 182022
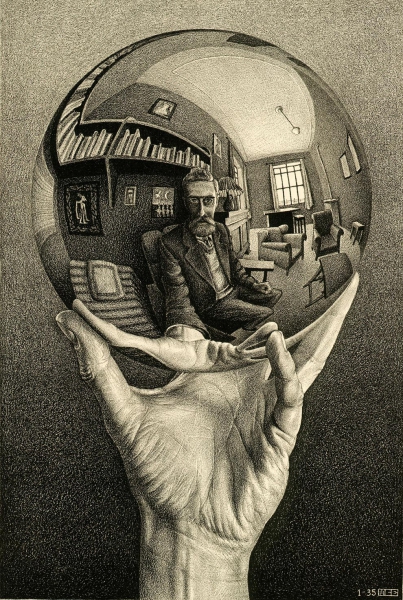
Se Il poeta riconosciuto pubblica con la Mondadori, l'Einaudi, la Feltrinelli, la Garzanti, il poeta del web pubblica nel suo blog letterario (o aspirante tale) i suoi versi. Ogni tanto fa qualche altra apparizione in altri lit-blog di amici oppure in una rivista online a cui collabora. Se il poeta riconosciuto viene elogiato da una miriade di aspiranti poeti, che si dicono amici (ma la loro amicizia è molto interessata e finalizzata a far parte delle patrie lettere), ebbene il poeta del web ha come amici dei sodali. In realtà il poeta riconosciuto e il poeta del web hanno entrambi pochi amici veri nel loro mondo artistico e invece molti conoscenti: il primo viene più invidiato che ammirato, il secondo è in competizione con gli altri e anche se non gareggia sono gli altri che sono comunque in gara con lui (pochi capiscono come Ferlinghetti che la poesia non è una gara). D'altro lato la poesia è anche pubbliche relazioni, consiste anche nello stringere alleanze. Il poeta riconosciuto frequenta solo i propri pari. Il poeta del web frequenta tutti oppure si autoesclude dalla vita. Se il poeta riconosciuto per un motivo imprecisato cade in disgrazia nessuno lo considera più. Il poeta del web se ha successo acquista molti falsi amici, ma perde anche qualche amico vero. Fino a quando il poeta del web è un carneade i suoi amici (o apparenti tali) gli danno manforte, gli danno sostegno emotivo/psicologico. Il poeta riconosciuto pubblica per tutti. Il poeta del web pubblica per la propria bolla ma anche per nessuno.
Il poeta del web si deve sudare collaborazioni in blog e riviste online oppure anche delle apparizioni in angoli di web. Spesso ricorre a delle pubblicazioni a pagamento di libri per dire che ha pubblicato anche lui e per essere più accreditato. Il poeta riconosciuto spesso è un cattedratico o ha buone entrature nel mondo universitario. Non ha problemi a trovare una casa editrice che non lo fa pagare perché sa che il suo nome è una garanzia e permetterà almeno un piccolo ritorno economico. Il poeta riconosciuto sa che il suo libro avrà molte recensioni sui quotidiani e che i suoi seguaci lo compreranno. Il poeta riconosciuto viene già antologizzato in qualche manuale scolastico. Nessuno regala niente al poeta del web. Talvolta chiede aiuto economico ai suoi familiari per pubblicare un libro di poesie. Fa dei sacrifici risparmiando per tutto l'anno oppure li fa fare ai suoi familiari. Nel corso degli anni potrà scrivere sul suo curriculum che ha pubblicato diversi libri. Inoltre ogni pubblicazione online è una piccola conquista, un piccolo passo avanti. Ma verso dove? Essere pubblicato su qualche sito letterario in più cambierà forse la sua vita, lo farà svoltare (come si dice a Roma) oppure migliorerà la sua arte? In ogni caso è un passatempo, un hobby...

Per essere poeti riconosciuti bisogna avere capacità intellettuali, cultura umanistica, saper sfruttare le giuste occasioni (per dirla alla Montale), la fortuna di avere almeno un maestro (io sostengo che la cosa più importante a tal riguardo sia avere una buona maestra elementare perché parte tutto da lì), ma spesso bisogna anche avere un trauma da superare, un lutto da rielaborare, essere considerati dei diversi per qualsiasi motivo, avere un grande amore non corrisposto, essere disadattati, avere una psicopatologia oppure essere poveri: una sola di queste cose o più cose insieme. I grandi poeti e le grandi poetesse sono tutti in un certo qual modo traumatizzati almeno da un evento della vita oppure in senso lato dalla vita stessa. Per essere poeti o poetesse bisogna soffrire. Non a caso alcuni critici talvolta scrivono agli aspiranti poeti: "bravo ma freddino" oppure più semplicemente "non sai ancora cosa vuol dire soffrire". Ci vuole quindi qualcosa che segni per sempre in modo indelebile. I casi sono due: vivere normalmente o soffrire e scrivere. Ma non è sufficiente. I casi sono ancora due: vivere o capire. Il poeta riconosciuto soffre, capisce, scrive. Il poeta del web pensa di capire, pensa di soffrire, nel frattempo scrive. Inoltre il poeta riconosciuto deve essere contro la mentalità comune, contro la logica del sistema, contro il potere costituito. Associando queste due caratteristiche, utilizzando le parole di De André, potremmo affermare che ogni poeta autentico, riconosciuto o meno, "viaggia in direzione ostinata e contraria, con il suo marchio speciale di speciale disperazione".
Il poeta del web spesso si guarda bene dal non mettere tutto in piazza. Se ha dei traumi non vuole metterli in piazza, neanche in una piazza virtuale. Sa che i suoi compaesani o i suoi concittadini potrebbero usare tutto ciò che scrive contro di lui. Cerca quindi di non autospubblicarsi. L'autopubblicazione va bene, ma non l'autospubblicazione. Prima di scrivere qualcosa di compromettente si autocensura pensando ai suoi familiari, ai suoi parenti, alle sue amicizie. D'altronde è con loro che deve convivere. Non tutti sono disposti a dare tutti sé stessi in pasto a tutti. Che poi anche i datori di lavoro o i potenziali datori di lavoro possono leggere le cose pubblicate sul web. Basta fare una semplice ricerca. Insomma di solito il poeta del web ha minore talento del poeta riconosciuto, ma non osa mai tanto. Si risparmia. È più pudico. È meno coraggioso. Ha una reputazione da difendere nel suo paese o nella sua cittadina. Il suo lavoro, il lavoro dei suoi familiari dipendono in buona parte anche dalla reputazione. Il poeta del web ha molto da perdere e forse il gioco non vale la candela. Il poeta riconosciuto ha le spalle molto più larghe. Sa che è un personaggio pubblico o semipubblico e che in questo villaggio globale ormai di chi è noto tutti sanno tutto di lui. Il poeta del web invece tratta difficilmente di sesso. Non fa invettive. Non combatte draghi né fantasmi mentali. Non fa nomi dei propri nemici per paura di denunce per diffamazione. Ma ci sono anche poeti del web che si lasciano andare a diarismo e intimismo. In linea di massimo diciamo che il poeta del web anche se si confida o entra nell'intimità gli prestano attenzione in pochi, mentre il poeta riconosciuto fa più notizia, anche se solo nella comunità poetica. Il poeta del web e il poeta riconosciuto hanno la stessa passione, hanno sempre avuto la stessa ambizione, coltivano da sempre il loro talento, sono entrambi alla ricerca della verità o della sua parvenza. Il poeta del web e il poeta riconosciuto si possono scambiare i ruoli, la faccia, la vita perché probabilmente sono ognuno la faccia della stessa medaglia o addirittura la stessa persona (chi è l'originale e chi la copia? Oppure sono due sosia che nessuno riconosce come tali).
ott 182022

Enrico Brizzi (1974) è uno scrittore bolognese, amante della montagna, delle camminate e della natura. Si è laureato al Dams. Con questo romanzo si è fatto conoscere dal grande pubblico, ma l'autore non ha deluso mai neanche nei libri successivi, nonostante siano meno famosi. Ho letto altri libri e sono stati sempre piacevoli. Leggendo questo libro ci si può far trasportare dalla fantasia e ci può sembrare di camminare sotto i portici bolognesi insieme allo scrittore, ma questo romanzo è anche un tuffo al cuore per chi ha vissuto gli anni Novanta e vuole ricordarli. Oppure quest'opera è anche un modo per far conoscere ai giovanissimi come vivevano e i miti in cui credevano i loro genitori della generazione X.
Trama:
"Jack Frusciante è uscito dal gruppo" è un romanzo generazionale, pubblicato nel 1994. Innanzitutto il titolo è dovuto al fatto che Frusciante dei Red Hot Chili Peppers lasciò il gruppo. Il romanzo non è ideologico e sessuale come "Porci con le ali". Non è trasgressivo come "Altri libertini" di Tondelli, anche se Enrico Brizzi riconosce nello scrittore di Correggio un maestro. Pur avendo anche come punto di riferimento "Il giovane Holden" non è presente in questo romanzo il tour de force del gergo giovanile presente nell'opera di Salinger. Il protagonista Alex è un diciassettenne che frequenta un liceo classico bolognese e si innamora di Adelaide, che però non lo ricambia, anche se tra di loro nasce una tenera amicizia. La ragazza in questione è troppo presa dall'ansia di futuro, dovrebbe andare a studiare in America, non vuole impegnarsi, vuole essere libera e allo stesso tempo non vuole illudere nessuno. Mentre Alex è alle prese con la sua prima delusione sentimentale, si suicida un suo amico, più benestante di lui, più svogliato negli studi e più nichilista. Il suo amico era pieno di ragazze e di amici, era un assiduo frequentatore di discoteche, ma al suo funerale ci sono poche persone perché quel popolo della notte, quegli amici della fauna notturna non lo hanno accompagnato per l'ultimo viaggio e questa è una constatazione di fatto molto amara per il protagonista, che vuole dirci che il sesso facile e il divertimento sfrenato non sono sinonimi di amore e amicizia veri. Il romanzo è colmo di citazioni postmoderne, molto spesso ludiche. Non voglio spoilerare ulteriormente.
Recensione:
Si tratta di uno dei libri più divertenti e spassosi degli anni Novanta in Italia. Brizzi irrompe nel mondo della narrativa con freschezza, originalità, talento. Di solito gli scrittori italiani si perdono nelle descrizioni ossessive o nelle narrazioni minuziose: Brizzi giovanissimo riesce a dosare sapientemente, con maestria, narrazione e descrizione. Pensate che il libro ha venduto più di un milione di copie e persino Umberto Eco lo ha trattato in una sua Bustina di Minerva. Prima di acquistarlo avevo sentito parlare Brizzi al Maurizio Costanzo Show e mi aveva incuriosito. È sicuramente stato molto furbo, intelligente e capace Brizzi ad aver trasformato una cocente delusione amorosa in un libro. Tuttavia il romanzo, anche se mischia cultura bassa e cultura alta, non è commerciale o quantomeno non è stato scritto con l'intento di farne un best seller. Forse l'autore voleva solo scrivere un libro non noioso. Comunque sia, Brizzi ha avuto il merito di scrivere un libro che meglio di molti altri rappresenta la generazione X italiana. Molto azzeccata la scelta di mettere in copertina una bicicletta scassata, come a voler rappresentare una storia giovanile qualsiasi tra persone comuni. In parte mi ricorda anche il film Ovosodo, seppur ci siano delle differenze e nessuno abbia copiato da nessuno. Brizzi colpisce per il suo modo delicato e ironico di raccontare una vicenda adolescenziale agrodolce, ma colpisce anche per le sue sentenze e il fatto di non guardare in faccia nessuno: così scrive a proposito di Adelaide che sono le albechiare che ti fregano e a proposito del cattolicesimo scrive che sono le persone che si mettono in prima fila in chiesa a rovinare la religione cristiana, attaccando quindi frontalmente il perbenismo e la vuota apparenza. Insomma un libro non pretenzioso ma ben scritto, che merita il successo che ha avuto. Un libro quindi da leggere a tutti i costi. È in definitiva un romanzo che punta sulla leggerezza, ma che fa anche riflettere.
ott 182022

(Nella foto Pisa)
Ottiero Ottieri (1924-2002) è stato scrittore, poeta, sociologo e dirigente della Olivetti. È stato un autore importante. Non a caso fu un autore Einaudi. Anche Walter Pedullà nella sua monumentale "Storia della letteratura italiana" tratta Ottieri a più riprese. Il suo romanzo "Donnarumma all'assalto" fu un caso letterario, che trattava della disoccupazione meridionale in contrasto con le rigorose selezioni del personale delle industrie del Nord. Quel romanzo era autobiografico perché Ottieri lavorò alla Olivetti di Pozzuoli. Se da un lato la Olivetti era un'impresa all'avanguardia, dove trovavano impiego i migliori intellettuali e dove nessun dirigente guadagnava più di cinque volte degli operai, dall'altro anche questa azienda non poteva assumere tutti, doveva selezionare e quindi discriminare in un certo qual modo, escludere, compiendo delle ingiustizie umane e sociali. Ma Ottieri riuscì anche a rappresentare le contraddizioni intrinseche dell'alta borghesia, classe sociale a cui lui stesso apparteneva, ad esempio con il racconto lungo "I divini mondani".
Trama
"L'infermiera di Pisa" è un poemetto eccellente, in cui Ottieri tratta del suo ricovero a Pisa perché era maniaco-depressivo. Quando fu scoperta questa patologia Kraepelin la definì psicosi. In realtà oggi è classificato come un semplice disturbo dell'umore e basta appunto uno stabilizzatore dell'umore, assunto quotidianamente, per curare efficacemente i pazienti. Il poeta andò così in cura dallo psichiatra Cassano, dopo essere stato per diverso tempo curato da un analista junghiano inutilmente in Svizzera. Per la cronaca Cassano era uno dei migliori studiosi della depressione ed era uno psichiatra organico, esperto di psicofarmaci. In quest'opera viene narrata l'infatuazione per una infermiera pisana, ma vengono anche descritti gli sbalzi d'umore, gli stati mentali di Ottieri tra citazioni colte, erotismo, invettive, resistenze psicologiche alla cura. Da una parte abbiamo l'amore per l'infermiera e dall'altra abbiamo la neurochimica. Sullo sfondo c'è Pisa con i suoi lungarni, la sua vita di provincia, l'università, le sue scuole di eccellenza. In questo libro vengono perciò trattati in modo esemplare sia l'innamoramento non corrisposto che la sofferenza psichica.
Recensione:
È un libro che consiglio spassionatamente di leggere per chi vuole diventare poeta, ma anche per chi ha molte titubanze a curarsi psichicamente, ad andare da uno specialista. A livello stilistico il poeta si rivela straripante, un vero e proprio fiume in piena, descrive minuziosamente tutto e tutti del suo soggiorno pisano. È un libro che ricorda il grande psichiatra Cassano ma non solo. Ottieri si dimostra un grande poeta, un autore da leggere e da gustare. Dimostra la sua bravura ed è una bravura che non annoia, che non incute soggezione, ma desta continuo interesse, spinge a riflettere. Nella poesia di Ottieri talento e cultura si uniscono armoniosamente, nonostante le sue tare psicologiche, i suoi fantasmi mentali, l'alcolismo e la dipendenza dal sesso. Ottieri non fu creativo grazie ai suoi difetti e ai suoi eccessi, ma nonostante questi. Quello che più stupisce è l'unicità della sua voce inconfondibile, che non fa il verso a nessuno e non somiglia a nessuno. In un mondo sempre meno rappresentabile e in cui sono poche le opere poetiche che ci stupiscono, ebbene questo poemetto spicca ancora oggi a distanza d'anni per la sua originalità, la sua genuinità, miscelate con sapienza da uno degli autori più singolari e versatili del Novecento italiano.
ott 152022
"Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione." (Dal film "Amici miei")
" Il nostro genio è per l’1% talento e per il 99% duro lavoro” (Albert Einstein)
Antefatto: una volta io e un mio amico discutemmo sulla gente. Per lui la maggioranza delle persone non ci arrivava mentalmente e si trattava di una grande stupidità collettiva. Per lui ciò che non dava la natura non lo dava neanche Salamanca. Secondo lui era un fatto di natura e perciò andavano scusati tutti. A mio avviso si trattava solo di ignoranza e quindi era rimediabile. Io comunque che ero meno conservatore ero quello più arrabbiato con la gente perché pensavo che molti si desssero la zappa sui piedi e che la loro ignoranza fosse colpa loro. A ogni modo siamo tutti un poco ignoranti. La questione di fondo è come essere civili e umani.
L'immunologa Antonella Viola su Alessandria Today e su Alessandria Online, blog ideati e gestiti dal consulente marketing e social media manager Pier Carlo Lava, ha scritto che il genio e il talento non esistono, che conosce premi Nobel che nella vita si dimostrano persone banali, che la maggioranza degli studiosi sono persone mediamente intelligenti che si sono impegnate. Perseverare insomma sarebbe fondamentale. Secondo questa scuola di pensiero non sarebbe questione di differenze individuali, ma di impegno e costanza. Che poi la branca della scienza che dovrebbe illuminarci a riguardo è la psicologia delle differenze individuali, che con test d'intelligenza e psicoattitudinali vari dovrebbe misurare le capacità di ognuno. Comunemente si usa avere una concezione molto lineare dell'intelligenza: qualcuno potrebbe obiettare che le differenze di intelligenza esistono e che sono lampanti, ma non è così semplice se si vuole approfondire la cosa. Cattell, noto studioso di questo argomento, alla fine della vita si chiese se poi l'intelligenza umana era quella misurata dal Q.I, dopo che aveva sottoposto quei test a migliaia e migliaia di persone. Ma secondo alcuni studiosi l'intelligenza non può essere misurata. Diciamo che per convenzione, per tradizione, per presunta scientificità la psicologia ha la funzione sociale di misurare l'intelligenza e le attitudini, seppur tra dubbi e criticità. In verità non è una scienza esatta. I suoi risultati sono controversi e si devono prendere col beneficio di inventario. Come esistono i falsi negativi e i falsi positivi nei test di medicina, esistono anche i falsi positivi e i falsi negativi nei test di psicologia. In realtà non c'è ancora nessun test che misuri il talento. Secondo i test d'intelligenza Andy Warhol aveva un Q.I di 86 punti, Salinger un Q.I di 104, Jim Watson (scopritore insieme a Crick della doppia elica del DNA) un Q.I di 115 punti, Muhammad Ali (campione di pugilato e leader dei diritti civili) aveva un Q.I di 73 punti. Al contrario non mi risulta che le persone più intelligenti del mondo secondo i test del Q.I abbiano mai fatto scoperte o invenzioni importanti oppure scritto o dipinto capolavori. La stessa precocità intellettuale spesso confusa con la genialità non è sempre indice di talento né di genio. Bisogna mettere in chiaro cosa si intende per talento o per genio. Se si intende andare in modo eccellente a scuola forse finiamo fuori strada e poniamo in modo errato la questione. Se si intende la capacità di scoprire, inventare, creare cose importanti, nuove, originali allora il talento e il genio non possono essere predetti con certezza, non possono essere sempre individuati ex ante ma solo ex post. E poi che differenza c'è tra talento e genio, al di là delle frasi fatte, delle frasi a effetto, delle citazioni, che invece di chiarire la cosa la complicano ulteriormente? Il genio è un talento maggiore, il talento è un genio minore, ma ad esempio quanto talento ci vuole per fare un genio? Non essendo quantificabili queste qualità non si può fare una ricetta con le dosi. Alcuni studiosi parlano appunto di qualità intellettuali e creative, che possono essere solo qualificabili. Inutile fare sottili distinguo tra genio e talento perché non si finirebbe più e saremmo punto e a capo. Al talento e al genio non si può dare una definizione esaustiva. Si può di volta in volta definire e specificare in che cosa consista per ogni opera creativa. La prova del nove è l'opera. Di Salinger non ci deve importare assolutamente il suo Q.I, ma il fatto che abbia scritto "Il giovane Holden" e molti racconti. Si può dire che aveva del genio perché aveva scritto dei capolavori. A ogni modo un'opera artistica oppure la soluzione di un rompicapo scientifico sono strettamente connessi a un certo sfondo culturale, a quello che Popper chiamava un quadro di riferimento, insomma a un contesto che nessun test d'intelligenza o di pensiero divergente ha ed è per questo che non sempre le persone ritenute brillanti secondo queste prove intellettive si dimostrano creative. Non sempre il talento e il genio, ammesso e non concesso che esistano, sono riconosciuti e riconoscibili. È proprio per questo che alcuni mollano, abbandonano la loro attività creativa, dopo delusioni e fallimenti, mentre altri continuano imperterriti, considerandosi dei geni incompresi. Il talento e il genio dipendono dai fatti e i fatti sono le opere creative. Ma artisticamente non esistono dei valori assoluti e davvero universali di capolavoro. Tutto ciò rientra nell'ambito dell'opinabile. Di solito si considera oggettivo il consenso quasi unanime della comunità artistica dell'epoca del genio presunto o di quella dei suoi posteri. La questione cruciale è essere considerati dei talenti e dei geni. Sono dei geni solo coloro che vengono considerati tali, a torto o a ragione. La genialità ha quindi una valenza sociale. In definitiva nessuno sa con certezza assoluta se il genio esiste o se non esiste perché non è definibile universalmente, perché non è quantificabile, perché talvolta non è riconoscibile. Ma poi è così importante saperlo? Nessuno può vedere se una persona è geniale da Tep, Tac, Risonanza magnetica. Secondo lo studio del cervello di Einstein lo scienziato aveva addirittura molte più cellule gliali della media e niente più. A una mente geniale non sempre corrisponde un cervello eccezionale allo stato attuale delle conoscenze. Se esistono dei geni o meno nessuno lo sa. Però esistono delle opere geniali, perché necessarie per l'umanità o perché capolavori artistici. Ma a volte i critici letterari o i critici d'arte sono faziosi, incompetenti o solo miopi. Anche loro hanno delle sviste e compiono degli errori. Non si potrebbe forse scrivere un'altra storia della letteratura oggi con gli autori scartati, ignorati, dimenticati, ostracizzati, perduti? Il fatto è l'opera creativa, ma il vero fatto, a pensarci bene, probabilmente non è la legittimazione dell'opera creativa? Cosa importa che tizio scriva un capolavoro sul suo blog o lo lasci nel cassetto se le grandi case editrici non lo considerano? A volte mi chiedo cosa sarebbe successo nel mondo della letteratura se le persone a loro care avessero rispettato i voleri di Pascal e di Kafka di disfarsi delle loro opere per sempre. Oppure penso a cosa sarebbe successo se non avessero pubblicato postumi Proust, Pessoa, Tomasi di Lampedusa, Morselli. Il problema non è che di solito non si riesce a capire quale alunno sarà un genio creativo domani, ma riuscire a riconoscere il talento a opera creativa compiuta, anzi talvolta il talento non viene riconosciuto neanche da morti. Comunque forse ognuno a suo modo è dotato se non di genio almeno di un piccolo talento, che deve essere messo a frutto. Invece molte persone hanno per tutta la vita delle potenzialità inespresse. E allora qui si aprirebbe tutto un discorso sulla crescita personale e sullo sviluppo umano, che viene malinteso almeno in questa società perché identificato con la concretizzazione di business e di successo economico e professionale. In fondo le persone che si rivolgono ai mental coach e ai life coach (figure solo recentemente regolate legalmente e professionalmente) chiedono solo e soltanto la realizzazione sul lavoro e monetaria. Mi vengono alla mente a riguardo i suicidi di alcuni studenti universitari molto indietro con gli esami, che avevano invece detto alle loro famiglie che avrebbero dato la tesi. Un mix incredibile di aspettative deluse, pregiudiziali insoddisfatte, sogni non realizzati può portare all'estremo gestto. I più vulnerabili in questa società, dove bisogna essere persone di successo, finiscono per soccombere. Bisognerebbe che tutti avessero la stessa libertà di creare. Ma siamo distanti da questo traguardo, oggi irraggiungibile. Il problema comunque alla base dello sviluppo delle capacità intellettuali invece come aveva capito il poeta Eliot riguarda soprattutto l'uguaglianza di possibilità prima ancora della possibilità di uguaglianza e la scuola, almeno quella italiana, che dovrebbe essere il primo motore della mobilità sociale è ancora lontana da dare tutto ciò agli studenti più disagiati. Tutto ciò non è una questione necessariamente politica, ma che dovrebbe essere affrontata da ogni tipo di politica.
ott 132022
La violenza è dentro di noi. Chi non ha sognato di ammazzare qualcuno? Chi non lo ha desiderato a occhi aperti? C'è una neuroanatomia dell'aggressività ed esistono i correlati neurofisiologici della violenza. Esiste una biologia della violenza. Alcuni studiosi hanno parlato di un gene della violenza. Freud scrisse di violenza come desiderio umano di morte. È altrettanto vero che esistono anche i neuroni specchio, che ci fanno immedesimare negli altri, seppur in modo meccanico perché l'empatia ha anche basi socioculturali. È una guerra incessante dentro di noi e nel mondo. C'è la teoria dell'aggressività come effetto della frustrazione. Esiste anche lo spostamento dell'aggressività: il capo tratta male l'operaio, che tratta male la moglie, che tratta male il figlio. Esiste la violenza socialmente indotta. Esiste l'aggressività per sovraffollamento, per gregarismo, per scarsità di risorse, per ingiustizia subita, per competizione, per antipatia, per odio, per anomia, per stati alterati di coscienza, per raggiungere degli obiettivi prefissati, per invidia, per rivalità sessuale/sentimentale, per ubbidire all'autorità, per disimpegno morale, per diffusione della responsabilità, per prepotenza, per l'effetto Lucifero scoperto da Zimbardo, per goliardia, per rito d'iniziazione, per altri motivi personali o prettamente psicologici. Esiste anche una psicopatologia della violenza, che viene considerata legalmente una attenuante. È tremendamente facile uccidere. Basta caricare un'arma e poi sparare. Basta prendere un coltello, poi portarlo alla gola di qualcuno ed esercitare un poco di pressione qualche secondo. Oppure è altrettanto facile avvelenare qualcuno senza che se ne accorga. Ma ricordiamoci anche come è facile ammazzare qualcuno nel sonno, prenderlo alla sprovvista, sfruttare i suoi punti deboli. Ci sono delle differenze individuali sia nella possibilità di compiere azioni violente che di avere reazioni violente. Talvolta il mix esplosivo è dovuto a una concomitanza di cause individuali e circostanze avverse senza scomodare il Fato, il destino. La violenza l'abbiamo anche interiorizzata a scuola, nei libri. Esiste una parte della cultura che è sadica, addirittura necrofila. Marx proponeva la rivoluzione proletaria. Nietzsche, per quanto filtrato e deformato dalla sua sorella prima e poi da Hitler è responsabile per alcuni versi del nazismo per alcuni e gli altri che lo difendono a spada tratta non possono negare che la sua filosofia elitaria, superomistica, contraddittoria può portare taluni all'autoesaltazione e alla sopraffazione dei più deboli. Per Darwin la vita è una lotta, esiste la selezione naturale. Per Freud nel complesso edipico uccidiamo il padre. E che dire della religione, visto che anch'essa è cultura? Ci sono state Crociate, Santa Inquisizione, terrorismo islamico, etc etc. Il nazismo aveva fatto come sua scienza l'eugenetica e guardate cosa è successo. La violenza talvolta è determinata dal furore religioso o ideologico. I brigatisti rossi erano quasi tutti intellettuali o comunque avevano un buon livello intellettuale. La violenza organizzata è spesso indice di un certo spessore intellettivo. L'ideologia nel Novecento è stata violenza al culmine. Mussolini leggeva un libro al giorno. Hitler era a suo modo una persona colta, per quanto folle e necrofila. Stalin era a suo modo un intellettuale. Ma guardiamo un attimo nel nostro piccolo mondo italiano ai tempi del nostro terrorismo interno. Perfino la Normale ha avuto i suoi estremisti, macchiatisi di sangue; Adriano Sofri, mandante dell'omicidio Calabresi, è stato un normalista: non è stato espulso dalla scuola di eccellenza perché violento ma perché portò in camera la sua ragazza. Roberto Rosso, terrorista rosso, studiò matematica alla Normale. Ma passiamo oltre. Senzani, capo delle Brigate Rosse, è stato anche un professore universitario. Ma anche alcuni terroristi neri erano persone con buon coefficiente intellettuale. Per non parlare di Licio Gelli, oggi ritenuto dalle forze inquirenti l'ideatore della strage di Bologna, che fu candidato addirittura da alcuni professori stranieri al Nobel per la letteratura, anche se la sua candidatura era assai debole e dovuta esclusivamente a intrallazzi culturali-massonici. Il grande poeta Villon fu un assassino. Caravaggio fu un assassino. Verlaine sparò a Rimbaud, anche se non lo ferì mortalmente. Althusser, filosofo e studioso marxista, uccise la moglie. Sono solo pochi esempi. Questo non giustifica né legittima nessuno a essere violento. Queste non sono delle scusanti perché la responsabilità è individuale e non si può dare la colpa solo alla cultura o alla società e nemmeno in gran parte a esse. Però esiste una cultura violenta oppure, meglio ancora, alcuni fattori ed elementi culturali possono condurre alla violenza. La cultura stessa è archeopsichica, è fatta anche dal nostro cervello rettile. C'è una parte della cultura che scaturisce dai nostri impulsi violenti. Ma c'è anche una cultura che viene travisata e interpretata in modo violento. Oppure ci sono brani di libri che vengono interpretati in modo letterale e perciò fraintesi totalmente. Esiste la violenza intellettuale quindi. Così come esiste la violenza degli intellettuali e la violenza tra intellettuali. Ma la violenza è la combinazione di più fattori, alcuni individuali, alcuni sociali, alcuni culturali. Si usa anche dire che la cultura, l'istruzione, l'educazione salvano dalla violenza, dalla criminalità organizzata. Di solito è radicata in moltissimi la convinzione che sia proprio l'ignoranza la causa della delinquenza e della violenza. Il problema è complesso. C'è chi delinque per mancanza di opportunità e per mancanza di scolarizzazione. In teoria dei bambini socializzati e degli adulti integrati socialmente non dovrebbero compiere reati. In realtà li compiono, anche se meno frequentemente di coloro che non sono socializzati e integrati. Laddove i bambini non vanno a scuola è dimostrato scientificamente che è più probabile che prendano da adulti una cattiva strada. Chi va a scuola interiorizza dei valori o almeno delle regole, si forma una morale. Almeno questo in teoria.
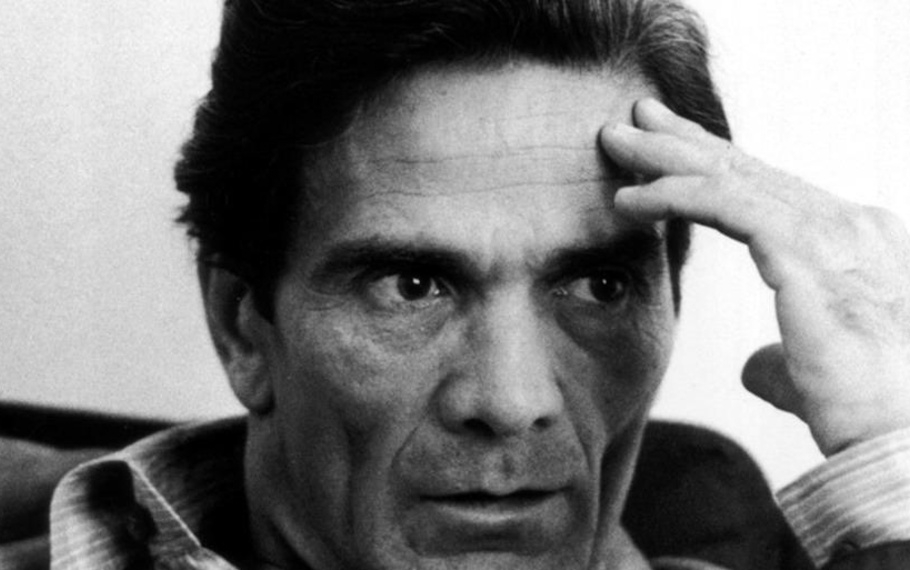
Per Pasolini la cultura e l'istruzione italiana portano a un gioco al massacro. Lui stesso odiava per questo i piccoloborghesi perché violenti e pensava che ci fossero due persone realmente candide e buone: coloro che erano estremamente colte e creative, coloro che erano totalmente ignoranti. Da una parte c'erano coloro che superavano il conformismo culturale e dall'altra coloro che ne erano totalmente sprovvisti. Ma volendo portare il ragionamento agli estremi si potrebbe affermare che anche la vita di strada, le regole della criminalità organizzata siano a loro volta cultura, anche se noi per etica, per legge, per convenzione la chiamiamo sottocultura. A onor del vero sono tante le forze in gioco che determinano la violenza. Bisogna anche vedere il vissuto del responsabile del crimine. Ci sono persone che agirebbero in modo violento sia da colte che da ignoranti. Come ci sono persone colte violente che non sarebbero state violente se fossero ignoranti e viceversa. Sono tantissime le variabili e le microvariabili umane. Sono anche se non infiniti illimitati per le nostre menti i casi della vita. Esiste una cultura della violenza ed esiste anche una violenza della cultura, che talvolta si fondono in modo incredibile. Anche la buona cultura, apparentemente cultura del bene, può diventare strumento di inganno e di dominio sugli altri. Si pensi ad esempio al latinorum di Don Abbondio o ai giri di parole degli azzeccagarbugli di tutto il mondo. Ogni violento ha una sua cultura di appartenenza e ogni violenza è espressione, anche solo per antitesi, di una cultura. La disumanità scaturisce dell'umanità. L'umanità talvolta porta alla disumanità. La cultura è umana e ciò che è umano è violento. Ma la stessa cosa vale per l'ignoranza.
ott 082022

L’inconscio per Freud è tutto ciò che non affiora alla coscienza. Secondo Freud si può accedere all’inconscio tramite le associazioni libere, l’ipnosi regressiva, l’interpretazione dei sogni, l’analisi della psicopatologia quotidiana (dimenticanze, lapsus, errori). Per intenderci potremmo definire questo come inconscio personale o individuale. Esiste anche l’inconscio collettivo, scoperto da Jung, che invece è formato da istinti ed archetipi. Un archetipo è un principio arcaico universale e al contempo un’immagine primordiale, presente nella psiche umana dagli albori. Riguardo agli istinti c'è chi sostiene che anche noi esseri umani li abbiamo e studiosi che pensano che li abbiano solo gli animali. Quindi la cosa è dubbia. Comunque gli archetipi esistono. Non è assolutamente detto che inconscio sia sinonimo di irrazionalità perché anche l’inconscio ha la sua logica. A riguardo si pensi al celebre aforisma di Lacan, secondo cui “l’inconscio è strutturato come un linguaggio”. Inoltre esiste anche l’inconscio cognitivo. Si pensi ad esempio alle recenti ricerche sulle euristiche di Tversky & Kahneman. Le euristiche, semplificando, sono delle scorciatoie mentali errate, che utilizziamo perché la nostra memoria a breve termine è limitata. Messi di fronte a certi problemi non decidiamo quindi come dei decisori esperti, che utilizzerebbero il calcolo delle probabilità. Ogni rimatore si confronta quotidianamente con il proprio inconscio cognitivo e con l'euristica della disponibilità. Ci sono infatti parole che vengono più alla mente e sono più disponibili, anche se magari sono meno frequenti di altre nel vocabolario. Oppure molto più banalmente si pensi a tutte quelle operazioni mentali, che sono divenute degli automatismi della psiche e che non giungono più alla soglia della coscienza. Si pensi quindi ad attività come guidare una macchina o suonare uno strumento musicale. In poesia a mio avviso esistono anche autori, che cercano di rimuovere il più possibile dalla loro scrittura qualsiasi tipo di inconscio. I loro scritti sono colmi di razionalizzazioni. Esistono e sono esistiti anche autori (ad esempio i surrealisti e i futuristi), che hanno lasciato che l’inconscio prevalesse su tutto e su tutti. È da ritenere che ci debba essere una giusta misura, un giusto equilibrio tra conscio e inconscio: la parte conscia però deve sempre prevalere sulla parte inconscia, anche se non può censurare tutto l’inconscio. Infatti è da ritenere che, quando prevale eccessivamente il conscio, si registra un’eccessiva intellettualizzazione. Invece quando prevale l’inconscio si assiste negli autori meno capaci a dei versi incomprensibili e illeggibili. Comunque far riaffiorare l’inconscio è un ottimo atto di autoterapia. Quando la scrittura si apre all’inconscio, rileggendosi, si può avere delle piccole sorprese: delle piccole rivelazioni. Talvolta scaturiscono espressioni inaspettate, che possono essere delle piccole scoperte e che aiutano a conoscere meglio sé stessi. Scrivere quindi è utile (prima di tutto per sé stessi). Gli ermetici sprigionavano il loro inconscio soprattutto tramite le analogie. La Neoavanguardia scatenava l’inconscio con l’asintattismo. Montale invece spesso rimuoveva l’inconscio. Amelia Rosselli e Zanzotto, pur avendo poetiche razionali e un’elevata intellettualità, liberavano spesso il loro inconscio. Di solito l’inconscio viene utilizzato nel dettaglio, nella figura retorica, nell’espressione verbale. L’inconscio può consentire la creazione di nuove immagini poetiche e di accostamenti inusuali, originali di parole. I poeti neo-orfici negli anni Settanta in Italia hanno instaurato un nuovo rapporto con l’inconscio. Sono stati dei poeti “innamorati” della parola. I neo-orfici hanno creduto nella funzione sacrale della poesia e nell’assolutezza della parola. Hanno preferito il prelogico al logico, unendo a ciò nei loro testi oscuri la mitologia. Inconscio individuale e inconscio collettivo si fondevano quindi armoniosamente. L’uomo moderno non può riflettere troppo perché diventerebbe pericoloso per il sistema produttivo; potrebbe infatti chiedersi quale senso abbia effettivamente il suo lavoro o potrebbe diventare un consumatore molto critico. La filosofia, la letteratura, la poesia sono quindi pericolose per il sistema perché possono creare degli umanisti, che esercitano nella vita il loro senso critico e la loro autonomia di pensiero. Il potere inoltre vuole dominare totalmente l’inconscio. Invece tramite la poesia qualsiasi persona si riappropria del proprio inconscio. Ecco perché la poesia viene considerata inutile dalla società odierna (fondata sulla razionalità tecnologica e scientifica) e chi scrive versi invece viene considerato un perditempo!!! La poesia è anche espressione della razionalità umana (per quel che è possibile). La parola poetica può dirci sempre qualcosa di nuovo sul mondo e sull’animo umano. La parola poetica può mettere ordine nel mondo: innanzitutto nel mondo interiore di chi scrive. Da questo punto di vista la bellezza non è solo verità, ma la riflessione poetica-filosofica può condurre alla verità umana (per cui sempre provvisoria e instabile, mai definitiva). Quindi molti poeti sono razionalisti e umanisti moderni. Poi naturalmente bisognerà anche valutare gli esiti. Come scriveva Saba in “Cose leggere e vaganti”: “anche i versi somigliano alle bolle di sapone; una sale e un’altra no”.
ott 072022

Non voglio fare assolutamente una descrizione dei tratti distintivi del carattere nazionale degli italiani. Illustri pensatori lo hanno già fatto. Giacomo Leopardi scrisse un saggio a riguardo, che si intitola “Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani”. Secondo Leopardi l’Italia, pur avendo le stesse cognizioni delle altre nazioni civili (Francia, Inghilterra, Germania) non ha una “società stretta”, “una società buona”, caratterizzata dall’opinione pubblica, dal “buon tuono”, dall’onore. Secondo il grande poeta il cinismo degli italiani determina un’immoralità diffusa. Prezzolini nel 1921 scrisse il “Codice della vita italiana”, in cui suddivise gli italiani in due categorie: i furbi e i fessi. Riguardo ai fessi scrisse: “non c’è una definizione di fesso. Però: se uno paga il biglietto intero in ferrovia, non entra gratis a teatro; non ha un commendatore zio, amico della moglie e potente nella magistratura, nella Pubblica Istruzione ecc.; non è massone o gesuita; dichiara all’agente delle imposte il suo vero reddito; mantiene la parola data anche a costo di perderci, ecc. questi è un fesso”. Ma non bisogna dimenticare nemmeno il lavoro di Luigi Barzini jr. e i recenti libri di Montanelli riguardo allo studio degli italiani. In questa sede non voglio trattare dei valori in cui credono gli italiani. Sarebbe un’impresa non ardua, ma addirittura improponibile in quest’epoca di soggettivismo dei valori. Probabilmente sono i difetti e i vizi piuttosto che le pubbliche virtù ad accomunare gli italiani: il trasformismo, la ricerca sempre più vana di individualismo, l’arte del compromesso, l’abilità di rendere complicate anche le cose più semplici, il pressappochismo, il disfattismo, la mancanza di amor patrio, l’assenza di civismo, la tendenza all’anarchia (non dal punto di vista politico, ma organizzativo), l’insofferenza nei confronti dell’autorità, la scarsa fiducia nelle istituzioni, il predominio costante dei diritti sui doveri. Orson Welles a proposito del nostro Paese ebbe modo di dire: “In Italia per trecento anni sotto i Borgia ci sono stati guerra, terrore, criminalità, spargimenti di sangue. Ma hanno prodotto Michelangelo, Leonardo, il Rinascimento. In Svizzera vivevano in amore fraterno, avevano cinquecento anni di pace e democrazia. E cosa hanno prodotto? L’orologio a cucù”. Gli italiani nonostante mille problemi riescono sempre ad arrangiarsi e a creare. Un popolo di santi, poeti e navigatori dunque, come si diceva un tempo. Nonostante il nostro machiavellismo perché da noi il fine giustifica sempre i mezzi. Nonostante mille crimini e delitti, spesso senza castighi. Questo infatti è ancora il Paese della mafia. Ma è anche uno dei paesi più industrializzati del mondo malgrado la scarsità di materie prime come ferro, rame, carbone, cotone. Comunque è facile incorrere nel rischio di fare delle generalizzazioni indebite e di cadere nel qualunquismo. L’Italia cambia continuamente. Anche il clima è mutato radicalmente. Se anni fa esistevano stagioni e mezze stagioni, oggi il clima è diventato totalmente instabile. In estate non è più un clima mediterraneo, ma addirittura torrido con alte percentuali di umidità. Gli esperti ci dicono che dipende dall’innalzamento delle temperature in tutto il globo terrestre. L’accelerazione storica di questi ultimi decenni è stata impressionante. Le indagini demoscopiche ci aiutano, in quanto ci forniscono delle istantanee dell’Italia. Ma non ci dicono le cause di certi comportamenti. Questa società è in continua trasformazione, anche se talvolta noi abbiamo il vizio di confondere il nuovo con il già visto, di dare a cose vecchie parole nuove. Ad esempio nel giro di pochi anni l’Italia, che appariva culturalmente fondata da archetipi della cultura latina e da principi cristiani (con qualche tocco di laicismo qui e là), oggi sembra apparentemente diventata la patria del relativismo culturale. Ma in realtà ciò che a prima vista sembra relativismo culturale -a mio avviso- non è altro che un binomio indissolubile di antico permissivismo e di solito menefreghismo, che da secoli dominano incontrastati nella nostra penisola. Scrivendo ciò non voglio offendere l’italianità. A tal proposito abbondano già i preconcetti e gli stereotipi degli stranieri. Ci vedono ancora come la patria degli spaghetti, della pizza, dei mandolini e della mafia. Un tempo forse eravamo davvero così. Forse certi pregiudizi erano dovuti alla nostra emigrazione massiccia. Le cose sono cambiate in questi anni. Se un tempo italiani semianalfabeti emigravano in America o in Germania in cerca di fortuna, oggi esiste invece la fuga dei cervelli: ricercatori scientifici, che espatriano perché non si sentono valorizzati da noi. Gli italiani poi se ne infischiano altamente di difendere la loro nazione. L’italiano a mio avviso fa bene a non essere patriottico o sciovinista. Però un minimo di orgoglio nazionale in più ogni tanto non guasterebbe. Invece prova sollievo ogni volta che parla male dell’Italia. Io ora voglio solo riflettere ironicamente (o forse amaramente?) sugli italiani e sull’Italia attuale. Può darsi che commetta molti errori, ma il compito non è facile. D’altra parte l’Italia non è solo quella disegnata sulle cartine geografiche, non è solo fatta di arte e di luoghi dell’anima, ma è anche una matassa senza bandolo di modi di essere e di modi di vivere. L’Italia attuale è come un disegno di Escher, dove le realtà socio-economiche e culturali più svariate si intrecciano e si sovrappongono. E’ anche il Paese tragicomico per eccellenza, dove regnano sovrani paradossi e contraddizioni di ogni sorta. Dopo secoli di dominazioni straniere D’Azeglio dichiarò: “L’Italia è fatta, restano da fare gli italiani”. Ci si potrebbe chiedere paradossalmente che senso abbia parlare degli italiani. Non è più l’epoca dei guelfi e dei ghibellini, però gli italiani non si sono ancora amalgamati a dovere. Si pensi anche ai regionalismi e ai campanilismi, che talvolta creano anche problemi di ordine pubblico in occasione di partite di calcio. Anche se la televisione è stata determinante per l’unificazione linguistica del nostro Paese, sono molte le persone che parlano con famigliari e amici il dialetto e lo preferiscono alla nostra lingua nazionale neolatina così musicale. Ma in fondo l’unità di Italia da un punto di vista storico è recente. Per secoli l’Italia è stata frantumata in comuni e signorie nel Medioevo e successivamente in statarelli. Gli ultimi a dominarla prima dell’unità sono stati i francesi, gli spagnoli, gli austriaci. E’ stata devastata e saccheggiata. Ci si ricordi a tal proposito alla immane confisca delle opere d’arte dovuta a Napoleone. Forse il problema oggi non è più nemmeno sapere se sono stati “fatti” o meno gli italiani, piuttosto viene da chiedersi se domani ci saranno ancora gli italiani, dato che le culle sono vuote o quasi e la crescita demografica è prossima allo zero, nonostante la densità della popolazione rimanga elevata in tutta la penisola. Viene inoltre da chiedersi anche se la qualità della vita degli italiani coincida con il benessere economico, oppure se la qualità della vita sia data non solo dal reddito, ma anche dal potere d’acquisto, dal tasso di microcriminalità nel proprio quartiere, dai servizi sanitari, dalla tutela dell’ambiente, dallo stare bene al lavoro, dalla vivibilità del proprio paese. Superficialmente potremmo ritenere che gli italiani vivono serenamente in un clima di permissivismo ed edonismo. In realtà il clima di permissivismo e di edonismo esiste, ma gli italiani non vivono serenamente. Pensiamo solo alle preoccupazioni per la guerra, per la crisi economica, per il lavoro, per i rincari, etc etc. Se consideriamo le centinaia di migliaia di italiani insonni, ansiosi, depressi, stressati ci possiamo subito rendere effettivamente conto che gli italiani non versano in buone condizioni di salute, oppure che non possiedono più gli anticorpi delle generazioni precedenti per superare gli ostacoli e le avversità della vita quotidiana. Gli italiani sono insicuri e per questo assumono tranquillanti, pagano profumatamente agenzie di vigilanza, aziende di porte, casseforti e di impianti di allarmi. Si stava quindi meglio quando si stava peggio? Alcuni rimpiangono la civiltà contadina. Pasolini denunciò la scomparsa delle lucciole. E’ facile rimpiangere la poesia e la magia della civiltà contadina: gli odori autentici e i sapori genuini di un tempo, le veglie, la comunità, l’armonia con la natura, i venditori di castagnaccio e di caldarroste. Ma qualcuno rimpiange forse il latifondismo del Sud? Qualcuno rimpiange forse le cene esclusivamente a polenta nel Nord? Qualcuno rimpiange forse i vasi da notte in quest’epoca di grandi comodità (di forni a microonde, di aria condizionata, di idromassaggi)? Ci ricordiamo davvero come era la vita quando non c’era l’insulina, il cortisone e la penicillina?
ott 012022
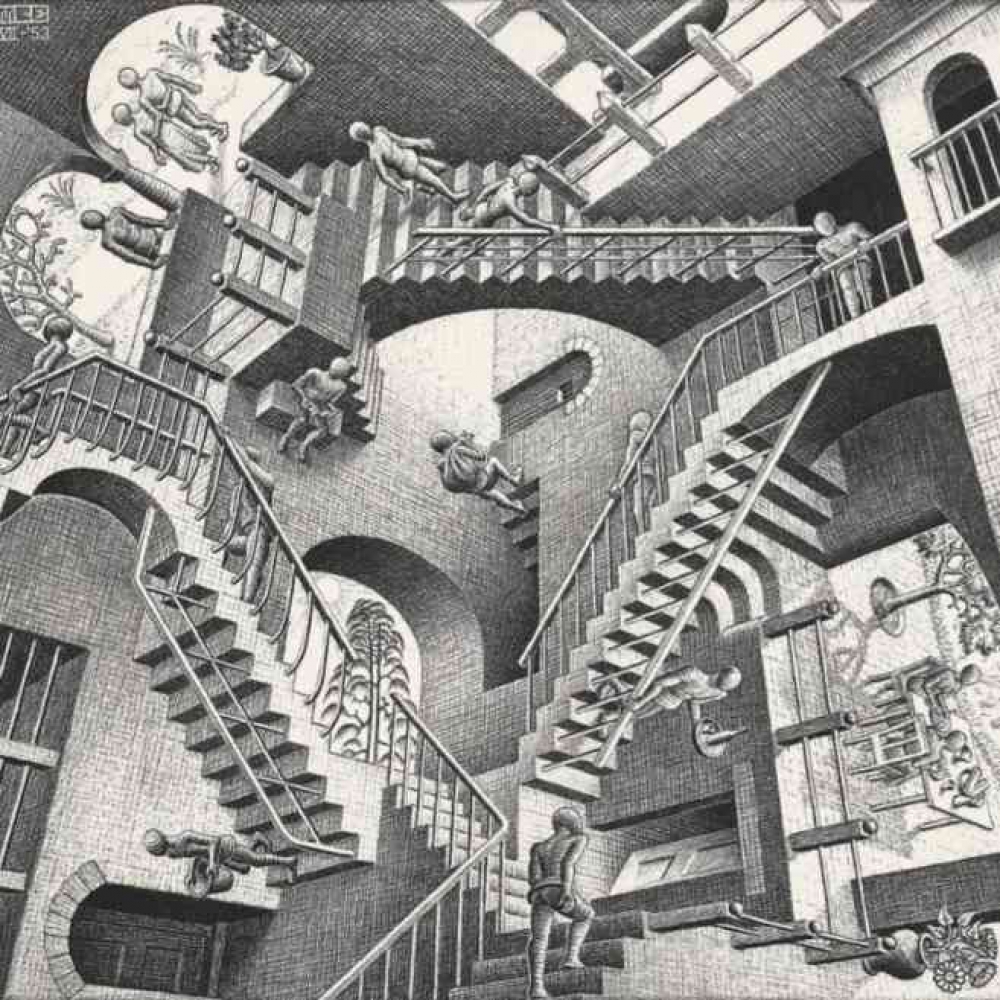
Si può avere dei pessimi gusti letterari ed essere delle brave persone. Si può pensare che l'impoesia sia poesia, che la poesia sia impoesia ed essere delle brave persone. Che tanto poi non esistono più da secoli dei criteri assoluti e oggettivi per stabilire che cosa sia poesia e che cosa non lo sia! Prima del Novecento i poeti dovevano essere aulici e rispettare i santi crismi della metrica. Ai tempi di Dante le terzine dovevano essere incatenate. Anche nell'Ottocento i versi sciolti di una poesia dovevano essere metricamente ineccepibili per sillabe e accenti tonici. Oggi tutto è permesso, tutto è lecito nel bene e nel male (sia inteso). Forse è anche la mancanza di regole a aver fatto perdere rispettabilità e credibilità alla poesia contemporanea (è un'ipotesi da non scartare, tant'è che qualche poetessa come la Valduga è ritornata all'ordine, all'ipermetrismo). Che poi la perfezione non è cosa umana e se c'è qualcosa che si avvicina alla perfezione é solo nel dettaglio, nel piccolo! Lo scrittore Sandro Veronesi, premio Strega, ha dichiarato che il romanzo perfetto non è mai esistito, nemmeno scritto da dei grandi geni, mentre invece esistono ogni tanto dei racconti che si avvicinano alla perfezione. Credetemi: si può avere ottimi amici illetterati e che nemmeno sono lettori forti. Magari si sta meglio in loro compagnia e non ci si avvelena il sangue. Scegliete le persone in base alla loro umanità, onestà, autenticità, lealtà, sincerità, non in base alla loro presunta intellettualità e non avrete mai delusioni cocenti. Di un amico non valutate le lacune culturali ma se manca o meno come persona con voi. Si può essere invece dei grandi letterati ed essere degli autentici farabutti. Che poi il sacrificio, l'abnegazione e la considerazione scarsissima delle persone, gli scarsi guadagni, molto spesso le poche risorse economiche, sommate tutte assieme, spesso rovinano il carattere di qualsiasi anima bella, di qualsiasi poeta. Perciò io li capisco, li comprendo pienamente certi letterati incompresi e fegatosi, come si suol dire a Roma. Spesso non solo non vengono capiti, ma vengono derisi, sbeffeggiati, irrisi o talvolta ancora peggio su di loro cala l'indifferenza. Certi preti per preservare le loro pecorelle dicono che la cultura umanistica allontana dalla fede (scordandosi che anche il cristianesimo è umanesimo antelitteram). Allo stesso modo direi che per non impermalosirsi, per non incattivirsi, per non rovinarsi il fegato è meglio stare ad esempio lontani dalla poesia e dalla scrittura in genere. Primo motivo: non girano i soldi. Secondo motivo: la fama è inconsistente. Terzo motivo: si spende e non si guadagna. Quarto motivo: il pubblico disinteressato non esiste, ma è fatto solo da aspiranti poeti in competizione tra loro. Quinto motivo, ovvero la risultante degli altri motivi: c'è il serio rischio di sviluppare una nevrosi o una psicosi, visto che il contesto poetico è nevrotico/psicotico. Ho la netta sensazione talvolta che il contesto poetico sia la sommatoria di tante psicopatologie, derivate dal disinteresse degli italiani nei confronti di questa materia. Alcuni o forse molti si ammalano o rischiano di ammalarsi e soffrire psicologicamente per quella che a tutti gli effetti dovrebbe essere una passione semplicemente. Molti cercano la riconoscibilità poetica. Non la trovano e da ciò scaturisce l'incomprensione perenne. Alcuni risultano provati dalle porte che la comunità poetica sbatte loro in faccia. In realtà anche in poesia bisogna rispecchiare certi canoni del conformismo culturale per affermarsi: essere integrati socialmente e lavorativamente, essere di buona cultura, essere sodale tra i sodali, essere solidali con i più deboli in forma vaga e indistinta, dimostrare di apparire sufficientemente contro il sistema, dimostrare di essere alternativi e anticonformisti, essere di sinistra (pur riservandosi di criticare la sinistra fino allo sfinimento e fino al disfattismo), presentarsi come anime belle e poi in realtà coalizzarsi con quelli che vengono considerati i nemici per le ragioni più banali e più inconsistenti. Spesso i poeti (veri o presunti) sono figli di buona donna con gli altri poeti perché si sentono in gara o sono amici di alcuni poeti per interesse, calcolo, quieto vivere. Spesso i poeti (veri o presunti) sono figli di buona donna con il resto dell'umanità non poetica perché se gli altri apprezzano le loro poesie i poeti (veri o presunti) li odiano dato che vorrebbero essere ripagati materialmente, sessualmente, socialmente, professionalmente e naturalmente ciò nella stragrande maggioranza dei casi non avviene. Molto spesso i poeti (veri o presunti) odiano il resto dell'umanità che non si cura di loro e delle loro poesie. Le loro parole, le loro moine, le loro formalità vuote non vi traggono in inganno: i poeti sono cattivi, profondamente cattivi e nemmeno amano più la poesia, ma i colpevoli di tutto ciò siamo tutti noi. Siamo noi che li abbiamo dimenticati. Siamo noi che non abbiamo voluto conoscere la loro poesia. Comunque tutti hanno le loro colpe: sia i poeti che i lettori che i non lettori hanno assassinato tutti la poesia. Poi diciamocelo chiaramente: un luogo comune vuole che i poeti siano tutti buoni e da ciò ne consegue che chiunque scriva poesia abbia il dovere di essere buono e comportarsi bene. Da ciò risulta che i poeti, veri o aspiranti, siano sempre sotto osservazione e sempre ricattabili dalle altre persone. Invece questo pregiudizio positivo che finisce per essere una trappola per i poeti crea aspettative troppo grandi e quasi sempre disattese. Un altro luogo comune è che il poeta sia una persona speciale verbalmente, concettualmente, per sensibilità, per cultura, per animo, per intelligenza. La realtà è che il poeta molto spesso è una persona come le altre. Non ha niente di speciale. Non ha niente di più. I poeti hanno assassinato la poesia con le loro parole. Tutto il resto dell'umanità ha assassinato la poesia con la mancanza di amore e di interesse nei confronti della poesia. Eppure, sembra tanto logico e scontato ma non lo è: ci vuole proprio la poesia di tutti per rendere il mondo più poetico, mentre invece l'assenza di poesia o una cattiva poesia lo rendono ancora più impoetico. L'equilibrio è instabile e precario. Talvolta ho la vaga impressione che ci sia meno poesia nelle poesie contemporanee e più poesia nelle piccole cose della vita quotidiana. Il terreno su cui tutti ci muoviamo è limaccioso, scivoloso. Come ha detto qualcuno molto più importante di me, ovvero Bobin, dovremmo tentare di abitare il mondo poeticamente. E lo stesso Bobin ha scritto che abitare il mondo poeticamente è l'identica cosa che abitare il mondo umanamente. La poesia è umanità. L'umanità è poesia. Naturalmente ci vuole pazienza e dedizione per riuscire a cogliere tutto ciò, per carpire la poesia nell'umanità e l'umanità nella poesia. Allora dobbiamo sopportare la vanagloria, l'opportunismo, l'arrivismo, il narcisismo, la smania di grandezza di alcuni o molti poeti (veri o presunti). La malignità dei poeti deriva dalla loro frustrazione, dal loro senso di sconfitta in una società che ha relegato ai margini la poesia. Naturalmente anche io un tempo scrivevo poesie (o presunte tali). Anche io un tempo facevo ridere. Ma come scriveva un tempo la grande poetessa Szymborska: "Preferisco il ridicolo di scrivere poesie, al ridicolo di non scriverne". Realisticamente parlando però, se non si è grandi poeti in grado di essere ricordati dai posteri, si trae molto giovamento quando si smette di scrivere poesie. Qualcuno che sa rinunciare ci vuole. Si dimostrerà avveduto. Ci guadagnerà in credibilità agli occhi del mondo. Ma questo non vuol dire che debba smettere di amare la poesia. Che tanto l'importante è che ci sia poesia. Non importa se la poesia sia propria o altrui!
set 252022

Forse tutto è già stato scritto e quello che non è stato scritto forse non meritava di essere scritto, non era degno di nota, era puro nonsense.
Forse -dicevo- tutto è già stato scritto.
La Neoavanguardia già nel dopoguerra sembrava aver divorato tutte le poetiche. È impresa ardua, quasi improponibile cercare di riformulare dei codici espressivi. Il ‘900 letterario è stato artefice di grandi stravolgimenti. Il panorama nell’ambito della poesia è mutato completamente. Per secoli ha predominato una tradizione aulica, intessuta di preziosismi, latinismi, grecismi. Per secoli il linguaggio poetico è stato vago, raffinato e circoscritto. Le sperimentazioni tutt’al più erano metriche.
Tutto a un tratto nel 1900 ecco una miriade strabiliante di innovazioni sintattiche, morfologiche e lessicali. Ecco affacciarsi l’antilirica, se si paragona la poesia moderna a quella dei secoli addietro. Un’antilirica, che sempre più si disinteressa della metrica e pone tutto il suo interesse nelle poetiche e nell’ampliamento del lessico. Non esiste più la poesia come entità autonoma di conoscenza e produzione, di corrispondenza prelogica e preconscia tra l’essenza delle cose e l’essenza dell’animo umano. Avviene il dominio del contenuto sulla forma, della poesia del fare poesia sulla poesia, dell’arte dell’arte sull’arte.
Alcuni critici riprendono il concetto hegeliano di “morte dell’arte”, ma piuttosto si tratta di serie di radicali trasformazioni, della dissoluzione di canoni preesistenti ormai sclerotizzati. Non esiste una “morte dell’arte”, ma il prevalere della poetica sulla poesia e ciò comporta una maggiore consapevolezza del proprio fare artistico e talvolta un eccessivo smontaggio analitico delle opere creative. Ogni aspetto del reale può ispirare, anche ciò che un tempo poteva essere considerato impoetico per eccellenza. Ogni termine di qualsiasi campo semantico può diventare poetico. Si pensi ai tecnicismi di Zanzotto recentemente, ma a dire il vero avevano iniziato Pascoli e Montale, profondi conoscitori della botanica. Ecco comparire all’improvviso l’inconscio con il surrealismo e il paroliberismo dei futuristi: i sintagmi sono in libertà, non c’è alcuna struttura interna.
Nella poesia sembra essere ammesso quello che ordinariamente non è ammesso altrove. Per seguire i flussi di coscienza l’artista spesso procede per associazioni, frammenti, immagini-frase.
Nel’900 è vietato ogni presupposto assolutistico. I poeti sono politeisti dell’arte. Ci si può perdere di primo acchito in questo caleidoscopio, in questa confusione di linguaggi che ha come comune denominatore il relativismo e il prospettivismo (la realtà viene indagata da più angolazioni).
Niente sembra più stabile e il cultore di poesia non sa più di chi e cosa fidarsi in questo apparente disordine, in questa molteplicità stilistica. Dopo lo schizoformismo di Giuliani, la prosa poetica di Nanni Balestrini, l’asintattismo di Elio Pagliarani, la Palus Putredinis di Sanguineti, il ritmo di Amelia Rosselli, il tono colloquiale e privato di Dario Bellezza, “Il disperso” di Maurizio Cucchi, le folgorazioni di Milo De Angelis è difficile non essere banali. È fuori luogo poi essere loro manieristi. Altra era la temperie culturale vissuta da questi grandi autori, altro era il contesto sociale del ‘900 e le problematiche annesse e connesse (boom economico, unificazione linguistica, comparsa della televisione, scomparsa della civiltà contadina, migrazioni interne dal Sud al Nord, contestazione studentesca, anni di piombo, il ruolo e lo status del letterato nell’era industriale, netta divisione tra cultura di massa e cultura alta).
Molte poi sono le scuole (l’idealismo, il crocianesimo, lo storicismo gramsciano, la critica formalista, lo strutturalismo, la semiologia), gli ismi letterari (il simbolismo, il crepuscolarismo, il surrealismo, l’ermetismo, il futurismo, il neorealismo, il neosperimentalismo, la neoavanguardia, il neo-orfismo), i maestri di pensiero (i più recenti ad esempio: Lacan e l’inconscio come linguaggio, Wittgenstein e i suoi giochi linguistici, Lyotard e il postmoderno, Heidegger e la sua ontologia della poesia, Gadamer e la sua ermeneutica, Foucalt ed il suo concetto di potere, Derrida ed il suo decostruzionismo e ancora… R. Barthes, Levi-Strauss, Chomsky, Marcuse, etc, etc) a cui un autore può fare riferimento. Molte sono le strade percorribili. Svariate sono le problematiche stilistiche: scegliere tra suggerire e nominare, tra prosaico e lirico, tra tradizione e innovazione, tra metafora e analogia, tra un linguaggio puro e astorico e uno ricco di contaminazioni.
Difficile oggi poi fare una mappatura esaustiva della poesia italiana, difficile definire attualmente che cosa sia in quest’epoca di “tradizione del nuovo”, di autori neo e post la vera poesia.
Simposi, convegni, corsi di creative writing, articoli, saggi hanno cercato e cercano di pontificare a riguardo.
set 142022

Analisi e commento di "Così siamo" di Andrea Zanzotto:
Dicevano, a Padova, “anch’io”
gli amici “l’ho conosciuto”.
E c’era il romorio d’un’acqua sporca
prossima, e d’una sporca fabbrica:
stupende nel silenzio.
Perché era notte. “Anch’io
l’ho conosciuto”.
Vitalmente ho pensato
a te che ora
non sei né soggetto né oggetto
né lingua usuale né gergo
né quiete né movimento
neppure il né che negava
e che per quanto s’affondino
gli occhi miei dentro la sua cruna
mai ti nega abbastanza.
E così sia: ma io
credo con altrettanta
forza in tutto il mio nulla,
perciò non ti ho perduto
o, più ti perdo e più ti perdi,
più mi sei simile, più m'avvicini.
Sarò possibilista dal punto di vista metrico. Il primo verso potrebbe essere un endecasillabo, se usiamo la dialefe. Il secondo verso è un decasillabo. Il terzo verso è un doppio settenario, sempre se consideriamo la dialefe. Il quarto verso è un endecasillabo, sempre con dialefe. Il quinto verso è un settenario. Nei primi cinque versi di Zanzotto, in questi due primi periodi, mi sembra che le parole debbano essere soppesate, ponderate. Nessuna parola è di troppo in questa lirica e ogni parola è al posto giusto: ciò denota una precisione chirurgica nella nominazione. Se non utilizziamo la dialefe invece gli endecasillabi sono solo due (uno è l’ultimo verso della poesia). Inizialmente si noti l’iperbato. Il romorio è un termine desueto per indicare un rumore persistente, incessante. Solo l’acqua sporca e la fabbrica scalfiscono il silenzio. Nelle prime due frasi il grande poeta si rifà metricamente alla tradizione, alternando due endecasillabi (uno solo se non contiamo con la dialefe) a un doppio settenario e a due settenari. Successivamente ci sono diversi ottonari, diversi novenari, diversi settenari e svariati enjambements. I versi sono liberi, ma c’è il rispetto delle regole metriche. In questa lirica non abbiamo ancora lo Zanzotto de “Il galateo in bosco”, che con il suo ipersonetto rinnova la tradizione del sonetto “classico”. Qui Zanzotto non tratta del petèl (della lingua dei lattanti) né della “psicanalessi” né utilizza il suo plurilinguismo. Qui Zanzotto non gioca con il linguaggio, non è in bilico tra balbettio e sproloquio, né tra afasia e amnesia. Qui non c’è ancora lo Zanzotto che tratta degli ossari del Montello. Qui ancora non c’è l’io “male sbozzolato” e neanche “Io – in tremiti continui, – io – disperso e presente”. Il poeta mette da parte psicologismi e nevrosi, insomma “l’esistere psichicamente”. Zanzotto qui doveva ancora diventare il poeta sperimentale, quello che si riferiva al significante (a Saussure, a Lacan), assolutamente non legato alla neoavanguardia, ma che però aveva fatto la sua gita a Chiasso (come voleva Arbasino) e aveva cultura non provinciale ma europea. Il poeta doveva ancora utilizzare il dialetto. Zanzotto doveva ancora diventare il poeta che voleva salvaguardare a tutti i costi il suo amato Veneto dall’industrializzazione selvaggia, dallo scempio edilizio, dall’inquinamento. C’è un fatto personale da un certo punto di vista che mi lega alla grande poesia di Zanzotto: avevo amici in giovinezza a Pieve di Soligo, Conegliano, Vittorio Veneto. Sono stato in quei posti. I miei amici mi raccontavano di questo loro grande poeta, di questo loro grande concittadino, schivo e riservato. Ho conosciuto anche io quei luoghi. Sia ben inteso che il Veneto che ho visto io è più quello cantato da Zanzotto che quello narrato a tinte fosche da Carlotto (con tutto il rispetto e la stima per quest’ultimo). A ogni modo questo componimento è tratto da “IX ecloghe”, raccolta scritta tra il 1957 e il 1960. Zanzotto doveva far ancora sua la frase di Hölderlin “siamo segni senza significato”, anche se leggendo attentamente questi versi memorabili c’erano già tutte le premesse, ma è altrettanto vero che qui il poeta è alla spasmodica ricerca di un’autentica significazione, che però naturalmente non trova, dato che di fronte alla morte ogni parola di conforto, di consolazione è vana. In questa lirica c’è un lutto e il suo tentativo di rielaborare il lutto. Ora anche il poeta è morto da anni, ma questo capolavoro è ancora attuale, ci parla ancora a noi e di noi perché la grande poesia è eterna. In fondo suo padre è morto, ma è stato eternato, immortalato. Zanzotto è morto, ma ha avuto gloria postuma e noi ancora lo leggiamo. La grande poesia quindi rende immortali. Qui c’è solo un brevissimo cenno descrittivo al contesto, all’ambiente nel terzo, quarto, quinto verso. Non c’è nessun bozzetto paesaggistico e non c’è nessuna descrizione minuziosa, ma vengono riportate alcune frasi degli amici del padre (a cui questa poesia è dedicata). Il verso più terribile è questo: “neppure il né che negava”. Il padre ormai se pensiamo al mondo dei viventi e al mondo del visibile non è più nulla. Però anche il poeta è allo stesso tempo nulla perché vive nella precarietà esistenziale e come tutti è prossimo alla fine. Il poeta cerca uno spiraglio, una fessura (la cruna), ma invano. Non è con la percezione usuale e nemmeno con la ragione che si trova un pertugio di speranza, ma come vedremo più tardi solo con un atto di fede nella propria umanità e nella propria interiorità (ricordando cosa diceva Sant’Agostino sul rapporto tra interiorità e verità). È impossibile per la ragione umana pensare a qualcuno che esiste ma che è non è più niente né nessuno, né oggetto né soggetto.

Mentre nella parte centrale era il “né”, ripetuto più volte (queste iterazioni determinano il ritmo di questi versi) a condizionare ogni periodo e a negare la presenza del padre su questa Terra, è decisiva negli ultimi sei versi la particella avversaria “ma”, che determina tutto. Nella parte centrale c’era quell’avverbio “vitalmente” poi seguito da “ho pensato” che era una sorta di eufemismo, un modo elegante e meno brusco per non usare le parole “morte”, “morto”: Zanzotto infatti non utilizza concetti banali come “passato a miglior vita”, eppure non utilizza nemmeno termini mortuari né necrofili. Se nei primi versi sembrerebbe che di un morto resti soltanto l’averlo conosciuto di persona, nell’ultima parte c’è l’affermazione della memoria, della vita, di una nuova vita, anche se mai esplicitata pienamente. Lo testimonia l’espressione “E così sia”, ripresa dalle formule liturgiche, che dimostra il fatto che questa splendida poesia è una preghiera laica. Zanzotto credeva nel divino. Non fu casuale a mio modesto avviso se criticò positivamente e promosse la poesia di David Maria Turoldo. Ritornando a questo componimento, a onor del vero, sono importanti tre parole che condizionano il discorso: “ma io credo”. Zanzotto fa un atto di fede, quello di credere con tutta la sua forza in tutto il suo nulla (dato che ogni uomo è poca cosa, essendo carnale e mortale). Altrettanto importante è la convinzione che ne consegue: “perciò non ti ho perduto” perché le parole, i gesti dei morti restano nella memoria dei vivi e prepotentemente ritornano quando meno uno se lo aspetta. A mio avviso in questo modo anche non essere più il né che nega significa ancora una volta che la doppia negazione afferma. Eppure la morte è terribile perché è fortissimo il contrasto tra assenza e presenza. L’autore ebbe a dichiarare che la poesia è “un elogio della vita”, però -aggiungo io- la morte nullifica non solo ogni poter essere ma ogni nostra dicibilità. La morte è l’evento clou, il trauma finale. Se esiste il trauma della nascita, quello della separazione dalla madre, esiste anche il trauma della morte, quello della separazione dai propri cari dal morente e del morente dai propri cari. Comunque è da notare è che il grande poeta quando tratta della morte lo fa con chiarezza memorabile, evitando citazioni, astrazioni, raffinatezze. Zanzotto di fronte alla morte non è mai troppo sentimentale né distaccato, ma sempre coinvolto e partecipe. Non è mai troppo semplice né troppo complesso. Sa trovare la giusta distanza e la giusta dimensione. Sa trovare le parole esatte. Si veda ad esempio “Idioma”, raccolta scritta tra il 1975 e il 1986, in cui compaiono una poesia dedicata a Maria Fresu, vittima della strage di Bologna (di cui non restò più niente, morta insieme alla figlia), e il Tato padovano. In quest’ultimo componimento l’autore scrive dell’anima immortale. In fondo questa concezione religiosa, ma prima di tutto metafisica, era già presente in questo componimento. Non è un caso che in ogni civiltà per fondare un’etica o anche solo una nuova cultura ci sono sempre stati due punti insostituibili: l’immortalità dell’anima e l’esistenza di Dio o delle divinità. È stato così per gli antichi greci. È stato così per gli illuministi, che credevano nella ragione in modo quasi totalizzante, ma erano anche deisti (credevano cioè in una sorta di panteismo). In fondo non è necessario e non l’ho fatta apposta una parafrasi di questo testo. Basta ricordarsi del titolo: “Così siamo”. Per ognuno, indistintamente, suona la campana, citando Hemingway.
set 082022

Ha un bel dire con tutti i suoi platani Firenze.
Non è uguale la musica, non può esserlo.
Ma uguale a che, la stessa di quando -
discetta perdutamente il senso
non trovando fondale a quel risucchio
di mancamento o rimorso.
Né so cosa m'intenerisce di lei,
se davvero la spina che le è infissa della mia vita
o quell'aria di congedo in lei da me, in me da lei. O il niente
di questo.
Mario Luzi è stato uno dei protagonisti della poesia italiana del Novecento. Attraversò quasi tutto il secolo breve. É stato anche senatore a vita. Fu candidato per anni al Nobel della letteratura. Consiglio a tutti di leggere le sue opere e magari anche di leggere "Saggio su Mario Luzi" di Anna Panicali. Luzi fu uno dei protagonisti al Caffè delle Giubbe Rosse. Fu professore universitario e saggista oltre che grande poeta. Apparentemente in questa lirica sembra che Luzi vada a capo quando vuole senza rispettare alcuna regola. In realtà si tratta di versi liberi che rispecchiano i canoni della metrica italiana, tutti con i giusti accenti tonici, anche se senza rime e con alcuni enjambements. Luzi utilizza alcune volte la sinalefe perché questa è la consuetudine tra poeti, mentre la dialefe è l'eccezione. La sinalefe infatti è più eufonica, mentre la dialefe è più disarmonica e più entropica. Ci sono anche degli endecasillabi canonici in questo testo. Non vi traggano in inganno alcuni versi più lunghi del componimento perché sono anch'essi metricamente ineccepibili. Mario Luzi nel corso di tutta la sua carriera poetica non è mai andato a capo a caso, come molti versoliberisti (forse a torto, più probabilmente a ragione). Il primo verso ad esempio è un doppio settenario con sinalefe. Il terzultimo verso è un doppio novenario, scandendo normalmente le sillabe. Il penultimo verso è un doppio ottonario con sinalefe. Certamente la sua prima produzione poetica era metricamente più rigorosa di quella in età matura e in vecchiaia, ma il poeta ha dimostrato sempre grande prolificità, capacità di rinnovarsi, una scrittura impeccabile. In questa poesia esprime sia un'idea che un sentimento. Non si perde nel dettaglio del dettaglio. È una lirica che va presa nella sua gestalt globale. È una poesia breve, ma solo apparentemente semplice.
"Ha un bel dire con tutti i suoi platani Firenze" è una personificazione. Firenze sembra parlare con i suoi platani. Luzi non cita la Firenze celebrata da cartolina, dei grandi capolavori artistici. Non rievoca neppure Firenze come grande città di marmo, come lui stesso ebbe modo di definirla. I platani appartengono al campo semantico della natura ma anche a quello associativo della familiarità (leggi anche della consuetudine).
Luzi è un grande poeta ermetico, che usa sapientemente le analogie e le metafore.
In questo senso è anche simbolista. Per lui fare poesia significa ricercare "corrispondenze", come nella celebre lirica di Baudelaire, e allora dopo aver trovato corrispondenze tra i propri stati d'animo e i paesaggi ogni città diventa un luogo dell'anima, un posto interiore, una "foresta di simboli", sempre per riprendere il poeta maledetto francese. Ma cosa significa "Non è uguale la musica, non può esserlo"? Significa che le corrispondenze cambiano continuamente, incessantemente perché cambia continuamente la città e cambiano sempre i moti dell'animo dell'autore. "Discetta" significa esamina. "Non trovando fondale a quel risucchio/ di mancamento o rimorso" significa che se la parola per Luzi deve volare verso il vertice della significazione (lo zenit) la memoria invece è un abisso, non ha fondo, eppure è un grande vortice, un grande gorgo. Ma di cosa? Di assenza (mancamento), perché mancano visi, volti, luoghi di un tempo, e di rimorso, ovvero di sensi di colpa per gli errori commessi. Si noti anche tutta l'umiltà e il basso profilo del grande poeta fiorentino che naturalmente non attribuisce niente di negativo a Firenze (non parla di nessun borgo selvaggio), ma paragona la propria vita a una spina infissa dentro la sua città. Ma cosa significa "quell'aria di congedo in lei da me, in me da lei"? Significa probabilmente che la Firenze di quei giorni non sarà più la stessa e forse non avrà più tutti i suoi bei platani, ma anche qui Luzi pensa alla sua dipartita. Oppure una terza opzione: Luzi chiude con "...o il niente di/ questo", con un versicolo ungarettiano di una sola parola, una clausola dal tono dimesso, che però significa che il poeta non è certo di niente, non sa davvero il senso della sua tenerezza, sa solo dell'affetto profondo che lo lega a quei luoghi senza saperne i motivi. Firenze per Luzi non è un posto come un altro. Leggendo questi versi sorgono in me alcuni interrogativi. Quanti anni bisogna vivere una città per conoscerla veramente? Quante strade bisogna conoscere? Quanti luoghi bisogna aver frequentato? Quante persone bisogna aver incontrato? Quante storie bisogna aver avuto? E se questo rapporto fosse una catena indissolubile? Cosa è che ci lega veramente a questo posto? Di cosa sentiremo la mancanza? Non ci sono risposte, ma solo impressioni e un vago sentore di essere abitudinari o recidivi. Approssimativamente posso solo dire che ogni paese ha il suo cielo e ogni cittadino ha un angolo di cielo, a cui spesso rimane fedele negli anni. Ma questa poesia mi dice altre cose, mi suggerisce altre cose. Quando descriviamo un paesaggio in realtà descriviamo il nostro punto di vista. Quando parliamo del mondo in realtà parliamo della nostra visione del mondo. L’umanità è una moltitudine incredibile di punti di vista, di visioni del mondo. Ognuno è una sintesi di interno ed esterno, di idee e cose, di soggettività e oggettività. Forse siamo fatti male, ma è così ad onor del vero. Questo è ciò che mi fa ricordare questa poesia. In definitiva Firenze sembra voler dire tante cose e sembra voler significare molte cose al grande poeta. Sempre Mario Luzi in una sua intervista dichiarava riguardo alla città: "La raffigurazione, naturalmente, è reale e simbolica nello stesso tempo e vuole denunciare che la città umana senza idea vitale si sfascia". Non a caso a conti fatti è difficile, anzi è quasi impossibile trovare il senso compiuto di una città, anche se è cara e familiare.
set 062022

Ho un modo di recensire particolare, nel senso che trasgredisco la regola d’oro del recensore, formulata sia da Giovanni Raboni in “La poesia che si fa” che da Massimo Onofri in “Recensire. Istruzioni per l’uso”.
Tengo a sottolineare che sono due libri molto importanti per iniziare a recensire, ma secondo questi due grandi letterati ad artista non di deve aggiungere artista (secondo un adagio degli antichi latini), ovvero un recensore deve essere sottotono, deve mantenere un profilo basso e nel testo deve vigere l’understatement.
Io ritengo piuttosto che una recensione debba spiegare tutto, essere esaustiva o quantomeno cercare di essere esauriente.
Forse così si rischia di strabordare. Nel primo caso invece si rischia di fare un compitino striminzito.
E poi a mio modesto avviso per capire cosa voleva dire un poeta bisogna un poco immedesimarsi nel poeta in questione ed essere di volta in volta un poco artisti anche noi miseri recensori. Ma è solo questione di opinioni. So benissimo che Onofri e Raboni sono delle autorità in materia e io sono un bastian contrario. Ma passiamo ad altro. Alcune volte mi arrivano dei documenti pdf da recensire via mail oppure dei libri a casa.
Sgombro il campo da ogni equivoco: non esiste assolutamente l’obbligo di recensire nessuno. Alcuni ritengono che tutto sia loro dovuto. Anche se mi arriva un ottimo libro non è mio dovere recensirlo: sia ben chiaro. Io non sono pagato a cottimo. È una bella pretesa! Alcuni sono anche molto sbrigativi e si scordano le belle maniere, ma questo fa parte della personalità egoriferita di alcuni autori.
Personalmente io non cerco lo scambio di favori. Non scrivo più poesie o presunte tali dal 2018. Quindi nessun do ut des! Non cerco recensioni incrociate. Tutto questo mi consente una maggiore obiettività e indipendenza, non scrivendo più poesie.
Alcuni potrebbero criticarmi per il fatto che scrivo recensioni in cui esprimo un giudizio positivo sul libro. Ma è solo una parte della verità. Diciamo piuttosto che io non voglio stroncare nessuno e quindi non pubblico mai stroncature.

Perché non stronco? Semplicemente perché onestamente non mi va. Inoltre ritengo che si debba avere una certa autorità per farla e io ne sono sprovvisto. Non solo ma esiste una regola non scritta secondo cui si stronca solo i big. So bene anche che ogni autore si sente padre della sua opera. Penso che una stroncatura sia più che un atto di lesa maestà (di cui mi importa poco) un vero colpo al cuore, una piccola ferita. Diciamocelo francamente: non voglio far rimanere male nessuno. Di conseguenza alcuni pensano che io sia facile di gusti o che tratti tutti i libri con bonaria indulgenza. Nella maggioranza dei casi io recensisco invece libri di qualità, ma questa è solo la parte emersa dell’iceberg: nessuno sa i libri e i documenti via mail che mi hanno inviato e che non ho recensito. Al momento mi sono anche imposto di recensire solo libri pubblicati e non autopubblicati, libri cartacei e non ebook (altrimenti non ce la farei a recensire tutto). Preferisco quindi non recensire che recensire negativamente. Non solo ma Giovanna Rosadini, direttrice di Atelier poesia, fa una scrematura di opere prima di inviarmi le cose da recensire.
È comunque vero che preferisco evidenziare i punti di forza di un’opera invece che i punti deboli. Ritengo in questo modo di spronare, di incoraggiare l’autore. Ma recensire è un diritto e non un dovere. Inoltre rivendico l’orgoglio di recensire. Tutti vogliono diventare scrittori o poeti, vogliono la fama, la gloria postuma. Il recensore invece è relegato ai margini della vita letteraria, eppure i libri vanno obbligatoriamente recensiti, altrimenti li leggerebbero in molti meno e non ci sarebbe alcun passaparola tra i lettori. Anzi forse è il caso di dire che al mondo d’oggi ci sono troppi poeti effettivi, aspiranti, sedicenti e davvero pochi recensori. Sempre a mio modesto avviso un recensore non deve essere obbligatoriamente un critico letterario e aver letto migliaia di libri come vorrebbe Valerio Magrelli. Un recensore deve solo avere un minimo di sensibilità, un minimo di comprensione del testo e sapere un minimo la lingua italiana. Questi sono i prerequisiti fondamentali. Aggiungo anche che se ogni lettore diventasse un recensore nel suo blog personale o sui profili social ne guadagnerebbe il lettore suddetto che eserciterebbe il suo senso critico e ne guadagnerebbe la letteratura che diventerebbe un grande oggetto di attenzione, un argomento di tendenza, di dibattito e non più un fenomeno marginale. Se ci fossero più lettori-recensori certo ci sarebbe qualcuno di essi che rientrerebbe nella categoria degli odiatori, ma la letteratura sarebbe più rizomatica, meno stagnante, insomma più viva. Infine va detto che anche se a nessun recensore spetta la gloria postuma a differenza dei poeti qualcosa possono guadagnare se lo vogliono. Qualche agenzia letteraria i recensori li può pagare; ci sono autori disposti a pagare recensori. Infine recensire libri può essere un primo passo per fare il saggista, il giornalista culturale o il web content editor (coloro che a pagamento riempiono di contenuti i siti web). Non solo ma c’è anche chi si inventa un’attività redditizia recensendo libri su Instagram, anche se ci riescono solo i giovani e non i letterati attempati. Nel peggiore dei casi arrivano gratis dei libri a casa, anche se le ore passate a leggere il libro e a recensire non vengono pagate.
set 012022
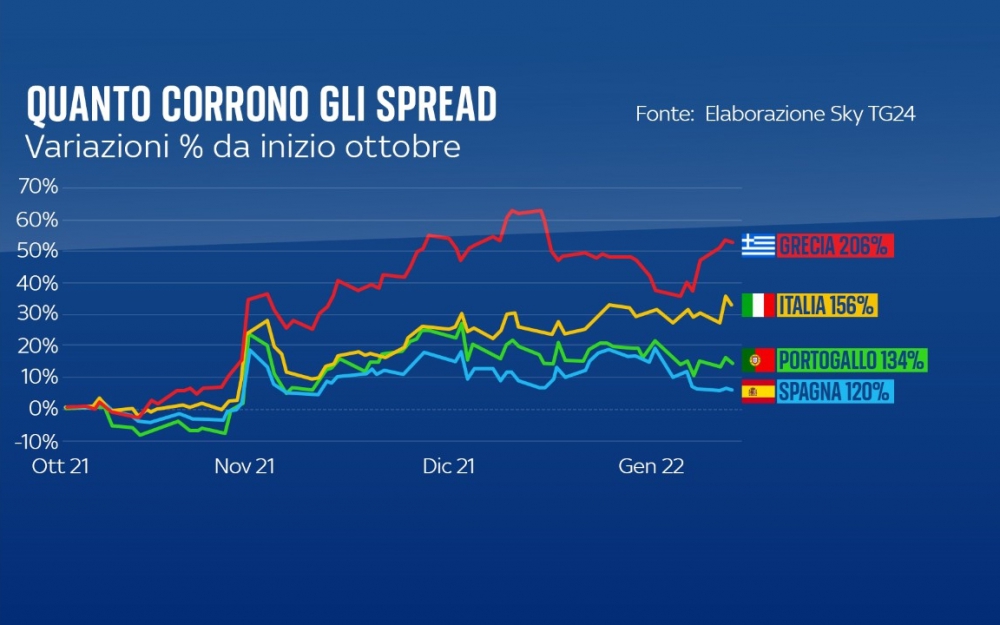
In questo articolo non tratterò di letteratura, ben sapendo che la letteratura può essere maestra di vita, ma è vero anche il contrario. Perciò ora parlerò della vita di ieri e quella di oggi.
Succede che talvolta mi volgo indietro e penso agli anni '90 quando ero ventenne. Cerco di individuare analogie e differenze con i tempi d'oggi. A volte mi sembra di essere stato catapultato nel 2022 direttamente dagli anni '90, però so bene che è solo un'impressione fugace, transitoria. Ritengo comunque che più di una svolta epocale, di una rottura improvvisa si possa parlare di continuazione di alcuni fenomeni agli albori, appena in atto negli anni '90. Allora erano di moda le discoteche. C'erano anche dei giovani che assumevano ecstasy e poi andavano fuori strada, ammazzandosi. Era l'inizio delle stragi del sabato sera. Oggi le discoteche sono in crisi, sono meno frequentate, ma la cultura dello sballo esiste tuttora nel mondo giovanile. Allora le prospettive erano più rosee per i giovani. Il lavoro si trovava, anche se la mia generazione X avrebbe dovuto fare i conti in seguito con la crisi economica del 2001 dopo l'11 settembre e con la crisi del 2008 dei mutui subprime americani. Ma oggi la situazione è molto peggiorata. C'è stata la pandemia, c'è la guerra in Ucraina. La vita è molto rincarata. C'è il problema delle bollette. Cosa fare? Mettere una tassa sugli extraprofitti? Fare ancora debito pubblico? Mettere un tetto al prezzo del gas? Investire in altre forme di energia? Nel frattempo migliaia e migliaia di posti di lavoro sono a rischio. Molte aziende e attività commerciali sono con l'acqua alla gola. La cosiddetta generazione Z è stata definita anche generazione 280 euro: chi non è disoccupato tra i giovani è spesso sottopagato o comunque sottoccupato. Tra generazioni covano rancori e incomprensioni. Per i più anziani i giovani non hanno voglia di lavorare e sono schizzinosi. Per i giovani gli anziani sono boomer, persone privilegiate che hanno sfruttato il boom economico e hanno votato politici, che hanno a loro volta creato un grande debito pubblico. Intanto le coscienze degli italiani vengono obnubilate e assopite con le armi di distrazioni di massa della televisione generalista e del gossip sempre più futile. Nel frattempo gli italiani si sono disaffezionati alla politica. Molto probabilmente alle prossime elezioni sceglieranno le false promesse irrealizzabili del centrodestra alla litigiosità e alla frammentazione del centrosinistra, che ha come maggior colpa la sua mancanza di capacità comunicativa. Ma forse è meglio non angustiarsi troppo. Probabilmente la politica nazionale non è più decisiva per le sorti del Paese. Probabilmente tutto si decide altrove (in ambito internazionale). Per quanto mi riguarda ho paura dell'aumento dello spread, di speculazioni economiche contro l'Italia. A mio modesto avviso non bisogna scegliere alle elezioni i migliori ma i meno peggio, cioè coloro che tutto sommato sembrano un poco più coscienziosi, responsabili, affidabili. Bisogna andare alle urne, procedendo per esclusione. E chi non è di sinistra si ricordi di votarla "turandosi il naso", come ebbe a dire a suo tempo Indro Montanelli. Mi fa paura che la potenziale futura premier, ovvero Giorgia Meloni, pubblichi online il filmato di uno stupro, non considerando la privacy della vittima, che poi tra l'altro è stata riconosciuta. Mi sembra, ma non so se sbaglio che tutto venga considerato lecito in nome della propaganda. Il problema del centrodestra non è tutto quello che promette, ma se malauguratamente quelle promesse le realizzerà, dimostrandosi a quel punto una coalizione sciagurata. Però gli italiani molto probabilmente voteranno di pancia. Il loro sarà un voto emotivo, dimenticandosi anche chi realmente ha fatto cadere il governo Draghi per personalismi e/o per andare alle elezioni anticipate, infischiandosene delle sorti del Paese. Gli italiani cercano di non pensarci, anzi distolgono completamente il pensiero e intanto hanno il culto dell'apparire. L'imperativo è quello di essere presentabili, in perfetta forma fisica, piacenti e appariscenti. È un obbligo (im)morale imposto dalla società di massa, dalla civiltà dell'immagine.

Tutti in palestra quindi. Già negli anni '90 c'era chi ne faceva un'ossessione e magari prendeva dei betabloccanti. Tutti dal dentista poi, a spendere soldi per i denti di porcellana, proprio come quella conduttrice di una trasmissione pomeridiana o come quell'opinionista di un reality show. Tutti dal chirurgo plastico, anche se poi ne risente l'espressività del viso e naturalmente a costo di apparire tutti uguali. Tutti o quasi, rifatti o ritoccati, con l'eterno dilemma della scelta tra botulino e lifting. Oggi per accettarsi bisogna essere accettati socialmente. L'io corporeo ha una parte preponderante. Se gli altri non ti apprezzano esteticamente non puoi essere felice. C'è bisogno dell'approvazione degli altri, c'è bisogno del consenso riguardo al tuo aspetto fisico. Questi sono i (falsi) problemi degli italiani. Le grane quotidiane, come il fatto che spesso i soldi finiscono alla terza settimana del mese, diventano più accettabili se si è piacenti esteticamente, se si è considerati dei begli omuncoli o delle belle donnine. C'è una grande pressione mediatica e sociale, che impone certi canoni estetici e la messa al bando di certi difetti fisici. Non è forse un campanello d'allarme oppure la cartina di tornasole il fatto che la Meloni abbia inserito tra le devianze l'obesità e l'anoressia, salvo poi fare un passo indietro (forse perché aveva paura di un danno d'immagine, di una crisi reputazionale più di altro?)? Già negli anni '90 si iniziava a parlare di anoressia e bulimia. C'era chi dava la colpa all'eccesso d'importanza dell'aspetto fisico in questa società. Dopo si sarebbe scoperto che le cause di questi disturbi alimentari erano multifattoriali, talvolta familiari, talvolta associati ai tratti di personalità dei soggetti. Ma il dibattito a riguardo è tuttora aperto. Aveva forse ragione il filosofo Emanuele Severino quando negli anni '90 sosteneva che era iniziata l'epoca dei Sileni "rovesciati", in cui tutti erano belli fuori e vuoti dentro? Già negli anni '90 era iniziata l'epoca del "vivere sano" e soprattutto del culto dell'immagine. Oggi l'aspetto fisico è fondamentale per trovarsi il o la partner. Più che l'anima gemella molti cercano un bel corpo. L'importante è l'involucro più di quello che ci sta dentro. I contenuti mi sembrano talvolta secondari. A ogni modo la prima scrematura la fanno in base all'estetica. Se non superi quello scoglio iniziale sei out. Le donne sono più emancipate ma anche molto più esigenti. Anni fa sognavano il principe azzurro, ma si accontentavano anche di un rospo gentile e premuroso, simpatico e alla mano. Oggi l'uomo lo pretendono palestrato, alto, bello, superdotato sessualmente, con una bella casa, con una bella macchina, con un bel lavoro, a costo di rimanere sole. Così gli uomini si imbottiscono di Viagra e Cialis, acquistano a rate macchine costose che poi non sanno come pagare, fanno mutui per acquistare belle case, vanno tutti i giorni in palestra, acquistano scarpe coi tacchi, raccontano bugie sul loro lavoro e i loro guadagni, etc etc. Anche gli uomini hanno aspettative sempre più alte. Gli uomini non sono da meno. Importante è apparire, anche magari bluffare. Tanto poi cosa importa dell'esame di realtà? La società occidentale tramite la moda e i mass media propone certi modelli estetici quotidianamente, ma ritengo che a tutto ciò si siano aggiunti trent'anni di berlusconismo, che hanno peggiorato l'andazzo generale. Lo so che è una caratteristica attribuita agli anziani dire "mala tempora currunt" ed essere lodatori del tempo passato. Lo so che ogni generazione crede ciecamente nei suoi miti, nelle sue mode, nelle sue icone. Certo a livello di diritti civili in questi anni sono stati fatti dei passi avanti. Prima c'era molta più omofobia e negli anni '90 non si poteva parlare di fluidità di genere; nessuno poteva mettere in dubbio l'identità di genere: lo dimostrano tutti i rifiuti editoriali al capolavoro "L'arte della gioia" di Goliarda Sapienza. Lo so che c'è il rischio di passare per persone retrograde, datate, antiquate (per quanto io non sia affatto moralista né bigotto) a ricordare con nostalgia quei tempi (forse enfatizzandoli e migliorandoli nella memoria), ma negli anni '90 comunque mi ricordo che c'erano allora amori che nascevano sugli scalini di una chiesa, complici una chitarra scordata e senza plettro, e alcuni conquistarono le ragazze solo perché conoscevano a memoria le canzoni dei cantautori. Negli anni '90 mi ricordo di amori nati dopo che taluni declamavano nell'alcova della loro stanza in affitto di studenti fuori sede con una luce soffusa le loro poesie acerbe o quelle di poeti già famosi. Negli anni '90 mi ricordo di amori nati in discoteca, facendo quattro salti in pista, che erano stati studiati allo specchio della propria camera per tutta la settimana. Era più facile allora ed è più difficile oggi oppure viceversa? Oggi se non sei piacente esteticamente sei out! Dipende dai punti di vista. Negli anni '90 conoscevo personalmente allora giovani che credevano nei contenuti, nella profondità d'animo, nella poesia. E oggi tra la gioventù si trovano isole (in)felici (dato che è tutto da dimostrare e da accertare che la poesia renda felici)? Sicuramente esistono; io spero e credo in quei giovani che amano la poesia, anche perché ognuno è libero di credere e sperare in coloro che lo rappresentano meglio e in coloro che pensa siano un futuro migliore, ammesso e non concesso che esista un futuro tra debito pubblico alle stelle, ingovernabilità del Paese, instabilità politica in Italia e poi nel mondo tra inquinamento e sovrappopolazione.
ago 262022

Gli italiani leggono poco. Le cause possono essere svariate. Alcuni dicono che siamo un Paese arretrato culturalmente. Alcuni sostengono sia colpa della grave crisi economica. Altri danno la colpa ad Internet. La giustificazione è che nessuno ha mai tempo libero per leggere. La verità è che gli italiani nel loro tempo libero fanno tutto tranne che leggere. I giovanissimi non leggono. Le donne leggono più degli uomini. Eppure le statistiche ci insegnano che sono troppi i laureati usciti dalle facoltà umanistiche e che solo il 30% dei laureati esce fuori da discipline scientifiche. Quindi ci dovrebbe essere uno zoccolo duro di lettori forti, determinato da un umanesimo diffuso, ma non è così. Le statistiche ci dicono anche che sono pochi i laureati in percentuale rispetto alla popolazione. Da questo si deduce che molti dottori, finiti gli studi, abbandonano completamente la lettura. È vero che con la pandemia le vendite sono aumentate, ma non siate ottimisti: nessun cambiamento di rotta; era solo perché eravamo in una situazione di emergenza e gli italiani non sapevano cosa fare. Tullio De Mauro a suo tempo aveva messo in guardia dall'analfabetismo di ritorno. Insomma sono davvero pochi i divoratori di libri: coloro che fanno shopping compulsivo molto probabilmente non sono affatto lettori accaniti. Sono rarissimi anche i cleptomani nelle librerie italiche. Non esistono affatto ladri di opere di poesia. Ma quali libri leggono gli italiani? Nella maggioranza dei casi leggono volumi di personaggi televisivi, cantanti, Youtuber, comici, cuochi, sportivi. È stato stimato che soltanto un quinto dei libri venduti è pubblicato da scrittori veri e propri. Il libro delle barzellette su Totti ha avuto un grande successo. Vengono venduti anche molti romanzi d'amore. I romanzieri autentici hanno problemi a vendere. Sono relativamente pochi i lettori, che cercano libri di qualità. Non voglio riportare tutte le cifre perché non sono il mio pane e perché questi dati vanno presi con il beneficio di inventario. Le case editrici e gli autori si vergognano a confessare le scarse vendite di libri "impegnati". È difficile trovare testimonianze a riguardo. Questa situazione infelice dovrebbe indurre autori e addetti ai lavori a fare autocritica, ma i più non fanno altro che chiudersi a riccio e a mantenere un atteggiamento snob. Sono pochi coloro che possono permettersi o che si potevano permettere di vivere di scrittura: Camilleri (più di 10 milioni di copie vendute) Susanna Tamaro (con il suo bestseller ha venduto circa 15 milioni di copie), Federico Moccia, Elena Ferrante, Niccolò Ammaniti, Isabella Santacroce, Saviano (con Gomorra ha venduto più di 2 milioni di copie), Sandro Veronesi, Andrea De Carlo, Erri De Luca, Dacia Maraini, Sveva Casati Modignani, Alessandro Baricco. Enrico Brizzi può vivere di sola scrittura grazie soprattutto alle ristampe del suo primo romanzo. Forse dimentico qualche nome? Perdonatemi. Molti altri arrotondano con il giornalismo, l'insegnamento, i corsi di scrittura, le consulenze editoriali, le traduzioni, facendo radio oppure facendo gli autori televisivi, gli editor, i redattori, gli sceneggiatori. In Italia gli autori fanno un doppio lavoro o addirittura sono costretti a considerare la scrittura un dopolavoro. D'altronde anche in passato Kafka lavorava in una assicurazione, Svevo lavorava nell'azienda del suocero, Gadda faceva l'ingegnere alla Rai, Bianciardi era un traduttore, S.King faceva il bidello, Salinger era un intrattenitore su una nave da crociera, Joyce faceva il musicista. Ai giorni nostri Vincenzo Pardini fa la guardia giurata, Carofiglio faceva il magistrato e Marco Buticchi gestiva uno stabilimento balneare. Andrea Vitali ha lasciato la professione di medico soltanto nel 2014 per dedicarsi esclusivamente alla scrittura. Sono lontani i tempi di Calvino e Pavese. Non c'e più neanche una azienda come la Olivetti in cui trovarono occupazione molti talenti. Questa condizione così precaria degli scrittori al mondo di oggi ha un unico grande vantaggio: non essendo considerati vip nella maggioranza dei casi non sono oggetto di gossip e neanche di critica biografica o psicoanalitica. Ma ritorniamo agli svantaggi. Si consideri che molto spesso le presentazioni dei volumi non vengono pagate. Addirittura spesso i costi delle presentazionidei libri e dei premi ricevuti (viaggio, pasti, pernottamento) ricadono tutti sugli scrittori. Le royalties sono scarse. Sono mosche bianche coloro che non pubblicano a proprie spese. Sono una rarità coloro che prendono un anticipo. La tiratura per la maggioranza dei libri è scarsa. La distribuzione lascia a desiderare se uno non pubblica con una grande casa editrice. Per un esordiente le difficoltà sono insormontabili. Per uno scrittore italiano vendere 5000 copie è già un successo. Ma con 5000 copie in un anno non si campa di certo. Per il momento abbiamo parlato di romanzieri ma per altri generi va molto peggio. L'eBook può essere una opportunità. Prendiamo ad esempio un genere come la poesia. Sono pochissimi coloro che non pubblicano a proprie spese: solo i poeti che pubblicano con Mondadori, Crocetti, Einaudi, Garzanti. I ricavi sono davvero scarsi.

Ma c'è sempre l'opportunità dell'autopubblicazione di eBook. L'unico inconveniente è l'impegno profuso, ma la scrittura va considerata sempre una passione. Pubblicare un eBook quindi può essere una fonte di reddito e un modo per farsi conoscere da una ristretta cerchia di persone (almeno per ora). Alcuni scrittori hanno avuto anche un grande successo, iniziando con l'eBook, come ad esempio Anna Premoli (premio Bancarella) e Roberto Emanuelli. Basta ricordarsi che la signora James (pseudonimo) ha venduto circa dieci milioni di copie tramite Internet, prima di approdare all'editoria tradizionale. Ora la trilogia delle Cinquanta sfumature è famosa in tutto il mondo. Che sia questo il futuro? L'editoria tradizionale dovrebbe stare in guardia e dovrebbe stare soprattutto al passo con i tempi. Dovrebbe fare molto più scouting per scrittori emergenti. Per il resto che dire? Ai nativi digitali l'ardua sentenza.
ago 162022
"È chiaro che il pensiero dà fastidio
anche se chi pensa è muto come un pesce,
anzi un pesce
e come pesce è difficile da bloccare
perché lo protegge il mare;
com'è profondo il mare.
Certo, chi comanda
non è disposto a fare distinzioni poetiche.
Il pensiero come l'oceano
non lo puoi bloccare,
non lo puoi recintare.
Così stanno bruciando il mare.
Così stanno uccidendo il mare.
Così stanno umiliando il mare.
Così stanno piegando il mare"
("Com'è profondo il mare" di Lucio Dalla)
"Se negli anni Sessanta l’obiettivo era andare sulla Luna – afferma Steve A. Garan, scienziato leader nel campo della ricerca sull’invecchiamento – oggi la sfida è riuscire a vivere il più a lungo possibile. Ci riusciremo, perché cinque milioni di persone qui nella Silicon Valley, in un raggio di dieci miglia, stanno lavorando per questo".
Alla Silicon Valley ci vogliono immortali (noi tutti o forse più probabilmente soltanto un'esigua minoranza che avrà i soldi necessari?). Ma ci vogliono anche tranquilli, sereni, pacifici e pacificati. Gli psicofarmaci non bastano più perché nessun psicofarmaco può ridurre o eliminare il desiderio o la libertà/il coraggio di pensare. Ci sono però le droghe sintetiche, le droghe pesanti che aiutano il potere a ridurre l'elaborazione del pensiero, ma non a ucciderlo. È sempre più diffusa la cultura dello sballo, dell'autodistruzione. Che dire poi del fatto accertato che finite le scuole sono pochissimi i lettori forti, che leggono più di dieci libri in un anno? C'è tempo per tante cose, ma per leggere mai. Perfino la giovane filosofa Ilaria Gaspari ha combattuto per anni contro l'idea che la filosofia fosse inutile, fosse "aria fritta". Lo ha ammesso lei stessa pubblicamente, candidamente. Il group thinking può arrivare a influenzare anche le persone più autonome. Si vedano a proposito i celebri esperimenti dello psicologo Salomon Asch. Musk vuole impiantare i microchip nel cervello. La scusa ufficiale è quella di combattere le malattie neurologiche, il pretesto ufficioso è quello di avere una migliore interfaccia tra fisico e digitale, tra reale e virtuale. Potremmo ordinare una pizza col solo pensiero. Io mi chiedo se ci sia davvero bisogno di questa comodità apparente che finirebbe in concreto per essere invasiva, anzi totalmente pervasiva perché finiranno per essere controllati tutti i nostri pensieri. Il capitalismo di sorveglianza attuale è solo una fase di transizione. Per ora siamo tutti schedati, videosorvegliati, identificati e controllati. Un tempo la psichiatria era una modalità di controllo psicosociale. La repressione finì in Italia nel 1978 con la legge Basaglia grazie a un movimento come Psichiatria democratica. Ci furono a ogni modo illustri personalità che levarono la loro voce contro la chiusura dei manicomi, come lo scrittore Mario Tobino. Basta leggere "Gli ultimi giorni di Magliano" per capire il dibattito acceso e le polemiche di quell'epoca.

Oggi le nostre camicie di forza sono informatiche, virtuali. Per ora stanno controllando solo il nostro comportamento. Non hanno ancora inibito totalmente la nostra libertà e capacità di pensiero. Per ora le macchine stanno sostituendo gli uomini sul lavoro e sempre più persone lavorano da casa. Gli algoritmi governano la nostra vita online: algoritmi di cui non conosciamo niente o ben poco perché le multinazionali ci tengono all'oscuro della loro logica. Oggi addirittura vogliono scoprire tutti gli "algoritmi" del cervello umano per poi riprodurli con le reti neurali. Siamo sempre più asociali e questo al potere fa molto comodo: è esattamente così che ci vogliono. Se andiamo in una metropoli i grandi assembramenti di persone non fanno socializzare nessuno; il fatto è che siamo sempre più disgregati psichicamente, interiormente. Però siamo ancora agli albori. Forse se prendessimo realmente provvedimenti saremmo ancora in tempo a fermare tutto. Comunque bisognerebbe essere in tanti ed essere organizzati: quindi realisticamente parlando ciò non è assolutamente fattibile. Qualcuno dovrebbe avere una visione, vivere per essa e riuscire a coinvolgere molte altre persone: è possibile in teoria, in pratica è quasi irrealizzabile. Ma forse il processo è irreversibile. E poi chi ha la forza di ribellarsi? Chi è che si prende la responsabilità di opporsi? Chi è che non ha paura di ribellarsi? E poi ribellarsi sarebbe illegale e porterebbe a degli spargimenti di sangue. Prima di tutto però gradualmente ci hanno tolto la capacita di sognare, di essere intraprendenti. Nessuno vuole perdere la propria comfort zone. Anche chi ha poco non vuole perdere quel poco, che rispetto ai cittadini del secondo e del terzo mondo è molto. Quindi siamo punto e a capo. Lasciamo perciò che facciano ogni tipo di esperimento psicosociale sulla nostra pelle e nella nostra mente. I potenti vivono con discrezione e al contempo sfrontatezza. Sanno che nessuno li può fermare concretamente. Prestiamo perciò il fianco al potere. In fondo qualche anno fa Fukuyama teorizzava la fine della storia e questo non è avvenuto. Quindi non disperiamo. Ricordiamoci che lo scrittore e ingegnere Roberto Vacca pubblicò "Il medioevo prossimo venturo" e fu un bestseller del 1971. Vacca era catastrofico, apocalittico. Invece questo grande uomo di scienza non ci indovinò. Era stato fortunatamente per noi troppo pessimista. La regressione umana tanto temuta da lui non si è verificata. Non sempre gli studi dei futurologi, le distopie e le ucronie sono attendibili.
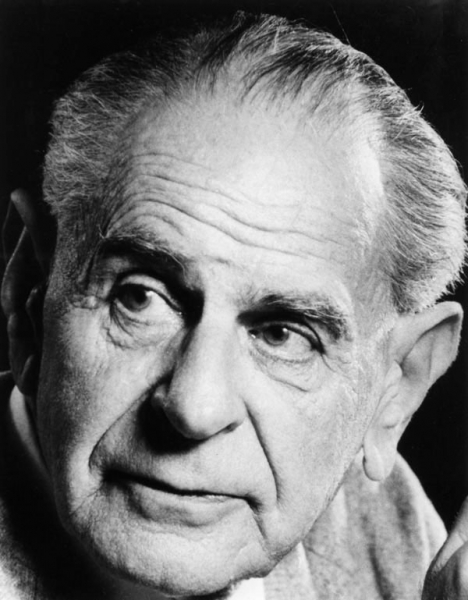
"Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno e faranno, oggi, domani e dopodomani. E quello che noi facciamo e faremo dipende a sua volta dal nostro pensiero e dai nostri desideri, dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da come vediamo il mondo e da come valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte."
(Karl Popper)
Gli scrittori di fantascienza hanno aguzzino le loro menti per proiettarsi nel futuro. Gli epistemologi hanno indagato la natura della conoscenza umana e i limiti di ogni metodologia scientifica. Alcuni scienziati si sono avventurati nell'ambito della teologia come de Chardin e Polkinghorne. A conti fatti però l'innovazione tecnologica più determinante nelle nostre vite per ora è la rivoluzione digitale; comunque siamo solo agli inizi. Ma è breve il passo tra telecomandare ed essere telecomandati. Saremo liberi di vivere nel metaverso, un universo parallelo virtuale. Ma saremo veramente liberi? Siamo ancora sicuri che il transumano, il postumano abbiano veramente qualcosa di umano? Non è che la tecnologia ci porterà all'antiumano? Per ora abbiamo solo un antiumanesimo diffuso. Sappiamo che è difficile rintracciare, definire, identificare l'essenza umana, ma mi chiedo io quale filosofia dell'uomo c'è dietro a tutto questo progetto? Più siamo pacifici, rincoglioniti, teledipendenti, internettiani più quelli della Silicon Valley sono felici, aumentano a dismisura ricchezza, potere, controllo. Vogliono diventare padroni dell'umanità intera. Quante persone sono dipendenti da televisione e Internet? Non c'è una stima precisa e gli esperti se ne guardano bene. Già oggi è molto difficile, impegnativo, quasi improponibile essere esseri pensanti. Ci sono troppe limitazioni e troppe inibizioni. Molte cose attaccano il libero pensiero. E se domani il pensiero non fosse più libero che razza di pensiero sarebbe? Sarebbe un pensiero eterodiretto. Ogni pensiero sarebbe vivisezionato e censurato. Cantava Gaber in tempi non sospetti: e pensare che c'era il pensiero! Hanno iniziato col controllare la nostra libertà d'azione, hanno proseguito impedendo di fatto la nostra libertà di cambiare il sistema, in futuro vogliono dominare il pensiero umano. Ma in futuro sarà un élite umana a controllare il pensiero della massa oppure tutto sarà delegato alle macchine? Ancora non lo sappiamo. Non c'è un angolo del mondo che non abbiano invaso, ma prima di tutto loro occupano la nostra mente, progettano con le loro tecnologia nuovi modi di essere e ci rendono sempre più dipendenti dalle loro invenzioni. In futuro solo una casta di scienziati e tecnologi dominerà il resto dell'umanità. Resta una speranza esile, incerta: sperare che il cervello umano non sia totalmente conoscibile, che la mente umana riservi sorprese e riesca a preservare zone inesplorate e auspichiamo inaccessibili agli scienziati. Forse come sostiene il filosofo della scienza Matthias Eckoldt non si può capire totalmente il cervello con il cervello. Trovare un equilibrio per noi poveri anonimi cittadini è difficile. In definitiva i condizionamenti dei mass media già oggi finiscono per essere un'efficace tecnica di controllo mentale, addirittura di manipolazione mentale, anche se apparentemente blanda ma persistente, martellante, ripetitiva e sempre presente. Una volta il poeta Lorenzo Mullon mi ha chiesto: "Davide, a quale Matrix giochiamo?".

Siamo veramente sicuri che questa sia la realtà effettiva? Disintossicarsi totalmente significa rinunciare totalmente al mondo, autoescludersi, essere fuori dal mondo. Per essere liberi per ora bisogna perciò essere anche connessi, ma bisogna utilizzare con prudenza e saggezza le nuove forme di comunicazione, le nuove tecnologie. Bisogna essere dentro e fuori allo stesso tempo per salvare l'indipendenza, il pensiero e questo atteggiamento ondivago fa male alla nostra salute mentale. Così viene da chiedersi: dobbiamo sacrificare il nostro benessere interiore per la libertà o viceversa? È quasi impossibile avere entrambe le cose. Inoltre se gli uomini diverranno immortali dovranno colonizzare altri pianeti. La sola Terra non potrà contenere tutti, a meno che non si controllino le nascite. E se saremo tutti telecomandati allora chi potrà fare ulteriormente progredire l'umanità? Solo i figli e i nipoti degli attuali esperti di tecnologia potranno migliorare l'umanità? Sarà quindi una nuova casta? Gli altri saranno tutti assoggettati e schiavizzati? Gibson era stato troppo ottimista col suo Neuromante. In futuro anche la giustizia e la medicina saranno predittive. Nessuno potrà delinquere probabilmente, come nel film Minority report.
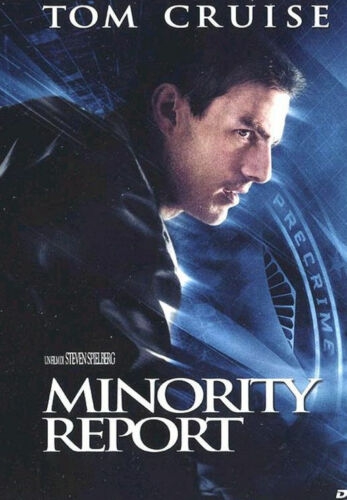
Forse arriveremo a quei livelli. Forse gli uomini saranno esseri totalmente prevedibili per il potere. Raggiunto l'obiettivo dell'immortalità la ricerca scientifica riguarderà solo quisquilie, solo minuscole migliorie. Il futuro è il presente, si usa dire. Non sappiamo ciò che è futuristico, ancora più precisamente futuribile, Tutti i grandi progetti a lungo termine però saranno inutili se non avverrà nel futuro immediato la decarbonizzazione energetica e industriale, se non inquineremo molto meno, se non salvaguarderemo il pianeta. Mi chiedo io se qualche potente non abbia mai dei dubbi a riguardo. Lo psichiatra Paolo Crepet ha sostenuto che una parte importante dell'intelligenza umana è costituita dalla capacità di coltivare dei dubbi. La cosa che mi stupisce di questi potenti è che non hanno dubbi o almeno non li manifestano pubblicamente. Speriamo che il futuro non sia già deciso dai signori di Cupertino in California. Di sicuro più andiamo avanti e più ci accorgiamo che non esistono le cosiddette frontiere della scienza, che la scienza è senza frontiere e che è un illuso chi cerca di porre a essa dei limiti etici.
ago 142022
(Nella foto Freak Antoni)
"Sono contro" degli Skiantos:
"Non ci credo,
alla carriera
alla pensione, soldi come soluzione
alla prigione
Non ci credo,
al panettone
ai finti artisti, parrocchiani, percussionisti napoletani
ai registi americani
E non mi fido,
dei paninari,
dei ragazzotti e Ramazzotti del decoro
che han le marlboro
Sinceralisti, moralisti, anticristi
albanisti, qualunquisti
Sono contro, io sono contro
si sono contro e fino in fondo
e sono pronto a stare contro
sono contro
Io sono contro
Non ci credo,
al nucleare
alla potenza militare, al radicale da salotto al buonsenso del bigotto
ai nuovi fan, ai Duran Duran
Non mi fido
Non mi fido
Non mi fido dei razzisti
dei cantautori ecologisti
della finta tolleranza dei barbuti
occhialuti intellettuali prevenuti tossicomani venduti
Sono contro, io sono contro
e fino in fondo
e sono pronto a stare contro
io sono contro
Si, sono contro
io sono contro
si sono contro
e sono pronto
a stare contro
e fino in fondo
Sono contro
io sono contro
e fino in fondo
io sono contro, si sono contro
e fino in fondo
Io sono contro
e sono pronto a stare contro fino in fondo
Io sono contro"

Achille Bonito Oliva (nella foto) ha scritto su Robinson: "Oggi il sistema riesce a inglobare qualsiasi tentativo di rottura e di novità, sia che si tratti di gesti diretti come la politica che di gesti indiretti come la cultura".
Achille Bonito Oliva sostiene che il sistema attuale inglobi tutto, anche le maggiori forme di dissenso e di contrasto al sistema stesso. Non c'è più niente che faccia scandalo. Non c'è più niente che cambi davvero qualcosa. Chiunque si metta contro il potere è innocuo e/o la paga cara con gli interessi. Se tutto va bene la sua iniziativa viene considerata una ragazzata o un volo pindarico e l'ideatore un fanciullo, un mattacchione o un matto. Un tempo uno era un poeta maledetto, era bohémien, era uno scapigliato. Bastava allora andare a vivere con una prostituta, sposarla oppure vivere una relazione omosessuale per fare scandalo, per far parlare i benpensanti. Oggi niente fa scandalo. Oggi per esempio qualsiasi rapporto sessuale tra maggiorenni, consenzienti, capaci di intendere e di volere è stato fortunatamente considerato normale. Certo già ai tempi di Rimbaud la buona borghesia sosteneva che gli artisti erano tipi strani e tollerava queste trasgressioni, bollandole come stravaganze, come eccentricità. Insomma gli artisti erano tipi matti, bislacchi. Li si tollerava, ma a quei tempi facevano la distinzione tra borghesi e artisti. I veri borghesi non potevano trasgredire e gli artisti avevano libertà, ma venivano etichettati, non venivano più considerati rispettabili e potevano morire poveri. Poi ci furono gli hippies, i sessantottini. Fare l'amore e non la guerra era uno slogan rivoluzionario. Adesso niente e nessuno può essere così innovativo. Ogni cosa, ogni persona, ogni idea, ogni movimento ha perso qualsiasi carica eversiva. Niente sorprende né entusiasma più a questo mondo. Flaiano aveva già ironizzato su questo, aveva già previsto tutto, scrivendo "Un marziano a Roma", dove il marziano appena sbarcato è un fenomeno da baraccone e tutti lo vogliono conoscere, ma dopo poco tempo nessuno più lo considera. Tutto viene fagocitato, metabolizzato in fretta. Anche tutto ciò che è contro è apparentemente contro, diventa una moda, diventa "in". Chi è davvero al di fuori dalla logica del dominio, del sistema finisce per essere incomprensibile o finisce per diventare invisibile. Non fidatevi di quelli che rivendicano in tutti i modi e in tutte le salse la loro diversità, la loro unicità e in fin dei conti il loro essere contro: in realtà sono sempre a favore di qualcuno, molto spesso a favore del potere. Anche se vuoi essere alternativo non puoi essere solo, devi essere con qualcuno o per qualcosa, devi mettere la testa a partito devi accettare dei compromessi: altrimenti vieni tacciato di finto ribellismo vuoto, astratto, improduttivo, inconcludente. La prima difficoltà insormontabile è che il potere corrompe tutto e tutti. Ci aveva già avvertito Pareto, un pensatore conservatore, che la controélite diventava élite, avveniva una cooptazione dei rivoluzionari più validi da parte del potere. Detto in parole povere a volte quando qualche allievo capace ma indisciplinato disturba troppo le lezioni lo si fa diventare capoclasse o rappresentante di classe, in modo da responsabilizzarlo e renderlo tranquillo, pacifico. Così avviene anche nelle logiche del potere. Ma il problema principale è che il potere corrompe prima di tutto nell'animo e nella mente perché deforma, inibisce la crescita interiore, la creatività, l'autonomia di pensiero, tarpa le ali sul nascere. Inibire la crescita come individui significa che il potere della società attuale ci lascia solo la libertà negativa, ovvero la scelta di vivere secondo gusti e preferenze, ma non ci consente la libertà positiva, ovvero di scegliere in modo razionale e con la possibilità di dire no al mainstream, al conformismo di massa (riprendendo i due concetti di libertà di Berlin). I veri falliti, i veri puri sono soli, sono costretti alla solitudine dal potere. Al limite possono creare una piccola comitiva di disperati, ma la comunità dei perdenti non esiste. I barboni si litigano la notte sotto stazione per un pezzo di cartone da adibire a giaciglio. La rivolta dei barboni è destinata a essere e rimanere solo un bellissimo racconto di fantasia di Bukowski. Non esiste alcun collante, alcun legame. Ognuno è chiuso nella sua storia, perso nei suoi problemi. Chi non è omologato è solo, chi agisce e pensa in modo difforme dalla massa è solo. Tutto ciò è dovuto anche alla solitudine dell'uomo contemporaneo. Si parla tanto di individualismo sfrenato, ma a conti fatti è in crisi la soggettività. Esiste la libertà di associarsi spontaneamente almeno a livello teorico, ma poi in definitiva non ci aggreghiamo più, non fraternizziamo più, non facciamo più comunità perché esiste solo una massa anonima con la conseguente legge del branco. Ma per essere contro veramente bisognerebbe anche essere contro una parte di noi stessi: quella che deriva, che è più legata alla logica del sistema e da qui nascerebbe una contraddizione insanabile, una grande lotta contro sé stessi. Noi abbiamo interiorizzato il sistema, il potere. Noi facciamo parte del sistema e il sistema è dentro noi, nella nostra mente, nelle nostre viscere. Qualche reazionario ci ricorda il celebre detto napoletano che "Nun sputà ‘ncielo ca ‘nfaccia te torna”, altri possono invitarci a non sputare nel piatto in cui mangiamo. Tutte le critiche sono ammesse teoricamente, nessuna critica è legittima. Essere contro nel migliore dei casi significa essere contro la propria famiglia spesso, contro il partner o la partner, contro le proprie amicizie. Ricordiamoci della scelta drastica che fu chiamato a fare San Francesco d'Assisi. Essere contro oggi significherebbe gettare la televisione, non leggere giornali, essere consumatori critici, essere attivisti. Insomma sono richiesti troppi sacrifici. E andare veramente contro potrebbe significare in forma estrema anche pagare con la stessa vita perché certi argomenti non si possono affrontare e certe verità non si possono dire né scrivere.

Allo stesso tempo non esiste più soltanto l'ineguaglianza dovuta alla distinzione marxiana tra cittadino e borghese, ma come ha sottolineato il professore Salvatore Veca a questa si è aggiunta la problematica della cittadinanza come frammentazione delle proprie identità socioeconomiche, sessuali, ideologiche, etniche, culturali, etc etc. Siamo troppe cose per accettarle, comprenderle pienamente in noi e gli altri hanno anch'essi troppe identità, troppe sfaccettature, troppe sfumature per riconoscerci pienamente negli altri, per rispecchiarci, per identificarci. Finiamo così per non fare neanche un pezzo di strada con gli altri. Al potere sempre più invasivo non si oppone più alcun contropotere. E poi il contropotere in questo mondo in cui siamo tutti sorvegliati, controllati, schedati non può essere più clandestino, viene subito istituzionalizzato, irregimentato, incanalato nei "giusti binari". Il contropotere deve essere presentabile, deve rientrare nell'ottica del sistema, nell'ordine del discorso. Nessuno può sgarrare. Niente e nessuno può deragliare. A ogni mossa originale e scaltra del contropotere si verifica puntualmente tutta una serie di contromosse opportune e neutralizzanti del potere, che rendono ogni tentativo goffo, inopportuno, velleitario, utopico, inutile. Inoltre per essere contropotere efficace ci vogliono soldi e chi ha davvero soldi difficilmente diventa contropotere o lo finanzia perché ha molto da perdere. Un rivoluzionario come Giangiacomo Feltrinelli oggi non esisterebbe più. Non solo ma viene da chiedersi come prendere alla sprovvista questo potere così pervasivo e onnipresente? Esistono dei cavalli di Troia per scardinare il potere? Infine questo potere, almeno in Occidente, non ha più forme dittatoriali e cruente, perciò moltissimi cittadini sottovalutano le dinamiche del dominio, così come le ingiustizie. Questo potere apparentemente democratico sa nascondere le proprie schifezze agli occhi dei cittadini. All'epoca di Feltrinelli c'era il pericolo imminente di un colpo di Stato, di una grande deriva autoritaria. E oggi? Non esistono così grandi paure o almeno non vengono avvertite dai cittadini italiani. Infine i cittadini hanno sempre paura di finire dalla padella nella brace, pensano che ogni cambiamento peggiori le cose.

E allora cosa ci resta? Forse la poesia? Forse l'arte? Scriveva Baudelaire che ogni poesia diceva un mondo. A patto che il mondo detto dalle vostre poesie non sia livellato, appiattito, omologato, già codificato troppe volte. E dire il vostro mondo con delle poesie a cosa può servire? A niente, non cambia niente, come scriveva Fortini. Però è terapeutico per voi e forse, anche se meno comunemente, per qualcuno che legge.
ago 132022
Maria Turtura (1930-1972) fu un medico bolognese, sorella della sindacalista Donatella, prima donna nel 1980 a far parte della segreteria generale della Cgil. La poetessa si suicidò dopo essere stata lasciata dal marito. Pubblicò "Qualcosa deve venire" (Rebellato, 1966) e "I cancelli della mattina" (Argalia, 1970). Unico critico letterario ad averla considerata è stato il grande Franco Fortini in "Poeti del Novecento", che ha definito la sua poesia "significativa" e di lei ha scritto che era una voce "severa e profonda". È stata una mia cugina di secondo grado, ma è morta l'anno che sono nato. Ecco alcune sue poesie:
Caro dottore che mi curi i nervi
voglio dirti in questi giorni com'è andata
affinché tu ti possa regolare
per quello che mi serve in questi giorni:
ho dei sintomi al cuore
nella parte che nessuno vede:
sapessi che disastro, dottore!
Il mattino lavoro
il pomeriggio lavoro
e di sera ho la netta sensazione
di essere un guscio vuoto in un cartoccio.
Ho altri mali che non dico
perché la lista è molto piena
e non posso far tardi soprattutto
ho quel mal di cuore
nella parte che nessuno vede:
ti consiglio di ascoltarmi, dottore.
Questi occhi che hai
non dimenticati
con dentro un'ombra
di mare del Nord tempestoso
che cosa guardano stasera
nel tuo freddo paese, amico,
mentre io mi ricordo
di una luce sul lago e di una
esile speranza, così esile
come solo può essere
un amore al principio.
Alberi di neve che non vedi
respiro corto della terra e voci
da luoghi ignorati
mentre suonano passi sul tuo capo
e la notte si prepara anche per gli altri.
Io non trovo più Dio, bambino cieco,
nel celeste sospeso dei tuoi occhi
nelle cose che indovini con parole ardite:
"Questo luogo è chiuso da mura".
Io so che fuori non sono centauri
né terre di lunga corsa.
Altre mura
chiudono altri luoghi.
Ogni recluso ha un orologio
che batte sbagliato i quarti.
Questo è tutto, e qualcosa
deve venire
a distruggere i muri
e all'ora giusta confondere i luoghi,
a cancellare gli ordini di Dio
perché valga la pena di vedere.
(Di lei che ama un mio amico sposato
e ha una malattia difficile da guarire,
di lei in ogni caso
padrona di sé stessa):
cara amica, io ti ho visto
su un ponte di primavera
tu eri là guardando in avanti
con uno sguardo che pareva azzurro,
dicendo parole di quieta meraviglia
e muovendo le tue esili mani.
La sua bontà capovolta
il rifiuto delle cose assolute
per un mondo di treni
e di letti da rifare,
il suo vestito, ai piedi
di uno da non confondere con altri.
Sempre lei, che di mattina
si prepara con cura
a un altro giorno di silenzio.
Si oscura l'aria sul tuo prato, Anna,
e con lenti giri
cala il falco.
Una notte di pioggia è in cammino
per accordare il tuo respiro al calmo
frusciare dell'acqua.
Stasera un cielo di inchiostro veleggiava sulle case
e la città muta guardava dalle finestre di maggio.
Un caldo vento mi spingeva innanzi
traendo il suono sospeso di un telaio.
Io venni alla tua casa
per un discorso che mi urgeva
nato da quelle immagini.
Tu sorridevi alla porta.
Alle undici Gesù è risorto.
Sulla Certosa il sole era alto.
Poiché non ho pregato: - Prendi per mano mio padre
e portalo con te a fare un giro nel cielo -
il babbo è rimasto dietro la sua pietra
e Gesù se n'è andato per conto suo.
Prima che scomparisse gli ho gridato:
- Fai morire quelli che uccidono i Viet! -
La luce è calata di una luce
e ora pare sera
ma l'uomo dai capelli bianchi
alto sullo sfondo dei vetri
deve avere in sua mano
il segreto finire del giorno.
L'ora di notte mi porta
alla piazza delle Sette Chiese
dai silenziosi cipressi.
Un inverno di piccoli passi
si irraggia verso il punto che tardi
chiamai la casa, luogo che nulla
dice agli altri, breve
inverno stellare, dove l'anima
tende a riavvolgersi.
Per aver visto il suo nome
su tre cose che gli altri
dicono belle, io vorrei
bere pazzamente e battermi
con la mia sfortuna fino a perdere,
fino a far sangue,
tanto mi sottrasse la donna
che si mise nella sua ombra
ed era in niente
migliore di me.
Si sono accese insieme nell'acqua
due luci; il giardino ha rumori;
con veste bianca e chino il capo
due donne dall'infermeria
mentre geme un autunno
di muri e di alberi
inseguiti dal vento.
Se avessi avuto un cappotto
con un colletto di pelliccia
forse non mi avresti lasciato.
Se un fischio arguto
avesse accompagnato i miei discorsi
ti saresti così confuso
da ritenermi importante.
Invece non sapevo fischiare
e avendo mal di gola
parlavo piano, per via di quel colletto
di pelliccia che non possedevo.
Quando il bambino
avrà finito di battere sul suo tamburo
comincerà la danza
delle zanzare,
suonerà qualcuno alla porta
o mi sentirò così triste
di qualcosa che ora non conosco.
Nel silenzio della campagna
a un tratto
chiamava una voce.
Veniva da una siepe oscura
presso gli alberi di confine,
mi gridava di ritornare.
Io cammino così
sotto le nuvole bianche
per raggiungere un sogno
di mezzogiorno.
Non disturbate questa
bellezza degli amanti giovani
che guardano solo dentro i loro occhi
e vivono come i rami degli alberi
strettamente confusi
alteri e senza presagi
della terra che tiene le loro radici.
Come le lettere bianche
sulla tenda azzurra del macellaio
come quest'aria di paese
così confidenziale e nuova
i miei pensieri.
Noi ci amammo poveramente.
Solo una luce di fanali
una tiepida pioggia
nella città di notte, e poco altro
ci diedero per amarci. Ma noi fummo
per il distacco e il ricordo
per la gioia di ritrovarci
sempre grati a noi stessi
di non esserci persi
nelle strade e nei porti
che mai vedemmo.
ago 042022
Nietzsche e il relativismo dei fatti:
E’ facile fraintendere la dottrina di Nietzsche perché la sua filosofia non è sistematica; è una filosofia delle contraddizioni e delle illuminazioni grazie all’utilizzo dell’aforisma.
Lukacs ha sempre considerato Nietzsche un distruttore della ragione, ma forse il filosofo tedesco dovrebbe essere considerato soprattutto un potenziale distruttore della metafisica platonico-cristiana. Per il filosofo tedesco nel cristianesimo è insito il nichilismo passivo; il cristianesimo è mortificazione del corpo, religione e morale dei vinti e dei deboli, risentimento dello schiavo nei confronti del signore, proiezione verso un altrove che riscatta la miserie del mondo terreno. Questo naturalmente è il suo punto di vista.
Nietzsche sceglie l’eterno ritorno per non cadere in un regresso all’infinito. Altrimenti dietro un velo ci sarebbe sempre un altro velo, dietro un fondo un altro fondo, dietro una maschera un’altra maschera.
Per il filosofo tedesco il tempo è circolare. Il divenire non è una linea retta, che prosegue all’infinito. I quanta d’energia per quanto illimitati per la mente umana, non sono infiniti. Di conseguenza ogni evento è destinato a ripetersi, a ripresentarsi. Ecco l’eterno ritorno.
La sua filosofia oltrepassa ciò che comunemente viene considerato nichilismo con l’amor fati e la volontà di potenza.
Il superuomo è colui che ha capito e accettato la dottrina dell’eterno ritorno. La genealogia della morale non è altro che la scoperta del meccanismo colpa-pena-punizione, meccanismo con cui la morale controlla totalmente le coscienze umane.
Nietzsche è un nichilista attivo, distrugge perché qualcuno in futuro ricrei. Nietzsche inizia dall’analisi e dal pessimismo di Schopenhauer, ma laddove quest’ultimo sceglie come rimedio l’ascetismo, Nietzsche opta invece per la volontà di potenza.
Le considerazioni di Nietzsche sono inattuali perché si volgono alla Grecia antica e denunciano la superficialità e il vuoto dei disvalori della sua epoca. La Grecia antica riusciva a trasfigurare la realtà con l’arte, che comprendeva la catarsi, l’elemento dionisiaco e l’elemento apollineo.
Il filosofo nella sua dottrina riesce a dire sì alla vita, pur essendo cosciente delle avversità, delle contrarietà e del dolore.
Nietzsche va letto più di una volta, facendo uso della parte più razionale di noi stessi, perchè di primo acchito e a una lettura superficiale la sua filosofia può condurre all’autoesaltazione fine a se stessa e all’odio nei confronti della religione e delle persone religiose. Ma veniamo ora al relativismo propugnato dal filosofo tedesco.
Nietzsche scrive nei Frammenti postumi che non esistono fatti ma solo interpretazioni. Per fatto si intende un avvenimento, un evento, un dato oggettivo, una prova. Ma nessuno dovrebbe più dire che esistono dati di fatto incontestabili e incontrovertibili a riguardo di una cosa. Non si dovrebbe più dire che qualcuno nega l’evidenza dei fatti. Nessuno dovrebbe usare espressioni come “constatazione di fatto”, “attenersi ai fatti” o “alla prova dei fatti”. Qualsiasi fatto e qualsiasi riscontro sono insostenibili. Non si può più neanche dire che esiste una interpretazione univoca per un certo fatto secondo la logica. Non ci può essere corrispondenza univoca tra un fatto e una interpretazione. Il filosofo scrive che i fatti non esistono e che possono esistere infinite interpretazioni. Questo relativismo ermeneutico è totale e sconfina nel nichilismo. Diventa nichilismo, ovvero totale perdita dei valori, perché quel che consideravamo fatti sono diventati nulla. Naturalmente agli uomini resta ancora la condivisione apparente delle percezioni. Ma anche le sensazioni sono soggettive. Variano da individuo a individuo. Nietzsche sempre nei Frammenti postumi scrive che ogni costruzione del mondo è un antropomorfismo. La conoscenza è illusione. Il relativismo di Nietzsche è prima di tutto gnoseologico. Il filosofo tedesco si pone contro la fiducia smisurata dei fenomeni e della scienza da parte dei positivisti, che vedevano nell’ascesa della borghesia e nel dominio della tecnica un enorme progresso. Nel Novecento il relativismo conoscitivo si estenderà ancora grazie al paradosso di Kripkenstein sul linguaggio privato e sul seguire le regole in ambito cognitivo. Questo paradosso scaturisce da una riflessione di Wittgenstein in “Lezioni e conversazioni”. Ma ritorniamo al filosofo della volontà di potenza. C’è chi come il filosofo Maurizio Ferraris ha ironizzato sulla questione, affermando “Non esistono gatti, ma solo interpretazioni”. Però il problema rimane. Per Nietzsche inoltre non vale più nessuna metafisica e nessuna religione. Possiamo perciò affermare che anticipa Lyotard secondo cui sono finite le metanarrazioni. Ogni ismo quindi è morto. Ogni grande racconto non ha più modo di esistere. È sempre più difficile distinguere il bene dal male e il vero dal falso. Nietzsche si conferma uno dei peggiori nemici del cristianesimo non tanto perché secondo lui era la morale dei vinti e dei deboli quanto per il relativismo di cui il grande pensatore è portatore. Non a caso i suoi libri vennero messi all’indice dalla Chiesa. Non a caso molti lo considerarono il filosofo del nazismo e non considerarono invece lo stravolgimento assoluto e la mistificazione della sua opera da parte della sua folle sorella. Allo stesso modo a ben vedere si può dire addio anche a ogni senso comune, che viene polverizzato dal filosofo tedesco. Ormai la maschera è stata tolta: dietro ogni verità c’è una convenzione, un compromesso, una realtà condivisa. Niente altro che questo. Qualsiasi interpretazione del mondo equivale a un’altra interpretazione. Una visione del mondo vale come infinite altre visioni. Sempre secondo Nietzsche sono i nostri bisogni che creano una interpretazione e non certo la nostra logica. Dietro ad ogni interpretazione ci sono così i nostri istinti e non la nostra razionalità. Dietro ogni interpretazione c’è un soggetto: un interprete, che ha un suo particolare punto di vista e una sua prospettiva. Il fatto in sé dei positivisti non esiste. Tutto è soggettivo. Ognuno si fida delle sue idee. Non resta altro che questo. Ognuno si tiene i suoi convincimenti più o meno radicati. Ognuno è creatore di senso. Il neopositivismo o positivismo logico potrà fare ben poco nel Novecento: solo proporre il criterio di verificazione e cercare di rendere inutile la metafisica. Popper successivamente rivaluterà la metafisica perché la considererà una risorsa di idee e di ipotesi plausibili per la scienza. Ma il neopositivismo e Popper non condizioneranno la filosofia e neanche la mentalità della popolazione quanto Nietzsche. Il relativismo etico finisce quindi per essere l’unico dogma, l’unica certezza, l’unica verità. Nessuno ora può scagliarsi contro il relativismo senza essere tacciato di essere antidemocratico, retrogrado o moralista. Il relativismo viene sempre più ritenuto una filosofia di vita, un modo di intendere e di approcciare la realtà. Chi è contro di esso viene considerato sostanzialmente un passatista. Questo ismo non nasce certo nell’Ottocento. Era già il perno della filosofia dei sofisti e degli scettici. Ma attualmente come ha dichiarato il Papa Ratzinger è avvenuta la dittatura del relativismo, che può assumere diverse forme e può essere etico, culturale, gnoseologico, antropologico. Eppure a rigor di logica si potrebbe criticare sostenendo che se tutto è illusorio anche lo stesso relativismo è illusorio e vano. Viene però da chiedersi alla fine chi vince in questa realtà occidentale dominata dal relativo? Vince l’interpretazione del più potente e/o del più ricco, che ha più forza e più mezzi per affermarla. Il logocentrismo non esiste più. Il Logos non esiste più nella parola. L’irrazionalità e l’assurdità regnano sovrane. Questa è la civiltà dell’immagine e dei messaggi subliminali. L’interpretazione dei più potenti diventa verità perché ripetuta all’infinito dai mass media. Il relativismo quindi si è diffuso a macchia d’olio e è al servizio completo del potere; ma era forse meglio il moralismo di un tempo? Oppure è più tollerabile questo nuovo tipo di edonismo scaturito dalla mancanza di morale? Di certo una filosofia di vita in cui tutto è relativo può indurre al consumismo e può essere facilmente al servizio di multinazionali e lobby. Il relativo è il più importante credo laico odierno e avrà molti limiti intrinseci, ma come ha affermato Giulio Giorello bisogna stare attenti perché il contrario del relativismo è l’assolutismo. Infine questo atteggiamento è una premessa indispensabile per il pluralismo di una società aperta. I filosofi oggi discutono perciò su come arrivare ad un relativismo ragionevole e non totalmente pervasivo.

Parole e fatti:
Le parole talvolta anzi spesso sono ambigue. Ma anche i fatti raramente sono chiari e inequivocabili. I fatti raramente sono incontestabili e incontrovertibili. I fatti raramente sono a interpretazione univoca. I fatti difficilmente sono fatti in sé. C’è anche chi dice che il fatto in sé non esiste. Ci vogliono parole per interpretare fatti. Ci vogliono parole per fare l’amore e poi raccontarlo. Ci vogliono parole per lavorare e per fare affari, per fare da mangiare e salvare vite umane. Ci vogliono parole per viaggiare. Ci vogliono parole per soddisfare bisogni primari. Ci vogliono parole per fare la guerra, ma altre parole ci vogliono per fare la pace. C’è chi dice che i fatti sono molto più eloquenti di molte parole e per affermare ciò usa parole e per giunta perentorie, si comporta come se con le sue parole fosse depositario della verità. Non si può far godere una donna con le parole. Però alcuni per fare fatti continuamente usano le parole con negligenza, trascuratezza, estrema disinvoltura, inconsapevolezza. E se fanno male con le parole che importa? Sono gli altri che sono permalosi, troppo sensibili e loro non l’hanno fatto apposta. Per alcuni le parole sono inutili, ma quando pensano ai fatti loro lo fanno con categorie verbali. Non si può negare l’evidenza dei fatti, ma neanche quella delle parole. Anche le parole sono fatti ed è per questo chei sto lontano da alcuni, che significa stare lontano dalla loro metafisica dei fatti e dalle intenzioni cattive delle loro parole. Voi pretendete di giudicare una vita dai fatti ma quali fatti selezionare e giudicare? Come giudicare in modo equanime i fatti di una vita? Le parole esattamente come i fatti fanno soffrire ma anche godere. La vita si vive con i fatti e con le parole. Alle parole devono seguire i fatti, a cui seguono altre parole e così via fino alla fine di ogni vita. Fatti si susseguono a parole che si susseguono ai fatti in un circolo infinito. Senza parole non ci sarebbero fatti. Abbiamo bisogno di fatti ma anche di parole. Fatti e parole continuamente si richiamano e intrecciano tra loro. Ai bambini si insegna prima a parlare per capire e dire i fatti. Le parole perciò vengono prima dei fatti. Quando uno muore vanno al capezzale a raccogliere le ultime volontà, le ultime parole. Le parole, neanche quelle di cordoglio o conforto, possono niente di fronte alla morte.

Sulla poesia:
La poesia non vende principalmente perché gli italiani non comprano libri, perché i libri di poesia costano 15 euro e si leggono in fretta, perché c’è insufficiente considerazione dei mass media per la poesia, perché le stesse case editrici non investono nella poesia, perché anche le grandi casi editrici guardano più ai follower di un aspirante autore che alla qualità, perché molti scrivono e pochi leggono, perché alcuni intellettuali vogliono che la poesia resti una nicchia, perché la comunità poetica è suddivisa in cricche, perchè altre cose contano oggi e non la poesia, perché l’editoria a pagamento pubblica tutti, perché a scuola la poesia viene insegnata in modo soporifero, perché nel mondo dominano il consumismo e la razionalità tecnologica, perché la cultura è in declino, perché la società è allo sbando, perché regna incontrastato il nichilismo, perché la lettura di un libro di poesia richiede impegno, perché la neoavanguardia ha intrapreso una strada difficile e impopolare, perché le persone credono che solo i cantautori facciano poesia, perché la gente non vuole pensare e ha altri problemi per la testa. Ma talvolta anche i poeti hanno le loro colpe perché non trattano dei problemi del mondo e della gente, trattano di sé soltanto in modo oscuro, difficile. I poeti non vanno incontro alle persone. Le persone non vanno incontro ai poeti. Io non so se la poesia è veramente distante dalle persone o se sono le persone a essere distanti dalla poesia. Forse entrambe le cose. Ma sta di fatto che la poesia in Italia non vende.

Su poesia, fatti, posteri:
Per Austin le parole sono atti linguistici, ovvero azioni, fatti. Le frasi hanno anche degli effetti. Agiscono. Sono anche atti perlocutori. Inoltre l’interlocutore come il lettore molto spesso, al di là dell’effetto, sa capire anche le intenzioni, gli atti illocutori; sa capire il retropensiero. Cosa è un fatto? Un fatto è ciò che accade nel nostro mondo, parafrasando e modificando un poco Wittgenstein. Anche le parole accadono; anche le conversazioni che restano nell’aria calda di quest’estate per qualche secondo. Le parole inoltre producono effetti. Fanno bene o male. Hai scritto un libro e pensi che sia un fatto? È un fatto di sole parole. I giudizi critici lo stesso. Ma alcuni vanno fieri di ciò e li chiamano fatti, li considerano fatti inoppugnabili. Sono totalmente sicuri di aver fatto una cosa importante. Invece è quasi impossibile distinguere tra fatti e parole in poesia. Invece spesso sono solo parole. Il problema è se la poesia incide nella realtà qui in Italia oppure no. La risposta è approssimativamente no, quasi per niente, in modo infinitesimale. Nella maggioranza dei casi la poesia non cambia la realtà, è impotente di fronte a essa. La poesia in buona parte dei casi fa più bene a chi la scrive che a chi la legge. Ormai è qualcosa di inessenziale. Un tempo ognuno sarebbe diventato famoso per quindici minuti secondo Warhol. Oggi secondo Roberto D’Agostino si può diventare tutti famosi nella stragrande maggioranza dei casi solo per pochi amici, ammesso e non concesso che si abbia degli amici. Molti sono famosi nella loro bolla. E tutt’al più sono conosciuti marginalmente anche in qualche altra bolla. Ma è molto difficile assurgere alla vera notorietà, uscire fuori bolla. Si tratta perlopiù sempre di bolle, ovvero di minuscole porzioni della realtà. Inutile bearsi del niente. E poi si è davvero sicuri del gradimento effettivo? In fondo si può mettere un like a un post perché l’autore fa pena e non metterlo perché sta antipatico, indipendentemente dalla valutazione della qualità di quel post. Ci sono autori con alcuni ammiratori ma anche con alcuni hater e constato che è meglio non avere ammiratori né hater perché gli odiatori lasciano in fondo parecchia negatività e strascichi nell’animo di ognuno. Ci sono stati casi di personaggi pubblici che hanno momentaneamente chiuso i profili social per critiche al vetriolo e insulti di pochi odiatori, pur avendo un grande seguito. Alcuni in poesia si convincono di aver raggiunto la fama con quella pubblicazione a pagamento, con quel premio di un paesino sperduto, con quella pubblicazione in un’antologia che compreranno solo gli antologizzati. La realtà è un’altra. La realtà è che nel 99,9% dei casi molti finiranno nell’anonimato, nel dimenticatoio. Di me non resterà niente e mi piace anche questa prospettiva di cadere nell’oblio. In fondo ci sono sempre stato nell’oblio, nel dimenticatoio. Non avrò alcun peso, alcuna responsabilità, alcun onere della fama. Ci sono abituato ormai e mi va bene così. Ma di chi avrà la cosiddetta posterità cosa resterà? Resteranno forse dei guadagni per gli eredi? Nel 99,9% dei casi assolutamente no. Resterà una via di periferia e nessuno saprà a chi era dedicata? Una pagina alla fine di un manuale di letteratura che nessuno consulterà e che nessun professore farà studiare agli allievi? Una conferenza in cui pochissimi amici faranno in sua memoria per un pubblico di pochissime persone? Una cena tra parenti che ricorderanno che grande poeta fosse il loro defunto? Oppure resterà una pagina Wikipedia scritta da un sodale, che quasi nessuno leggerà in un anno? Oppure un sito Internet con pochissimi visitatori, più intenti a curiosare che ad apprezzare o ad ammirare? La poesia contemporanea italiana non è di moda, non fa tendenza, non è popolare. La poesia è moribonda e perciò viva la poesia! Sono altre le persone incisive. Sono le persone pratiche, pragmatiche. È loro la realtà. Loro hanno compiti e funzioni precise. Loro hanno lavori e guadagni importanti. La gente li considera, li rispetta, li stima, li ammira. Loro fanno qualcosa agli altri per gli altri. La poesia di fatto non riesce a sortire alcun effetto. Tanti scrivono poesie ed è come se non le scrivesse nessuno. Bisognerebbe ricordarsi come sostiene Federico Fiumani che si può anche vivere poeticamente senza obbligatoriamente scrivere versi. Inoltre non si può essere elitari e rifugiarsi in una torre eburnea in nome di un’aristocrazia di pensiero, che non c’è più. Un tempo ci voleva kunstwollen, ovvero volontà d’arte per scrivere poesie. Oggi sono necessarie molta convinzione di sentirsi artisti e un minimo di consenso, poco importa se in grandissima parte amicale e autoreferenziale. Beckett tratta del fallimento umano, di riprovare ancora e di fallire di nuovo. Ebbene la condizione umana dell’uomo contemporaneo è la stessa di molti poeti, che però vivono di illusioni e non sanno riconoscere il proprio fallimento umano e artistico. La poesia oggi perlopiù è amorfa, cade nell’indistinto, non produce effetti benefici né malefici. Non è benedizione né maledizione. Non fa niente. Nella gran parte la poesia non è perlocutoria, è semplicemente inoffensiva, improduttiva, sciatta. A meno che non si tratti di voci inconfondibili, di ottimi poeti e poetesse. Ma io non sto parlando delle eccellenze che ci sono. Sto parlando soprattutto del gran marasma generale, del grande caos, che tutto appiattisce, tutto livella, quasi tutto annulla. È quasi come se non ci fosse la poesia oggi. Le altre parole hanno un uso comune. Le parole poetiche sembrano perdere di senso. La colpa non è dei poeti ma di questa cultura, di questa società allo sbando. Le poesie sono atti linguistici quasi inutili, per pochissimi eletti. Ma non si può nasconderci purtroppo dietro alla retorica del “meglio pochi ma buoni”. Bisogna ambire a molto di più. Certi poeti però hanno un minimo di responsabilità: la società occidentale dà loro già addosso e loro tanto per gradire finiscono per fare gratuiti atti autolesionistici, allontanando sempre di più le persone, il pubblico già sospettoso e lontano. Certi poeti infatti fanno terribilmente sul serio. Si prendono terribilmente sul serio. E questo va a loro discapito. Si rinchiudono nella loro cricca. Non cercano di andare incontro alle persone. Le cose sono due almeno: dovrebbero riversare la loro ironia nella pagina o sulla loro persona, nel loro atteggiamento esistenziale, nel modo di relazionarsi agli altri, se non addirittura a fare tutte queste cose insieme. Invece la postura è sempre la solita. Alcuni non scendono dal piedistallo e hanno come modelli dei monumenti. Come se non bastasse alcuni sono rimasti a una condizione della poesia tipica del Pascoli. Se poi la poesia non ha pubblico non lamentiamoci. Forse chiedo troppo chiedendo autoironia, ma certi poeti dovrebbero abbracciare la semplicità, l’umiltà. La strada è tutta in salita. Montarsi la testa per piccoli insignificanti traguardi oltre a essere così poca cosa è controproducente alla causa della poesia. Infine i poeti dovrebbero sapersi gestire. No ai falsi miti, all’autodistruzione, al trascurare disturbi psichici e non curarli in nome di un presunto genio creativo, tutto da dimostrare. Un’altra cosa utile alla poesia sarebbe parlare chiaro, dire pane al pane e vino al vino, non perdersi in inutili intellettualismi. Questa è l’amara realtà di cui bisogna prendere coscienza: questi sono i fatti inoppugnabili.
ago 022022

Sicuramente alcuni letterati giustamente hanno cercato di raccogliere o meglio hanno aspirato a raccogliere l'eredità letteraria e critica di Fortini, però mi chiedo io se ha più senso oggi la cosiddetta funzione Fortini, ovvero l'intento di politicizzare la letteratura italiana, in vista di una rivoluzione. Me lo chiedo ora che la rivoluzione a mio avviso non è più possibile, dato che le coscienze sono addomesticate dai mass media e che il capitalismo di sorveglianza ci ha tutti schedati, vivisezionati, controllati totalmente. Bisognerebbe forse cercare di distruggere mass media e capitalismo di sorveglianza? Bisognerebbe quantomeno boicottarlo? Non sarebbe forse un tentativo puerile, utopico, come del resto quello del luddismo? Forse la cosa migliore è aspettare tempi più propizi. Forse anche le multinazionali e le lobby faranno dei passi falsi. La speranza è che il mondo migliori. Di ingiustizie e disuguaglianze ce ne sono a bizzeffe. Come è possibile fare la rivoluzione quando questo sistema ha svuotato e distrutto la concezione sociale della comunità? Non esiste più il senso della comunità. Siamo in una società in cui è sempre più difficile dire "noi". Le classi sono scomparse e con esse anche la coscienza di classe e la lotta di classe. La rivoluzione pacifica non è più possibile e molto probabilmente neanche quella non pacifica: sarebbe solo un inutile e utopico bagno di sangue, in cui sarebbero i rivoluzionari prima di tutto a rimetterci. Il problema non è solo accettare una quota fisiologica di violenza per fare la rivoluzione, ma ormai la questione di fondo è rassegnarsi alla sconfitta, accettare le istanze della rivoluzione mancata, accettando razionalmente che quei tentativi non sono più ripetibili. La lotta è impari, realisticamente parlando. Allora non sarebbe meglio unirci tutti, indipendentemente dell'orientamento politico, in nome del buon caro umanesimo, un umanesimo più moderno, che comprenda anche le scienze umane, per una critica serrata e radicale alla società attuale? Che senso ha rimpiangere la rivoluzione? Non sarebbe un grande atto politico cercare di riunirsi in nome dell'umanesimo? Il treno della rivoluzione è stato perso e probabilmente non passa più. Che fare ora? Stare sempre rivolti al passato? È utile la nostalgia di un'epoca che non tornerà probabilmente? Certo di grandi insegnamenti da trarre da quegli anni ce ne sono. Quell'epoca e la quella cultura non devono essere passati invano. Non sarebbe però ritornare sempre a quei giorni ripetere il solito mantra, il solito continuo "vorrei ma non posso", nel vero senso della parola? Per fare una cosa molto umana, ovvero il comunismo ci vogliono dei metodi sanguinari e disumani. Chi tutela il sistema capitalistico tutela i propri interessi ed è mosso dal proprio egoismo. Cosa succederebbe poi se il sistema intero implodesse? Che ne sarebbe di noi? Inoltre al mondo d'oggi molti hanno qualcosa da perdere, anche poco, anzi pochissimo, ma se lo tengono stretto. Siamo sicuri che il comunismo sarebbe un sistema migliore? Siamo sicuri che il tracollo del capitalismo non ci porterebbe in condizioni umane ancora più disastrose? Comunque anche se non si può accettare le dinamiche e le trasformazioni socioeconomiche odierne vanno capite e criticate. In questo il pensiero di Fortini può aiutarci molto, può venirci in soccorso. Non si può nascondere la testa sotto la sabbia. Ci vogliono comunque anche nuovi strumenti intellettuali per capire nuove dinamiche. Bisogna stare al passo con i tempi. Fortini va sempre tenuto presente perché è un grande maestro e un lucidissimo intellettuale, anche se apparteneva a un'epoca lontana. Fortini, per quanto sant'uomo e autore geniale, non poteva prevedere tutto, anche se ha previsto molto. Il primo interrogativo è come fanno molti a definirsi fortiniani e perciò militanti quando hanno accettato di buon grado tutti i meccanismi dell'industria culturale e i compromessi delle carriere universitarie? Più che raccogliere l'eredità diciamo che ne hanno subito gli influssi, anzi degli echi lontani. Infine un ultimo dubbio: raccogliere interamente l'eredità fortiniana significa anche abbracciare la sua religiosità (i Salmi, i libri sapienziali del Vecchio Testamento, i profeti, etc etc), per quanto Fortini non fosse sionista (vedere "I cani del Sinai"), e non fraintendere, non equivocare la sua chiamata alla clandestinità, che non significava prendere le armi e che al mondo d'oggi molto probabilmente, questa clandestinità, non è più possibile perché qualsiasi lotta, qualsiasi forma di opposizione richiede una certa visibilità, anche a rischio di farsi fagocitare dai mass media: sono finiti i tempi dei fogli ciclostilati e delle riunioni piene di fumo. È vero che Fortini era anche un ideologo e oggi l'unica ideologia rimasta è quella del mercato, come cantava Gaber.

È vero che possono sembrare, anche se solo di primo acchito, un poco datate la politicità di Fortini e la politicizzazione del reale. Però non bisogna fermarsi alla superficie; bisogna sempre valutare la grande capacità critica e dialettica fortiniana, la sua costante ricerca di oggettività, le sue grandi intuizioni intellettuali. Non bisogna dimenticarsi neanche della grande capacità di accettare il dialogo e di mettersi sempre in discussione di Fortini: qualità o quantomeno cortesia che mancano a molti intellettuali oggi. Fortini va sempre tenuto in considerazione. Il suo saggio "Verifica dei poteri", più di ogni altro suo lavoro, va tenuto sul comodino, sempre a portata di mano, per dubbi, chiarimenti, delucidazioni, nuovi interrogativi. Ma bisogna anche chiedersi non qual è l'eredità di Fortini, piuttosto ciò che è vivo e ciò che è morto in noi del suo pensiero, parafrasando Croce. Insomma Fortini è importante e non deve essere dimenticato e lo scrivo anche se non sono fortiniano. L'eredità di Fortini sarebbe a ogni modo ingente, cospicua, ma molto probabilmente mancano gli eredi legittimi.
lug 272022
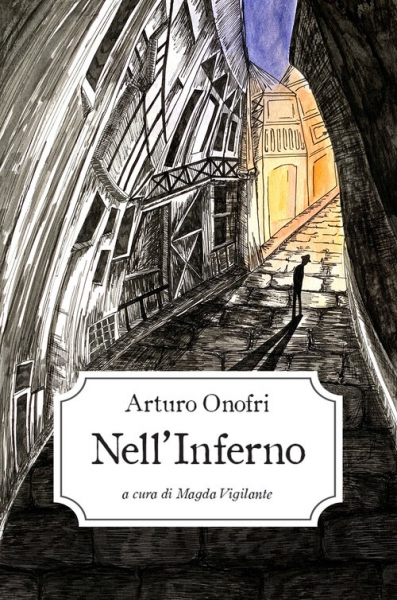
Questi tre racconti, editi in un volume dalla Pandilettere, di Arturo Onofri, poeta metafisico e scrittore (1885-1928) rappresentano a mio modesto avviso delle autentiche rivelazioni. Non lo scrivo per essere celebrativo perché Onofri è un letterato memorabile, che ha in modo inequivocabile segnato il '900 per l'originalità e la qualità della sua scrittura. Dell'importanza di Onofri ne è la controprova che una esperta italianista come Magda Vigilante ha dedicato una prefazione di quaranta pagine, facendo una disamina accurata dei racconti. Cercherò quindi di fare una breve rassegna di questo libro, spoilerando il meno possibile per non togliere istinto di acquisizione e gusto della lettura. Farò delle considerazioni di carattere personale, senza parlare della sua vita, del suo apprendistato, delle sue frequentazioni e delle sue collaborazioni con le riviste letterarie. Il primo racconto si intitola "Il pollice esercitato" (che sta a significare il talento coltivato) e tratta il tema della creazione artistica e della ispirazione con tutte le difficoltà del caso (la creta non è mai molle, indipendentemente dal fatto che si cerchi la mimesi, la trasfigurazione, la creazione ex novo). Come ci ricorda la Vigilante le idee in questione non sono quelle dell'Iperuranio, ma sono spiritelli maligni. Forse il poeta vuole suggerirci che la vera creatività spetta alle donne oppure solo a madre natura: forse solo loro hanno la vera capacità di generare. Le stesse idee sono signore algide e scostanti. Ho letto recentemente che le idee veramente innovative e originali scaturirebbero in modo casuale secondo i neuroscienziati e che addirittura la loro frequenza potrebbe essere descritta dalla distribuzione statistica di Poisson: semplificando ogni idea sarebbe un evento raro e fortuito nelle menti più creative. Ecco quindi la fatica di Sisifo della creazione artistica. Insomma Onofri aveva anticipato i tempi. Il secondo intitolato "I due" mette in scena sia il tema del doppio che quello psicologico del falso Sé (più che dell'Ombra junghiana a mio modesto avviso). Alla fine viene da chiedersi chi sia il personaggio autentico, se la figura in carne e ossa oppure il sembiante. Uno è il Sé autentico e l'altro è la maschera sociale, colui che rispetta codici e convenzioni borghesi. Il terzo intitolato "Inferno" esamina il perturbante in senso freudiano. Il protagonista prova allo stesso tempo repulsione e attrazione verso la donna, descritta inizialmente come orrida. Il lettore viene spiazzato più volte con alcuni straniamenti, con alcuni colpi di scena. Perché una scena sia effettivamente perturbante per Freud deve essere ambivalente emotivamente, deve essere familiare ed estranea al contempo. Onofri si dimostra un artista enigmatico, simbolista, decadente, esoterico (non a caso studiò l'antroposofia steineriana) in questi tre racconti, a cui lasciamo libera interpretazione agli acquirenti del volume; in questa sede ho voluto solo dare delle indicazioni di massima. D'altronde l'arte si caratterizza per la sua polisemia e ambiguità. Ognuno quindi può dargli il suo significato. Posso solo affermare che Onofri nei suoi racconti accosta elevazione spirituale e spavento, grazia e solitudine, levità ed angoscia, orfismo e scissione, purezza e terribilità. Sulla scena si affaccia prepotente il mistero, l'irrazionale sotto la forma di ossessione, di paura. Senza mai cadere nell'intimismo c'è una propensione innata alla penetrazione psicologica. Sono ineludibili lo sgomento e la sorpresa dei protagonisti, che sono tra la veglia e il sonno, quasi in uno stato di reverie e hanno delle apparizioni sconvolgenti. Onofri dà forma al materiale informe dell'onirico. Getta un ponte tra conscio e inconscio, trovando archetipi senza scandagliare oscenamente i segreti recessi dell'anima. Lavora di cesello e l'oscuro non è mai incoerente né incongruo. La sua prosa -per quanto subisce echi, risonanze, influssi- è suggestiva e mai suggestionata da nessun altro autore. Centrali sono le visioni e le analogie di Onofri. Non imita né prende a prestito alcunché. Piuttosto si rifà sporadicamente ed episodicamente alla tradizione. Per dirla alla Peirce il poeta era mosso da autentico amore per la conoscenza, era all'instancabile ricerca della verità. Non è forse un caso che amò diverse dottrine, ma non divenne mai dottrinario? E ora veniamo all'inghippo: quella di Onofri è una prosa poetica? E ancora si può cercare un discrimine tra poesia e prosa poetica?

Voglio sgomberare il campo da ogni possibile fraintendimento: è impossibile a mio avviso fare una distinzione oggettiva tra poesie in versi e prose poetiche. Di distinzioni se ne possono fare ma sono solo soggettive e a mio avviso stucchevoli. Mi auguro che non lo si faccia per faziosità o per partito preso. È sempre arduo stabilire una relazione tra prosa e poesia oppure una linea di confine. C'è chi sostiene che non vi sia più una grande differenza tra i due generi e che per vendere più copie molti poeti farebbero meglio a non andare a capo. Ricordo a tutti che condannare la prosa poetica può voler dire giudicare negativamente i capolavori di Pagliarani e Bertolucci. Perché condannare un certo ibridismo? Per quale motivo? Inoltre ricordatevi che per i puristi del verso scrivere in versi liberi significa andare a capo arbitrariamente ed è considerato alla stessa stregua dello scrivere in prosa. Il verso libero è il lasciapassare e allo stesso tempo la diretta conseguenza della prosa poetica. È meglio non mettere steccati e paletti. Nel secondo Novecento non l'hanno fatto. A mio avviso è lecito scrivere in ogni modo. È sempre meglio non fare restrizioni di nessuna sorta e permettere ogni tipo di libertà. Preferisco per quel che mi riguarda essere onnicomprensivo e inclusivo ai massimi livelli. Un poeta può dimostrare la propria versatilità e scrivere in ogni modo: Onofri ne è stato l'esempio lampante e ha dimostrato tutta la sua versatilità. Un poeta deve avere sempre la massima libertà espressiva. Di conseguenza può utilizzare qualsiasi registro espressivo, che deve essere considerato comunque espressione artistica. Può anche adottare il pluristilismo. La poesia in versi liberi può essere a mio avviso poesia come, anche la prosa poetica può essere allo stesso tempo poesia. Tutto il resto è polemica sterile fatta per amor della polemica. Personalmente non cerco ossessivamente come fanno taluni una linea di demarcazione tra poesia e non poesia. Cerco solo di distinguere solo ciò che mi emoziona da ciò che non lo fa, ciò che mi fa pensare da ciò che non lo fa. I tre racconti di Onofri mi hanno colpito favorevolmente, mi hanno emozionato. Una cosa che contraddistingue la sua scrittura è il fatto che, nonostante le innumerevoli variazioni della lingua italiana dagli anni di stesura a oggi, essa sia ancora comprensibile e chiara senza l'ausilio di alcuna nota: ciò dimostra la capacità comunicativa dell'Onofri. Quella del poeta romano è a ogni modo una prosa lirica, è quella che un tempo veniva chiamata prosa d'arte. Per tutte queste ragioni il volume meriterebbe di essere letto.
lug 232022

"Il mondo di ieri" di Stefan Zweig, scrittore austriaco ebreo di successo negli anni '20 del Novecento, è un'autobiografia illuminante, che fa piena luce sia sulla sua vita che sulla sua epoca. Il libro è caratterizzato da riflessioni e ricordi, intesi in senso guicciardiniano. Il libro fu scritto tra il 1939 ed il 1941 in Brasile, dove l'autore si era rifugiato. Si possono rintracciare aforismi, massime, avvertimenti, però a differenza del segretario fiorentino, Zweig non si impegna nella scrittura breve, non è discontinuo né frammentario, anzi è un accumulatore seriale di aneddoti e ricordi, pur tuttavia sempre racchiusi in una forma organica, lineare e razionale. L'opera si legge tutta di un fiato. Lo scrittore riesce sempre a ravvivare e ridestare l'interesse nel lettore, non perdendosi mai in intellettualismi e senza scadere mai in digressioni prolisse. Zweig fa un affresco memorabile dell'impero austro-ungarico e della sua caduta; lo fa a pieno diritto, visto e considerato che è stato un rappresentante di alta levatura della cultura mitteleuropea. In Europa fu un autore molto letto. Zweig inizia col descrivere la sua infanzia a Vienna. Definisce la scuola una galera, a causa della disciplina ferrea vittoriana che determinava molti "complessi di inferiorità". In quella Vienna la massima aspirazione delle famiglie borghesi non era che i loro figli si arricchissero ulteriormente ma che diventassero dottori. Molti bambini e adolescenti volevano diventare artisti. Allo stesso modo l'educazione era molto rigida e impostata. I doveri avevano la priorità assoluta sui diritti. I ragazzi avevano come modelli dei maestri di pensiero, prima di tutto rispettabili. La sessualità era un tabù. Era un'attività da non mettere in mostra e un argomento di cui non parlare. L'erotismo in quella società sessuofobica era tutto nascosto e adulterato o almeno mistificato. Ma allo stesso tempo per un meccanismo di compensazione quella era in Austria anche l'epoca della sicurezza. Era la Felix Austria. Era la Belle Époque. Era la società del liberalismo e del progresso, delle "magnifiche sorti e progressive". Zweig proveniva da famiglia agiata ed ebbe la fortuna sia di poter andare all'università che di scegliere la facoltà, cose non affatto scontate a quei tempi. Scelse filosofia, ebbe modo anche di pubblicare le prime poesie e di conoscere Herzl, fondatore del sionismo. Poi il 28 giugno 1914 Princip, uno studente serbo, assassinò l'erede al trono asburgico. Come scrive Zweig erano stati 40 anni di pace e poi era sopraggiunta all'improvviso la guerra. Molto fuoco covava sotto la cenere. L'equilibrio in Europa era precario. C'erano molte tensioni di varia natura (economica, politica, sociale, ideologica). Iniziarono gli sconvolgimenti, gli eccidi, gli orrori. Come ci racconta Zweig i soldati al fronte morivano, mentre gli altoborghesi imboscati se la spassavano in patria. I superpatrioti ce l'avevano con lui che era pacifista. Ma lo scrittore era impegnato lo stesso perché aveva la coscienza e l'esatta percezione di quanto fosse importante il parere e la presa di posizione di un letterato o di un artista a quei tempi, mentre come sottolinea molto lucidamente nella seconda guerra mondiale gli intellettuali erano ormai fuorigioco e ininfluenti. Finita l'università si trasferisce a Parigi. Zweig descrive con nostalgia la capitale francese, una città cosmopolita per eccellenza, e scrive che sulla Senna ognuno si sentiva a casa propria. Racconta anche i suoi viaggi, che lui definisce "pellegrinaggi". Un artista, per essere tale, deve avere frequentazioni con giganti intellettuali e lui ebbe molti incontri con geni come Rilke, Harden, Richard Strauss, Herzl, Romain Rolland, Pirandello, Freud, Dalì. Riconobbe nella Svizzera un modello per tutti per la civiltà e l'accoglienza, dato che in terra elvetica trovavano rifugio tutti i perseguitati. Allo stesso modo ci descrive gli Stati Uniti come il paese in cui ci sono più libertà ma anche più opportunità, visto che in pochi giorni gli offrono ben cinque impieghi. Inoltre descrive il periodo londinese, che va dal 1934 al 1940.
altmann-zweigandrothinostendin1936(cropped)1_0_o.jpg)
Zweig dagli anni '20 era uno scrittore noto al grande pubblico. I suoi libri vendevano molto. Aveva ottime entrature nell'alta società, anche se tutto ciò non lo interessava granché. Conosceva tutti gli scrittori, gli editori, i direttori di riviste che contavano in Europa. Eppure fece naufragio perché si suicidò in Brasile insieme alla moglie. Nonostante il suo successo personale aveva vissuto anche troppo orrore per la guerra, la crisi dell'Austria, che non aveva più fabbriche, era povera e la cui banca nazionale era senza più oro, tutti segni di una miseria inenarrabile e della fine di un'epoca felice. Ma non c'è solo questo: Zweig aveva assistito anche all'ascesa di quel folle di Hitler. Gliene avevano parlato già all'epoca in cui istitgava all'odio i bavaresi nelle birrerie. Aveva avuto modo di constatare la follia di Hitler, che aveva saputo approfittarsi della difficile situazione in cui versava la Germania in quegli anni, obbligata a pagare una indennità di guerra incredibile. Hitler si approfittò di una Germania umiliata e colse la palla al balzo, coniugando necrofilia, imitazione del fascismo, antisemitismo, anticomunismo, sadismo e crudeltà infinita. Zweig era un intellettuale così lucido che si era accorto del pericolo. Cosí come probabilmente forse si era accorto della "banalità del male" del popolo tedesco. Date queste premesse la fine di Zweig era quasi scontata.
lug 172022
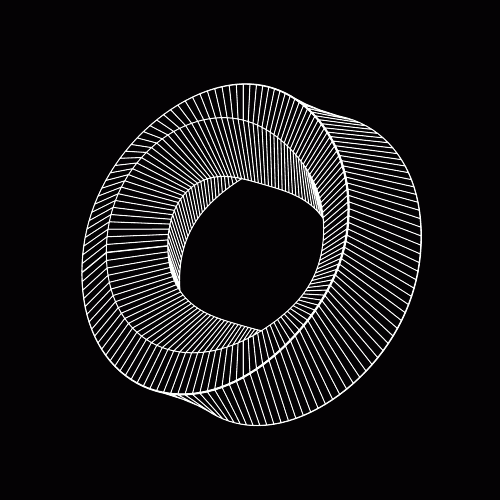
“Quando avremo quarant’anni altri uomini e più validi di noi ci gettino pure nel cestino come manoscritti inutili” (Filippo Tommaso Marinetti)
Molto probabilmente Marinetti, fondatore del futurismo, quando scrisse questa frase voleva solo provocare. Oppure forse ci credeva davvero. Oppure era un modo per opporsi al passatismo e alla tradizione. Cosa è che ha dettato queste parole? Il calcolo oppure l'incoscienza giovanile? O forse entrambi in una miscela esplosiva? Per rendere più popolare il suo movimento d’avanguardia scrisse molti manifesti dissacranti. Per far parlare di sé e del proprio movimento non disdegnò polemiche al vetriolo e vere e proprie risse. Propose il culto della macchina e della velocità, la teoria delle parole in libertà, “l’immaginazione senza fili”. Si scagliò contro i professori passatisti e la tradizione, invitò ad “uccidere il chiaro di luna”. I futuristi come scrisse Boccioni inseguirono “l’estasi del moderno e il delirio innovatore della loro epoca”. Ecco il motivo per cui volevano distruggere i musei e le biblioteche e odiavano chi imitava e ammirava il passato. In letteratura furono veramente degli innovatori tramite la distruzione della sintassi, l’abolizione degli avverbi e degli aggettivi, la distruzione dell’io. Politicamente - nonostante il loro antiparlamentarismo - lo furono un po’ meno, dato che furono nazionalisti e considerarono la guerra “sola igiene del mondo”: furono fascisti della prima ora. Per la maggioranza dei letterati della loro epoca furono visti come esaltati, ignoranti, militaristi e violenti, creatori di stramberie e goliardismi. A distanza di decenni dalla loro comparsa va senz’altro riconosciuto che il futurismo - nonostante mille difetti - ebbe il merito di essere il primo vero movimento di avanguardia. Marinetti scrisse forse questa frase per scagliarsi contro l’immobilismo sociale e culturale, in cui versava l’Italia di allora. Però nella nostra epoca sembra che molti imprenditori e dirigenti di azienda abbiano messo in pratica la provocazione di Marinetti. Il giovanilismo imperante induce al prepensionamento e al licenziamento di chi abbia superato gli anta. Non solo, ma una volta licenziato da un’azienda un cinquantenne ha molte più difficoltà di reinserirsi a livello lavorativo perché le aziende gli preferiscono persone più giovani. Un tempo si considerava la vecchiaia come possibile fonte di saggezza. Oggi perfino la maturità è vista come un periodo di declino inarrestabile. Erroneamente molti selezionatori del personale ritengono che chi ha superato gli anta non è provvisto di capacità di apprendimento. Molto probabilmente quando prendono sbrigativamente le loro decisioni non tengono conto della ponderatezza di chi ha più di quaranta anni. Eppure la stessa vecchiaia non è una stagione della vita, in cui si debba per forza consegnarci al silenzio. Per quel che mi riguarda penso di sfruttare al meglio le mie facoltà intellettuali oggi rispetto a quando avevo 20 anni. Mi ritengo anche più equilibrato interiormente.
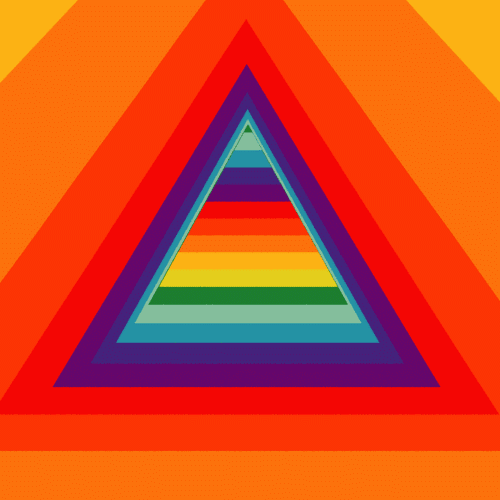
A 20 anni volevo tutto e mi accontentavo solo con molto. Oggi voglio poco e mi accontento di pochissimo. A 20 anni si può vivere delle crisi interiori spaventose. A 50 ormai sono un'esistenzialista positivo: nell'antichità c'era chi vedeva Dio come "pensiero di pensiero", io oggi vedo il trascendente come il filosofo Abbagnano, ovvero come "possibilità di possibilità", come scelta di scelta; la sola possibilità di poter scegliere, anche senza fare niente di speciale, nella vita, mi infonde speranza e ottimismo. Andare al bar piuttosto che rimanere a casa mi inebria di libertà. Oggi ho una consapevolezza esistenziale che prima non avevo. Forse non so niente di più o di nuovo, ma quello che sapevo un tempo viene confermato, rafforzato, corroborato da letture e riflessioni odierne. Mi basta stare bene di salute e tirare a campare. Non chiedo l'impossibile. Questo già mi basta. Per quanto riguarda la sessualità con il Cialis e il Viagra le persone anziane hanno risolto molti problemi. Non vivono più i drammi descritti da Brancati ne "Il bell'Antonio" e non esiste più il gallismo e la concezione dell'onore di un tempo. Inoltre sono molti gli anziani attivi intellettualmente, che leggono libri e periodici. Non dimentichiamoci che la morte colse Moliere mentre stava recitando. Più recentemente non dimentichiamoci dell’attività intellettuale di Norberto Bobbio, Carlo Bo, Karl Popper, Mario Luzi, quando erano ormai ottuagenari. Solo la malattia mentale e la morte prematura annichiliscono la mente e l’intelletto. Non dimentichiamoci infine che l'invecchiamento cerebrale inizia da ventenni, ma che abbiamo a disposizione miliardi di neuroni ed esiste anche la neuroplasticità.
lug 132022
In molti credono nel mito dell’artista maledetto e nel binomio genio e sregolatezza. Di studi ne sono stati fatti parecchi negli ultimi duecento anni sul rapporto tra psicopatologia e creatività.
È dall’antichità che si suppone che gli artisti siano saturnini. Secoli fa si pensava che la creatività fosse un dono per pochi che avevano una dote innata. Erasmo da Rotterdam elogiò la follia (“la sola capace di rallegrare uomini e dei”), mentre lo stesso Cesare Lombroso associò il genio alla follia in quanto fu colpito dall’ingegno dei pazienti nei manicomi.
Alcuni si chiederanno cosa significhi esattamente il termine “follia”. Per i saggi è follia anche il possibile suicidio collettivo della specie a causa dell’inquinamento e della distruzione delle risorse naturali. Ma torniamo al rapporto tra disturbi psichici e creatività.
Secondo le ricerche più recenti in linea di massima sarebbero creative alcune persone depresse, alcuni ciclotimici, alcuni maniaco-depressivi, ma anche alcuni che soffrono di schizofrenia. Secondo la psichiatria la schizofrenia sarebbe contrassegnata oltre che da deliri e dalle allucinazioni anche da ritiro sociale e scarsa capacità di comunicazione. Ciò sembrerebbe in netto contrasto con la smodata voglia di esprimersi e dalla grande capacità comunicativa degli artisti. Gli schizofrenici in genere dovrebbero avere povertà ideativa e soffrire di anaffettività.
Eppure nel corso della storia ci sono stati anche casi di artisti schizofrenici. Secondo gli studiosi Van Gogh, Holderlin, Tasso, Gogol, Dino Campana, Strindberg, Artaud erano schizofrenici (tanto per citare i più celebri). Si veda a tale riguardo lo studio di Eugenio Borgna su Artaud.

Non è assolutamente detto però che se uno è schizofrenico debba per forza diventare artista o che al contrario essere artista comporta il rischio di diventare schizofrenico. Le persone schizofreniche in Italia sono circa l’1% della popolazione e solo una esigua minoranza di essi è veramente creativa. Bisogna però considerare che non a tutti gli schizofrenici viene diagnosticata la schizofrenia. Esiste comunque un legame tra schizofrenia e creatività artistica. Lo possono testimoniare gli psicoterapeuti e gli psicologi che curano pazienti psicotici con l’arteterapia.
Nessuno però è riuscito a spiegare scientificamente questo legame tra creatività e follia, anche se di ipotesi ne sono state fatte molte. L’espressione artistica sarebbe una valvola di sfogo e la creazione produrrebbe uno stato euforico. Le persone cosiddette equilibrate e normali non avrebbero alcun bisogno di provare queste emozioni. Starebbero già bene senza bisogno di creare.
Per gli psicoanalisti la creatività sarebbe una risposta all’angoscia. Per gli psicologi cognitivi le persone creative starebbero buona parte del tempo in uno stato di rêverie prima di giungere all’illuminazione. La psicopatologia inoltre potrebbe causare originali associazioni di idee, che potrebbero rendere pregevole la creazione di uno psicotico. Come definire però la creatività?

Secondo il matematico Henri Poincarè: “Creatività è unire elementi esistenti con connessioni nuove, che siano utili”. A mio avviso questa è la definizione più sensata, ma molti hanno provato a stabilire in cosa consistesse il pensiero creativo. Gli psicologi ad esempio hanno studiato la creatività tramite vari approcci (psicometrico, psicodinamico, cognitivo, comportamentale) e sono giunti a conclusioni differenti.
Spesso per essere creativi gli intellettuali devono essere fuori dagli schemi e originali. Avere disturbi dell’umore, disturbi di personalità o turbe psichiche può talvolta aiutare a vedere il mondo in modo inusuale e ad accorgersi di cose che gli altri non vedono. Ritornando alla schizofrenia, bisogna ricordare che sono diversi i miti da sfatare e che non sempre una persona affetta da schizofrenia ha un deterioramento cognitivo e una disorganizzazione del pensiero tale da non poter comunicare con gli altri.
Ogni caso clinico è una storia a sé e deve essere valutato singolarmente. Ci sono diverse forme di schizofrenia: quella di tipo paranoide, quella di tipo disorganizzato, quella di tipo catatonico, etc etc. Ci sono anche diverse fasi. Ci possono essere storie di persone caratterizzate da miglioramenti e ricadute.
È sempre difficile generalizzare. La creatività è un mistero; la cosiddetta follia è un mistero e anche il legame tra queste due realtà è un enigma insolubile su cui molti studiosi hanno cercato di indagare senza approdare a niente di certo. Viene poi da chiedersi se il disturbo psichico tolga o aggiunga all’artista. I pareri sono discordanti.
C’è chi sostiene che un artista sia tale a causa del disturbo psichico e chi invece ritiene che lo sia malgrado questo. Una cosa è sicura: l’arte non fa impazzire ma nella stragrande maggioranza dei casi è terapeutica.
lug 082022
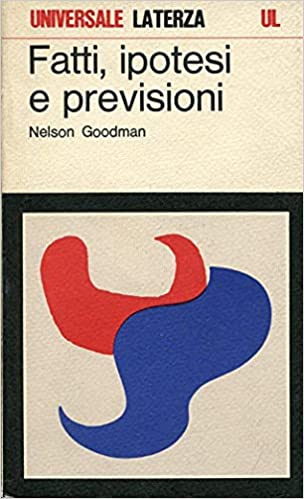
Riporto testualmente dal sito www.platon.it: “Paradosso di Goodman (o degli “smeraldi blerdi”): data una certa proprietà contraddistinta da una variazione dopo una certa data (l’essere blerde, ossia verde fino a una certa data, quindi blu), per quante osservazioni io faccia relative a oggetti che sembrano godere della stessa proprietà senza variazione (p.e. smeraldi verdi), non posso mai escludere che questi stessi oggetti godano della proprietà con variazione (siano smeraldi blerdi); in particolare, aumentando i casi confermativi, aumenterebbero sempre nello stesso modo sia la probabilità di registrare la proprietà senza variazione (smeraldi verdi), sia la probabilità di registrare la proprietà con variazione (smeraldi blerdi)”.
N. B: la stessa cosa si può dire del vlu.

E ora ecco le mie considerazioni:
Secondo il paradosso di Goodman dobbiamo considerare un nuovo predicato: il vlu. Mettiamo di applicare questo predicato a uno smeraldo. Uno smeraldo vlu è uno smeraldo, che fino al tempo t è verde e dopo il tempo t diviene blu. Mettiamo che alcuni individui credano che gli smeraldi dopo il 2030 diventeranno blu. Mettiamo che io non creda a questa loro affermazione. Allora io posso formulare due ipotesi opposte per ciò che accadrà dopo il 2030: “tutti gli smeraldi restano verdi” oppure “tutti gli smeraldi sono vlu”. Tutte e due le ipotesi sono possibili, quindi nessuna è meglio dell’altra. Da un certo punto di vista potremmo affermare che si equivalgano. Il problema che ne consegue è che se le due ipotesi si equivalgono anche il verde e il vlu si equivalgono. Quindi io potrei adoprare il vlu ogni volta che voglio. Il linguaggio finirebbe per diventare vlu. Voi vi chiederete: perché mai gli smeraldi, che sono tutti verdi e che sono sempre stati verdi, dovrebbero cambiare colore? Mettiamo per assurdo che dopo il 2030 cambi la struttura del mondo fisico, oppure cambi il nostro sistema nervoso (e quindi anche le nostre percezioni e i nostri stati mentali) oppure che lo smeraldo per qualsiasi motivo emetta un’altra lunghezza d’onda. Comunque sia…. noi - secondo il filosofo Goodman - possiamo fare due previsioni. Come mai noi consideriamo più probabile (più “proiettabile”) l’ipotesi che tutti gli smeraldi siano verdi piuttosto che l’ipotesi che tutti gli smeraldi siano vlu? Ora io farò delle semplici osservazioni da uomo comune e non da filosofo (perché naturalmente non sono filosofo). Io so che per gli smeraldi l’essere verde è una proprietà, che considero permanente di quell’oggetto. Se uno smeraldo cambia colore - potrei anche affermare - che non posso più considerarlo uno smeraldo, piuttosto un nuovo oggetto. Un nuovo oggetto, che avrà bisogno di un altro nome. In modo molto semplice: Goodman dà un nuovo nome al colore in base ai cambiamenti nel tempo, mentre si dovrebbe dare solo un nuovo nome all’oggetto. Poniamo il seguente principio: quando la proprietà (ritenuta prima permanente e inalterabile) di un oggetto viene modificata non bisogna etichettare in modo nuovo il predicato che descrive la proprietà di quell’oggetto in base ai possibili cambiamenti nel tempo, ma bisogna considerare che quell’oggetto sia un nuovo oggetto e necessiti di un nuovo nome. Il paradosso di Goodman, se seguissimo questo principio, esisterebbe ancora? Resterebbe comunque una domanda: perché dobbiamo utilizzare per forza questo principio? Ma veniamo di restare nella realtà e di non fare astrazioni campate per aria. L’acqua a 0 gradi oppure al di sotto diventa ghiaccio, mentre invece in condizioni normali (alla pressione di 1 atmosfera) vaporizza alla temperatura di 100 gradi. Sappiamo che ciò dipende dallo stato fisico della materia. Sappiamo quindi che lo stato fisico della materia (e quindi anche dell’acqua) può cambiare. Nella realtà io non utilizzo predicati come acqua-ghiaccio o come acqua-vapore per indicare l’acqua che è diventata ghiaccio o per indicare l’acqua che è diventata vapore. Non utilizzo aggettivi- definiamoli- “deciduali”. Altrimenti sarei costretto ogni volta per l’acqua ad utilizzare un aggettivo (predicato) come acqua-ghiaccio-vapore perché c’è la possibilità che l’acqua a certe condizioni possa diventare ghiaccio e ad altre condizioni possa diventare vapore. Noi invece sappiamo che lo stato fisico dell’acqua cambia, ma non utilizziamo un linguaggio “deciduale” (come le foglie. Mi riferisco all’esempio di Piattelli Palmarini) per definire lo stato fisico dell’acqua. Semplicemente cambiamo nome all’oggetto quando la proprietà di quell’oggetto non è permanente, costante. Facciamo un altro esempio. Consideriamo l’animale dal colore più mutevole (e diciamo più “deciduale”) del mondo: il camaleonte. Che cosa caratterizza il camaleonte? Potremmo dire: gli occhi grandi, la lingua che si può ritirare in qualsiasi momento, il fatto di cambiare colore in base all’ambiente. Queste sono le caratteristiche ritenute costanti di quest’animale. Per le nostre menti le proprietà permanenti di un oggetto o di un soggetto sono le proprietà, che caratterizzano quell’oggetto. Qualcuno potrebbe chiedere il perché. Non lo so. Io so solo che quelle proprietà ritenute costanti lo distinguono dagli altri oggetti. Ma il problema è che se io mi imbattessi in un animale, che ha tutte le caratteristiche fisiche di un camaleonte e non cambia più il colore in base al colore dell’ambiente, non potrei più considerarlo un camaleonte. Semplicemente: sarebbe un altro animale. Se la proprietà ritenuta permanente di un oggetto cambia allora cambia anche l’oggetto (o il soggetto) e perciò cambia anche la definizione di quell’oggetto. Se quell’oggetto è diventato un altro oggetto è chiaro che ha bisogno di un nuovo nome, di nuovi predicati, di una nuova definizione. Se facciamo in questo modo (e nella realtà facciamo in questo modo) il paradosso di Goodman diventa più semplice. Ci sono sempre due ipotesi: 1) quell’oggetto (lo smeraldo) subirà una trasformazione (oppure la realtà oppure il soggetto conoscente) e diventerà (oppure verrà considerato dal soggetto) un altro oggetto. 2) quell’oggetto (lo smeraldo) non subirà trasformazioni e resterà lo stesso. E’ un problema di semplice convenzionalismo linguistico? Quello che Goodman chiama “trinceramento” è soprattutto un fatto derivante dalle convenzioni linguistiche? Il problema che si pone è: perché non possiamo utilizzare predicati “deciduali” e un linguaggio “deciduale”? Perché il verde va sempre preferito al vlu? Se io ammetto il vlu, cioè ammetto un aggettivo “deciduale” allora ammetto che qualsiasi predicato possa essere “deciduale”. Permetto quindi che tutto il linguaggio possa essere “deciduale”. Ma un linguaggio “deciduale” non è una semplice foglia, che cade per terra. E’ l’intera conoscenza umana, che cade nel nulla. Alcuni sostengono che il paradosso di Goodman sia una riformulazione più elaborata del vecchio problema di Hume sull’induzione. Secondo Hume gli uomini facevano delle inferenze in virtù di “uso e abitudine”. Potremmo oggi parlare di innatismo e di intersoggettività. Ma è lo stesso. Detto in parole povere: data una mole di osservazioni io ho bisogno di individuare delle proprietà costanti dagli oggetti per poi successivamente classificarli e definirli. I problemi sembrerebbero quindi due: come io giungo all’inferenza e come passo dall’inferenza alla classificazione. In questo senso in filosofia dal “tacchino induttivista” di Russell oggi sono passati al “tacchino anti-induttivista” di Goodman. Ma non c’è solo questo. Il tacchino di Goodman è anche un tacchino anti-classificatorio. Io ragiono come l’uomo della strada, anzi sono l’uomo della strada. Allora mi chiedo molto semplicemente una cosa. Se io ammetto il vlu posso anche dare un nome a ogni singolo oggetto? Se io ammetto il vlu tutto è possibile nel linguaggio. Il linguaggio diventa eracliteo. Ogni elemento del linguaggio potrà variare in base al fattore tempo o in base a qualsiasi altro fattore. Alcuni studiosi hanno pensato che il paradosso di Goodman dipendesse esclusivamente dal tempo, ma a mio avviso non è così. Il fattore tempo è solo un pretesto. Comunque se accettassimo tutti universalmente il concetto di vlu non ci sarebbero più limiti. Finiremo quindi per dare un nome anche ad ogni singola sedia o ogni nostro stato mentale. Sorge spontanea una domanda: perché io ogni sedia la chiamo sedia e non scelgo un nome specifico per ogni singola sedia? Ora mi posso chiedere: perché classifico gli oggetti? Probabilmente ho bisogno di classificare gli oggetti per i limiti della memoria umana, per economia di tempo e di risorse cognitive, per non avere rappresentazioni mentali offuscate, per vivere la vita e non per passare tutta la vita a nominare oggetti. Se io ammettessi che qualsiasi proprietà di un oggetto ( o soggetto) possa essere definita in base ai cambiamenti passati, attuali futuri (o possibili) francamente passerei tutta la vita immobile nel letto soltanto a definire sempre tutti i miei umori e i miei stati mentali. Non ci può essere una corrispondenza totale tra linguaggio e realtà. Per motivi di tempo e di risparmio di energia abbiamo sempre bisogno di etichettare, catalogare, generalizzare. Ma perché ho parlato di tacchino anti-classificatorio di Goodman? Prendiamo ad esempio il noto paradosso del mentitore. Epimenide di Creta sostiene che “tutti i cretesi sono bugiardi”. Essendo cretese Epimenide è bugiardo e sta dicendo il falso. Oppure Epimenide sta dicendo il vero, ma essendo anch’egli cretese l’affermazione è falsa perché allora non tutti i cretesi sono bugiardi. Nel celebre paradosso del mentitore il soggetto contraddice se stesso o il predicato. Ma perché? Perché in fondo predica se stesso. Nel paradosso di Goodman non è il soggetto a “mentire” (diciamo così). E’ piuttosto il predicato a mentire. Ci sono infatti due alternative: 1) se una proprietà costante degli smeraldi è di essere verde non potranno mai essere blu. Quindi in questo caso è il concetto di vlu che si autocontraddice. 2) se lo smeraldo, che viene definito come tale in base alla proprietà costante dell’essere verde, diventa blu non è uno smeraldo. Quindi in questo caso il predicato sembra contraddire il soggetto della proposizione. Il predicato quindi annulla la proprietà interna del soggetto.
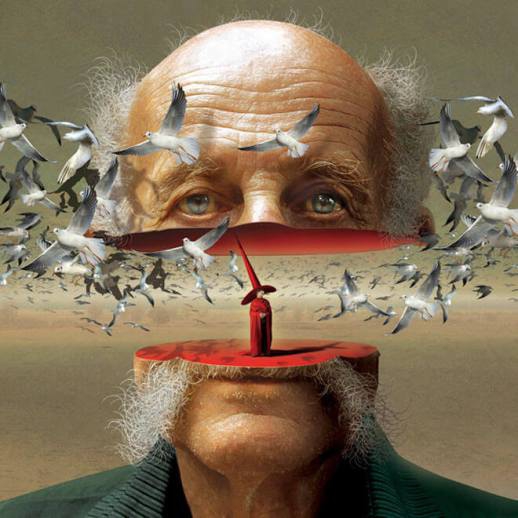
Fino ad oggi il colore dello smeraldo ha sempre denotato lo smeraldo e lo smeraldo è sempre stato definito anche in base al colore. Ma cosa posso fare se gli smeraldi diventano blu dopo il 2030? Posso ridefinire il soggetto della proposizione successivamente e dare un nuovo nome al nuovo tipo di smeraldo. La domanda allora è: posso considerare un nuovo tipo di smeraldo (che non è più verde) e considerarlo un altro oggetto e dargli un altro nome. Sì. Io posso. L’umanità può. Può incessantemente costruire logicamente e verbalmente in modo nuovo la realtà. Perché quindi devo preferire il “vlu” (che porta all’anarchia linguistica) quando posso costruire in modo logico e verbale nuovi oggetti mentali? E poi posso considerare sempre in modo probabilistico le proprietà ritenute costanti degli oggetti o dei soggetti. Se l’umanità accettasse (e quindi estendesse) il vlu a tutte le proprietà e a tutti gli oggetti non ci sarebbe più alcuna classe. Non ci sarebbero nemmeno più gli insiemi in matematica. Russell definiva gli stessi numeri delle “proprietà di classi”. Alcuni studiosi sostengono che ci sia una certa parentela tra il paradosso di Goodman e il paradosso del corvo di Hempel. Secondo quest’ultimo paradosso le cose non nere confermano il fatto che tutti i corvi siano neri. E’ esclusivamente un problema di induzione. In fin dei conti questo paradosso filosofico ci insegna a chiederci: perché facciamo inferenze soltanto sui corvi e non sulle cose che non sono corvi? Alcuni filosofi hanno ragionevolmente pensato che sia dovuto al fatto che l’insieme dei corvi è molto inferiore rispetto all’insieme dei non-corvi. Inoltre mi chiedo molto semplicemente a proposito di questo paradosso: perché le cose non nere devono per forza confermare il fatto che tutti i corvi sono neri? Quello che voglio dire è che alla fin fine non dovremmo chiederci solo perché facciamo inferenze nel dominio di quell’oggetto di indagine, ma anche perché ogni volta che facciamo un’inferenza non cambiamo oggetto di indagine. E’ una domanda scontata. Ma a mio avviso è una domanda scontata anche chiederci perché osserviamo solo corvi quando vogliamo confermare l’ipotesi “tutti i corvi sono neri”. Vlu in fin dei conti significa semplicemente “prima verde e dopo un periodo stabilito blu”. Potrei sostenere semplicemente che il paradosso di Goodman porta a una situazione indecidibile perché gli aggettivi in qualsiasi lingua umana non sono caratterizzati da un istante t (che determina il cambiamento di questo o quello oggetto). Si può però dire che un oggetto è mutevole. L’aggettivo “mutevole” indica genericamente che quell’oggetto può subire dei cambiamenti o delle trasformazioni nel tempo. Mutevole però indica una qualità dell’oggetto. Ci dice che genericamente quell’oggetto cambia sempre. Il vlu invece ci dice che quell’oggetto dopo un certo istante t da verde diventerà blu. Ci dà due informazioni precise. Nessuna lingua umana contempla un aggettivo, che sia predittivo ed esatto. Inoltre un unico aggettivo ci dà due informazioni: quell’oggetto fino ad un certo istante t sarà verde e poi diventerà blu. Pensiamo per un attimo a quanti concetti e a quante relazioni ci vogliono per definire il vlu. Ci vuole il concetto di cambiamento, il concetto di colore, la definizione di verde, la definizione di blu, il concetto di tempo, l’avverbio di tempo “prima”, l’avverbio di tempo “dopo”, la conoscenza dell’istante t, la relazione tra il colore verde e l’avverbio di tempo “prima”, la relazione tra il colore blu e l’avverbio di tempo “dopo”. L’aggettivo “mutevole” invece richiede solo due concetti: il cambiamento e la forma. Potremmo quindi ritenere che nell’aggettivo vlu ci sia un eccesso di senso, un surplus di informazioni. Gli aggettivi qualificativi di solito sono più vaghi. Almeno nella lingua italiana ci forniscono la qualità di un oggetto o di un soggetto. Niente altro. Se si vuole fare una frase di senso compiuto comprendendo anche il tempo - è banale dirlo - utilizziamo gli avverbi di tempo e non gli aggettivi. Il vlu è un concentrato di concetti. Nasce da un paradosso linguistico perché almeno nella lingua italiana è un aggettivo (il vlu), che comprende anche due avverbi di tempo e altre cose. Allora bisogna chiedersi perché utilizziamo gli avverbi di tempo e non il vlu? Facciamo così, parliamo così. Probabilmente per economizzare le nostre risorse cognitive. Probabilmente se dovessimo estendere il vlu a ogni qualità e a ogni colore e a ogni trasformazione la nostra memoria a breve termine andrebbe a fottersi. E’ così in italiano, ma è così anche in tutte le altre lingue. Non solo ma se io ammetto il vlu ammetto anche il ble. Infatti dopo che quell’istante t l’oggetto che prima era verde ora è blu, ma io devo anche presupporre che in futuro possa ridiventare verde e quindi devo ammettere anche il ble (il blu che dopo un istante t diventerà verde). Se io accetto il ble accetto anche il giasso (il giallo che prima era giallo e dopo un certo istante è diventato rosso). E così all’infinito. Ma per economia delle risorse cognitive umane nessuno si sogna di utilizzare aggettivi, che tengano conto di tutti i cambiamenti della realtà e di tutti gli istanti esatti in cui avvengono questi mutamenti. Il problema di Goodman è quindi solo di natura semantica? Assolutamente no. Se io accetto il vlu accetto non solo le proposizioni scaturite dal paradosso del mentitore (del tipo: “questa frase non è vera”), ma sono costretto ad accettare anche proposizioni come “questa proposizione è vera-falsa” oppure proposizioni come “questa proposizione è vera-falsa-priva di significato” oppure come “questa proposizione è bella-brutta”. Perché restino in piedi le classi e le classi delle classi bisogna estromettere dalle classi delle proposizioni quelle derivanti da concetti come quello di vlu. Alcuni studiosi potrebbero parlare di gerarchie linguistiche tra predicato e soggetto, altri di metalinguaggio. Russell sosteneva che paradossi come la sua antinomia e il paradosso del mentitore fossero determinati da quella che definiva una circolarità viziosa. Può darsi che anche il paradosso di Goodman dipenda da una circolarità viziosa. Non lo so con certezza. Per i filosofi medievali non esistevano questi paradossi e non esistevano quindi tutte le implicazioni annesse e connesse. Loro le consideravano senza significato. Comunque sia nel paradosso di Goodman è presente il fattore tempo (quell’istante t in cui avviene il mutamento della qualità dell’oggetto). Ma potremmo anche cambiare e considerare il fattore spazio: ad esempio un oggetto che in casa mia è verde e fuori dalla mia casa è blu. Anche in questo caso abbiamo il famigerato vlu. Anche in questo caso compaiono due ipotesi: il verde e il vlu. Ecco perché sostengo che il fattore tempo è solo un pretesto. Nell’induzione le osservazioni possono dipendere dal tempo, ma anche dallo spazio. Visto che possiamo ipotizzare e fare qualsiasi cosa nel mondo filosofico di Goodman allora possiamo pensare che le osservazioni (e l’induzione) possono dipendere da infiniti elementi. L’importante è che ci sia il cambiamento della proprietà dell’oggetto di indagine. Ci vuole questo per fare il paradosso di Goodman e per farne altre varianti. Il paradosso di Goodman si basa sull’ipotesi riguardo alla proprietà (ritenuta costante) di un oggetto. E non riguarda solo il fatto in sé (l’osservazione), ma riguarda anche come siamo fatti noi esseri umani (come percepiamo, interpretiamo e nominiamo il mondo là fuori). Il paradosso di Goodman ci dice che prima della formulazione di quell’ipotesi abbiamo osservato la realtà, abbiamo fatto delle inferenze, abbiamo individuato delle proprietà costanti di un oggetto, abbiamo fatto una classificazione successiva, abbiamo nominato e definito l’oggetto. Dopo aver fatto queste cose ora possiamo fare un’ipotesi. Dopo l’istante t se gli smeraldi saranno vlu noi faremo le nostre osservazioni, faremmo delle nuove inferenza (osserveremo mille smeraldi vlu e concluderemo che tutti gli smeraldi sono vlu), individueremo delle proprietà costanti di un oggetto, faremo una nuova classificazione (in cui per forza di cosa gli smeraldi saranno tali se sono blu). Comunque da che cosa è composto dal punto di vista epistemologico il paradosso di Goodman? Da due ipotesi. Da un lato abbiamo un’ipotesi (quella del verde), che è dovuta all’induzione e alla verificazione (e anche alla convenzione linguistica, alla credenza, alla probabilità, alla rappresentazione mentale, alla classificazione, al concetto di tipo). Dall’altro abbiamo l’ipotesi del vlu che a primo acchito sembrerebbe dipendere dalla falsificazione. Dal punto di vista epistemologico la falsificazione va preferita alla verificazione, perché sappiamo che esiste quella che viene chiamata un’asimmetria logica tra verificazione e falsificazione. Il problema però è che il vlu del paradosso di Goodman non rischia di falsificare solo il verde e il blu, ma anche le nostre invarianze linguistiche. Uno scienziato potrebbe formulare qualsiasi tipo di ipotesi, anche quelle più improbabili e addirittura quelle ritenute impossibili. Potrebbe ipotizzare che nel 2030 il verde diventerà blu, nel 2040 il blu diventerà rosso, nel 2050 il giallo diventerà viola, nel 2060 il bianco diventerà nero. Potrebbe anche ipotizzare che il verde tra due minuti diventerà blu e dopo due minuti diventerà grigio e dopo ancora due minuti diventerà rosso e dopo due minuti ancora sarà nero. La stessa cosa non vale solo per le ipotesi formulate in base al fattore tempo, ma in base ad altri fattori (ad esempio il fattore spazio). Per dirla in modo generico - se noi non accettiamo delle invarianze nell’induzione, delle invarianze nella categorizzazione e delle invarianze linguistiche - finiamo per essere sommersi da infiniti vlu e da infiniti ble (il blu che dopo un istante t diventerà verde. E se accettiamo il vlu dobbiamo accettare il suo complementare ble). Nella realtà noi cerchiamo di fare economia anche nel campo delle ipotesi. Consideriamo solo le ipotesi ritenute più probabili e non tutte quelle possibili (altrimenti ci sarebbe un proliferare di ipotesi). Ma riflettiamo sulla frase “tutti gli smeraldi sono verdi”. Dire che “uno smeraldo è verde” almeno in questo mondo fino a oggi è una tautologia in fin dei conti. Si può considerare come tale. Prima chiamo l’oggetto A (lo smeraldo) quell’oggetto che ha come proprietà B (l’essere verde) e poi dico che quell’oggetto A ha come proprietà B. Quando dico uno smeraldo è verde dico questo. Qual è il problema? Il problema è che l’ipotesi del vlu può falsificare quella tautologia. Dopo quell’istante t se l’ipotesi che si verificherà sarà quella del vlu allora potremmo dire che uno smeraldo non è più uno smeraldo. Ora io posso fare tre cose per risolvere questo problema: posso ridefinire tutti gli smeraldi in base al fatto che siano tutti blu, posso dare un nuovo nome agli smeraldi (e considerarli dei nuovi oggetti) oppure posso definire gli smeraldi in base ad altre proprietà (ritenute) costanti, non considerando più quindi il colore degli smeraldi. Posso quindi chiamarli ancora smeraldi e non nominare più il loro colore perché potrebbe cambiare da un momento all’altro. Posso chiamarli ancora smeraldi e dire che un tempo erano verdi e ora sono blu senza utilizzare il vlu. Sono possibili tutte le soluzioni. Sono le soluzioni più efficaci e più economiche. Perché dovrei utilizzare il vlu? Visto e considerato che sono a conoscenza che questi cambiamenti non avvengono che raramente (lo so dall’esperienza) posso anche cambiare il nome allo smeraldo e chiamarlo in altro modo. Posso fare in diversi modi senza utilizzare il vlu. Inoltre prima ho scritto che il vlu sembrerebbe falsificare il verde. Ma se analizziamo bene la questione dal punto di vista linguistico potrebbe essere così, ma non dal punto di vista metodologico. Dopo il 2030 gli smeraldi potrebbero diventare verdi o vlu. Io però dopo il 2030 ho bisogno dell’induzione (come prima del 2030) per constatare se gli smeraldi siano verdi o vlu. Posso trovare che molti smeraldi siano vlu, ma mi basta un solo smeraldo verde per constatare che nessuna delle due ipotesi è valida (smeraldi tutti verdi e smeraldi tutti vlu). Posso anche trovare che molti smeraldi siano verdi, ma mi basta un solo smeraldo vlu per constatare che nessuna delle due ipotesi è valida. Ho bisogno dell’induzione quindi anche dopo il 2030. Inoltre il principio di falsificazione di Popper può smentire tutte e due le ipotesi. Tutti gli smeraldi potrebbero essere vlu tranne uno che è rimasto verde oppure tranne uno che è diventato verde (tranne uno che è ble). Tutti gli smeraldi potrebbero restare verdi tranne uno che è sempre stato blu (e non ce ne siamo accorti) oppure tranne uno che è diventato blu e che prima era anch’esso verde (quindi vlu). Io non sarò mai certo che tutti gli smeraldi siano verdi o vlu dopo il 2030. Il vlu quindi dal punto di vista epistemologico non è migliore del verde. Visto e considerato che gli esseri umani hanno delle convinzioni radicate e hanno anche una certa resistenza al cambiamento perché adottare il vlu anche a livello linguistico e logico (se il vlu a livello metodologico non è migliore di come noi nominiamo i colori in questo mondo fino ad oggi?). Possiamo anche cambiare regole, ma le nuove regole non migliorano assolutamente niente.

Piattelli Palmarini ci ricorda che il filosofo Donald Davinson ha complicato ulteriormente le cose, immaginandosi degli smerazi. Gli smerazi vengono definiti come degli smeraldi che dopo un certo istante t diventeranno topazi. Piattelli Palmarini scrive di immaginarsi le implicazioni di affermazioni come “tutti gli smerazi sono vlu”. Il fatto qui si complica anche perché i topazi possono avere molte colorazioni. In questo caso può cambiare sia il soggetto che il predicato della proposizione. Ci sono molte ipotesi concorrenti dell’ipotesi “tutti gli smerazi sono vlu”. Tutte ugualmente valide dal punto di vista logico. C’è l’ipotesi “tutti gli smeraldi sono verdi”, “tutti gli smeraldi sono vlu”, etc etc. Ci sono anche le ipotesi che gli smerazi saranno di molte altre colorazioni, ma non vlu. La stessa frase “tutti gli smerazi sono vlu” a sua volta è composta dall’ipotesi (o informazione) “tutti gli smeraldi dopo l’anno 2030 diventeranno topazi” e “tutti i topazi dopo il 2030 diventeranno vlu”. Prima del 2030 potremmo considerare gli smeraldi dei semplici smeraldi oppure degli smerazi. “Tutti gli smerazi sono blu” significa che queste gemme prima erano smeraldi verdi e dopo il 2030 sono diventati topazi blu. Potremmo anche affermare che “tutti gli “smerazianti sono vlugi”. Per smerazianti posso intendere gli smeraldi che dopo il 2030 diventano topazi e dopo il 2040 diventano diamanti. Per vlugi posso intendere che il verde dopo il 2030 diventerà blu e dopo il 2040 diventerà grigio. E potrei continuare all’infinito. Ma la memoria a breve termine degli individui ha dei limiti ben noti. Apparentemente queste sono frasi semplici, ma rischiano di racchiudere troppe informazioni e/o troppe ipotesi per la nostra mente. Perché quindi non utilizzare il vlu invece del verde? Semplicemente per i limiti della mente umana. Continuando a complicare le cose potrei anche formare un unico predicato che contiene tutte le trasformazioni da un oggetto all’altro e potrei anche formare un aggettivo che contiene tutte i cambiamenti possibili e impossibili di una proprietà del predicato. La frase sarebbe assolutamente semplice dal punto di vista sintattico, ma il soggetto sarebbe costituito da migliaia di mezze parole e così anche il predicato. La domanda che si pone è: perché non utilizziamo una frase con un soggetto lunghissimo e un predicato lunghissimo per fare delle ipotesi o per trasmetterci delle informazioni? Perché invece quando facciamo ipotesi utilizziamo un linguaggio fatto di parole corte? La nostra mente procede in questo modo, perché la nostra memoria ha dei limiti. Ho fatto una ricerca singolare. Ho guardato quale era la parola più lunga del vocabolario italiano. E’ una parola impronunciabile e ha 29 lettere. Per me non è pronunciabile e penso anche per molti altri. Più dell’80% delle parole italiane sono formate da un minimo di tre lettere a un massimo di venti lettere. Qualcuno potrebbe farmi l’esempio dell’inui (la lingua parlata dagli eschimesi). Ma anche in questa lingua ci sono parole molto lunghe rispetto all’italiano, ma non sono composte da centinaia di sillabe. E invece se accettivamo il vlu non esisterebbero più limiti di lunghezza delle parole. Immaginiamoci ora parole formate da migliaia di lettere composte da sillabe di altre parole. Diventerebbe insostenibile la situazione. Non solo perché dovremmo ricordarci parole lunghissime, ma perché dovremmo utilizzare due vocabolari. In fondo noi (esseri umani del 2021) per definire il vlu abbiamo bisogno sia della parola verde che della parole blu. Avremmo quindi bisogno di una lingua madre con cui creare successivamente il vlu, il ble, etc etc. La domanda che mi chiedo è: il vlu presuppone sempre l’esistenza di una lingua preesistente? Se così fosse perché io devo utilizzare una seconda lingua che mi dà più problemi quando posso utilizzare una lingua da me ritenuta più semplice o più adeguata? Il vlu, lo smerazio, lo smeranziante sono parole composte, che mi ricordano di tutti i cambiamenti e di tutte le trasformazioni del soggetto e del predicato. Noi esseri umani abbiamo bisogno di queste parole composte se vogliamo utilizzare il vlu, lo smerazio, lo smeraziante. Un uomo che parla il vluese non esiste. Nella sua vita ha trovato oggetti che erano verdi e lui gli ha dato un nome a quel colore. Nella sua vita ha trovato oggetti che erano blu e gli ha dato un nome. Può forse definire un colore in base ai cambiamenti che questo colore ha nel tempo? Dare un nome a un colore significa porre un’invarianza linguistica. Nessuno può esimersi da questo. Il vlu quindi presuppone due invarianze linguistiche (il blu e il verde). Il colore vlu può esistere solo se esiste un linguaggio con il blu e il verde. Qualcuno potrebbe sostenere che gli uomini che parlano la lingua del vlu non hanno bisogno di parole composte. Ma non è così. Chiamiamo X la proprietà di un oggetto, che subisce dei cambiamenti. Chiamiamo Y un soggetto, che subisce delle trasformazioni. Potrei formulare l’ipotesi “tutti gli X sono Y” e tutto ciò sembrerebbe molto semplice a livello linguistico. Ma dovrei ricordarmi mentalmente tutti i cambiamenti di X e tutti i cambiamenti di Y. La memoria sarebbe sempre sovraccarica e ingolfata. In ogni caso non si va da nessuna parte con parole composte da migliaia di mezze parole e non si va da nessuna parte con una proposizione sintatticamente semplice, che contiene implicitamente centinaia di informazioni o ipotesi. In ogni caso dobbiamo ricordarci che la nostra memoria a breve termine ha dei limiti. Perché dovremmo preferire il verde al vlu? Anche per il semplice motivo che dovremmo cercare di stabilire sempre una corrispondenza tra percezione e linguaggio. Alcuni esperimenti in psicologia hanno dimostrato che alcune tinte di colori sono innominabili per qualsiasi essere umano. Quindi una corrispondenza totale non può esserci. Ma una certa corrispondenza c’è. Per la psicologia la percezione è il modo con cui organizziamo le sensazioni, gli stimoli esterni del mondo. Quando noi cerchiamo di individuare a livello percettivo la forma degli oggetti per esempio lo facciamo anche tramite delle inferenze inconsce. La percezione è data da questa interazione continua tra organismo ed ambiente. La nostra mente alcune volte convalida, altre corregge. Secondo la psicologia l’uomo ha bisogno delle costanze percettive, anche perché sono necessarie per adattarsi in qualsiasi ambiente. Faccio un esempio banale. Una tribù di indigeni sa che nei campi ci sono due tipi di serpenti perfettamente uguali nella forma, ma che hanno colore diverso. I serpenti verdi sono velenosissimi. I serpenti marroni sono innocui. Salvarsi o non salvarsi la vita dipende quindi dalla percezione del colore ed è scontato dirlo (ma è bene dirlo) dalla costanza percettiva del colore. Il verde è una invarianza linguistica, determinata da una costanza percettiva. Possiamo dire che il verde è in corrispondenza con il nostro modo di percepire i colori. Per adattarsi all’ambiente l’essere umano ha bisogno di costanze percettive e di conseguenza anche di costanze linguistiche. Che senso avrebbe avere il linguaggio sfasato rispetto alla percezione? Mettiamo che un indigeno ipotizzi che un serpente velenosissimo possa essere vlu invece che verde. A questo punto ammette qualsiasi possibilità. Ammette anche che possa essere vlugio (cioè essere verde fino all’istante X, quindi diventare blu e dopo l’istante Y diventare grigio). E così via. Diventerebbe una sorta di serpente-camaleonte nella sua testa e ciò genererebbe un eccesso di ansia e di apprensione, che lo condurrebbe all’immobilismo. Mettiamo che gli indigeni per sopravvivere debbano andare a caccia e ci rendiamo conto che questo modo di concepire la realtà sarebbe inconcepibile!!! Goodman sostenne che non si poteva risolvere il suo paradosso utilizzando la nozione di adattamento. Da un certo punto di vista è vero: quali sono le cose che mi permettono di creare queste costanze percettive se non la pratica e l’esperienza? Però bisogna anche ammettere che queste costanze percettive a loro volta ci permettono di adattarci al mondo a differenza del modo di percepire-nominare la realtà in vlu o in vlugio. Goodman ci insegna che esistono l’io e il mondo e che non sapremo mai dove finisca l’io ed inizi il mondo e dove finisca il mondo e inizi l’io. Il paradosso di Goodman ci insegna che c’è una base di partenza di noi esseri umani e che noi agiamo partendo sempre da lì. Non possiamo fare altrimenti. Ma la nozione di adattamento ci aiuta a capire come le nostre basi di partenza si accordano o meno al mondo. Se al posto degli smeraldi utilizziamo i serpenti velenosi ci accorgiamo che non solo noi preferiamo il verde piuttosto che il vlu in base alle nostre basi di partenza innate, ma anche in base alla nostra interazione continua con il mondo. Ma non c’è solo questo. Se io ammetto il vlu - serpenti o non serpenti, smeraldi o non smerald i- ammetto anche qualsiasi tipo di ipotesi possibile e impossibile. Noi scegliamo quindi le ipotesi più probabili? Se le intendiamo come ipotesi più probabili dal punto di vista soggettivo, allora senza ombra di dubbio. Sappiamo però che se accettiamo il vlu rischiamo di passare tutta la vita a formulare ipotesi. Una selezione delle ipotesi quindi ci vuole. Buona o cattiva che sia. Se tutta l’umanità fosse in preda all’immobilismo si estinguerebbe la razza umana. Che cosa ci permette di creare costanze percettive? Hanno ragione gli innatisti o gli empiristi? In questo caso non ci interessa. Molto probabilmente individuare delle costanze percettive dipende prima di tutto dalla nostra struttura cerebrale. Ma la cosa più importante è che le costanze percettive abbiano una funzione adattiva dell’essere umano all’ambiente. Di solito esiste una “discreta” corrispondenza tra percezione e linguaggio. Non deve esserci una corrispondenza totale tra percezione e linguaggio, ma non deve esserci nemmeno nessuna corrispondenza. Perché? Perché siamo fatti così. Tra percezione e linguaggio c’è una corrispondenza non totale e non può essere altrimenti per noi esseri umani. Allora perché adoprare il vlu quando non risponderebbe a queste esigenze primarie di sopravvivenza? Perché dovremmo avere un linguaggio sfasato rispetto alla percezione? Il paradosso di Goodman sembrerebbe farci capire che fare in un modo o fare in un altro è uguale. Ma se cerchiamo di estendere il concetto di vlu a ogni possibile ipotesi (trasformazione o cambiamento) ci accorgiamo che la mente umana preferisce il verde al vlu a causa dei limiti della propria memoria a breve termine. Per noi esseri umani il verde e il vlu possono essere ipotesi ugualmente valide dal punto di vista logico, ma non possiamo considerarle ugualmente valide da un punto di vista linguistico. Abbiamo i nostri limiti. Questo naturalmente non vuol dire che l’evoluzione della specie umana non continui e non ci siano in futuro altri uomini che preferiranno il vlu. Questo naturalmente non vuol dire che nell’universo non ci siano extraterrestri più evoluti rispetto a noi, che utilizzino il linguaggio del vlu. Con queste mie osservazioni non penso assolutamente di aver risolto il paradosso di Goodman. Sono abbastanza fesso, ma non fino a questo punto. Con queste mie osservazioni ho voluto solo precisare alcune cose. Per esempio alcuni formulano il paradosso di Goodman prendendo come esempio una tribù di indigeni, che parla il vluese. A mio avviso nessun essere umano fino ad oggi ha parlato e può parlare il vluese a causa di certi limiti mentali di noi esseri umani. Dovrebbero piuttosto parlare di esseri superiori alieni, che parlano il vluese. E ora vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale. L’epistemologia in Inghilterra e in America viene intesa come lo studio della conoscenza umana, mentre in Italia viene considerata come metodologia della ricerca scientifica. Il paradosso di Goodman ci dimostra che per una seria analisi della metodologia della ricerca scientifica gli scienziati e i filosofi della scienza devono occuparsi seriamente anche dell’analisi del linguaggio. E’ questo che il paradosso di Goodman ci invita a fare. Su questo paradosso, che riguarda la scienza e anche il linguaggio, sono stati versati fiumi di inchiostro. Nessuno lo ha risolto e non è detto che qualcuno in futuro possa risolverlo (e sono passati decine di anni). Con questo suo paradosso Goodman sferrò un attacco decisivo al neopositivismo logico del circolo di Vienna. La metodologia scientifica sembrava basarsi fino ad allora sul principio di causalità, sull’induzione, sul principio di verificazione. A distruggere il determinismo e il causalismo filosofico (secondo cui ogni cosa era allo stesso tempo causa ed effetto di qualche altra cosa) ci pensò Heisenberg. Quello che ci interessa sapere a riguardo è che con il suo principio di indeterminazione dimostrò che non si poteva stabilire contemporaneamente la posizione e la quantità di moto di una particella. Ma non c’era solo questo. Le scoperte di Heisenberg avevano anche altre implicazioni. Per esempio si poteva dedurre che un osservatore (uno strumento scientifico oppure uno studioso di scienze umane) interagiva con l’oggetto di indagine e quindi in un certo qual modo interferiva. Dopo il principio di indeterminazione di Heisenberg crollò la certezza di stabilire con esattezza delle relazioni lineari di dipendenza tra due eventi. I filosofi invece che criticarono in modo serrato l’induzione e il principio di verificazione furono soprattutto Popper e Goodman. Quest’ultimo molto probabilmente ideò questo celebre paradosso per attaccare l’induzione ed invece finì per mettere in crisi l’intera epistemologia. Il paradosso di Goodman è una sorta di violazione del principio di non contraddizione della proposizione. Se io ritengo che possa esistere una cosa che allo stesso tempo è e non è allora violo il principio di non contraddizione. Goodman scatena un putiferio con un solo aggettivo: il vlu. Il vlu è ciò che è verde e dopo un certo periodo di tempo potrebbe diventare blu. Ecco allora che gli smeraldi fino ad allora considerati da noi tutti verdi finiscono per essere e non essere. Il verde è una qualità costante dello smeraldo. Ma se il verde diventa vlu gli smeraldi per il linguaggio umano sono e non sono allo stesso tempo, almeno fino a quando non ci decidiamo di cambiare nome agli smeraldi oppure fino a quando non decidiamo di definirli in base ad altre qualità. Visto e considerato che trattare questo paradosso è molto complesso fino ad ora ho cercato di essere più chiaro possibile. Potremmo essere più filosofici e affermare che il vlu è un elemento metalinguistico della proposizione “tutti gli smeraldi sono vlu”. E se ci pensiamo questo potrebbe anche essere un modo per approcciare il problema. “Tutti gli smeraldi sono vlu” significa che “tutti gli smeraldi sono verdi fino al 2030, ma dopo il 2030 saranno tutti verdi”. E poi avete notato una cosa? Il verbo. Quando utilizziamo il vlu condensiamo due ipotesi e mettiamo il verbo “sono”. In realtà gli smeraldi sono blu e dopo il 2030 saranno verdi se è vera questa ipotesi. In realtà gli smeraldi vlu sono e saranno allo stesso tempo. Il vlu implica che gli smeraldi “sono e saranno”. Potrei quindi sostenere che in ogni lingua umana esiste almeno un passato, un presente e un futuro. Noi esseri umani abbiamo bisogno in ambito linguistico di distinguere tra passato, presente e futuro. Siamo fatti così. Se io ammetto il vlu ammetto anche la confusione temporale. Noi esseri umani non possiamo permettercelo. Potremmo anche pensare che quel vlu non sia che metalinguaggio condensato.

E ora una riflessione di carattere più generale. Kuhn aveva parlato già di “sfondo fornito dai paradigmi” quando descriveva la “scienza normale”, che cercava di risolvere i rompicapi. Popper aveva controbattuto sostenendo che si doveva disfarsi del “mito dello sfondo” e che lo sfondo poteva venire superato di volta in volta. Goodman con il suo celebre paradosso è riuscito a mettere in crisi non solo lo sfondo determinato dai paradigmi. E’ riuscito a mettere in crisi anche lo sfondo fornito dal linguaggio comune (qualsiasi tipo di linguaggio), dagli schemi mentali umani, dalle credenze e dalle costanze umane: lo sfondo fornito dal nostro modo di esperire e concepire la realtà. Molto probabilmente ci vorrebbe un essere di un altro pianeta per superare questo paradosso: un altro essere con un altro sfondo che riesca a vincere questo nichilismo degli sfondi. Il paradosso di Goodman non mette in crisi una “nicchia” culturale o scientifica. Mette in crisi tutto lo sfondo della conoscenza umana. Ci fa capire che gli esseri umani non possono uscire dai limiti e dalle possibilità del loro linguaggio. Forse l’unico tentativo per arrestare provvisoriamente questo paradosso è attaccarsi al caro vecchio nominalismo. Prendere per buono il fatto che possiamo individuare delle proprietà degli oggetti e ritenerle costanti. Qualcuno potrebbe chiedermi: come fanno gli esseri umani a rilevare queste proprietà? Oppure potrebbe chiedermi: ma per una tribù di indigeni il vlu non potrebbe essere considerato una proprietà costante di un oggetto? Allora io risponderei: non mi importa come gli esseri umani rilevano le proprietà e se una proprietà è più o meno semplice da rilevare di un’altra. E aggiungerei: mi importa il fatto che gli uomini individuino delle proprietà, che ritengono costanti. A questo punto sorge una domanda: su quali basi gli uomini ritengono costanti delle proprietà? E’ questo che in fondo ci domanda il paradosso di Goodman. Molto probabilmente lo fanno tramite l’induzione. Ma per tentare di arrestare provvisoriamente il paradosso di Goodman mi può bastare anche dimostrare che tutti gli esseri umani hanno bisogno dell’induzione, delle costanze linguistiche, di classificare oggetti in base a delle proprietà ritenute costanti. A mio avviso nessun uomo può parlare il vluese per tutta la vita e instaurare una corrispondenza tra linguaggio e realtà parlando il vluese. Non può farlo perché il vlu non definisce la proprietà (ritenuta) costante di un oggetto. Almeno per gli uomini di quest’epoca. Tra migliaia di anni non lo so. E ora concludo…..perché quindi non dobbiamo accettare il vlu? Perché sarebbe il nichilismo del linguaggio (è quello che più mi interessa) almeno per noi esseri umani del 2021. Ma è possibile combattere il nichilismo del linguaggio soltanto tramite il linguaggio? Molto probabilmente è impossibile. Goodman che era uno dei più grandi filosofi del ‘900 creò questo paradosso, ma è morto senza risolverlo. Fino ad oggi nessuno lo ha risolto.
lug 042022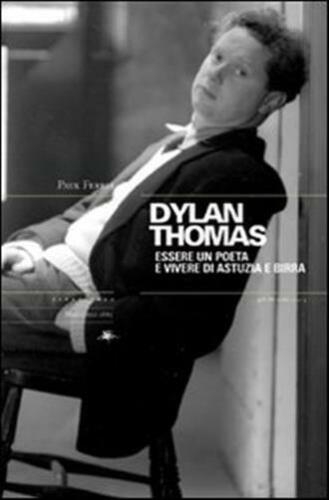
Quest’opera è una biografia del grande poeta Dylan Thomas, che nacque nel 1914 nel Galles e morì in America nel 1953. L’ultimo capitolo del libro sembra far chiarezza in modo definitivo sulle cause della morte del poeta gallese. L’ipotesi più accreditata è che non fu il delirium tremens scaturito dai 18 whisky ingurgitati a causarne il decesso, ma un’eccessiva dose di morfina somministrata dal medico. Il biografo cerca innanzitutto di distinguere gli episodi realmente accaduti da tutta una serie di leggende, aneddoti e dicerie riguardo all’eccentrico Dylan Thomas. D’altronde accade spesso nel caso di grandi poeti, che hanno fama postuma e imperitura. Se poi aggiungiamo che Thomas non è solo ricordato per le sue poesie immortali, ma anche per il fatto che il cantautore Robert Zimmerman ha utilizzato il nome d’arte Bob Dylan per rendergli omaggio, si capisce perché le leggende siano fiorite ad iosa. Nel libro non viene presa in esame la poetica di Thomas. Nessun cenno alle liriche visionarie, agli schemi metrici, alle analogie che gli procurarono la gloria. Nessuna analisi accurata sulla poesia che cercava di “penetrare la chiara nudità della luce”. Piuttosto possiamo leggere alcuni inediti, tra cui le sue prime incerte liriche. Da questi scritti si può arguire che Thomas fu un poeta molto precoce. Inizialmente i pareri della critica letteraria riguardo alle sue poesie furono discordanti. Vengono anche riportate le testimonianze degli amici e i brani più significativi delle lettere scritte alla moglie. Da questa biografia scopriamo quindi alcuni lati della personalità del poeta. In fondo la sua poesia traeva linfa proprio dalla sua personalità. Un amico del poeta dichiarò che Thomas non faceva altro che costruire e riassemblare la sua personalità incessantemente. Infatti Dylan Thomas dichiarò: “Dentro di me albergano una bestia, un angelo e un pazzo, la mia indagine riguarda le loro opere, il mio problema è soggiogarli vittorioso, scaraventarli a terra e risollevarli, la mia fatica è la loro espressione”.

Dylan Thomas morì a soli 39 anni. Ebbe una vita breve, ma intensa. Visse spesso di espedienti. Fu un clown per gli amici e un assiduo frequentatore di pub e di bordelli. Quando era in comitiva amava sempre essere al centro dell’attenzione. Fu un accanito fumatore e probabilmente soffrì di asma. Per alcuni fu solo un compagno di sbronze, uno che beveva come una spugna. Certamente amava la “compagna bottiglia”, ma il biografo non riesce a stabilire esattamente, dopo aver raccolto molte testimonianze in proposito, se fosse un forte bevitore o un vero alcolizzato. Fu un clown per molti amici. Essendo spesso squattrinato approfittò spesso di loro, chiedendo ospitalità e dormendo spesso sui loro divani. Fu un pessimo studente, nonostante suo padre fosse un insegnante della scuola in cui studiava. Fu cronista locale, ma venne licenziato. Per un periodo visse a Londra, frequentando pseudoartisti e pseudorivoluzionari. Fu sregolato e a tratti si ha la netta impressione che fosse indifferente a tutto (anche alla guerra), tranne che alla propria arte. Si sposò con Caitlin: una ragazza disinibita, piacente, infedele, amante del ballo, inquieta, litigiosa, spesso ubriaca. Alcune incomprensioni nacquero anche perché lei proveniva da una famiglia aristocratica e si disinteressava totalmente di ciò che dicevano vicini e conoscenti, mentre invece il grande poeta gallese - essendo di estrazione borghese - cercava di non dare adito ai pettegolezzi, pur vivendo anche lui di eccessi. Sua moglie odiava i piccoli paesi perché a suo dire nelle piccole comunità vigeva una mentalità ristretta e retrograda, mentre Thomas - pur essendo cosciente di ciò - riteneva che in un borgo poteva fare vita più sana e essere più concentrato per scrivere. Caitlin inoltre era un’aspirante artista e non voleva accontentarsi di essere solo e semplicemente la moglie del poeta. Un’estate andarono in vacanza all’isola d’Elba, ospitati dall’intellettuale Luigi Berti. Passarono anche qualche giorno nei pressi di Firenze, ma da ciò che Thomas scrisse nelle lettere si deduce che non si trovò affatto a suo agio. Molti intellettuali americani e italiani volevano incontrarlo e ciò lo infastidiva. Si guadagnò da vivere per alcuni anni scrivendo le sceneggiature di documentari per il cinema. Per un periodo lavorò anche alla BBC. Infine si recò in America in quanto il direttore del Poetry Center dell’associazione giovani ebrei di New York era disposto a pagarlo perché tenesse conferenze e readings. Questa opera è quindi una biografia rigorosa, accurata e per niente romanzata di uno dei più grandi poeti inglesi e del secolo scorso.
giu 302022

La letteratura è minacciata dalla comunicazione di massa, al punto che Montale nel suo discorso per il Nobel nel 1975 si domanda se in una società di massa possa sopravvivere la poesia e conclude così: "Si potrebbero moltiplicare le domande con l’unico risultato che non solo la poesia, ma tutto il mondo dell’espressione artistica o sedicente tale è entrato in una crisi che è strettamente legata alla condizione umana, al nostro esistere di esseri umani, alla nostra certezza o illusione di crederci esseri privilegiati, i soli che si credono padroni della loro sorte e depositari di un destino che nessun’altra creatura vivente può vantare. Inutile dunque chiedersi quale sarà il destino delle arti. E’ come chiedersi se l’uomo di domani, di un domani magari lontanissimo, potrà risolvere le tragiche contraddizioni in cui si dibatte fin dal primo giorno della Creazione (e se di un tale giorno, che può essere un’epoca sterminata, possa ancora parlarsi)".
La letteratura è amplificata, potenziata, ma in parte deformata e resa un poco asettica dal web. Siamo sicuri che la critica non diventerà giornalismo? Il significato non prevarrà sul suono, il segno sul simbolo, l'algoritmo sul mito?
La letteratura italiana è inoltre diventata poca cosa, relegata ai margini con il dominio dell'inglese. Siamo una provincia dell'impero anglofono. Non siamo neanche più una riserva. La lingua italiana arricchita o divorata dagli inglesismi? Avrà ancora modo di esistere la letteratura italiana?
La poesia che relazione può avere con la tradizione (a chi deve rifarsi uno scrittore? Con chi deve essere uno scrittore stilisticamente e letterariamente? Oppure deve pensare: "toglietemi la storia, sennò da dove ricomincio?" come negli anni '70 scrisse Milo De Angelis)? Bisogna guardare "Conversazioni su Tiresia", monologo di Andrea Camilleri e poi magari decidere, anche se per Eliot la tradizione e il talento individuale dovrebbero sempre interagire.
Ha più senso scrivere? Cosa può comunicare oggi uno scrittore? Essere per esempio irregolari e di nicchia può servire a qualcuno? Probabilmente né agli altri né a sé stessi. Comunicare la propria incomunicabilità spesso significa parlare da soli contro un muro e sentire l'eco delle proprie parole. Niente altro che questo. E se uno invece vuole arrivare alle masse finisce di solito per non fare letteratura. In ogni caso spesso non vengono salvaguardati né lo scrittore né la letteratura.

"Duchamp diceva: se un oggetto a tre
dimensioni proietta un'ombra a due,
dovremmo immaginare quell'ignoto
oggetto a quattro dimensioni di cui noi
siamo l'ombra. Da parte mia, mi affascina la
ricerca dell'oggetto a una dimensione che
non getta ombra".
Octavio Paz da "Corrente alterna"
Forse l'oggetto a quattro dimensioni di cui teorizzava Duchamp è ciò che ci trascende, ovvero Dio. Meglio rasentare terra col nostro volo, direbbe Bob Dylan. Quindi è del tutto legittima la ricerca di Paz dell'oggetto a una dimensione che non getta ombra. Ma noi esseri umani percepiamo il mondo in modo tridimensionale grazie alla superficie bidimensionale della nostra retina. La quarta dimensione ci sfugge, ma anche una sola dimensione ci sfugge. Una sola dimensione è al di sotto della nostra soglia di coscienza. Noi non possiamo percepirla come gli ultrasuoni, che invece sentono i cani. Noi non abbiamo neanche gli occhi mirifici della mosca. Certe cose sono precluse alla nostra percezione. Lo scrittore deve perciò fare riferimento a un'altra dimensione inaccessibile? Non è chiedere troppo? Forse è troppo. È un dato di fatto. Dobbiamo accettarlo. Non possiamo farci niente, a meno che l'oggetto a una dimensione che non getta ombra non debba intendersi come l'inconscio (non totalmente attingibile) o il nostro Sé (sfuggente). La vera letteratura potenzialmente si dovrebbe confrontare con tutto ciò? E se scrivere significasse gettare un ponte sull'assurdo?

Houellebecq scrive che l'uomo contemporaneo legge perché "ha bisogno di altre vite, diverse dalla sua, semplicemente perché la sua non gli basta". Leggere significa quindi avere un arricchimento esperienziale. Di solito ci arricchiamo con le parole, i pensieri, la fantasia degli scrittori morti, difficilmente degli autori contemporanei. Ma come affrontare il mondo? Con la crudezza anche se con la penetrazione psicologica di Houellebecq, che talvolta finisce nella provocazione fuori luogo e nelle forzature estremistiche? Oppure con il rigore morale di Dante, che addirittura si erge a giudice delle azioni altrui, ma anche con la sua grazia e la sua leggiadria, come per esempio in queste terzine del primo canto del Purgatorio, in cui descrive come si lascia alle spalle l'inferno. In queste terzine è Virgilio che pulisce il viso di Dante con la rugiada:
Quando noi fummo là ‘ve la rugiada
pugna col sole, per essere in parte
dove, ad orezza, poco si dirada, 123
ambo le mani in su l’erbetta sparte
soavemente ‘l mio maestro pose:
ond’io, che fui accorto di sua arte, 126
porsi ver’ lui le guance lagrimose:
ivi mi fece tutto discoverto
quel color che l’inferno mi nascose.

La prima cosa che il potere vuole è interferire su quelli che Lewin chiamava “campi di forza”. Anche questo è un modo per imbrigliare le carte, per confonderci interiormente. È sempre più difficile trovare il modo, lo spazio e per molti il tempo di concentrarsi, di riflettere. Anche molte persone che svolgono professioni intellettuali non ci riescono e delegano perciò a intellettuali riconosciuti il compito arduo di pensare. Però a molti cittadini oltre alla possibilità di riflettere sul mondo manca la possibilità di riflettere, di meditare sulla propria psiche, sulla propria vita; per questo chiedono aiuto a un/a analista. In poesia spesso è il testo che ci fa da analista. Oppure paziente e analista coesistono in noi stessi all’interno della scrittura, della valutazione, della censura, della revisione. In poesia uno può dar libero sfogo al suo materiale spurio psichico, così come può controllare l’inconscio. Ma l’inconscio non si può rimuovere totalmente: qualcosa sfugge sempre. Esprimere il proprio inconscio oltre che una rispettabile scelta artistica è anche un atto di libertà interiore, per alcuni addirittura una necessità interiore.
Un’altra cosa che il potere vuole fare è imporre un immaginario e un inconscio collettivo che sovrasti totalmente sull’inconscio individuale. Ho già espresso a più riprese questo concetto: l’inconscio collettivo attuale non ha più archetipi decenti perché mass media, moda, cinema, televisione non sono più mitopietici come un tempo lo era la letteratura. Oggi gli archetipi propinati sono tutti negativi. È anche questo un modo per renderci senza principi, per farci mancare punti fermi e terreno sotto i piedi. Ma non c’è solo questo. Andiamo oltre.
“Se la funzione alfa non agisce sulle percezioni, ad esempio emozioni dolorose, allora l’esperienza viene espulsa, mediante un’attività pilotata dall’angoscia. Una paziente diceva: “non mi sono dovuta alzare per andare in bagno, nel bel mezzo della notte, perché ho fatto un sogno”. Intuitivamente riconosceva che il sogno trattiene qualcosa in modo che non si debba evacuare precipitosamente. Bion chiama questi elementi che non possono essere trattenuti nella mente elementi beta. […] Sono non-digeriti e danno la sensazione di essere cose-in-sé. Come corpi estranei all’interno della mente. Sono solo adatti ad essere evacuati perché non li si può pensare. Sono persecutori: pezzi di scarto dei quali la mente vuole sbarazzarsi; secondo il principio di piacere quel che provoca disagio viene espulso.” (Symington J e N. (1996), Il pensiero clinico di Bion, Raffaello Cortina, Milano, 1998. [p. 68]). Il potere tramite mass media, moda, pornografia non vuole che metabolizziamo gli oggetti del nostro desiderio. Non vuole che li comprendiamo, che li interiorizzamo globalmente, che li rielaboriamo criticamente e consapevolmente. Per Kernberg in questo modo non siamo più in grado come un tempo di “integrare le parti buone con quelle cattive”. Il potere vuole da noi la scarica, l’acting out senza naturalmente che mai avvenga l’abreazione. Così facendo il potere cerca di ridurre la funzione alfa e di aumentare gli elementi beta. La funzione alfa digerisce tutto ciò che è psichicamente negativo. Bion usa proprio la metafora della digestione. Il desiderio non è che una delle tante cose umane su cui agisce la funzione alfa. La poesia è funzione alfa allo stato puro. Ecco perché la poesia dà noia al potere e i mass media rivolgono un’attenzione insufficiente nei confronti della poesia. La poesia è conoscenza e comunicazione dal nostro profondo al profondo altrui ed è per questo che dà noia al potere, che ci vorrebbe conformisti, frivoli, superficiali, consumistici.
A ogni modo lo scrittore non può autoesaltarsi. Dovrebbe essere contro il potere. Dovrebbe denunciare il disastro ecologico, le ingiustizie economiche. Dovrebbe fare denunce sociali e/o esprimere disagio esistenziale. Ci si potrebbe accontentare quando non tratta delle grandi assurdità della vita e del mondo se riesce a mostrare quelle piccole, come un turista, che da dieci anni non va in ferie e quando va in vacanza è costretto a stare tutto il tempo in albergo a causa del maltempo, oppure come una donna che porta con sé il suo bambino, gli mette anche il casco, e poi attraversa con il rosso.
Ma non scordiamoci che l'uomo sarà sempre un "animale simbolico" come lo definì Cassirer e inoltre anche Goethe nel Faust scrisse: "Tutto ciò che passa è solo un simbolo; l'inattingibile, qui si fa evento; l'indescrivibile, qui ha compimento; l'Eterno Femminile ci fa salire".

La scrittura, anche quella di infimo livello (come la mia) è memoria o suo tentativo goffo, maldestro. Quando scrivo mi ricordo, cerco di ricordarmi. Ma cosa? Per quel che mi riguarda è ricordarmi all’improvviso di pomeriggi afosi ed estivi in una stanza d’albergo in una località imprecisata del lago di Garda oppure di una delle tante sere sulla soglia dell’ingresso a guardare la vita della piazza in attesa di chiudere la cassa e il negozio. È ricordarmi all’improvviso di tutto il tempo perso a rigirarsi nel letto, rimuginando in un mix quasi letale fantasie erotiche e frustrazioni sessuali. Ricordarmi scene di vacanze da bambino o da adolescente sotto l’ombrellone a Cecina oppure al bagno Trieste a Rosignano. Ricordarmi da giovane delle mie notti brave e poi il tempo passato in sala di attesa ad aspettare il treno del mattino, che mi riportava a casa. Ricordarmi tutte le notti insonni e i giorni sonnambuli da giovane. Ricordarmi i viaggi di due/tre giorni fatti con mio padre, a giro per l’Italia e pensare che forse non andremo mai a visitare Matera o che non ritornerò più nelle Marche o all’Aquila. Ricordarmi le cene con gli amici in varie località d’Italia, amici persi, mai più rivisti. Ricordarmi i pochissimi amori e i tanti rifiuti, le delusioni cocenti. Ricordarmi le ore distratte a leggere libri da studiare e le lezioni frequentate svogliatamente. Ricordarmi il vocio indistinto di una strada principale del centro o il brusio in una osteria. Ricordare i viaggi in treno, le impressioni guardando fuori dal finestrino, le viaggiatrici nello stesso scompartimento, i giochi di sguardi, le conversazioni, i silenzi. Ricordare tutte le passanti che abbiamo guardato e che non ci consideravano minimamente. Ricordare le passeggiate col mio cane, con mia madre al parco dei Salici o alla Sozzifanti. Ricordare tutti i sogni, le aspirazioni, i voli pindarici, le albagie, le illusioni, alcuni dichiarati, altri mai minimamente confessati, tutti abbattuti dalla realtà, dalla ragione, dall’età. Ricordare tutti i viaggi, tutte le città che ho visto. Ricordare tutte le nostre metamorfosi, le nostre idee, i nostri sentimenti, la nostra rabbia, le nostre malinconie, i miti creduti. Ricordare tutti gli omicidi, le scene di violenza reali o fittizie a cui abbiamo assistito alla televisione o su Internet. Ricordare tutti i libri letti e accorgersi che è rimasto solo un senso implicito, una conoscenza implicita. Ricordare le astrazioni, gli intellettualismi che non servono a proteggersi dai colpi bassi della vita né a fare da schermo per non mettersi a nudo. Ricordare che nessuna opera d’arte rende la vita fedelmente così come è. Ricordare della maturità acquisita, della pochissima arte, della insipida e scontata saggezza. Ricordare della teoria che si fa esperienza di vita e dell’esperienza di vita che si fa teoria. Ricordarmi di tutte le nozioni apprese, interiorizzate e poi lasciate andare, perdute per sempre. Ricordarmi tutte le nostre conversazioni, le frasi dette agli amici, ai familiari, frasi di circostanza, spesso di convenienza e chiedersi quanto fosse di vero, di autentico in tutte le parole dette e scritte (ma solo io, nessun altro cretino, posso stabilire se siano autentiche o meno le mie parole e forse nel momento in cui le ho scritte o proferite erano autentiche). Ricordare tutte le persone sfiorate, intraviste e tutte le persone conosciute, apparentemente in modo profondo, ma che non abbiamo mai afferrato, mai colto totalmente. Ricordare e dopo aver fatto notevoli sforzi di memoria capire che probabilmente tutto ciò che era più importante ci è sfuggito, è passato dalle maglie della memoria, si è involato chissà dove. Quale archivio disordinato e immenso di cianfrusaglie, di cose squallide è la memoria di ognuno! Fatico a trovare un senso a tutto questo, anzi sarò più sincero: non lo trovo assolutamente. Lo smemorato di Collegno e il Funes di Borges sono due facce della stessa medaglia. L’ippocampo serve per l’apprendimento, ma poi ci vuole la reiterazione per conservare tutto a lungo termine. La memoria talvolta degenera fino alla malattia degenerativa, ma non improvvisatevi neurologi! Si può vivere senza ricordare? Ogni sera prima di addormentarci facciamo il riepilogo spesso del giorno trascorso. Si può ricordare senza vivere? Non ci si può limitare a ricordare senza più vivere perché ricordare non è vivere ma tutt'al più rivivere. Memoria e vita sono legate a doppio filo, ma forse il loro impasto è sadico, crudele, eppure così raffinato. Alcuni perdono memoria e altri si perdono nella memoria. Ci vorrebbe un uso saggio della memoria per vivere! Ma non ci sono leggi certe perché ogni vita, ogni memoria hanno le loro regole. Aveva ragione Proust: la selezione, l’archiviazione, il richiamo della memoria è grosso modo involontario. Do ragione a Proust senza erigere una cattedrale della memoria come fece lui perché non ne avrei il genio né ne scorgerei la benché minima utilità: non frequentai la crema della crema della società come fece lui. Ho in mente solo piccoli ricordi, minuscoli pensieri, pronti a ogni evenienza, spesso adibiti a scacciare la noia. Francamente ammettiamolo pure: ognuno di noi nel profondo conserva una certa ossessività, ritornano nella sua mente, anche quando essa è libera di scorrazzare liberamente, sempre le solite immagini ricorrenti.
giu 302022
Riguardo al mito di Teuth: "O ingegnosissimo Theuth, c'è chi è capace di creare le arti e chi è invece capace di giudicare quale danno o quale vantaggio ne ricaveranno coloro che le adopereranno. Ora tu, essendo padre della scrittura, per affetto hai detto proprio il contrario di quello che essa vale. Infatti, la scoperta della scrittura avrà per effetto di produrre la dimenticanza nelle anime di coloro che la impareranno, perché fidandosi della scrittura si abitueranno a ricordare dal di fuori mediante segni estranei, e non dal di dentro e da se medesimi: dunque, tu hai trovato non il farmaco della memoria, del richiamare alla memoria. Della sapienza, poi, tu procuri ai tuoi discepoli l'apparenza e non la verità: infatti essi, divenendo per mezzo tuo uditori di molte cose senza insegnamento, crederanno di essere conoscitori di molte cose, mentre come accade per lo più, in realtà, non le sapranno; e sarà ben difficile discorrere con essi, perché sono diventati portatori di opinioni invece che sapienti.»
(Platone, Fedro)
Sant’Agostino si stupì quando vide Sant’Ambrogio che leggeva non a voce alta ma silenziosamente. Il dialogo permette una maggiore interattività e una maggiore reattività. Le lezioni degli insegnanti servono anche a questo. Si può ricorrere maggiormente alla metacomunicazione; si possono avere chiarimenti, delucidazioni in modo più semplice e in tempo reale. Poi c’è naturalmente il mito di Teuth tutto a vantaggio dell’oralità, ma c’è da dire che lo stesso Platone a differenza di Socrate lasciò tutto per iscritto. La scrittura permette maggiore complessità, talvolta porta alla complicazione delle cose semplici. Però per quel che mi riguarda permette di argomentare, di approfondire, di elaborare, di rielaborare le idee, di formularle compiutamente, di ristrutturare il pensiero. Richiede più tempo e più ponderatezza. L’oralità richiede più sintesi e semplificazione. Il talk show indicato da molti come l’apice dell’intelligenza verbale sfocia invece a mio avviso nella tracotanza e nella rissa verbale. I dialoghi tra persone comuni spesso mi sembrano ricalcare i talk show, le interviste, le conduzioni televisive più che essere davvero frutto di autenticità.

La scrittura porta a maggiore riflessività, a maggiore accuratezza. L’oralità richiede più sangue freddo. Con la scrittura si possono raffreddare gli animi, si può ragionare più a mente lucida. Ma questo non significa che l’oralità sia facile e la scrittura più difficile. Entrambe hanno pro e contro, punti di forza e punti deboli. C’è un modo per cercare la verità nel dialogo come nella corrispondenza epistolare, nella scrittura. Ci sono ostacoli, inganni che si frappongono alla ricerca della verità in entrambe queste forme comunicative. La scrittura, soprattutto quella artistica e filosofica, è frutto di meditazione estenuante. I dialoghi sono spesso più approssimativi e improvvisati, specialmente quelli quotidiani. Ci sono scrittori che non sanno parlare bene perché sono introversi e/o ansiosi. Tra scrittura e oralità vinse una mistura raffazzonata come i commenti nei blog, sui social, i messaggini, etc etc. Chi sa cosa ci riserva il futuro in questo senso? Ci sarà la creazione di nuove forme di comunicazione? Oggi sembra avere la meglio l’oralità sulla scrittura: fondamentale è bucare lo schermo; un Leopardi senza oratoria, senza un eloquio veloce non sarebbe minimamente considerato. Leggere permette di entrare in contatto intellettuale con i pensieri di grandi uomini vissuti in tutti i tempi e in tutti i luoghi (come in una celebre canzone). Borges annovera tra i giusti del mondo “Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto”.

Che poi, scrittura o oralità, alla fine è importante questo, come ha scritto Gianni Rodari: “Tutti gli usi della parola a tutti: mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico. Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo”. Un poco classista invece Valentino Bompiani che scriveva: ““Un uomo che legge ne vale due”. Non sempre questo corrisponde a verità. Don Chisciotte a leggere pessimi libri impazzisce per esempio. Comunque sul furgoncino della biblioteca comunale hanno verniciato proprio questa frase. Alla frase di Bompiani fa da controcanto Rino Gaetano, il cui “fratello è figlio unico” perché “è convinto che anche chi non legge Freud può vivere cent’anni”. Io ritengo che Freud vada letto, ma poi subito dopo dimenticato per vivere meglio. Per quel che mi riguarda leggere non cambia la vita, almeno non ha cambiato la mia vita, forse l’ha addirittura peggiorata, ha contribuito a isolarmi, a peggiorare i rapporti umani. Ma forse dipende da me soltanto, mentre per altri la lettura è un mezzo di promozione sociale. Come ho scritto in un mio aforisma tempo fa (scusate l’autocitazione) la lettura fortifica l’intelligenza. Umberto Eco a favore della scrittura sostenne: “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è un’immortalità all’indietro”.

C’è una cosa però che lo scritto non darà mai ed è il calore umano, per quanto anche le parole scritte possono testimoniare vicinanza umana. Ci sono conversazioni banali quotidiane tra familiari che sono molto più importanti anche per persone ad alto coefficiente intellettuale del libro di un grande scrittore o di un filosofo memorabile, ma ci sono anche persone per cui le voci dei grandi artisti sono un bisogno insopprimibile, come un mio lontano parente di Bologna, che, pur essendo consapevole della fine, il giorno stesso della morte finì di leggere un libro. La lettura non avrebbe certo contribuito a salvargli l’anima, ma d’altronde in tutta onestà agiamo sempre per salvarci l’anima? Eppure leggeva perché ne traeva beneficio il suo animo e la sua mente. E poi chi può sapere con certezza, anche se è prossimo alla fine, che quel giorno morirà? A un colloquio di lavoro possono chiedere a un candidato quale è il suo ultimo libro letto (domanda molto sciocca), ma nessuno saprà mai quale sarà il nostro ultimo libro, l'ultimo libro della nostra vita.
giu 292022
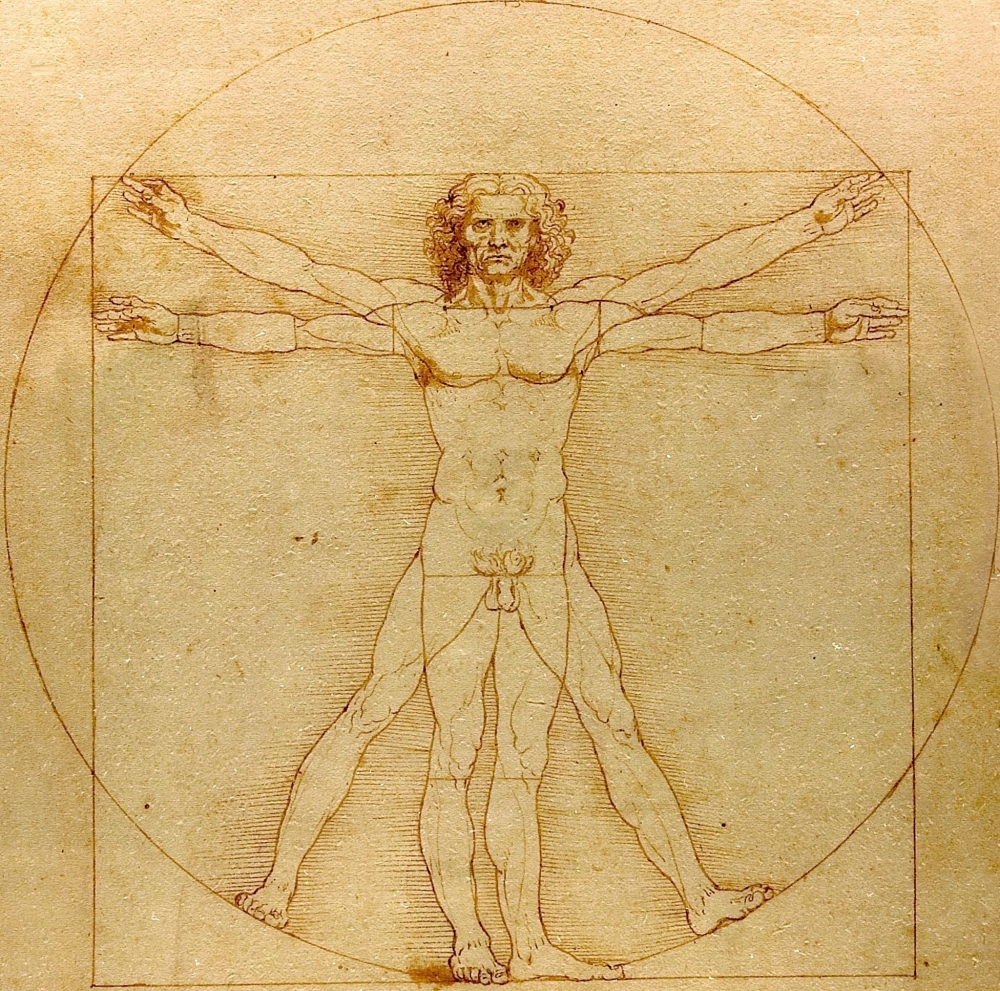
Cercherò di essere semplice e breve perché essere sintetici significa fare meno errori e inoltre come scrivevano ne "I quaderni piacentini": "poche parole=poche mistificazioni". Ma veniamo subito al nocciolo. La cultura umanistica è in crisi in Italia. È chiaro che l'umanesimo è in crisi in quasi tutto il mondo perché la razionalità scientifica ha avuto la meglio, come sostengono Husserl, Heidegger, Spengler, Junger, Emanuele Severino e molti altri ancora. Secondo queste filosofie il trionfo della tecnica è dovuto al diffondersi a macchia d'olio del nichilismo nella società occidentale. Certo anche gli umanisti possono avere le loro colpe. Possono essere stati snob, elitari, incomprensibili, oscuri, criptici, noiosi, impopolari, troppo ideologici, mentalmente disturbati, addirittura guerrafondai. Si potrebbe stare a criticare per ore l'umanesimo classico, gli umanisti e non la finiremo più! Ortega y Gasset a proposito delle avanguardie scrisse anche della "disumanizzazione dell'arte", ovvero neanche il nuovo che avanzava si salvava perché anche le avanguardie tracciavano in nome di una presunta oggettività ancora un solco tra letterati e popolo. Ma nessuno era ed è esente da colpe. Però l'Italia un tempo era Magna Grecia, antica Roma, Rinascimento. Era la culla della civiltà e dell'umanesimo. E allora perché si è per così dire imbarbarita? Una parvenza di umanesimo, comunque ancora oggi rimane. Rimane come zoccolo duro nelle scuole elementari, nelle scuole medie inferiori e superiori. Si fa leggere Leopardi già alle elementari. Alle medie si fa già "I promessi sposi". Ai miei tempi nei licei scientifici le ore delle materie umanistiche superavano di gran lunga le ore di quelle scientifiche. Oggi le cose non sono sostanzialmente cambiate. Ma era un umanesimo datato, un poco retrogrado, comunque non aggiornato (se si considera che anche la psicologia, la sociologia, la pedagogia sono umanesimo oltre che scienze appunto umane). Oggi in Italia siamo ancora alle "due culture" di Snow, ovvero scienza e umanesimo sono nettamente separati, difficilmente vengono fatti dei collegamenti, ancora più raramente vengono integrati. Non dimentichiamoci invece che la relazione tra i due saperi può essere proficua. Calvino vedeva in Galileo Galilei il più grande scrittore italiano. Ma anche la fantascienza ha fornito ipotesi e idee agli scienziati.

Un tempo c'era il boom delle iscrizioni nelle università. Anni fa anche le facoltà di lettere e filosofia erano sovraffollate. È vero che allora molto genitori "parcheggiavano" i figli all'università, sognando che conseguissero il famigerato pezzo di carta. Oggi per trovare subito lavoro bisogna essere medici, ingegneri, informatici. Dopo la pandemia c'è stato un grande calo delle iscrizioni. Un tempo anche alcuni datori di lavoro pensavano che gli "umanisti" avessero la mente più aperta, potessero impostare meglio i problemi, riuscissero a mettere meglio le cose in prospettiva, potessero avere un'opinione su tutto, fossero anch'essi in grado di apprendere il nuovo e affrontare la complessità crescenti, riuscissero a mettere in relazione le cose più disparate, avessero insomma quella che Mills definiva come "immaginazione sociologica". Oggi questa visione del mondo viene considerata superata. In un mondo tecnologico i laureati nelle facoltà scientifiche sono visti e presi, sono considerati più preparati perché hanno studiato discipline necessarie e hanno superato una selezione scolastica più dura. Gli umanisti hanno meno opportunità non solo perché ci sono meno posti di lavoro per loro ma anche perché un datore di lavoro preferisce assumere come operaio o impiegato un perito o un ragioniere a un laureato in lettere e filosofia con maturità scientifica o classica. Esiste così la cosiddetta disoccupazione "intellettuale" e anche la sottoccupazione "intellettuale". Esistono anche i casi di alcune persone che dopo aver conseguito il diploma di ragioneria con il massimo dei voti hanno rifiutato il posto in banca, a loro subito offerto, si sono laureate in una facoltà umanistica e al momento dell'ingresso del lavoro hanno trovato serie difficoltà, ovvero hanno trovato tante porte chiuse in faccia. Un laureato "umanista" può dire al datore di lavoro: "mi dia un'opportunità. Imparo in fretta". Altrettanto prontamente quest'ultimo può rispondere: "Cerco persone con esperienza e competenze. Non ho tempo di insegnare e non posso aspettare che tu impari il mestiere". Per gli economisti è questione di mismatch, ovvero domanda e offerta non si incontrano. Dicono che le università non formano le figure professionali e non danno le competenze che servirebbero nel mercato del lavoro. È anche vero però che l'istruzione, anche quella universitaria, dovrebbe formare per imparare a imparare, visto che non si può spesso prevedere ciò che sarà richiesto nel mercato del lavoro in futuro. È anche vero che molte aziende italiane investono poco per la formazione del personale così come investono poco per il settore ricerca e sviluppo. D'altronde il mondo economico italiano è fatto di piccole imprese e queste nella stragrande maggioranza dei casi non hanno le risorse e qualche volta, pur avendole, non hanno la lungimiranza di investire. Ma sul laureato "umanista" oltre a un certo discredito c'è anche il sospetto che sia uno non pratico, uno troppo teorico. Esistono diversi pregiudizi nei confronti degli "umanisti" tra cui quelli di essere troppo critici del sistema. In fondo per dirla alla Said l'umanesimo è anche critica del sistema, della sua scientificità, della sua industrializzazione, della sua managerialità. L'umanista è visto quindi oltre a uno che non è abituato a faticare anche come un sovversivo potenziale. Non solo ma a tutto ciò si aggiunga il fatto che molti piccoli imprenditori si sentono dei self made men, nutrono una sorta di complesso di superiorità nei confronti del laureato umanista, salvo poi commuoversi se il loro figlio si laurea in una disciplina anch'essa umanistica e andarne fieri per tutta la vita. Ma nessuno naturalmente è esente da contraddizioni.

La crisi dell'umanesimo in Italia è data anche dal fatto che molte librerie di paese o di periferia nella città stanno chiudendo. Quelle rimaste lavorano soprattutto con i libri scolastici. Probabilmente a rendere critica la situazione sono stati gli ebook, gli acquisti online di libri, il fatto che oggi si legge di meno. Sembrava una commedia al di fuori della realtà "C'è posta per te" nel 1998, ambientata a New York, dove un grande imprenditore di una catena di librerie metteva in crisi una piccola libreria. Il web ha condannato oggi le piccole librerie italiane. Le anime belle sostengono che quelle librerie dovevano sopravvivere grazie a dei finanziamenti statali perché erano l'anima del quartiere, il cuore di una piccola comunità, però magari loro stesse hanno fatto sempre pochissimi acquisti prima, decretandone l'insuccesso. È indubbio che ci siano dei vantaggi ad acquistare online: è più comodo, si può fare tutte le ricerche online e trovare tutti i libri da soli senza l'aiuto di nessuno. Trent'anni fa uno andava in libreria anche per vedere quello che passava il convento, i libri che erano lì in bella mostra, sempre se non ordinava dei libri e doveva aspettare di solito due settimane per ritirarli.

Alle presentazioni dei libri ci vanno sempre poche persone, a meno che non siano influencer o personaggi televisivi che pubblicano un libro.
C'è chi dice che il teatro non è in crisi, che bisogna intendere cosa significa crisi, insomma spacca il capello in quattro, fa sottili distinguo per negare l'evidenza dei fatti. In realtà la stragrande maggioranza degli italiani non va a teatro e non ha mai assistito a uno spettacolo teatrale. Secondo le statistiche ISTAT nel 2018 7 italiani su 10 non andavano nei musei. Poi le cose si sono aggravate col Covid.
I caffè letterari sono in crisi, poco frequentati come sono, e spesso i giovani ci vanno per bere, rifocillarsi, incontrarsi ma non per fare letteratura. Dove si fa letteratura oggi? Soprattutto online, anche su blog, siti letterari, social. La piazza non esiste più. Sono tutti più social e anche più asociali rispetto a un tempo. A riprova di questo fatto il nel 2018 il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della società che gestisce il caffè Le giubbe rosse. Eppure questo storico locale aveva fatto la storia della letteratura del '900. Era un luogo di ritrovo abituale per Montale, Luzi, Alfonso Gatto, Parronchi, Bigongiari, etc etc. Cosa sarebbe stato l'ermetismo senza questo locale? Eppure ha chiuso i battenti prima della pandemia. Naturalmente riaprirà prossimamente, ma la chiusura temporanea ha rivelato il segno dei tempi. A cosa è dovuta questa crisi delle librerie e dei caffè letterari? Potremmo affermare che il globale sembra aver preso il sopravvento sul locale. Non sembra esserci competizione. Le multinazionali come Amazon mangiano sempre le piccole realtà periferiche. Eppure l'Italia potrebbe vivere di rendita, pardon, di turismo culturale, se valorizzasse il proprio patrimonio e formasse culturalmente i giovani. Hanno un bel dire ad affermare che in Italia c'è accoglienza se non ci sono strutture e persone idonee ad accogliere i turisti che vogliono apprendere, sapere, vedere l'arte e la cultura. Secondo report statistico fornito dalla World Tour Organization (UNTWO) l'Italia è terzo per turismo in Europa, superato da Spagna e Francia. Bisognerebbe incominciare a capire, noi italiani, di sfruttare al meglio il nostro patrimonio culturale perché siamo molto di più di pizza, mandolino spaghetti, Capri (che vanno già bene). Non dimentichiamoci che il turismo culturale è sottovalutato oggi. Ma ha una grande tradizione alle spalle. Si ricordi i viaggi in Italia di Goethe e Stendhal. Si pensi che la cosiddetta sindrome di Stendhal prende il nome dal fatto che lo scrittore ebbe un malessere visitando la basilica di Santa Croce a Firenze.
giu 282022

Non è così tanto alla luce del sole, ma chi scrive versi non deve farsi nessuna illusione. Nel migliore dei casi la strada è impervia e in salita. Uno pensa bonariamente che il mondo della poesia sia senza macchia e alieno da ogni forma di mercificazione, di compromesso commerciale. Pensa che sia un'isola felice, un'eccezione in questo mondo consumista. È vero che il business poetico è poca cosa e che c'è poco giro di denaro. Ai tempi degli antichi romani dicevano che carmina non dant panem (lo sosteneva Orazio per l'esattezza). Oggi scrivere versi e venire un minimo riconosciuti non è un atto gratuito ma addirittura una spesa. Non è così ovvio e scontato, ma comunque per fare carriera poetica ci vogliono soprattutto i soldi. Sono un requisito indispensabile, una conditio sine qua non. Oltre a un minimo di talento ci vogliono gli schei detto alla veneta, i danee detto alla milanese. Non è richiesta una grande quantità di capitale, ma bisogna avere uno stipendio oppure una famiglia alle spalle disposta a investire/spendere per arricchire la nota biografica/il curriculum artistico del figlio o della figlia. La carriera poetica può dipendere dalle opportunità economiche o quantomeno da quanto una persona è disposta a spendere per la sua passione. Non è un atto di accusa, un'invettiva o chissà che. È un dato di fatto assodato ormai. Sono rarissimi i casi in cui ciò non avviene come ora vi esporrò. Non succede se un poeta pubblica con Einaudi, Mondadori, Garzanti, Crocetti o Feltrinelli e poi si ritira dalle scene. Nei restanti casi, anche i poeti affermati sono costretti a spendere qualcosa e difficilmente fanno pari o guadagnano. Non c'è niente di male: la mia è solo la presa di coscienza dello stato in cui versa la poesia italiana attuale. I poeti affermati non campano come poeti ma lavorano come giornalisti, impiegati, editor, insegnanti, non parlando di quelli non integrati come erano la Merini o Zeichen.
"Io non ho bisogno di denaro.
Ho bisogno di sentimenti.
Di parole, di parole scelte sapientemente,
di fiori, detti pensieri,
di rose, dette presenze,
di sogni, che abitino gli alberi,
di canzoni che faccian danzar le statue,
di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti...
Ho bisogno di poesia,
questa magia che brucia le pesantezza delle parole,
che risveglia le emozioni e dà colori nuovi."
Alda Merini, Terra d'Amore (Bari, Acquaviva 2003).

Una parte delle proprie entrate economiche, una voce in bilancio per le spese poetiche va messa in conto. Innanzitutto un poeta nella stragrande maggioranza dei casi deve pubblicare a pagamento. Spesso come costo ulteriore c'è l'editing che viene fatto. Autopubblicarsi non è visto di buon occhio dalla critica. Gli ebook, anche se pubblicati gratis su riviste online pregevoli, non vengono presi in considerazione. Inoltre il poeta deve spendere per la prefazione, per organizzare un aperitivo per la presentazione del suo libro. Non solo ma deve spedire decine e decine di copie a critici, direttori di riviste online e blog letterari perché questi poi recensiscano la sua opera: spedire un semplice pdf significa non essere presi in considerazione; non è comunque una grande spesa, se si invia tramite posta ordinaria e non per raccomandata. Un poeta deve partecipare a dei premi letterari, nella maggioranza dei casi deve pagare la tassa di iscrizione e poi se vince il premio o concorso deve viaggiare, pernottare nella località della premiazione, deve bere e mangiare, quindi presenziare alla cerimonia. I rimborsi spese non esistono per poeti effettivi, aspiranti e sedicenti. Per non farsi mancare niente qualche poeta si rivolge a un'agenzia letteraria, che lo promuove, lo istrada, lo avvantaggia, lo fa entrare nel giro giusto. Ma tutto ciò ha anch'esso un costo. Quindi ci sono le antologie di poesia. Molto spesso si tratta di antologie non scolastiche e dopo essere stati inseriti i poeti devono acquistare almeno una o due copie: spese irrisorie, ma pur sempre delle spese. Ci sono anche i libri di poesia e di critica letteraria comprati per acculturarsi ulteriormente, per approfondire o estendere le conoscenze culturali. Non sempre le biblioteche comunali, anche quando esiste una rete efficiente di prestito interbibliotecario nella provincia come a Pisa, si trovano i libri attuali. Quindi ci sono le riviste letterarie a cui abbonarsi per informarsi ulteriormente e per aggiornarsi. Ma la comunità poetica non è solo online. Bisogna anche frequentarsi, andare alla presentazione dei libri, frequentare i festival poetici, incontrarsi con poeti affermati e critici, partecipare alle conferenze universitarie o a quelle delle associazioni culturali. Non solo ma un poeta o una poetessa che si rispetti ha un suo sito personale con un suo dominio registrato, con la sua brava informativa della privacy, con la sua grafica accattivante creata da un webmaster professionista: insomma altri soldi da spendere. Quindi ci sono poeti che pagano per appartenere a un'associazione culturale o un'accademia poetica. Poi ci sono alcuni siti di poesia che mettono in vetrina online i propri iscritti, ma bisogna versare una quota annua. Come se non bastasse ci sono anche delle scuole di scrittura e alcuni sia per migliorare a scrivere che per entrare in contatto con critici o scrittori importanti spendono centinaia di euro per frequentare. Infine ci sono i poetry slam e uno spende per recarvisi. Inoltre per combattere l'ansia beve qualche birra oppure spende bevendo qualche birra per avere maggiore comprensione empatica nei confronti dei partecipanti: in ogni caso dopo un certo tasso etilico anche i mediocri sembrano Montale nella notte in cui tutte le vacche sono nere e le poesie sono capolavori. Però anche viaggi, panini, piadine, birre costano.

Inoltre bisogna offrire qualcosa al bar o al pub al cronista, che molto spesso non si intende assolutamente di poesia contemporanea, perché scriva un trafiletto su un quotidiano in modo da certificare alla comunità locale che uno esiste come poeta. Non solo ma va considerato tutto il tempo speso a occuparsi di poesia e che poteva essere occupato in attività più remunerative, Molte di queste cose non l'ho mai fatte (qualcuna sì, ma pochissime e le più economiche), però per fare carriera poetica è questo ciò che legittima culturalmente. Non dico che tutto ciò sia giusto o sbagliato. La mia è una pura e semplice constatazione di fatto. I soldi sono una grande facilitazione, aprono molte porte, anche nel mondo apparentemente puro e incontaminato della poesia. Nel mondo della poesia un poco di soldi da spendere sono una premessa indispensabile. Ci sono poeti che mettono al primo posto nei loro valori e come priorità nella loro vita la carriera poetica. Così si ritrovano con la casa piena di libri pubblicati a proprie spese e di premi e targhe di scarsa importanza, ma in ristrettezze economiche e con pochissimi soldi per fare la spesa. Pur con tutta la solidarietà dell'intera comunità poetica forse potrebbero gestire in modo più avveduto e oculato i loro soldi. Ma molto spesso dopo tutti questi sforzi economici e dell'impegno profuso la maggioranza dei poeti ha successo oppure diventa memorabile? Assolutamente no. Ogni sforzo spesso è vano. Tutto è destinato a finire nel dimenticatoio. Poi i soldi non vanno considerati lo sterco del diavolo. Di solito si assiste a questo doppio sacrificio: 1) i genitori hanno speso soldi per mandare all'università i poeti con scarso o addirittura nessun ritorno economico 2) i poeti sacrificano tempo e denaro per la loro passione, vivendo un'esistenza precaria.
Mi è stato riferito da alcuni che conoscono a menadito la comunità poetica che la maggioranza dei poeti proviene da famiglia benestante, ma nel corso della vita sono destinati di solito a impoverirsi tra mancati guadagni di una educazione umanistica che non dà frutti economici e le spese per partecipare all'agone lirica.

Di solito però quando un poeta recita le sue liriche alla maggioranza della gente questa gli dice che le sue poesie sono belle, come contentino. In realtà la poesia contemporanea è vista dai più come oziosa, inutile, noiosa, incomprensibile. Alla cosiddetta gente non importa nulla della poesia e dei poeti contemporanei. Come scrive il critico e poeta Davide Brullo fino a quando non ci saranno soldi statali per finanziare i poeti e fino a quando non verrà istituito un centro di ricerca per la poesia statale ci sarà un grande bailamme di poeti, alcuni veri ma anche molti presunti, pronti a fare un baccano inenarrabile. La poesia, anche la migliore, viene considerata solo un hobby. I poeti quindi dovrebbero rimanere con i piedi per terra. Spesso ai poeti manca il senso pratico e un poco di sano realismo. Non c'è niente di male in questo. Ognuno ha le sue pecche. Nessuno è perfetto, come la celebre battuta di Casablanca. Basta esserne consapevoli. Non sempre il talento viene riconosciuto. Lo pensavo proprio stamani che ero seduto al bar e solo dopo che se ne è andata ho riconosciuto una bella donna come la sorella di una ragazza che trent'anni fa mi aveva rifiutato. Allo stesso modo non sempre si riconosce la poesia come tale, anche se è bella. Comunque la poesia può essere considerata per alcuni un atto di pace, per altri un atto di insubordinazione nei confronti della società attuale (scrivere in questo senso è un piccolo atto "rivoluzionario" anche da parte di chi non è rivoluzionario politicamente), per altri ancora un atto d'amore che poche persone, forse nessuno raccoglierà. Questo bisogna tenerlo presente, pur tra molte difficoltà per i poeti e tra tanta ilarità delle persone pragmatiche. Se è vero che i poeti in Italia suscitano ilarità, la libertà di scrivere è concessa. Qui non accade come a Brodskij che nel regime russo decenni fa fu accusato perfino di parassitismo. A ogni modo i poeti non possono fare a meno di scrivere. Quindi si sobbarcano, più o meno incoscientemente, costi e crisi reputazionali.
giu 282022

Il verso libero:
Nel corso del '900 si è diffuso il verso libero. Questo è avvenuto non solo tra quelli che vengono definiti dai cattedratici poeti dilettanti ma anche da grandi poeti stranieri e italiani. Laforgue fu il primo grande poeta ad adoprare il verso libero e a tal proposito scrisse: "mi dimentico di rimare, mi dimentico il numero delle sillabe, mi dimentico la distribuzione delle strofe". Anche Pound fece un uso moderato nelle proprie liriche del verso libero. I poeti dell'imagismo scrivevano tutti in versi liberi. E. Lee Masters nella celeberrima Antologia di Spoon River adoprò spesso nei suoi epitaffi versi liberi e non prestò molta attenzione al rispetto della metrica. Per quel che riguarda il nostro paese i crepuscolari Corazzini, Gozzano, Govoni, pur utilizzando anche forme metriche tradizionali, introdussero il verso libero nella poesia italiana. Anche il poeta simbolista Gian Pietro Lucini scriveva soprattutto versi liberi e dichiarò che al momento della creazione non cercava "misure prestabilite (versi), né sequenze numerate di misure (strofe)", né il posizionamento di accenti tonici. Inoltre bisogna ricordare che i poeti vociani Jahier e Boine scrissero solo prose poetiche. Infine i futuristi utilizzarono solo ed esclusivamente il verso libero. Se in poesia e in letteratura devono essere messe delle regole forse devono riguardare il rapporto tra l'arte e il tentativo di ideologizzazione dell'arte stessa. Ritornando al verso libero alcuni intellettuali ritengono che la vera libertà si acquisisca nell'ambito delle regole imposte e degli schemi precostituiti o almeno questa è la loro giustificazione alla loro concezione di una poesia, che per essere tale deve adoprare le forme metriche classiche. Altri intellettuali ritengono invece che nell'arte la libertà non esista, per cui devono essere accettate le regole imposte dalla tradizione. Per il poeta Robert Frost "scrivere versi liberi è come giocare a tennis senza rete».
Ma non è detto che chi scriva versi liberi e non rispetti la metrica tradizionale non si imponga altre regole riguardanti altri ambiti. Un tempo erano presenti dei canoni estetici. Oggi forse è più problematico valutare un poeta. Sono rari i casi di coloro che scrivono endecasillabi canonici. I più scrivono in versi liberi.

La crisi della poesia:
Comprendere le poesie non sempre è facile. Un testo può essere analizzato per il suo significato psicoanalitico, esistenziale, sociale, letterario, ideologico. Ogni testo può essere studiato valutando il contesto storico, la parafrasi, le figure retoriche, la metrica. Non solo ma va anche detto che ogni lirica può scaturire dal sentimento, dall'osservazione o dalla trasfigurazione. Inoltre non sempre un poeta si basa sulla realtà oggettiva ma spesso anche sulla vita segreta delle cose e della natura. Nel Novecento tutto diventa ancora più complesso. Basta pensare a Eliot e Pound con le loro citazioni colte e il loro montaggio. Nel secolo scorso sono stati molti gli ismi letterari. In Italia agli inizi del Novecento l'Ermetismo non era affatto di facile comprensione sia perché in esso era presente l'Orfismo (connotato dal valore sacrale della poesia e dalla ricerca costante di assoluto e infinito) sia perché i testi erano colmi di simboli, analogie e sinestesie. Negli anni Sessanta si registra un notevole cambiamento. Erano contro l'Ermetismo sia i poeti di Officina (Pasolini, Roversi, Volponi, Fortini, Leonetti) che i Novissimi (gruppo 63), ma anch'essi non erano di facile comprensione. Da un lato i poeti di Officina avevano buoni intenti: volevano il rinnovamento, erano contro l'intimismo degli ermetici, erano contro i reazionari. Dall'altro lato erano anche contro il Neorealismo, uno dei pochi ismi del Novecento (insieme ai crepuscolari) i cui autori si facevano capire da tutti. Forse nel Neosperimentalismo erano presenti troppe premesse teoriche. Anche la Neoavanguardia era ammirevole negli intenti perché contro il neocapitalismo, contro l'egemonia culturale e l'estetica dominante, contro la mercificazione dell'arte. Però spesso spiazzava i lettori per i suoi non sensi, il suo linguaggio multidisciplinare, i suoi shock verbali, la ricerca di essere originali a tutti i costi. Infine la poesia degli anni Settanta con il Neo-orfismo cambia di nuovo le carte in tavola perché prende le distanze sia dalla Neoavanguardia che dal Neosperimentalismo, ma il linguaggio poetico è sempre oscuro e di non facile decifrazione. Per capirne di più basta leggere due antologie poetiche: "La parola innamorata" e "Il pubblico della poesia". Il poeta comunque da decenni non ha più alcun status e la poesia contemporanea è divenuta marginale. Molti scrivono. Pochi leggono. C'è anche troppa creazione ma è scarsa la fruizione. La poesia contemporanea è determinata talvolta dall'egocentrismo, dal narcisismo, dall'autobiografismo. È una poesia talvolta autoreferenziale e non comunicativa. I poeti sono sempre più appartati. Il loro messaggio talvolta non è chiaro. Il gradimento del pubblico è scarso. I giornali raramente recensiscono libri di poesia. Nelle Facoltà di Lettere i poeti contemporanei non trovano spazio. Il fatturato dei libri di poesia in Italia è inferiore all'1% del fatturato globale. I libri di poesia nella stragrande maggioranza dei casi finiscono al macero. I poeti sono stati sostituiti e rimpiazzati socialmente da cantanti e cantautori. Sono molteplici i motivi di questa situazione e non li analizzeremo ora. Comunque oggi i poeti viventi sono sconosciuti al grande pubblico. Come sono cambiati i tempi da quando Vico scriveva che i poeti sono i primi storici delle nazioni! Oggi è innegabile che la poesia di questi anni è in crisi e alcuni critici l'hanno definita minimalista. La lirica di questi tempi è talvolta illeggibile e non memorabile. Comunque non bisogna essere ottimisti né apocalittici.
Poesia e moralità:
È sempre difficile giudicare la qualità delle poesie. È vero che è improponibile il paragone tra la poesia di un bambino di prima elementare e una di Montale. Ma spesso le differenze non sono così marcate. Un tempo si consideravano la metrica e l'eufonia. Oggi non più. Decenni fa in Italia si considerava anche la persona del poeta, che doveva essere assennato e ponderato. Al poeta si richiedevano delle virtù come una certa moralità e la saggezza. Se era sregolato allora era solo un erudito e/o un immaturo. Non poteva considerarsi persona di cultura. Si guardava il comportamento. Si considerava soprattutto l'etica. Si giudicava la condotta. C'era molto moralismo. D'altronde anche la Neoavanguardia valutava la persona (che doveva essere schierata ideologicamente). Loro erano gli unici puri e onesti. Consideravano anche la poetica. Quindi il contenuto veniva giudicato in modo fazioso perché secondo loro il linguaggio era "ideologia". Insomma si doveva combattere. Erano in trincea. Bisognava condannare la borghesia. Quindi bisognava per forza di cose odiare i piccoli borghesi. È chiaro che la Neoavanguardia ha avuto anche dei meriti come quello di rinnovare il linguaggio, inventare il pluristilismo, etc etc. Le due "chiese" comunque si sono appropriate della cultura nella seconda metà del Novecento. La maggioranza della gente se ne fregava. Negli anni Settanta le nuove generazioni erano perse nella droga o nella politica. La letteratura era ritenuta cosa di poco conto e non incisiva. Addirittura era ritenuta evasione. Molti giovani di allora pensavano ad altro e si rovinavano con altro: l'eroina o il terrorismo. La stessa poesia da allora è stata relegata ai margini e non si è più ripresa. Giudicare le poesie è sempre impresa ardua e risente di una certa soggettività. Spesso è questione di gusto più che di criteri estetici.

Poesia e ideologia:
Quali qualità deve possedere un artista per essere tale? Sono sicuro che a questa domanda molti risponderebbero che deve avere talento. Ma forse questo è un prerequisito fondamentale ma non sufficiente. Vittorio Sgarbi in "Lezioni private" scrive che un artista deve avere uno stile. Per esempio un poeta deve avere una visione del mondo. Successivamente avrebbe una poetica (ovvero una dichiarazione di intenti) e uno stile. Un artista di conseguenza secondo tale concezione deve anche essere un intellettuale, che riflette sul mondo e che rappresenta una coscienza critica per gli altri. Secondo Sgarbi l'artista è tale innanzitutto per il proprio pensiero (che deve contraddistinguersi per una certa originalità) e questo è valido sia per chi appartiene alla tradizione che per chi appartiene ad una avanguardia. Secondo altri si può scrivere anche senza una piena consapevolezza di sé stessi e del mondo, ma in fondo sono un'esigua minoranza. Molti critici la pensano come Sgarbi. Altra cosa importante oltre al pensiero è quella che alcuni chiamano la posizione intellettuale. Un artista può esprimere dissenso, consenso o non schierarsi rispetto alla politica e al potere. Per Gramsci ogni artista doveva essere un intellettuale organico. Sartre nella presentazione a "I tempi moderni" proponeva l'engagement. Lo scrittore era da ritenersi sempre responsabile. Non doveva scrivere per i posteri ma per i contemporanei. Non doveva evadere dalla realtà ma essere sempre testimone. Però molti altri erano per una posizione intellettuale meno impegnata politicamente. Per Saba i poeti dovevano essere "sacerdoti dell'eros". Anche D'Annunzio faceva dire a Claudio Cantelmo ne "Le vergini delle rocce" che gli artisti dovevano soltanto difendere la bellezza. Ma in fondo era in buona compagnia. Lo stesso Dostoevskij scriveva che la bellezza avrebbe salvato il mondo. Chissà cosa avrebbero pensato oggi di questa epoca in cui l'arte è soprattutto ricerca del nuovo a tutti i costi e provocazione fine a sé stessa?
Lo stile comunque può essere giudicato subito dai critici letterari, mentre le scelte politiche devono essere comprese e interpretate almeno dopo qualche decennio. Il rischio infatti è quello di essere troppo faziosi e di confondere l'estetica con l'ideologia. In alcuni casi c'è la possibilità di confondere l'estetica con l'etica. Non ci scordiamo che in alcuni autori l'appartenenza politica è più che una presa di posizione politica una scelta dettata da idealismo. Per alcuni artisti il liberalismo, il comunismo, il socialismo, la socialdemocrazia, l'anarchia sono categorie dello spirito. Non dimentichiamoci neanche che furono pochi gli intellettuali a opporsi all'entrata in guerra e al fascismo. Condanniamo pure il loro fascismo ma bisogna anche considerare obiettivamente le loro opere artistiche. Lo stesso dicasi per altre ideologie e altri regimi. Facciamoli però processare dagli storici, anche se si può legittimamente mostrare una certa repulsione per i loro atteggiamenti e comportamenti. Condanniamoli pure come uomini ma non rimuoviamo totalmente gli artisti che sono stati e neanche quello che hanno rappresentato per gli uomini della loro epoca.
Poeti di ricerca e neolirici:
Forse è troppo riduttiva la distinzione tra poesia di ricerca (sperimentatori del verso) e poesia neolirica. Non è detto che tutto lo sperimentalismo porti per forza di cosa sempre al rinnovamento del linguaggio e al rovesciamento di prospettive. In fondo anche alcuni poeti lirici o neo-orfici possono essere originali ed innovativi: non è assolutamente detto che siano sempre dei manieristi o degli epigoni. Non è detto inoltre che questa distinzione tra i due generi di poesia possa racchiudere tutte le dicotomie concettuali ed espressive (comprensibile/difficile, tradizione/innovazione, impegnato/reazionario, etc. etc.). Per quanto riguarda la comprensibilità dei testi la Dickinson scriveva che si doveva dire la verità in modo criptico, mentre K. Popper sosteneva che niente è così facile che scrivere in modo difficile e che tutti coloro che scrivono devono porsi come dovere la chiarezza espositiva (però era un filosofo). La realtà in poesia è che i componimenti dovrebbero in teoria cercare sempre di raggiungere i vertici della significazione. Però i poeti spesso cercano termini ricercati, talvolta antiquati, perché li considerano più consoni. I poeti tra gambo e stelo scelgono sempre il secondo vocabolo, anche se non sarebbe necessario. Anche i poeti in fondo hanno il loro gergo. Mi sembra che Pasolini avesse dichiarato a riguardo che esistesse in poesia un codice classista del linguaggio. Ma non è forse riduttiva questa distinzione tra poesia di ricerca e neolirici? Non potrebbe essere considerata anche una poesia aforistica come quella dell'ultimo Montale, degli Shorts di Auden, dell'ultimo Cesare Viviani? Non sarebbe forse originale se questo genere di poesia aiutasse a chiarire i pensieri, portasse talvolta a "pensare contro sé stessi" per dirla alla Cioran (il riferimento è alla sua opera "La tentazione di esistere")? Naturalmente una scrittura aforistica rischia sempre di essere troppo didascalica oppure ostensiva. Ma in fondo anche gli sperimentatori o i neolirici rischiano anch'essi di perdersi in virtuosismi, di innamorarsi troppo delle parole. I rischi ci sono per tutti. Comunque la distinzione autentica che dovrebbe essere fatta è tra chi cerca di descrivere/raggiungere/ rendere tutta la complessità del reale (il rischio è quello di rendere ancora più complicato e di più difficile comprensione ciò che è già complesso) e tra chi cerca di semplificare la realtà (il rischio è quello di rendere tutto troppo semplicistico, di creare delle smagliature da cui evade il reale). Queste dovrebbero essere le due scuole di pensiero (ma forse sarebbe meglio dire due atteggiamenti esistenziali) di una poesia, che allora potrebbe essere veramente ricerca di senso. Ma forse è solo una utopia. Però la distinzione basilare è tra chi cerca di raggiungere la soglia del dicibile e chi cerca la sostanza delle cose, l'essenziale. Questi a mio modesto avviso sono i due modi di porsi in estrema sintesi. Poi a prescindere dal tipo di atteggiamento chiunque può essere o meno innovativo. Per cercare l'essenziale intendo l'estrema sintesi del reale. La soglia del dicibile non è detto che sia estrema sintesi. L'essenziale lo si raggiunge con il levare. È la caratteristica tipica della scrittura epigrammatica. La soglia del dicibile invece la si raggiunge con il battere, con l'accumulo: significa cercare di descrivere in modo esaustivo la realtà, di comprenderla in modo totalizzante.
giu 272022

Una tematica può essere trattata, sviscerata nei modi più disparati. Infinite possono essere le chiavi interpretative, infinite le chiavi di lettura. Ci sono molti autori che trattano la depressione, sono depressivi, sono deprimenti. Ma la questione non è tanto come affrontare una tematica. A volte mi chiedo perché certi autori scelgano quell'argomento. Mi chiedo quanto ci sia di razionale e di irrazionale, di conscio e dell'inconscio. Comunque la natura della tematica e lo stile con cui viene trattata dipendono dalla visione del mondo, dalla personalità, dalla cultura, dall'esperienza, etc etc. Si ritorna al discorso delle ossessioni. Ogni autore ha le sue. Ogni autore ha le sue fissazioni. Difficile discostarsi da esse. Anche quando si sceglie un argomento del tutto nuovo apparentemente originale ecco che ritornano schemi, costanti, stilemi, manie, tare psicologiche. A vedere bene sembra che le varianti di ogni autore siano infinitesimali. Se leggiamo "Gli indifferenti" constatiamo quanto ci sia del Moravia successivo in quel libro, quanto anticipi ciò che verrà dopo in quel romanzo. La prima opera di un autore è allora l'anteprima di quel che verrà dopodomani? Come dicono molti ogni scrittore è destinato a ripetere il primo libro?
In Meditazione milanese Gadda dedica un metro capitolo ai fini e scrive che «gli n tendono agli n+1 ma non sanno a cosa tendono, ché, se lo sapessero, gli n+1 non esisterebbero già". L’uomo forse tende ad n+2, ad n+3, ad n+infinito. Questo significa che gli uomini vogliono progredire infinitamente la loro conoscenza. L’uomo vuole incrementare il sapere continuamente. Ma siamo sicuri che scrivere significhi progredire all'infinito, evolversi ad libitum? Oppure si rimane sempre lì?
Dante aveva le sue ossessioni (Beatrice e la metrica), era ossessionato, è ossessionante per i lettori, aveva un tratto di personalità ossessivo (si veda per esempio come era un maniaco delle forme chiuse e come seguisse rigorosamente certe regole). Ecco spiegato perché non sono un dantista o un dantologo. In un certo qual modo non studiare Dante è un modo per preservare quel poco che resta della mia salute mentale. Non voglio idealizzare le mie ossessioni, vere o presunte, come fece lui con Beatrice. Mi ricordo di Paolo e Francesca, di Ciacco, del sodomita Brunetto Latini, del suicida Pier della Vigna, del conte Ugolino che mangiò i figli, del fatto che Dante mise Maometto all'inferno, di Virgilio, di Beatrice appunto, di Cacciaguida, del pigro Belacqua, dell'invettiva di Dante con Sordello, di Maria Pia de' Tolomei, di Piccarda Donati. Insomma mi ricordo qualcosa, anche se poco. Ho delle vaghe reminiscenze. Sento molti altri autori più vicini a me per l'epoca, le tematiche, la cosiddetta affinità intellettuale. Di solito nei confronti di Dante ci sono due atteggiamenti contrapposti: 1) chi sa Dante a mente e lo ritiene fondamentale per la formazione culturale. 2) chi pensa che la Divina Commedia non dovrebbe essere insegnata nelle scuole.

Per avvicinare Dante ai giovani di oggi ci sono le pubblicazioni della Divina Commedia in prosa, che non sono uno scempio né un'assurdità. Si possono acquistare con poche decine di euro. Lo so che alcuni insegnanti hanno la loro impostazione. Devono insegnare agli studenti che quella terzina incatenata Niccolò Tommaseo la interpretava in un modo, mentre invece Francesco de Sanctis in un altro. Se invece per esempio compri il Decameron in prosa moderna (si pensi alla curiosità dei corsi e ricorsi storici e di quanto con la pandemia il Boccaccio sia diventato di nuovo attuale), "tradotto" da Aldo Busi (ed è un grande merito), hai solo quell'interpretazione. Però forse hai un poco le idee più chiare. È vero comunque che la lettura di queste opere, attuali o meno, devono aiutare a leggere la complessità attuale. Affrontare oggi il mondo significa sfidare la complessità. La scuola poi è questione più di prestazione che di competenza. Ma aver studiato qualche canto della Divina Commedia può aiutare a interpretare la realtà. La cultura poi, non dimentichiamolo, non è solo conoscenza esplicita da richiamare alla mente ed esporre in una conferenza, ma è anche conoscenza implicita. Ciò significa che anche delle nozioni ormai dimenticate possono essere considerate come basi della nostra formazione culturale. Anche libri letti e poi dimenticati hanno plasmato e plasmano i circuiti del nostro hardware intellettuale, delle nostre sovrastrutture intellettuali. Noi siamo anche i libri che abbiamo letto. Anche quelli possono salvarci. Quindi anche se è un poco noioso e a volte non se ne vede l'utilità pratica fa anche bene a uno studente sapere le differenze interpretative de "I promessi sposi" tra Angelo Marchese e Luigi Russo, tra chi riteneva che Manzoni credesse in un deus absconditus e chi in un deus ex macchina. Va anche bene imparare ciò che ha scritto la critica sulla redenzione etico-religiosa di Renzo nella notte sull'Adda oppure leggere attentamente l'ultimo capitolo de "I promessi sposi" e imparare che per Manzoni la realtà non è mai idilliaca, che l'idillio non esiste mai. In fondo, anche se preferisco altri autori stranieri, sapere qualcosa di Dante e Manzoni significa sapere qualcosa dell'Italia, degli italiani, di ciò che eravamo: capire come siamo diventati ciò che siamo oggi e capire qualcosa in più di noi. Se non ho fatto mai del male a una mosca (e la tentazione di fare del male agli altri talvolta ce l'avrei veramente, talvolta mi immagino di fare del male a chi non posso soffrire, ma poi desisto), se freno i miei impulsi aggressivi (anche bestiali) forse è anche per i libri letti, per le mie riflessioni su di essi. Ma i libri letti, un poco studiati e dimenticati fanno parte del nostro bagaglio, del nostro retroterra culturale. Ci riparano anche dal male che ci fa il mondo e la vita. Sono quelle pagine dimenticate ormai che forse ci permettono di metabolizzare il male. Forse qualcosa resta delle nozioni apprese a scuola, anche se solo inconsciamente e resta al di sotto della nostra soglia quotidiana di consapevolezza. In fondo i libri basta averli capiti, metabolizzati. Cosa importa se certe nozioni cadono nell'oblio? Certo bisognerebbe ripassare. Ma riprendere certi libri di scuola, ormai polverosi e incartapecoriti, mi immalinconisce, mi intristisce profondamente. Rimarrò con alcune dimenticanze e alcune lacune. Non dimentichiamocelo mai: ognuno ha le sue lacune, ognuno è analfabeta in qualche ramo dello scibile. A volte, certi termini di Dante e Manzoni saranno arcaici, desueti. A tratti la loro concezione del mondo ci sembrerà distante anni luce. In fondo anche se ci siamo dimenticati di quelle pagine, di quelle nozioni in un certo qual modo ci hanno formato come uomini e donne. Però trovo una forzatura bella e buona il fatto che fino a pochi anni fa per superare un concorso nello Stato dovevi sapere certe nozioni di letteratura italiana, un poco stantie, mentre invece gli esaminatori magari soprassiedevano su alcune nozioni basilari e imprescindibili riguardanti la professione di quell'impiegato. Così come trovo assurdo l'esame di maturità, come è concepito oggi. Il poeta Maurizio Cucchi qualche anno fa si stupì del fatto che all'esame oggi chiedono le stesse cose che chiedevano a lui decenni fa. La maturità è datata, retrograda. Ma gli insegnanti sono esenti da colpe se i programmi ministeriali delle materie non cambiano. Come rendere attuale la scuola? Come modernizzarla? È proprio alla scuola che si deve chiedere il compito di interpretare la realtà attuale? È la scuola che deve avere la missione di decifrare il mondo attuale? Cosa può dire la scuola sull'uomo contemporaneo e sul mondo attuale? Cosa far studiare ai ragazzi della storia a loro più vicina? Come distinguere tra cronaca e storia? Esiste forse un modo oggettivo? Assolutamente no.

Spesso è necessario almeno un secolo perché certi fatti storici vengano valutati con serenità di giudizio e imparzialità. Per valutare con obiettività e con equanimità i fatti spesso bisogna esserne distanti. Dico semplicemente che per esempio oggi gli storici non sarebbero sufficientemente equipaggiati di obiettività nel valutare il conflitto tra Israele e Palestina. Inoltre il susseguirsi degli eventi è incalzante, inarrestabile. Il mondo moderno è caratterizzato da un dinamismo impressionante. Di punto in bianco ecco presentarsi - quando nessuno se lo aspetta - una svolta epocale, per cui al momento è difficile fare disamine o trovare modelli esplicativi adeguati. Si pensi all'undici settembre. Fino ad allora quanti occidentali sapevano le distinzioni tra sunniti, sciiti? Ci eravamo a mala pena "abituati" alle istigazioni al suicidio per uccidere gli infedeli da parte di Khomeini e degli Ayatollah, ma non pensavamo certo che Bin Laden colpisse al cuore l'America. Tutto a un tratto ecco presentarsi una contrapposizione inaspettata tra la solita America gendarme del mondo e gli uomini-kamikaze della Jihad. Per il momento questa è attualità, è cronaca. Quanto tempo ci vorrà per metabolizzare questi fatti e farli divenire storia? Non è un caso quindi che ultimamente la ricerca storica sia in crisi. C'è addirittura chi propone la "microstoria", ovvero restringere il campo d'indagine a dei fatti e delle situazioni particolari e più facilmente documentabili.
E' chiaro che la storia non può essere mai totalmente obiettiva, ma lo storico può avvicinarsi asintoticamente all'obiettività. In questa sede non voglio nemmeno parlare dei libri sulla resistenza di Pansa. Alcuni rimuovono le testimonianze dei vinti e nascondono gli orrori generati dalla loro parte. Ma la verità viene sempre fuori. Nonostante i negazionisti, che sono i peggiori storici. Niente di nuovo sotto il sole: sono sempre esistiti. Attualmente esistono i negazionisti dell'Olocausto, così come i negazionisti delle foibe. Tempo addietro in Turchia esistevano anche i negazionisti del genocidio armeno da parte dell'impero ottomano, che oggi è stato riconosciuto sia dall'Onu che dal Parlamento europeo. In tutto questo bailamme mi sembra assurda la domanda che si pone Spengler ne "Il tramonto dell'Occidente", ovvero se la storia ha una sua logica. Non credo affatto che la storia abbia una sua logica, semmai infinite contraddizioni, orrori e atrocità. Si pensi che addirittura i nazisti hanno confezionato i paralumi con la pelle degli ebrei e i rivoluzionari francesi hanno conciato l'epidermide dei reazionari.

E quale deve essere il rapporto tra scuola e sapere scientifico? Cosa può insegnare oggi la scuola se molti studenti andranno domani a fare un lavoro che oggi ancora non esiste? Jung riguardo al rapporto tra i progressi della scienza e l'umanità aveva scritto: "i voli spaziali sono soltanto una fuga da sé stessi, perchè è più facile andare su Marte o sulla Luna che penetrare nel proprio io". In attesa di nuovi stadi evolutivi e di nuove fasi antropologiche l’uomo contemporaneo, la cui psiche non è più una struttura equilibrata e bilanciata, può dimenticare sé stesso nella prassi o nel nuovo misticismo del corpo, ma mai giungere alla sintesi degli opposti, mai approdare alla totalità, considerando lo iato tra natura e arte, tra natura e cultura, tra natura e civiltà. L’uomo contemporaneo non ha più la vitalità sufficiente per vivere il dionisiaco, né la saggezza per giungere all’apollineo. La società di massa e i media non aiutano. Le sensazioni, le informazioni, le notizie sono eccessive e invece di fagocitarle finiamo noi stessi per essere fagocitati da queste. Anche le quisquilie più irrilevanti, se si tratta di fatti che riguardano i vip, diventano cronaca. Poi interi massacri di popoli lontani vengono taciuti. D’altronde sono i paradossi della modernità. Decenni fa un radiodramma di Orson Welles fu scambiato per un notiziario e creò il panico perché molti americani cedettero che l’America fosse stata invasa dagli extraterrestri. Oggi nessuna notizia crea più scompiglio. In un attimo la novità si perde nel dimenticatoio. Sorel aveva profetizzato che la modernità sarebbe stata caratterizzata sostanzialmente dalla velocità e dalla violenza. Era stato lungimirante. Oggi infatti le notizie vengono presentate e scompaiono rapidamente e nella maggioranza dei casi trattano di cronaca nera. Tutto finisce per essere sciatto, ovvio, banale, risaputo. Un tempo certi libri vengono messi all’indice. Oggi niente fa più scandalo. I romanzi sono troppo lunghi per essere letti. Anche il minimalista e postmoderno Carver, maestro ineguagliabile della short story non è conosciuto al grande pubblico. Allo stesso tempo nessun saggista prova più un’indignazione per essere un vero pamphlettista. Il mondo è proteiforme. Nazioni, identità, appartenenze, culture stanno scomparendo. Il tessuto sociale si sta disgregando. Stanno scomparendo le comunità e la comunicazione fatica. L’individuo è atomizzato. La massa è anonima. Il potere è così neutro da apparire impalpabile. Su tutto prevale l’immagine, la cupidigia, il culto del denaro ed un’etica del lavoro, che se analizzata risulta riprovevole moralmente. La trilogia di Mastronardi (“Il maestro di Vigevano”, “Il calzolaio di Vigevano”, “il meridionale di Vigevano”) è eloquente a riguardo, illustra chiaramente la grettezza e l’arrivismo della borghesia votata esclusivamente al profitto. Questa è la civiltà dell’immagine e le masse sono idolatre, solo pochi solitari rabbiosi trovano la forza per essere iconoclasti. L’uomo contemporaneo non sa come utilizzare la libertà. Una libertà inaudita rispetto ai secoli precedenti, ma in fin dei conti una libertà apparente. Dostoevskij aveva già affrontato questa problematica. Paradossalmente potremmo anche concludere che se l’uomo utilizza la libertà come il protagonista di “Delitto e castigo” allora ben venga un Grande Inquisitore, che lo affranca da ogni tipo di libertà, perché ritiene l’uomo un essere immaturo e irresponsabile. La cultura occidentale si sta dissolvendo. L’America ha voluto colonizzare anche il nostro immaginario, volendo far credere nei loro film che gli americani hanno una villetta a schiera con tanto di barbecue e di canestro, i figli al college (che tra l’altro ha dei costi elevati perché non conoscono il significato dell’espressione “diritto allo studio”) , una moglie che va con le amiche a giocare al bridge e un ragazzo che ti porta il giornale ogni mattina. L’affluent society insomma, dimenticandosi di presentare al mondo i senzatetto senza uno straccio di assistenza sanitaria. Il declino è inarrestabile. Lo scrivo a costo di passare per catastrofista. Però noto che queste tematiche non sono contemplate dalle fraseologie dell’ortodossia culturale, che piuttosto cerca di giustificare l’esistente.
giu 262022
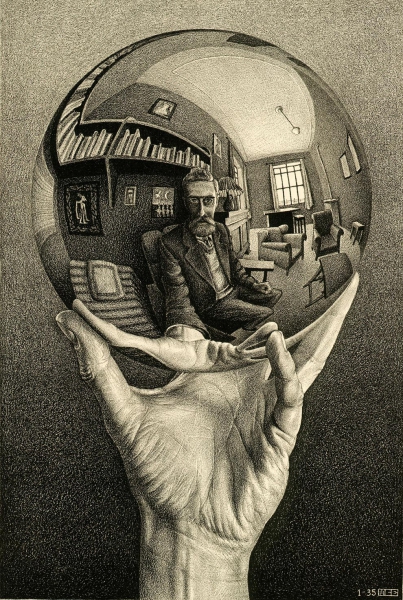
Il secolo, che ci siamo appena lasciati alle spalle, è stato un secolo policromo, ricco di ismi, correnti letterarie, correnti critiche. Per quanto riguarda la creatività letteraria si è assistito a una molteplicità di forme espressive e comunicative. Diverse sono state le correnti letterarie in Italia: il Decadentismo, il Crepuscolarismo, il Futurismo, l’Ermetismo, il Neorealismo, la Neoavanguardia, il Postermetismo, il Neosperimentalismo, il Neo-orfismo. Se consideriamo anche l'Europa bisogna ricordarci anche dell'Espressionismo, del Simbolismo, del Dadaismo e del Surrealismo. Non sono naturalmente mancate le polemiche, come quelle tra tradizione e Neoavanguardia e come quelle tra neorealisti e postermetici. Mai come nell’arco del ’900 la letteratura ha registrato dei mutamenti così radicali. Nel primo Novecento la letteratura italiana passò dall’estetismo dannunziano all’Ermetismo, che stilisticamente si distingueva per le sue analogie, le sue sinestesie e per l’assolutezza della parola poetica; da un punto di vista etico si registrava il passaggio dai vizi e dal lusso sfrenato di D’Annunzio a una letteratura - come quella ermetica - intesa come impegno e testimonianza civile. Se si considera le riviste questo cambiamento di rotta, questa svolta dal dannunzianesimo a un ruolo nuovo di letterato avvenne ancora prima. Infatti “La Voce”, nella prima fase diretta da Prezzolini, fu una rivista “militante”, che si pose problematiche filosofiche e sociali, come la questione meridionale e la politica del trasformismo giolittiana. In prosa si passò dagli epigoni del Verismo all’antiromanzo, cioè ad un romanzo-saggio in cui si dissolveva il personaggio e predominavano il contenutismo, i sociologismi e gli psicologismi. I protagonisti dei romanzi del '900 sono quasi tutti inetti e/o nevrotici a cominciare dai personaggi di Svevo. Ma nella maggioranza dei casi la causa del disagio esistenziale è ignota. Solo nel "Memoriale" di Volponi la paranoia del protagonista ha un motivo certo, ovvero l'espulsione dalla fabbrica a causa della tubercolosi.
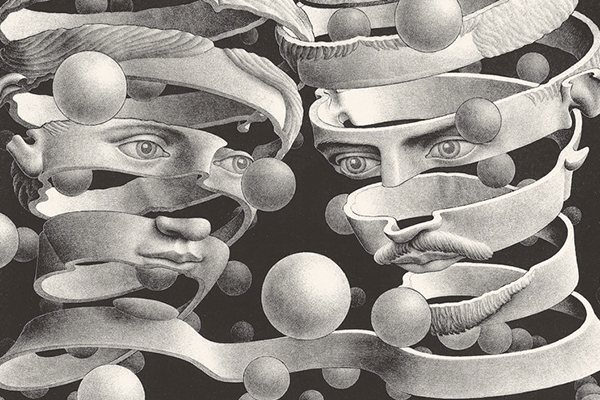
Molti scriveranno della nevrosi, ma Tobino con "Le libere donne di Magliano" sarà colui che affronterà il tema della follia nel modo più realistico. Uno dei pochi che resiste alla tentazione dell'inettitudine è Fenoglio. Per lui si tratta semplicemente di osservare e trascrivere ("see and transfer"), come riesce a fare magistralmente ne "Il partigiano Johnny". Raramente il malessere esistenziale dell'uomo contemporaneo passa in secondo piano. Le tematiche dell'inettitudine e della follia vengono però eluse da alcuni grandi romanzi del '900, che trattano in modo esemplare le conseguenze del nazi-fascismo: "Il giardino dei Finzi-Contini" di Bassani (l'emarginazione degli ebrei), "Se questo è un uomo" di Primo Levi (il lager), "Cristo si è fermato ad Eboli" di Carlo Levi (il confino). Durante il periodo della guerra e dell'immediato dopoguerra la letteratura italiana è contrassegnata dall'impegno morale e politico. L'unico che si concede un divertissment è Vasco Pratolini con "Le ragazze di San Frediano". Anche in poesia avvennero dei mutamenti radicali. Si passò dalle reminiscenze petrarchesche-leopardiane del Canzoniere di Saba a un frammentismo, talvolta prosaico. Il Novecento non è stato caratterizzato solo dall'originalità delle correnti letterarie, ma anche da quella dei singoli autori. Si pensi per esempio alle innovazioni introdotte da Ungaretti, che fu il creatore del versicolo. Nel Novecento comparve nel mondo della scrittura anche l'altra metà del cielo. Furono protagoniste della scena letteraria la poetessa Ada Negri ed Elsa Morante, che scrisse capolavori come "L'isola di Arturo" e "La storia". Ci si ricordi anche di Natalia Ginzburg, che in "Lessico famigliare" ritrasse l'ambiente culturale torinese antifascista, di cui fecero parte Pavese, Adriano Olivetti, Carlo Levi, Giacomo Debenedetti, Carlo Levi. Diverse sono state le correnti della critica: lo storicismo marxista, il crocianesimo, lo strutturalismo, la critica psicanalitica. Non vanno nemmeno dimenticati gli apporti più recenti della semiotica e dell’ermeneutica nell'ambito della critica letteraria. La letteratura nel secolo appena trascorso non è stata considerata solo a livello sintattico, stilistico, simbolico, ma i critici del ’900 hanno indagato a 360 gradi sul rapporto autore-opera e sul rapporto lettore-opera. Attualmente non è ancora possibile fare il bilancio del '900, valutare obiettivamente la portata di correnti letterarie e autori, stimare effettivamente l'eredità di questo secolo, appena trascorso. Può accadere anche che autori, che nel corso della loro vita ebbero fortuna critica, vengano dimenticati e che autori, che non conobbero grande notorietà un tempo, vengano rivalutati. Ciò sta in parte avvenendo con D'Arzo, Silone, Comisso, Brancati, Manganelli, Guido Morselli, D'Arrigo. La letteratura del ’900 è stata contrassegnata da innumerevoli svolte epocali e da profonde trasformazioni. Tutto ciò per aderire maggiormente alle realtà sociali, economiche, politiche, antropologiche di un secolo colmo di errori, orrori, nefandezze di ogni genere. Tutto ciò per riuscire a decifrare la successione, mai fino ad allora così veloce, di avvenimenti. Il Novecento è stato un secolo intenso; ricco di paradossi e rompicapi da risolvere, di enigmi da decifrare.

Illustri filosofi hanno cercato di rintracciare la causa principale della crisi della modernità. Freud scrisse del "disagio della cività", Max Weber della "gabbia di acciaio". Per Nietzsche l'origine di tutti i mali è il nichilismo, per i marxisti il plusvalore, l'alienazione, i rapporti di produzione, i mezzi di produzione, per i cattolici la secolarizzazione, per gli esistenzialisti l'angoscia della scelta. Per Husserl il mancato ritorno al mondo della vita, per Mounier l'individualismo, per Dewey il fatto che il mondo sia aleatorio e rischioso. Per Niezsche Dio è morto, gli strutturalisti invece annunciano la morte dell'uomo. Ma forse non esiste una sola causa alla crisi della modernità. Forse sono molte le cause. La letteratura italiana del '900 ha cercato di intraprendere la sfida al labirinto gnoseologico-culturale, di cui parlò Calvino. Una sfida difficile, ma allo stesso tempo anche affascinante. La letteratura italiana del '900 proprio come uno dei personaggi più famosi di Pirandello - il fu Mattia Pascal - ha dovuto rischiare più volte il proprio patrimonio (in questo caso la propria tradizione) come chi gioca al casinò, darsi per morta e cambiare identità per ritrovarsi e ritrovare il senso di un mondo, sempre più arcano e sfuggente. Talvolta ha assunto rischi folli in modo ludico, presentando i lati più grotteschi e più comici della realtà. Si pensi ad esempio a Landolfi, a Zavattini, a Malerba, ad Achille Campanile, a Cavazzoni.
giu 262022
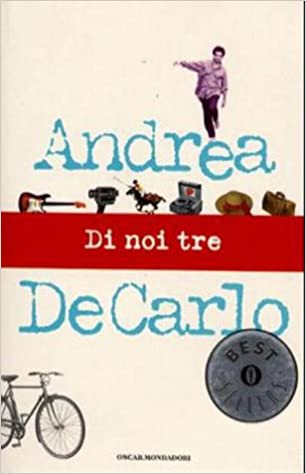
Vi consiglio di leggere due romanzi sulla giovinezza. Il primo è "Di noi tre" di Andrea De Carlo, che ha una trama avvincente e che si legge tutto di un fiato. L'io narrante è Livio, ma i protagonisti sono tre: Livio, Misia, Marco. Il primo ha appena discusso la tesi in storia antica e ha polemizzato con la commissione di laurea. La stessa sera incontra Misia. Livio rimane colpito da questa ragazza bionda nel marasma di una cantina (dove si balla) perché emana "una luce speciale", "un'aria luminosa", "una naturalezza leggera". Per arrivare a conoscerla si intromette addirittura nella lite tra lei e il suo ragazzo, subendo l'aggressione del tipo. Poi Livio inizia a frequentare assiduamente Marco, che lo vuole coinvolgere in uno dei suoi tanti progetti strampalati: fare un film senza alcun tipo di finanziamento. I due devono perciò trovare attori non protagonisti, organizzare la troupe, scrivere la sceneggiatura, decidere la scenografia, gli interni e gli esterni. Livio presenta Misia a Marco e la coinvolge nel film. A questo punto Livio avverte che tra Misia e Marco è nata un'intesa. Della sofferenza causata da questa delusione sentimentale non c'è traccia nel libro. Livio è come se rimuovesse questa frustrazione. Comunque quest'ultimo diventa un pittore affermato grazie all'interessamento di Misia, che riesce a organizzare una mostra dei suoi quadri. Anche il film ha successo e porta alla ribalta Marco come regista e Misia come attrice. Marco addirittura diventa quasi un mito, prigioniero del suo stesso personaggio. Rifiuta la mondanità, detesta l'ambiente dello spettacolo, rifiuta lavori. Non voglio però raccontare tutta la trama. Dirò solo che i colpi di scena si susseguono tra Barcellona, Londra, Buenos Aires. A mio avviso le tematiche di questo romanzo sono due: 1) l'amicizia tra i tre che riesce anche a destare dal torpore esistenziale Livio, il quale alla fine riesce a dominare i propri sbalzi di umore (muovendosi rasoterra, così basso che non ha nessun posto dove cadere...De Carlo cita questo verso di Bob Dylan). 2) la critica nei confronti della società moderna in cui tutti si vendono: chi vende il corpo, chi l'intelletto, chi la dignità. Tuttavia le scelte di vita di tutti i protagonisti sono antitetiche a questa legge di mercato.
A mio avviso questo è un libro da leggere. Sono a conoscenza naturalmente che molti critici letterari storcono il naso ogni volta che si parla di un libro di Andrea De Carlo perché le sue opere vengono considerate troppo commerciali. De Carlo infatti è uno dei pochi che riesce a vendere senza essere un letterato e neanche un personaggio televisivo. Probabilmente alcuni invidiano allo scrittore la prolificità. Secondo me questo è il suo romanzo migliore. Riguardo a De Carlo sono dell'idea che avessero ragione Italo Calvino, che fu il suo talent scout, e Carlo Bo, che lo criticò positivamente.
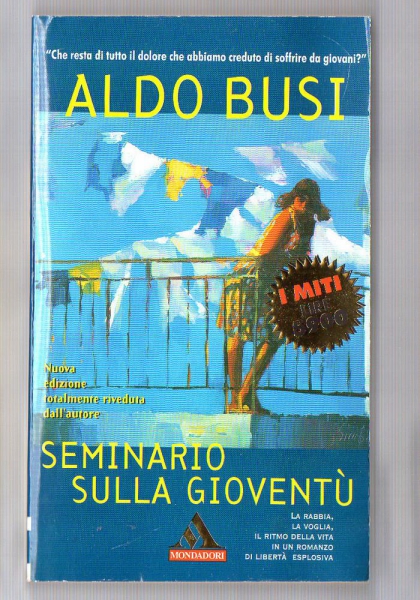
Il secondo romanzo è "Seminario sulla gioventù" di Aldo Busi. La frase che mi ha colpito di più di questo capolavoro è l'incipit del libro: "Che resta di tutto il dolore che abbiamo creduto di soffrire da giovani? Niente, neppure una reminiscenza". Il tempo e la maturità rimarginano ferite ritenute allora letali. Ma il vero fulcro del romanzo è lo stesso Busi, che ci mette dentro il corpo, l'animo, la rabbia, la disperazione, il cinismo, l'ironia disincantata. Tra un susseguirsi di mestieri per mantenersi, tra una ricaduta del trigemino e un incontro furtivo, Busi ci spiega tutti i meccanismi di quello che lui chiama "sessualterrorismo". Come scrive Busi uno fa tanta fatica "per sfuggire allo scemo del villaggio e al genio, e si ritrova giullare di una fighetta turistica". Il protagonista infatti per riuscire a barcamenarsi, pur essendo omosessuale, si fa mantenere da Arlette, sopportando a stento le sue amiche con le loro vanità, narcisismi e frivolezze. Il protagonista in un crescendo di insofferenza nei confronti del perbenismo si vendica dei suoi amanti, borghesi dalla reputazione immacolata, con ricatti e stoccate. Il protagonista esamina a fondo l'emarginazione che subisce dalla società e analizza i vizi segreti di coloro che sono insospettabili, pur avendo una doppia vita. Un'altra felice intuizione di Busi è la seguente: "le vere personalità sono quelle inventate: non c'è grandezza dove non c'è violenza". Come a dire che Busi è diventato un grande scrittore perché ha dovuto sopportare e accettare persone e mestieri, che se avesse avuto la possibilità di scegliere avrebbe rifiutato categoricamente.
Alcuni potrebbero chiedersi perché leggere questi due romanzi. A mio avviso servono a far riflettere in questo mondo dove tutti vanno di corsa e dove le menti non fanno altro che immagazzinare dati. Questi due romanzi fanno riflettere: fanno riflettere sulla giovinezza. Penso proprio che potrebbero essere definiti due romanzi generazionali. Non solo ma non sono mai noiosi. Non sono certo pretenziosi e non sono assolutamente due metaromanzi, genere in voga tra gli intellettuali. Inoltre Cioran scrisse: "quello che so a sessanta anni lo sapevo altrettanto a venti. Quaranta anni di un lungo, superfluo lavoro di verifica...". Ebbene a mio modesto avviso tutti abbiamo bisogno di fare questo "superfluo lavoro di verifica", anche se potrebbe sembrare paradossale di primo acchito. Talvolta non c'è niente di così necessario delle cose apparentemente superflue.
giu 262022

Ritengo sia interessante paragonare “La nausea” di Sartre a un suo racconto, pubblicato un anno dopo, intitolato “Il muro”. Ne “La nausea” il protagonista Roquentin, dopo aver viaggiato per il mondo, si trova in una cittadina a fare ricerche storiche su un personaggio minore del Settecento. Queste ricerche lo portano spesso alla Biblioteca dove conosce l’autodidatta, che si erudisce leggendo per ordine alfabetico gli autori. L’autodidatta è una figura importante del romanzo perché il suo atteggiamento nei confronti dell’umanità è agli antipodi di quello del protagonista. L’autodidatta dichiara di essere socialista e di amare l’umanità. Pur tuttavia gli ideali non trovano corrispondenza nella vita dell’uomo, che viene addirittura scoperto a molestare un ragazzo in biblioteca. Roquentin ha viaggiato per tutto il mondo. Ma se è vero che per Sartre alla nausea si può contrapporre solo l’avventura, è altrettanto vero che il protagonista guardandosi indietro si rende conto di aver avuto solo storie e non avventure. Da quattro anni si è lasciato con Anny, la sua donna, che nel frattempo è diventata un'obesa depressa. Anny non gli interessa più, così come non gli interessano più le sue ricerche storiche. Mentre scrive questo capolavoro, Sartre ha in mente la sua filosofia dell’ “uomo solo”. Ma quest’opera, strutturata come un romanzo poliziesco, è anche un feroce attacco alla borghesia. La nausea causa nel protagonista l’estraneità degli oggetti, la percezione distorte delle cose e della propria immagine. Non riesce nemmeno a conciliarsi con l’immagine che gli rimanda lo specchio: un uomo addirittura estraneo a sé stesso. A mio avviso la nausea è dovuta principalmente alla illogicità dell’esistenza. Per dirla in termini esistenzialisti è determinata dal riconoscimento della “deiezione”, cioè dal fatto dell’essere gettati nel mondo senza saperne il motivo. Non solo, ma Sartre in questo suo capolavoro registra fedelmente lo scarto tra la richiesta chiarificatrice e classificatrice della logica umana e l'aspetto frammentario e dispersivo della realtà. Roquentin è sospeso tra solipsismo e scetticismo. Ma non ha certezze né riguardo al proprio modo di essere né riguardo al mondo esterno. Sartre svela sia la fallibilità della conoscenza interiore che la limitatezza e la pochezza dell'agire umano. Il rapporto tra protagonista ed esperienza non è però solo quello del divenire temporale, ma è anche quello della negazione di ogni forma di relazione tra simili. Mi viene in mente l'esistenzialismo positivo di E.Paci, filosofo oggi ormai dimenticato. Per Paci non è possibile essere soltanto idealisti (cioè prendere in esame solo "il pensiero per il pensiero") né soltanto esistenzialisti (cioè considerare solo "l'esistenza per l'esistenza") né avere soltanto dei presupposti etici (cioè considerare solo "il valore per i valori"). Bisogna invece attuare una sintesi tra queste tre sfere dell'universo umano. Sartre per tutto il romanzo analizza solo il pensiero e l'esistenza: è invece totalmente assente qualsiasi fondamento etico, che possa risollevare Roquentin. Il protagonista de “La nausea” non ha un’ideale per vivere. Questa sarà poi l’unica ancora di salvezza secondo Sartre, che infatti successivamente scriverà in un suo saggio: “l’uomo è costantemente fuori di sé; solo progettandosi e perdendosi fuori di sé egli fa esistere l’uomo e, d’altra parte, solo perseguendo fini trascendenti”.

Ma nel suo racconto “Il muro” Sartre fa sfoggio di un umorismo tragico, che era totalmente assente nel suo primo capolavoro. Qui il protagonista è un anarchico spagnolo, condannato a morte per le sue idee. Viene messo in una cella con altri due condannati e deve passare la notte più lunga della sua vita: all’alba lo fucileranno. La luce entra da alcuni spiragli e da piccola apertura sul soffitto, da cui si può intuire uno squarcio di cielo. Ma il cielo non comunica né simboleggia niente. Ha la morte nell’anima, ma non ha paura di soffrire. Gli altri sono sempre l’inferno e la compassione lo disgusta. Oramai è preparato a morire perché passare tutta la notte ad aspettare la morte significa “vivere venti volte l’esecuzione”. Nonostante questo il protagonista ritiene che morire sia la cosa meno naturale del mondo. Non ha nemmeno più ideali. Dell’anarchia e della liberazione della Spagna non gli interessa più niente. Al mattino però gli danno un’opportunità: deve scegliere se essere fucilato o dire dov’è il suo amico Gris. Il protagonista sa che Gris si è nascosto in casa dei suoi cugini, ma nonostante questo preferisce morire. E prima di morire ha una trovata comica. Vuole gabbare i soldati, dicendo che Gris si trova al cimitero. Vuole immaginarsi la scena di quegli uomini in uniforme che corrono tra le tombe.

Ma Gris ha abbandonato la casa dei cugini e si è rifugiato davvero al cimitero. Il protagonista ha salva la vita. Mi viene naturale paragonare la notte insonne che passa il protagonista de “La nausea” in un albergo di commessi viaggiatori a questa notte terribile, che passa il protagonista de “Il muro”. E’ questa la chiave di volta per capire il rovesciamento di prospettiva che Sartre attua in questo breve racconto. Ne “La nausea” il grande scrittore fa un’analisi minuziosa dei paradossi dell’esistenza, scrive una fenomenologia del disagio interiore. Il protagonista tuttavia ha libertà di scelta e d’azione. Ne “Il muro” invece si trova di fronte al paradosso dei paradossi della vita: la morte che nullifica ogni scelta e ogni malessere interiore. Il filosofo Adorno a proposito dell’esistenzialismo scrisse che la scelta alla fin fine era tra crepare o crepare. E se per K. Jaspers l’uomo di fronte alla morte si può aggrappare alla fede, molto più difficoltoso è il rapporto con la finitezza e la precarietà dell’esistenza per un esistenzialista ateo come Sartre. Ma viene in soccorso la trovata comica e il protagonista si salva, ridendo dell’assurdità dell’esistenza e della morte. Sartre ne "Il muro" dà scacco matto alla nausea e alla morte.
giu 242022

Monod ne "Il caso e la necessità" parla di "male dell'anima" dell'uomo contemporaneo. Per farla breve sono la mancanza di animismo (cioè non pensare più che le cose, gli animali, la natura abbiano anch'esse un anima) e il postulato di oggettività a causare il malessere dell'uomo odierno, secondo Monod. Insomma è colpa della scienza e a dirlo non è un umanista ma uno scienziato, un premio Nobel. In parole povere il vero male dell'anima è che l'uomo considera sé stesso e il mondo ormai senza anima. Nemmeno l'anima del mondo esiste più. Forse l'anima delle cose e del mondo erano riflessi dell'anima dell'uomo, ormai non pervenuta, scomparsa. Forse il problema è che noi siamo, le cose sono, la vita è e l'essere, qualsiasi essere, è dolore. Forse il dolore è anche dovuto a ciò che non siamo, a ciò che le cose e la vita non sono. Forse il male risiede, come intuì Pessoa, nella "stanchezza di esistere delle cose". In Montale abbiamo " il male di vivere", "l'anello che non tiene". Ungaretti in "La pietà" si sente "esiliato in mezzo agli uomini" e "Attaccato sul vuoto/ Al suo filo di ragno,/ non teme e non seduce/ se non il proprio grido". Eliot scrive "La terra desolata". Nessuno quindi sa con certezza se il male è nell'anima o nella vita. Nessuno sa qual è la radice del male. Tutto ciò è al di fuori della nostra portata. Di certo si sa che spesso il male sembra avere il sopravvento. C'è una quota parte di male ineliminabile, inestirpabile. Kant lo chiamava male radicale. Cristianamente il male esiste per tre motivi plausibili: 1) perché fa parte di un disegno divino imperscrutabile e non comprensibile all'uomo 2) per l'esistenza del diavolo 3) perché Dio ha dato il libero arbitrio all'uomo.
Forse per uno solo di questi motivi, forse per tutti i motivi. Fatto sta che siamo sempre circondati dal male. Ma cosa è il male? Il male può essere inteso sia come dolore, ingiustizia, peccato, mancanza, non essere, privazione del bene. Come rapportarsi a esso? Quale senso dare al male?
Per il poeta Maurizio Cucchi "il male è nelle cose" come il titolo omonimo del suo primo bel romanzo, il cui brano è molto eloquente: "Comunque, secondo me, le cose ci sono, ci sono e basta. La colpa non è di che le trova, e forse neanche di chi le adopera. In fondo il loro potenziale è sempre nel programma. E forse il male è proprio nel programma. L’uomo non crea un bel niente" (p.90).
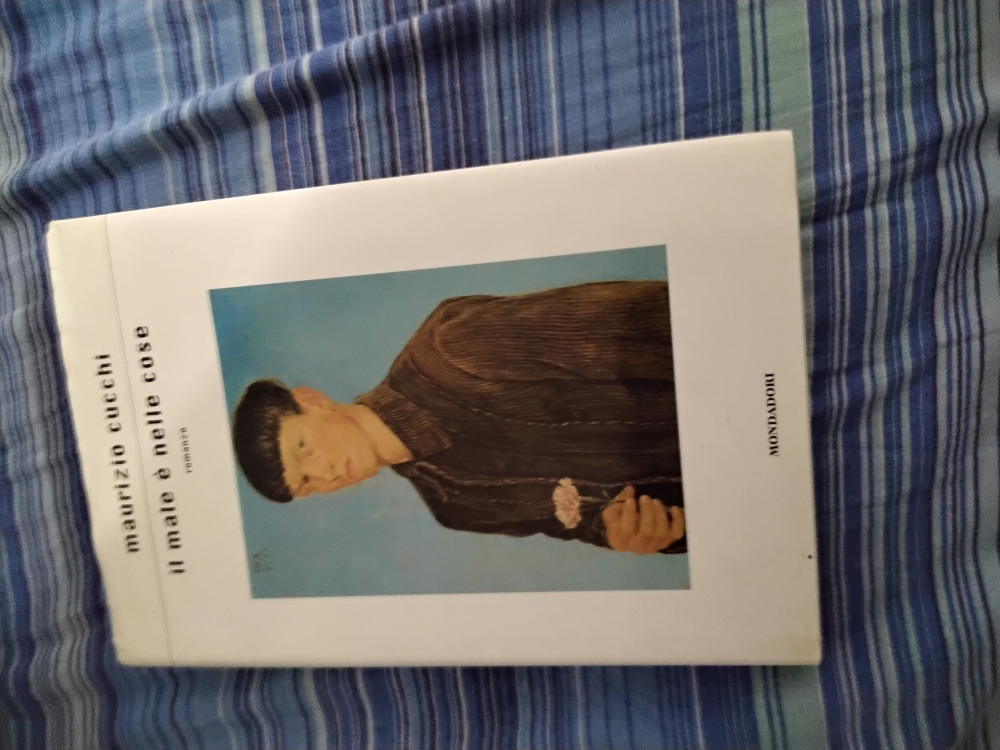
La colpa è quindi del programma, ovvero della vita e del mondo: ipotesi più che plausibile. E da questo che proviene tanto disagio? A ogni modo il romanzo di Cucchi è da leggere perché la narrazione è sapiente e non è per niente un concione. È un bel libro, scritto bene. Ne rileggo spesso alcuni brani. Penso che Cucchi come posatore sia sottovalutato, se consideriamo tutti i suii brani, a partire da "Il viaggiatore di città". Ogni giorno comunque la solita noia, il solito smarrimento, la solita estraneità. Poi la notte giunge improvvisa ad addormentare noi e le cose. Abbiamo un'anima rabberciata per la vita odierna. Potremmo affermare che questa vita moderna è senza anima. E se il male fosse dappertutto, sia nell'uomo che nelle cose? L'uomo fa male alle cose. Le cose fanno male all'uomo. L'uomo usa le cose per fare del male. Il circolo è vizioso. Per Husserl bisogna "ritornare al mondo della vita", mettere tra parentesi la scienza. Bisognerebbe perciò percepire le essenze, riappropriarsi della quotidianità, cogliere la bellezza della natura. L'etnometodologia studia le conversazioni comuni, le pratiche, le interazioni della vita quotidiana. E se la vita però fosse altrove, come nel romanzo di Milan Kundera? E se il male fosse nell'inafferrabilità, dell'inattingibilità dell'esistenza? E se il cerchio non fosse destinato a chiudersi? Ci sono cose buone e belle. Ci sono cose cattive. Ci sono istanti buoni e cattivi. Bisogna anche cercare di difendersi dalle cose, dagli istanti, dagli altri cattivi. Bisogna anche saper chiudere gli occhi, saper tollerare, incassare, lasciar andare, lasciar passare. La vita può far male. Egoisticamente una persona che legge o che scrive si fa del bene momentaneamente, anche se il male sembra invincibile.

Forse il male sta nella morte di Dio (Nietzsche), nell'ingiustizia economica e nell'uomo ridotto a merce (Marx), nell'inautenticità dell'esistenza (Heidegger), nell'insensatezza e nell'aleatorietà dell'esistenza (Beckett, Ionesco), nella razionalità limitata (H. Simon), nella lotta per la vita (Darwin), nella civiltà repressiva e nella rinuncia pulsionale (Freud), nella crisi etica e nella perdita di valori (molti filosofi). Forse tutte le altre problematiche sono conseguenti a questi filoni di cose. Forse tutto origina dai mali individuati da Nietzsche, Marx, Heidegger, H. Simon, Darwin, Beckett, Ionesco, Freud, etc etc. Forse tutti gli altri derivano da essi, sono dei sottoproblemi. Di solito anche gli intellettuali privilegiano solo uno di questi aspetti della vita. Ci sarebbe bisogno invece di una cura che prevedesse tutti questi piani della realtà. Come sosteneva Federico II di Svevia bisognerebbe far vedere le cose come sono. Le cose però non sempre sono come appaiono. Poi il passaggio ulteriore è intuire l'essenza dell'apparenza e quindi manifestarla. Rendere evidenti le cose per quello che sono veramente è molto impegnativo. Ma ci sono anche le cose che non sono (gli "oggetti eterni" di Whitehead, ovvero le idee, i valori, le essenze). Scrive Remo Ceserani che Pascoli ha fiducia di "far parlare le cose". Ma per altri autori la coscienza è alienata e quindi non ci può essere corrispondenza veritiera con le cose oppure ontologicamente non si può giungere alle cose. Come scriveva Sant'Agostino "la verità abita nell'interiorità dell'uomo". Ma se l'interiorità è falsa, malata, alienata, inadeguata, lacerata tutto il resto percepito sarà tale anch'esso. Forse assistiamo all'impotenza delle parole. Le parole non sempre rappresentano fedelmente le cose. Il male è un corpo estraneo nell'uomo ma è anche un nemico interno. Infine bisognerebbe far vedere l'uomo come è e non è. Ma qual è con certezza la vera natura umana? L'uomo può essere bestiale o angelicato. Probabilmente l'origine di tutto è che siamo fatti male noi, ma anche le cose e il mondo. Bisognerebbe perciò fare piena luce sul male nostro e delle cose? Ne siamo davvero capaci? La letteratura sa trattare il male, lo sa affrontare, lo sa mostrare. Ma la letteratura non è mai un male. Poeti e scrittori si propongono di arrivare al fondamento dell'essere, intanto assumono un atteggiamento depressivo, nominano, sognando di ritornare nel ventre materno. Gli artisti cercano per tutta la vita quello che Borges chiamava un nuovo filone di cose. Però se non ci prepariamo al male esso ci prenderà totalmente alla sprovvista. È spesso all'improvviso che si presenta il male e per affrontare le cose bisogna essere sopratutto pragmatici. Non scordiamoci mai. La letteratura può rappresentare il male. Può condannarlo. Il male probabilmente è in me come nel mondo: è dappertutto. C'è violenza in me e nel mondo. Non ci si salva. Ogni istante almeno apparentemente è un bivio. Si brancola nel buio. Le certezze sono poche a onor del vero. La vita, stare al mondo è un compito arduo.
giu 242022

Negli anni Settanta andava di moda Marx. Molti facevano corsi accelerati di marxismo, studiavano i riassunti dei riassunti senza leggere i libri di Marx e ciò nonostante si dichiaravano ferventi marxisti. Alcuni erano marxisti-leninisti. Altri erano maoisti. C’era chi leggeva Tronti, Panzieri, Toni Negri: i filosofi e politici dell’operaismo italiano. C’era chi si dichiarava gramsciano perché voleva l’egemonia culturale della sinistra. A sinistra tutti volevano fare gli intellettuali organici, anche persone improvvisate. Per i riformisti era d’obbligo sapere la teoria keynesiana. Ancora oggi ci sono molti keynesiani tra i progressisti. Insomma ci voleva l’intervento pubblico per far ripartire l’economia. A destra andava di moda leggere Nietzsche e Heidegger. Il superomismo di Nietzsche poteva portare all’autoesaltazione. Nietzsche non può però considerarsi responsabile del nazismo se non in modo molto indiretto, come del resto Marx per i regimi comunisti. Il pensiero di Nietzsche fu deformato dalla sua sorella e da Hitler. L’antisemitismo di Nietzsche inoltre non era dispregiativo e violento, ma basato sulla paura indotta dalla superiorità culturale ebraica. Molto probabilmente Hitler odiava gli ebrei per questioni personali e perché aveva letto il falso documento dei protocolli dei savi di Sion, non per colpa di Nietzsche. Heidegger era compromesso con il nazismo, ma non era nazista per quello che sosteneva, piuttosto per quello che non scriveva, per quello che ometteva. Per capire cosa è stato il nazismo bisogna leggere la Arendt e non Heidegger, ciò che la filosofa definisce banalità del male e ciò che scrive a riguardo del totalitarismo, anche se la sua concezione dello stato totalitario non è a mio avviso universale ma ancorata a quell’epoca e a quel contesto storico, sociale, politico. Heidegger quindi può essere letto da tutti. Non c’è bisogno di condannarlo a priori né a posteriori. Naturalmente Heidegger è un grandissimo filosofo, scrive cose molto profonde sul nichilismo, sull’esistenza, sull’arte, sul declino della società occidentale, che nessuno aveva detto prima di lui. Inoltre in Italia il miglior interprete e intenditore del filosofo tedesco è stato Emanuele Severino, uno studioso attento e molto equilibrato, che non ha mai travisato il pensiero di Heidegger. Sono state tuttavia mode culturali. Certo ci può essere stato qualche facinoroso che tirava per la giacchetta il pensiero di questo o quel filosofo. Questo deve essere messo in conto. Per molti si trattava di mode. Solo pochi padroneggiavano la disciplina e gli argomenti.

Solo pochi studiavano severamente la materia ed erano veramente versati. Per molti si trattava di rimasticature, echi lontani, deboli influssi, vagheggiamenti. Acculturarsi di filosofia politica, di economia politica era comunque una imposizione dall’alto, i partiti lo esigevano e naturalmente erano disposti a fare scuola agli iscritti. Sempre negli anni Settanta andava di moda a destra leggere Tolkien oltre ad Evola, Guénon, Spengler, Jünger. Era quasi un imperativo categorico. Per i liberali italiani era un dovere culturale leggere Croce e Gobetti. Negli anni Novanta per i liberali era quasi d’obbligo leggere Popper. I primi ad occuparsene nel nostro Paese del filosofo austriaco furono Dario Antiseri e Marcello Pera. Sempre negli anni Novanta e nei primi anni del Duemila i liberali necessariamente dovevano guardare alle teorie dell’economista von Hayek, che non voleva l’intervento statale a differenza di Keynes. Negli anni Novanta e nei primi anni del Duemila tutti i riformisti italiani leggevano o citavano Rawl e la sua teoria della giustizia. Per chi era di sinistra era un obbligo dover sapere qualcosa della teoria del potere di Foucault, del suo concetto di biopolitica, della decostruzione e del logocentrismo di Derrida, così come bisognava aver letto i libri di Chomsky, che criticava l’imperialismo americano. Qualche decennio fa erano di moda anche la psicanalisi, lo strutturalismo, la semiologia. Poi sono finite le mode culturali o comunque non hanno la grande presa di un tempo sulle persone. Sono finite le ideologie e quindi le grandi mode culturali a esse strettamente connesse. Un tempo chi si occupava e si interessava di politica leggeva decine di libri ogni anno, leggeva ogni giorno più quotidiani. Era una minoranza, una cerchia di persone non dico intellettuali ma di buone letture. Ogni ideologia aveva sempre bisogno di pensatori, libri, teorie che continuassero a giustificarla. Una ideologia non era qualcosa data per sempre. Perché aderisse efficacemente alla realtà c’era sempre bisogno di correttivi e aggiornamenti. Inoltre per ogni ideologia spuntavano come funghi dei critici e di conseguenza gli intellettuali di parte dovevano prendere le contromisure a quelle critiche. Insomma era il gioco delle parti, le solite schermaglie culturali. Ogni ideologia aveva bisogno di nuovi ideologi che la reinterpretassero e la rinnovassero continuamente.

D’altronde noi esseri umani siamo degli esseri incompiuti. Per trovare compiutezza abbiamo bisogno di cultura: alcuni studiosi chiamano ciò antropopoiesi. L’ideologia un tempo doveva essere appresa, capita, interiorizzata, ma anche creduta. Il marxismo come il fascismo erano anche degli atti di fede che duravano tutta la vita. Un tempo si giurava fedeltà per tutta la vita a una ideologia. Un tempo credevano alle ideologie, erano innamorati delle idee, credevano alcuni di avere la verità in tasca. Poi per alcuni era breve il passo dalla ideologia alla ubriacatura ideologica o al delirio ideologico, ma in questi casi era questione più che altro del lato Freud, di personalità di base. Certamente c’era chi usava l’ideologia in modo strumentale per violenza e sopraffazione. Oggi buona parte dell’elettorato è incerto, indeciso, si astiene dal voto. Un tempo mia nonna si vestiva in modo impeccabile per andare a votare. Era un giorno memorabile quello delle elezioni. Le persone si vestivano bene, non perdevano un capello. Adesso la politica italiana è molto più pragmatica. I politici non parlano più di convergenze parallele. Sono più diretti e non c’è bisogno che la base si acculturi. Si fanno comprendere da tutti. I politici di tutti gli schieramenti oggi sono molto social. Utilizzano il web per fare diffondere le loro idee. Usano post brevi di Facebook, commentano i fatti del giorno con un tweet. Insomma ecco l’elogio della comprensibilità e della brevità. E se fosse questa non dico la democrazia dal basso ma una nuova forma di democrazia rappresentativa? Dell’ideologia è rimasto ben poco: il minimo indispensabile per dare una identità ai partiti e ai loro iscritti, per creare delle contrapposizioni tra di essi. La falce e il martello sono stati deposti in soffitta, a torto o a ragione. Sono finiti il senso di appartenenza, la fedeltà, la coerenza. Sono finiti simboli, pratiche, riti. Bisogna farsene una ragione. Se ne facciano una ragione anche coloro che hanno scannato e si sono scannati per l’ideologia. Nel frattempo le multinazionali hanno conquistato i mercati e hanno avuto la meglio su tutte le nazioni. Ma in fondo di cosa avevano bisogno l’Italia e gli italiani? Di stabilità politica, di sobrietà, di competenza, di lungimiranza, di oculatezza. Ideologia o non ideologia, tutto questo nella prima repubblica non c’è mai stato. Vedremo in futuro, se avremo futuro.
giu 242022
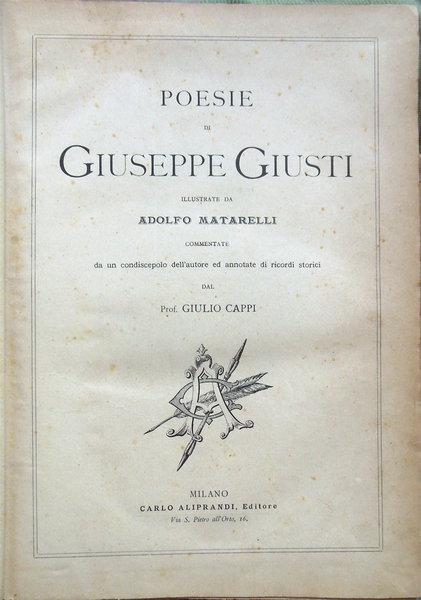
Giuseppe Giusti nacque a Monsummano nel 1809. Dopo aver frequentato diversi collegi toscani, si iscrisse a legge all’università di Pisa. Divenne avvocato, però non esercitò mai la professione. Visse la maggior parte della vita a Pescia. Affetto da tubercolosi polmonare si trasferì a Montecatini per curarsi. Morì di tisi a Firenze nel 1850 e fu sepolto a San Miniato. Nel corso della sua breve vita ebbe modo di conoscere Alessandro Manzoni. Fu anche accademico della Crusca e deputato al parlamento di Firenze. Il Giusti fu un liberale illuminato e uno dei migliori poeti satirici italiani della ’800. Anche Benedetto Croce si occupò della sua arte e lo definì "poeta prosastico". Il nostro avanzò critiche nei confronti delle istituzioni e delle ambizioni individuali. Le sue opere satiriche sono perfettamente aderenti alla realtà dell'epoca; presentano parodie e tratteggiano tipologie di persone senza alcun moralismo: i politici voltafaccia, i nobili esterofili, gli arricchiti, i falsi preti, i governanti indolenti. Il poeta comunque non si atteggia mai a censore di vizi e non è mai paternalista. Giunge sempre alla comicità, enfatizzando certi tratti ed esasperando certe caratteristiche di figure, che esistevano realmente ai suoi tempi. Il Giusti fu un artista colto, ferrato nella cultura classica e nella tradizione letteraria. Nelle sue poesie però fa la caricatura del potente, ma non offre una parola di conforto al povero. Certamente non fanno parte del suo retroterra poetico l'impegno civile e la partecipazione emotiva del Porta e del Belli, che riuscirono a dare risalto nei loro lavori a quel popolo, che fino ad allora non aveva mai avuto voce.

Il nostro poeta tratta spesso e volentieri di crapule e baldorie di persone, che non vivono in ristrettezze economiche. Resta da definire però se questo sia un difetto o un pregio. Infatti se da un lato può apparire distaccato, dall'altro non fa mai demagogia, non si abbandona a facili utopie e non ha la presunzione di dire qualcosa alla gente, che soffre e fatica. I poemetti satirici dei suoi "Scherzi" sono stati riconosciuti pregevoli all'unanimità, hanno avuto vasti consensi sia all'epoca (anche Gino Capponi era un grande estimatore del poeta), sia nel '900 (si pensi al Palazzeschi). Meno apprezzato dalla critica letteraria invece per le opere intime e di carattere sentimentale. Anche se in alcune liriche si può identificare il carattere risorgimentale, il Giusti non fu un mazziniano perché timoroso del popolo e di eventuali insurrezioni popolari. Comunque sono costanti nei suoi versi l'avversione per lo straniero conquistatore e il patriottismo. Difficile collocarlo politicamente. Fu davvero un liberale singolare in quel tempo: né un neoguelfo alla Gioberti, né un federalista come Cattaneo. Il Guerrazzi, suo avversario politico, disse di lui che scardinò lo stabile della società del periodo, avendo però paura dei calcinacci. Non mancano critici letterari che hanno una visione più giacobina dell'opera del Giusti. La sua produzione poetica è vasta e originale. Tocca gli argomenti più disparati. Spazia dall’ambito politico-sociale a quello storico. Notevole l’uso sapiente del poeta della metrica italiana. Prima dell’avvento nel ’900 del verso libero i poeti utilizzavano soprattutto l’endecasillabo (che non è necessariamente un verso di undici sillabe, ma l’importante è che abbia l’accento tonico sulla decima sillaba e un altro accento tonico sulla quarta o sulla sesta). Il Giusti invece varia prosodia continuamente. Spesso utilizza quinari e settenari. Più raramente usa le strofe saffiche (tre endecasillabi ed un quinario) e le ottave. Si può notare la sua autoironia in vari componimenti. Ad esempio in “Rassegnazione e proponimento di cambiar vita” scrive: “in quanto al resto, poi non mi confondo: / faccia chi può con meco il prepotente: / io me la rido e sono indifferente”. Il suo umorismo però talvolta è pervaso da un sentimento di nostalgia come nell’opera “Le memorie di Pisa”, in cui descrive la goliardia degli studenti universitari toscani.

La poesia satirica che mi ha divertito di più è l' "Apologia del lotto", che tra l'altro è ancora attuale. Il Giusti decanta i pregi del lotto, tra cui diventare signori con pochi soldi, far fare studi approfonditi sull'interpretazione dei sogni. Come se non bastasse scrive che il Lotto è l'unica fede rimasta al popolo e che giocando non si rischia la libertà, come invece accadde a Galileo che fu processato per aver professato la verità nell'ambito scientifico. Ma leggendo tra le righe, si capisce che lo Stato non perde mai e che chi è contento della sua condizione economica non gioca di certo al Lotto. La sua opera più famosa è senz’ombra di dubbio la raccolta di proverbi toscani. Popolari per i toscani e gli appassionati di letteratura anche poesie come “Lo stivale” e “Sant’Ambrogio”. Nella prima opera il Giusti adopra l’allegoria dello stivale per narrare le tribolazioni storiche dell’Italia: le dominazioni straniere, gli avvicendamenti di principi e regni dall’epoca dell’impero romano fino ai suoi tempi. Il poeta scrive: “Per un secolo e più rimasto vuoto,/ cinsi la gamba a un semplice mercante”. Questo verso sta a significare che solo durante il tempo dei Comuni l’Italia visse un periodo di relativa libertà, anche se la Sicilia era dominata dagli stranieri. Il capolavoro finisce con l’appello all’unità nazionale. Il Giusti scrive infatti: “E poi vedete un po’: qua son turchino, / là rosso e bianco, quassù giallo e nero;/ insomma a toppe come un Arlecchino: / se volete rimettermi davvero/ fatemi con prudenza e con amore, / tutto d’un pezzo e tutto d’un colore”. In Sant’Ambrogio invece il poeta tratta della dominazione austriaca. All'inizio della poesia l'artista dichiara che è stato considerato anti-tedesco solo perché in alcuni suoi versi ha parlato male degli sbirri. Ma nel finale il poeta ha una levata di umanità anche per i soldati austriaci, che sono lontani da casa e costretti a vivere in un paese straniero. Anche loro che in fondo sono gente comune "l'hanno in tasca". Solo i regnanti ci guadagnano sempre grazie all'antico "divide et impera". Anche la poesia dal titolo "Gingillino" gode di una certa fama. Il poeta descrive un tipo conformista e arrivista, che ingannando gli altri riuscirà a mettere le mani in pasta. Divenuto dottore in legge Gingillino va nella capitale per cercare un posto. Lì diventa "un birro", cioè un ufficiale della polizia e conosce l'ex-cuoca di un notabile, che gli dà tutti i consigli giusti per fare carriera: scansare i liberali e chi pensa con la propria testa, non parlare mai di libri e di giornali, arrufianarsi con il superiore, lodarlo a più non posso, riferirgli i pettegolezzi. Non ho voluto fare un saggio critico sul Giusti, anche perché non ne sarei in grado. Ho voluto invece dare un consiglio di lettura nel modo più semplice possibile. Leggete il Giusti. Le sue rime sono divertenti e mai scontate. Personalmente lo ritengo geniale per il suo estro e la sua arguzia. A mio modesto avviso è uno dei pochi poeti italiani di tutti i secoli che sappia sorridere e accantonare la tragicità.
giu 242022
Molte piante negli ultimi anni hanno raggiunto la fioritura a fine inverno. Si è parlato infatti di primavere anticipate. La natura è sempre più imprevedibile. Gli agricoltori rischiano molto a livello economico perché anche in caso di gelate tardive tutto va alla malora. Si pensi alla fioritura anticipata della frutta come ciliegie, susine, mele e pesche. Si consideri soltanto a come in alcuni anni è fiorita prima la mimosa. Recentemente si sono registrati notevoli sbalzi termici. Si pensi negli ultimi anni anche alle grandinate e ai danni del maltempo, sempre poco prevedibili. Un tempo non esistevano più le mezze stagioni secondo un noto luogo comune. Adesso non esistono quasi più le stagioni, forse a causa dell’inquinamento e del surriscaldamento del pianeta. La natura sembra impazzita. L’agricoltura può risentirne in caso di fioriture anticipate o tardive. Basta ricordarsi di quanto può compromettere la produzione di olio la fioritura anticipata dell’ulivo. Guardiamo i vigneti. Ma queste sono solo piccole beffe della natura nei confronti dell’uomo. Pensate all’invasione di cavallette in Africa, che ha costretto a fare la fame a 20 milioni di persone.

Nel nostro piccolo in Italia abbiamo avuto la diffusione esponenziale delle nutrie, che erano utilizzate per la pellicceria. Alcune fuggirono dagli allevamenti e altre vennero liberate in modo incosciente. Ma tutto ciò non ha compromesso niente fortunatamente. La situazione almeno per ora è sotto controllo. Pensate al riscaldamento climatico in Antartide, che ha causato lo scioglimento dei ghiacciai. Pensate più recentemente all’enorme invasione di topi in Australia. Pensate ad un fenomeno come quello dello spiaggiamento delle balene.

La natura può essere molto crudele. Può essere matrigna come pensavano Leopardi e Voltaire (dopo il terremoto di Lisbona). Altri pensatori hanno considerato positivamente la natura come San Francesco nel “Cantico delle creature ” e come Spinoza con il suo “Deus sive natura”. C’è chi vede nella natura una nemica e chi l’immagine di Dio. In definitiva la natura può far male all’uomo con cataclismi e siccità, ma anche l’uomo con l’industrializzazione ha fatto molto male alla natura. Dalla rivoluzione industriale a oggi l’uomo ha rovinato il pianeta. Probabilmente oggi siamo alla fine dell’Antropocene. Pensate solo all’inquinamento. Osservate solo tutta la plastica che c’è nel mare. L’umanità deve prendere provvedimenti tempestivi. Bisogna pensare anche a un futuro remoto. L’uomo contemporaneo vuole dominare e manipolare a suo piacimento la natura. Vuole solo servirsene senza rispettare fauna e flora.

Ma non rispettando l’ecosistema, non rispetta nemmeno sé stesso. Non possiamo uccidere la balena perché viviamo per ora nel suo ventre. Per ora non c’è stata nessuna intercessione divina che ha fatto in modo che la balena ci vomitasse su una serena spiaggia, come Giona. Ricordando Moby Dick di Melville non bisogna comportarsi come Capitan Achab perché non si salva, mentre si salva invece Ismaele. Dobbiamo accettare il lato terribile della natura. Dobbiamo rispettare la natura perché è il nostro habitat naturale. È al momento il solo mondo di cui disponiamo, ma gli interessi di alcuni potenti e di alcune nazioni ricche sembrano avere il sopravvento su tutto e su tutti. Il futuro del pianeta è lo stesso futuro dell’umanità. Jonas non a caso parla di etica della responsabilità, di pensare anche alla vita di coloro che verranno, di avere uno sguardo lungimirante ed a lungo termine. Staremo a vedere. Per dirla alla Popper “il futuro è ancora aperto”.
giu 232022
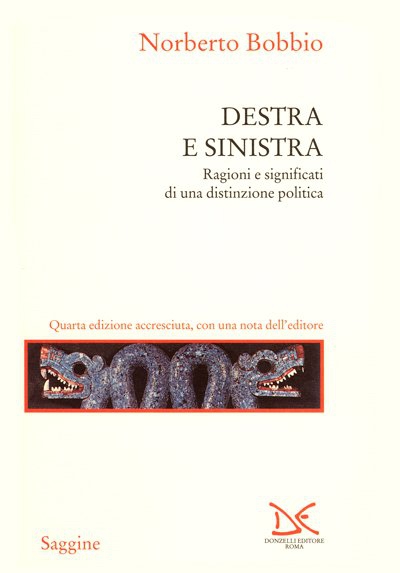
Dopo tre quarti d'ora a parlare di politica io e Lele concludiamo così:
"è tutto un darselo a intendere."
Secondo recenti studi esiste ancora la cosiddetta "eredità politica". I genitori fanno proselitismo, educano, formano, influenzano. I figli li imitano. Questo accade 6/7 volte su dieci. Oppure i figli in piccola parte vogliono "uccidere" il padre, si contrappongono, perché c'è un rapporto conflittuale, un complesso edipico da risolvere, come successe nel '68. Plausibile l'ipotesi di Adorno sulla personalità autoritaria. Secondo Adorno il fascismo era determinato da una educazione rigida, repressiva, autoritaria. Si tenga però presente che l'avalutatività delle scienze umane è un'utopia e che allora molta sociologia, molta psicologia contenevano in sé la teoria implicita che chi era progressista era sano psichicamente oltre che nel giusto. Tutto ciò era in buona parte giustificato perché gli studiosi progressisti in gran parte erano memori degli orrori del nazifascismo, ma ancora non conoscevano a dovere quelli dei regimi comunisti. Le loro conclusioni non corrispondevano totalmente al vero, se si ragiona a rigore di logica e se si conosce un minimo la natura umana. È presumibile che anche dittatori e persone comuni comuniste possano avere o possano avere avuto aspetti patologici correlati significativamente alla loro ideologia. Come scrive Andreoli di ogni scelta politica si potrebbe dare una "lettura psicoanalitica". C'è anche la questione dell'età. Secondo un celebre aforisma di Pitigrilli "si nasce incendiari e si finisce pompieri". C'è anche chi vota non in modo affettivo/emotivo ma in modo razionale, facendo un'analisi costi/benefici. Sono quelli che votano chi difende i loro interessi. In modo opposto ci sono ricchi che votano il partito comunista anche per eliminare o ridurre il loro senso di colpa di essere privilegiati.

Secondo le scienze umane l'ideologia sarebbe definita come "un complesso di credenze, opinioni e valori che orientano un determinato gruppo sociale o un individuo; tale insieme di credenze, inoltre, è condiviso all’interno di un gruppo e ne sostiene le azioni" (Carraro e Bortolotti, 2020, p. 337). Ma recentemente è nata la psicologia politica, ovvero lo studio delle variabili psicologiche che decidono l'orientamento politico. Secondo alcuni studi l'orientamento politico è "predeterminato geneticamente", addirittura sarebbero individuati i geni del conservatorismo o del progressismo. Io sono rimasto agli studi degli psicologi nelle carceri che per esempio hanno evidenziato quanto i brigatisti rossi spaziassero dal delirio di onnipotenza alla mania di persecuzione, croce e delizia di quella che loro consideravano una sorta di guerra tra guardie e ladri.

Bobbio ha scritto il long seller "Destra e sinistra" che ha venduto centinaia di migliaia di copie ed è stato tradotto in tutto il mondo. Per Bobbio "destra" e "sinistra" erano "reciprocamente esclusivi e congiuntivamente esaustivi". Il libro è ancora attuale, sebbene sia stato pubblicato nel 1994. Bobbio era uno dei più grandi filosofi italiani, molto acuto e altrettanto rigoroso. Non le mandava a dire. Scrisse che il fascismo era dovuto anche alla compromissione del popolo italiano, che non era esclusivamente colpa di Mussolini e dei gerarchi: ebbe il coraggio di dire e scrivere che anche la popolazione italiana, sebbene avesse l'attenuante dell'ignoranza a quei tempi, aveva avuto un'ubriacatura ideologica, si era fatta lusingare, sedurre, incantare, ipnotizzare dai fascisti della prima ora, diventando essa stessa fascista, ed era in un certo qual modo responsabile del fascismo. Bobbio considerava certamente la propaganda del partito fascista, ma chiamava gli italiani a un esame di coscienza collettivo. Bobbio sapeva che il fascismo era stato, per così dire, "nazionalizzazione delle masse". Il filosofo sapeva esattamente come era avvenuta l'ascesa di Mussolini. Anche per via della dittatura e della violenza esercitata comunque furono pochissimi gli italiani a non aver pagato il pedaggio al fascismo. Bobbio evidenziò anche i meriti della Resistenza d'altra parte. Per chiarire il giudizio di Bobbio sulla compromissione degli italiani durante il regime basta citare il titolo di un suo saggio sulla memoria e i valori della Resistenza: "eravamo ridiventati uomini". Insomma fu sempre attento ad analizzare con obiettività luci e ombre degli italiani e dell'Italia. Quindi per l'autorevolezza, la competenza, l'onestà intellettuale, il rigore morale quando venne pubblicato questo volume, filosoficamente accurato ma leggibilissimo, molti pendevano dalle labbra di Bobbio, volevano ascoltarne le interviste, si recavano ad acquistare il libro. Ma davvero come scrive Bobbio sinistra è uguaglianza, emancipazione, bisogno e destra è diseguaglianza, tradizione, merito? Per alcuni queste categorie sono desuete, non hanno più modo di esistere, come cantava Gaber. Personalmente penso che oggi molti tifino un orientamento politico, un partito politico come si fa con una squadra di calcio, senza avere idee precise o valori di riferimento stabili e certi. Non hanno molti la preparazione adeguata, le conoscenze teoriche. Non sono aggiornati. Non seguono la politica. D'altronde il discorso è complesso. Tutti hanno il diritto/dovere di votare. Calvino lo mise in evidenza con "La giornata di uno scrutatore". Il voto per tutti è uno dei valori fondanti della nostra democrazia. Continuo però a pensare che ci sia gente che si tira la zappa sui piedi. Comunque molti votano cosa hanno votato i loro genitori (se esiste il partito ancora o se c'è un minimo di continuità), intrattenendo spesso un rapporto di natura clientelare con gli uomini di quel partito. Chiamatele pure conoscenze, pubbliche relazioni, conoscenze utili, amicizie interessate. È insomma anche un do ut des. Pochi si acculturano e si documentano per la politica. Hanno anche ragione. Anche io sono tra questi. Nessuno sta dietro alla politica come accadeva negli anni '70. Non dico che esista il voto di scambio, ma quasi. Di solito ci sono i referenti politici, che io per esempio non ho. In Italia come dichiarò l'allora ministro del lavoro Poletti per trovare un lavoro sono importanti esperienza e curriculum, ma più di tutto le relazioni sociali: per Poletti era più importante andare a giocare a calcetto con gli amici o a cena con ex compagni di scuola che andare all'ufficio di collocamento (visto che fino a pochi anni fa solo il 4% dei disoccupati trovava lavoro grazie a esso). Fortini scriveva: "...Gli oppressi/ sono oppressi e tranquilli, gli oppressori tranquilli/ parlano nei telefoni, l’odio è cortese, io stesso/ credo di non sapere più di chi è la colpa". Se un tempo in chiave marxista gli oppressi erano i proletari e gli oppressori i capitalisti e gli imperialisti oggi si dovrebbe parlare di gruppi dominatori e gruppi dominati, di categorie avvantaggiate e di categorie svantaggiate. Oggi il mondo non è più wasp comunque. In realtà il discorso è sfumato e complesso. Come scrive Bailey lo status di persona svantaggiata è multidimensionale. Non esiste più la categoria unica sulla base del capitale. Ci sono varie dimensioni come il genere, l'età, l'etnia, il grado di istruzione, lo stato di salute, l'orientamento sessuale. Ma in Italia almeno esistono anche stereotipi e conseguenti discriminazioni sulla base dell'appartenenza politica. Gli italiani, pur essendo disinformati ed essendosi disaffezionati alla politica, si odiano ancora in base alle categorie politiche; chi è di destra odia le cosiddette zecche, chi è di sinistra odia i fascisti. Ancora oggi non c'è una riappacificazione, una conciliazione tra le due parti. Ci sono sempre almeno due fazioni, c'è una logica della contrapposizione. Ci sono sempre nella popolazione la suddivisione tra Don Camillo e Peppone, tra guelfi e ghibellini. Siamo un popolo emotivo, litigioso. Si vien sempre chiamati a stare da una parte, bisogna sempre sapere da che parte stare in Italia. Nessuno si può esimere. Il voto in teoria è segreto, però dimmi chi voti: così si potrebbe riassumere tutto. Si può diventare falchi o colombe. Si può essere galline azzannate da volpi. Si può far la fine delle volpi, che dopo aver azzannato le galline, venivano uccise e qui da noi in Toscana a chi le uccideva gli venivano regalate le uova delle galline. Il potere come al solito divide e governa. In Toscana per esempio esiste una tradizione rossa dovuta alla fondazione del partito comunista a Livorno, alle tante case del popolo un tempo, alla diffusione di circoli Arci oggi, alle tante cooperative rosse. In Toscana un semplice liberale apartitico può essere penalizzato. In Veneto lo è altrettanto un comunista. Gli italiani discriminano, ghettizzano, emarginano, danno amicizia e amore, includono o escludono, favoriscono oppure ostracizzano, offrono opportunità socioeconomiche oppure non le danno in base al colore politico, eppure al governo vige la logica del consociativismo e della spartizione. Tutto è già deciso. Il saggio di Bobbio è in bella vista nella mia libreria, lo tengo sempre a portata di mano. Adriano Sofri in "Altri hotel" scriveva che era in disaccordo con le equazioni di Bobbio sinistra=uguaglianza e destra=libertà. Anche Vittorio Foa proponeva che se la destra significava liberalismo la vera libertà invece stava a sinistra. Bobbio naturalmente vedeva distante, ma non aveva la sfera di cristallo.

Su una cosa aveva totalmente ragione: la destra si basava allora su un concetto dell'antropologia tradizionale, ovvero gli uomini non sono uguali e bisogna valorizzare la diversità. Personaggi come Almirante volevano esaltare le differenze individuali. Dagli anni '90 in poi all'egemonia culturale della sinistra opponevano l'egemonia mediatica berlusconiana. Oggi la destra è populista e parla di identità. La sinistra vuole la fluidità. Oggi la sinistra ha il merito maggiore di difendere i diritti civili e forse non riesce a difendere a dovere i precari. La destra un tempo, come sostiene Bobbio, era inegualitaria, prendendo come riferimento Nietzsche. Bisogna leggere anche "La sinistra nell'era del karaoke" di Bobbio, Bosetti, Vattimo. Quest'ultimo scriveva a riguardo: "Credo di vedere delle spiegazioni di questo conservatorismo della sinistra italiana: essa, o almeno una gran parte di essa, si è liberata lentamente, negli ultimi decenni, del mito della rivoluzione e ha scoperto relativamente da poco il valore che hanno le regole del gioco. Questo spiega in termini non puramente denigratori perché oggi la sinistra sembra più arroccata in difesa della Costituzione" (pp.21-22). Forse essere di sinistra significa oggi come ieri difendere le minoranze e sentirsi una minoranza, che è o si sente élite. Come dice Nanni Moretti in "Caro diario": "Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io, anche in una società più decente di questa, mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Ma non nel senso di quei film dove c'è un uomo e una donna che si odiano, si sbranano su un'isola deserta perché il regista non crede nelle persone. Io credo nelle persone. Però non credo nella maggioranza delle persone. Mi sa che mi troverò sempre d'accordo e a mio agio con una minoranza...".
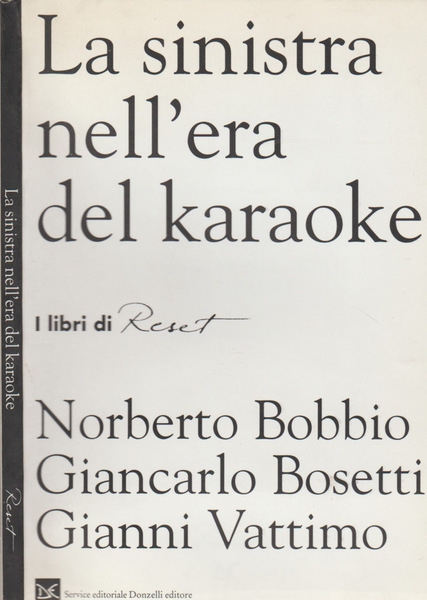
E la destra invece? E adesso come è da questo punto di vista la destra? Oggi i punti programmatici dei partiti sembrano assomigliarsi tutti. Qualcuno dice che la sinistra non esiste più e la destra è troppo camaleontica. Poi oggi si registra il primato dell'economia sulla politica. Che cosa conta la politica italiana così provinciale in un mondo dominato dal nuovo neocolonialismo delle lobby economiche e delle multinazionali? Nessuno vuole più fare la rivoluzione. Chi potrebbe farla è pur sempre "uno svantaggiato integrato". Gli esclusi non hanno forza né voce in capitolo. Ma esiste più il senso di appartenenza? Oppure non esistendo più le classi non esiste più la coscienza di classe e non esistendo più le ideologie non esiste più l'amore per la politica? Talvolta ho la vaga sensazione che chi dice che sinistra e destra non esistono più non vuole schierarsi, non vuole dichiararsi oppure addirittura vuole mistificare la realtà. Il saggio di Bobbio ha avuto a mio avviso il merito, piccolo o grande che sia stato, di innalzare la discussione politica, di far volare alti gli italiani, in un Paese allora sclerotizzato sulla distinzione netta tra berlusconiani e antiberlusconiani, al punto da regredire politicamente, mantenere lo status quo per anni, non evolvere, arenandosi nelle secche e non facendo le riforme. Ma anche qui il consociativismo alla fine aveva la meglio: i politici progressisti facevano accordi sottobanco, pubblicavano libri con le case editrici del nemico, andavano a fare ospitate nelle reti Mediaset, sempre prezzolati. Per molti intellettuali progressisti duri e puri Berlusconi era un imprenditore illuminato perché permetteva loro di essere pubblicati o di scrivere sui suoi giornali. Nel frattempo Berlusconi si impossessava di buona parte del Paese e decine di migliaia di persone erano suoi dipendenti. Sicuramente il saggio di Bobbio va letto comunque, anche per essere contro e per dissentire. È un saggio tascabile, colto, penetrante, divulgativo e chiaro. Bobbio fa delle pregevoli argomentazioni e solleva interrogativi validi ancora oggi. Ecco perché ha avuto meritatamente questo successo inaudito, forse impensabile. È ancora molto attuale a mio avviso, ma anche se fosse datato avrebbe il merito di ricordarci come eravamo, come pensavamo, su quali problemi ci accapigliavamo quasi trenta anni fa. In ogni caso va letto.
giu 232022

Il gruppo 63 aveva teorizzato lo "schizomorfismo" nella scrittura, ovvero ci doveva essere una mimesi (una copia che riproducesse rispecchiamento) tra un mondo schizofrenico e le forme letterarie. Se in particolare per Sanguineti l'ideologia era sempre linguaggio (primo passo per smascherare l'inganno della realtà) per la neoavanguardia (di cui lo stesso Sanguineti faceva parte) bisognava compiere un ulteriore passo avanti: denunciare la follia del mondo, riproducendola fedelmente nella letteratura. Il mondo per Sanguineti era folle e ingiusto per il predominio dell'ideologia capitalistica. Nel gruppo 63 non veniva esplicitata la natura della follia del mondo. Il mondo era folle fisiologicamente, ontologicamente? Oppure il capitalismo selvaggio, che sfruttava alcuni uomini e la natura, era un agente catalizzatore? Il capitale era il motivo scatenante di tutto? Oggi sappiamo che il comunismo non è la panacea di tutti i mali. Ma la questione restava irrisolta. Secondo una diagnosi di natura la schizofrenia negli uomini era causata da un'eccessiva produzione di dopamina nel sistema mesolimbico. Ma cosa causava la follia del mondo? Che questo fosse un crazy world, che tra l'altro scatenava nevrosi e psicosi nei cittadini che vi si adattavano, l'aveva già scritto Fromm. Era il "disagio della civiltà" studiato, primo tra tutti, da Freud. Quindi la follia non solo scatenava in taluni disadattamento, ma in alcuni era l'effetto dell'integrazione a questo mondo. Perché trattare dei pochi folli quando era l'intero mondo a essere folle? Era la follia del mondo che contagiava gli esseri umani, che perpetuavano a loro volta le dinamiche perverse e ingiuste del sistema folle. La follia, intesa in senso erasmiano, può essere rivelatrice di conoscenza e verità. Il folle può coincidere con il saggio. Appartenendo a un mondo apparentemente altro, può vedere cose che le persone comuni non vedono e arrivare dove gli altri non arrivano. Scriveva in una sua celebre poesia Zanzotto: "Mondo, sii, e buono;/ esisti buonamente". Ma il mondo non è mai buono. Ha troppe brutture. Montale in una sua poesia scriveva:
"Se il mondo va alla malora
non è solo colpa degli uomini.
Così diceva una svampita
pipando una granita col chalumeau
al Cafè de Paris.
Non so chi fosse. A volte il Genio è quasi
una cosa da nulla, un colpo di tosse."
La colpa è di tutti e di nessuno? Il mondo va male non solo per gli uomini ma anche per Dio allora? La domanda fondamentale dell'etica cristiana è la seguente: "Se esiste Dio perché allora c'è il male?". Questa è la teodicea cattolica e non solo. La domanda che si fa un cattolico è: perché un essere onnipotente, infinitamente buono e misericordioso non ha fatto un mondo buono? E poi mi chiedo anche perché se Dio ha fatto a sua immagine e somiglianza gli uomini ha messo in noi anche la capacità di essere violenti e fare del male? Perché un Dio buono non ha fatto gli uomini buoni? Perché ci sono uomini più propensi a fare del male, essendo più predisposti dalla loro natura e/o dalle circostanze? La colpa è degli uomini ma anche di Dio che ha dato loro il libero arbitrio? Cosa può fare la letteratura di fronte a tutto ciò? Per Carlo Bo la letteratura deve essere come la vita. Per Bo la letteratura e la vita sono "strumenti di ricerca e quindi di verità: mezzi per raggiungere l’assoluta necessità di sapere qualcosa di noi, o meglio di continuare ad attendere con dignità, con coscienza una notizia che ci superi e ci soddisfi". Sempre Bo scriveva: "sappiamo che la letteratura è una strada, e forse la strada più completa, per la conoscenza di noi stessi, per la vita della nostra coscienza". Però per Bo la vita del letterato doveva essere pura o quantomeno coerente all'opera. Da tempo immemorabile a questo proposito ci sono critici letterari interessati anche alla vita dell'artista e altri meno. E ancora sempre per Bo gli autori dovevano essere di specchiata moralità e agire secondo coscienza. E allora gli autori con coscienza infelice o falsa coscienza? Per Giorgio Manganelli la letteratura è menzogna. La letteratura, quando va bene, è un "come se" per il grande scrittore. Ma se il mondo è diventato favola, come scriveva Nietzsche, allora Manganelli è nel giusto perché la letteratura come menzogna rispecchia la menzogna del mondo. Ci sono diversi modi in cui approcciare la realtà per uno scrittore o un poeta:
pensare che il mondo sia vero e riprodurlo con la verità dell'artista
pensare che il mondo sia vero e opporsi con la menzogna dell'artista
pensare che il mondo sia falso e opporsi con la verità dell'artista
pensare che il mondo sia falso e riprodurlo con altrettanta falsità

Il mondo quindi può essere considerato vero o falso e poi essee capovolto, rovesciato con la scrittura. Ma qui la faccenda si complica ulteriormente perché verità e menzogna, falso e vero, possono essere mischiati e non c'è modo di dividerli, separarli. Oppure l'uomo non è più in grado di saper distinguere oggi il vero e il falso, di modo che vero e falso sono un tutt'uno inscindibile. Nessuno sa con certezza assoluta lo statuto né l'essenza della realtà. Inoltre per farla diventare letteratura la realtà va analizzata e sintetizzata correttamente. Quanti sono in grado di farlo? Riprendendo Nietzsche ne "Il crepuscolo degli idoli" non solo il vero può essere "inattingibile" ma anche il falso. Secondo l'ipotesi di Nietzsche il vero è inconoscibile. È naturale che se non si può distinguere il falso dal vero non si può neanche discernere tra il bene e il male. Noi occidentali abbiamo un'idea cumulativa del sapere, tendiamo alla verità perché pensiamo di potervi avvicinare sempre più, passo dopo passo, tassello dopo tassello, gradino dopo gradino. Come scrisse Emerson: "il saggio cerca la verità. Lo sciocco crede di averla trovata". Wittgenstein in "Della certezza" scrive: "Se il vero è ciò che è fondato, allora il fondamento non è né vero né falso". Ma quale è è cosa è il fondamento? La verità poggia su fondamenti instabili. Kant proponeva lo schematismo trascendentale. Le categorie con cui conosciamo la realtà per Kant erano innate e universali. Invece Umberto Eco ha messo in dubbio tutto ciò con l'esempio dell'ornitorinco che ha alcune caratteristiche dei mammiferi ma non è mammifero, bensì oviparo. Di conseguenza le categorie e gli schemi cognitivi non sono un a priori, ma spesso sono a posteriori, ovvero storicamente e culturalmente determinate. E poi anche se sapessimo la verità quale senso dovremmo darle e con esso quale senso dovremmo dare alla nostra vita? Ma c'è un altro problema insormontabile. Merleau-Ponty ne "La fenomenologia della percezione" scriveva che "la scienza non è stata per nulla capace di illuminare la natura dell'esperienza soggettiva". E ancora cosa è la coscienza? Grazie a cosa siamo coscienti?
E poi si aggiunge la difficoltà che viviamo nell'epoca delle post-verità, in cui si crede alle bufale del web, alle fake news, alla disinformazione, senza cercare la verifica e il controllo dei fatti. Trovo che questa frase sia inoppugnabile: "Il fatto moderno è che noi non crediamo più in questo mondo” (G. Deleuze, L’immagine-tempo. Ubulibri, 1989, p. 191).

E se la vita è liquida per dirla alla Bauman (ovvero precaria, imprevedibile, piena di incognite, estremamente mutevole) allora anche la verità potrebbe essere altrettanto "liquida". La vita comunque nella migliore delle ipotesi, in assenza di certezze, dovrebbe essere una ricerca incessante, spesso infruttuosa, si spera non vana. Jung scrisse che qualsiasi visione del mondo era da considerarsi solo un'ipotesi. Come cantava Enrico Ruggeri nella vita dovremmo morire crescendo.
Infine come scritto nell'Ecclesiaste il sapere accresce il dolore, ma è anche vero che la sofferenza accresce il sapere. Ma siamo così convinti di conoscere? E se la verità che ha il conforto e la sicurezza della conoscenza condivisa fosse solo un'illusione? Siamo poi così sicuri che possa verificarsi l'etica del discorso, la situazione discorsiva ideale di Habermas, secondo cui i dialoganti si dimostrano chiari, sinceri, comprensibili, onesti intellettualmente? Siamo certi che si possa mettere in pratica i dettami di Habermas sull'agire comunicativo? E se tutta la vita fosse illusione? Se questa vita non fosse che sogno?
giu 232022
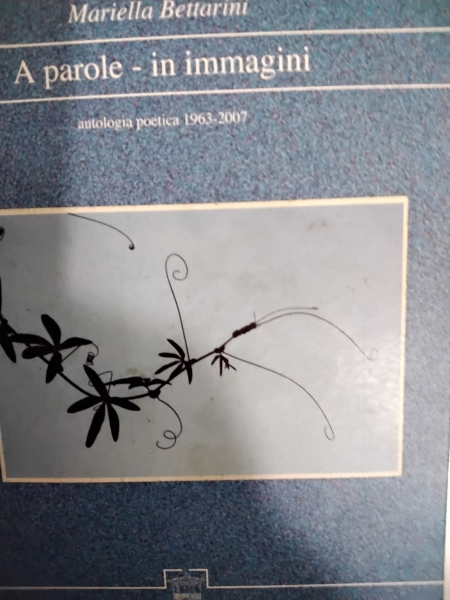
Molti anni fa dopo che le inviai via email un mio saggio breve sulla poesia contemporanea, riletto oggi molto acerbo e pretenzioso, Mariella Bettarini, che ne individuò i punti di forza, omettendo probabilmente quelli deboli per bonaria indulgenza, mi inviò per posta ordinaria la raccolta di tutte le sue poesie, insomma la sua opera omnia lirica, intitolata “A parole – in immagini” (antologia poetica 1963-2007) per la casa editrice “Gazebo”. Per inciso scrivo che la poetessa è sempre stata un’instancabile animatrice e operatrice culturale, ha fondato la rivista letteraria “Salvo imprevisti” (oggi dirige “L’area di Broca”), ha fondato la casa editrice “Gazebo”, ha ottenuto vasto consenso dalla critica, ha colloquiato con molti protagonisti letterari del secondo Novecento, ha tenuto a battesimo molti giovani in poeti. Ha anche curato il libro capolavoro di Alice Sturiale. Un’altra curiosità: è stata anche inserita nell’enciclopedia tematica dell’Espresso Grandi Opere anni fa. Un’altra cosa: non partecipa a premi letterari perché sa come scriveva Ferlinghetti che la poesia non è una gara. Mi invitò comunque anche a una riunione letteraria a casa sua, ma declinai l’invito. A quel tempo ero un piccolo commerciante. Firenze distava poco più di 60 km col treno. C’era il rischio di perdere l’ultimo treno della sera e ritrovarsi sotto stazione tutta la notte. Avevo anche paura del confronto serrato perché non sono un abile oratore. Avevo e ho molte lacune. Avevo paura di un terzo grado o anche di una persona che mi facesse le pulci. Ma forse il vero motivo è che avevo paura di deludere le aspettative. Non ero più abituato alle discussioni intellettuali. Non ero più allenato mentalmente. Soffrivo di timor panico, ovvero di ansia a parlare in pubblico. E poi perché andare? Non ero un letterato. Il mio futuro lavorativo era molto incerto. Avevo altre grane. Le ricordai via email che erano tempi grami per la poesia e che i poeti, aspiranti, sedicenti o effettivi dovevano parlare d’altro e utilizzare la diglossia, parlare nel modo più semplice possibile con la gente. Ciò nonostante mi misi a leggere tutto il suo volume. Sapevo che era un dono prezioso. Ma vivevo in quel periodo una mia crisi interiore e faticavo a esprimere un mio parere articolato. Poi dove pubblicare una mia recensione? Non avevo più un sito né un blog. Inoltre mi arrampicavo sugli specchi perché oltre alle mie contrarietà prettamente interiori, personali mi imbattevo in una voce che faceva dell’unicità la sua caratteristica precipua. La sua poesia sembrava paradossalmente essere a sé stante, autonoma, eppure le sue strutture portanti erano fatte dalla tradizione letteraria novecentesca. Insomma la sua opera si riassumeva nella celebre formula letteraria “tradizione+innovazione”. Ero in un periodo in cui la mia passione per la poesia contemporanea si stava affievolendo. Mi chiedevo a che pro leggere e scrivere? Ma quel libro mi ridava un poco di passione, riaccendeva il desiderio di capire.

La Bettarini però scompigliava le mie certezze poetiche. La sua bravura mi dava addirittura fastidio perché aveva un modo di concepire e fare poesia completamente diverso da come intendevo farlo io. C’era una profondità mista a un’originalità che mi spiazzava. Il suo talento poetico creava in me dei dubbi e delle perplessità. La sua era una poesia sfaccettata in cui confluivano varie anime e molti echi. Era difficile dire la propria e chiudere i miei pensieri così su due piedi come ero abituato a fare. Non era una poesia facile. Ci sarebbe voluto tempo e una certa disposizione d’animo e io rimandai, rimandai e poi abbandonai l’idea di farmene un’idea mia. Ma non c’era niente che non andasse in lei o nella sua poesia; ero solo io che non ero nel momento migliore per accoglierla, farla mia, interiorizzarla. La sua voce arrivava dritta dritta dagli anni ’60, attraversava tutti gli anni ’70 e ’80. Quelle realtà e quel modo di percepirle mi sembravano distanti da me. Eppure con quel passato e con quella poetessa dovevo fare i conti. Non ero un filologo acuto per valutare il suo mutamento linguistico, se era o meno cambiata poeticamente. Quella sua poesia così densa e sostanziosa mi arrivava tra capo e collo all’improvviso e non mi lasciava affatto indifferente. Mi piaceva. Le sue poesie avevano ritmo, musicalità, proprietà di linguaggio, vera intellettualità. Ma da un certo punto di vista mi disturbavano un poco perché non le avevo scritte io e erano totalmente altro da me o almeno sembravano tali di primo acchito. Ma ne ero veramente certo? E se fossimo stati molto più simili di quel che pensavo? A ogni modo non ero certo di niente. Avevo visitato il suo sito. Avevo visto che era stata una maestra. Mi ricordai che anche il miglior poeta pontederese, ovvero Dino Carlesi, era stato maestro elementare. La cosa mi piaceva perché avevo un’ottima opinione dei maestri elementari e mi ricordavo che secondo ricerche internazionali l’unico insegnamento ritenuto valido ed efficiente in Italia era proprio quello elementare. Ma passiamo oltre. Alcuni critici avevano parlato del suo neorealismo fiorentino. Ma la sua poesia era allo stesso tempo complessa concettualmente e denotata da una grande ricchezza lessicale. Immagini, espressioni verbali, metafore, descrizioni, simboli venivano declinati nei modi più disparati: molte erano le tematiche e ancora di più le loro variazioni. La Bettarini col suo modo schietto, confessionale e al contempo discreto metteva in scena tutte le sue sfumature dell’animo. Ma un dato di fatto assodato era che la poetessa scriveva sempre col cuore in mano, pur facendolo con pudore e senza quell’effusione presente in molti, che Sanguineti detestava. Un’altra cosa era che la Bettarini con il suo impegno civile, poetico, letterario, sociale, politico era lì a testimoniarmi e a indicarmi che bisognava di nuovo imparare a vivere sia dal punto di vista privato che pubblico, riprendendo un celebre verso della Achmatova. E imparare di nuovo a vivere significava anche imparare di nuovo a sentire, a pensare, a relazionarsi col prossimo.

Sapevo che quel libro e quella sua dedica erano importanti, erano uno stimolo per me, erano il segno che dovevo continuare a scrivere saggi brevi. Ma quel volume stava anche a certificare un pezzo di poesia fiorentina e poi universalmente italiana. Le lessi una dopo l’altra, ma senza cercare di scorgere metamorfosi interiori né differenze stilistiche. Avvertivo innanzitutto una forte personalità, anche se la presenza dell’io non era assolutamente ingombrante, e il fatto di essere di fronte alla storia di una vita. Ogni poesia si intrecciava con la sua esistenza. L’una richiamava l’altra. Nel volume molto corposo c’erano anche alcuni capitoli delle tesi di laurea che trattavano della sua poesia. Un altro motivo che mi faceva desistere dallo scrivere un commento o una nota critica era che ormai mi trovavo di fronte a una poetessa già riconosciuta, mi trovavo di fronte al fatto compiuto. Che altro avrei avuto da dire? Che altro avrei avuto da aggiungere? Sarebbe stato presuntuoso tentare un nuovo approccio critico. Dovevo farmi da parte e così feci. Mi occupai d’altro. Avevo altri problemi che mi passavano per la testa. Lasciai il libro in un angolo della mia biblioteca. Ogni tanto lo leggiucchiavo di nuovo. Mi sentivo un ingrato a non avergli dedicato del tempo, a non aver scritto niente, a non essermi soffermato. Ero irriconoscente. Ma allo stesso tempo ero ormai convinto che non avrei mai più firmato nessuna recensione per nessuna rivista letteraria. Una cosa che scrissi alla Bettarini, dopo averla letta, è che la sua lingua era impreziosita da tanti toscanismi senza mai forzare troppo la mano e senza mai rivendicare con orgoglio, come fanno moltissimi nostri corregionali, la toscanità. Ora mi viene in mente che in tempi di milanesizzazione nello scritto e nella dizione della lingua italiana la poetessa con la sua opera si opponeva a questa imposizione, quasi questo obbligo morale per chi scrive o opera nei mass media. Già prima dell’avvento di Berlusconi in poesia era egemone la linea lombarda. Una volta addirittura molti anni fa lessi in un muro di una stazione ferroviaria del Nord una scritta leghista, secondo cui non si doveva più parlare toscano. Ma forse, più realisticamente parlando, la poetessa dall’Isolotto provava a concepire una nuova idea della poesia, della letteratura, della cultura, della società, dell’Italia stessa. Queste righe naturalmente non sono un’esegesi. Non voglio fare un’analisi testuale o critica. Era solo un chiarimento doveroso mischiato con alcuni ricordi e con alcune impressioni provate all’epoca. Quel volume è sopravvissuto al trasloco, in cui ho buttato diversi libri e altri li ho regalati alla biblioteca. Lo conservo ancora. Ne sono intimamente orgoglioso di averlo con me. A distanza di anni talvolta rileggo qualche poesia. Non l’ho sottolineato come faccio di solito perché so che è prezioso. Queste righe erano un atto dovuto. Niente di più.
giu 232022

La prova tangibile che i poeti non se li fila nessuno è l’inesistenza del gossip poetico. Se non c’è gossip poetico è perché non interessa nessuno. Cosa volete che importi alle gossippare di professione sotto l’ombrellone o in portineria di poeti e letterati? Se qualche circolo letterario o qualche piccola casa editrice cercasse di ravvivare il mondo poetico con del gossip poetico non alimenterebbe niente, non produrrebbe niente di positivo. Nel migliore dei casi il gossip poetico finirebbe per scimmiottare maldestramente il gossip dello spettacolo. Qualcuno potrebbe sostenere, neanche troppo paradossalmente, che il vero gossip poetico dai tempi di Freud in avanti è la critica psicoanalitica o biografica, che dir si voglia (per intendersi quella che parla delle emorroidi e non degli epistemi, come annotava Montale). Certo a vantaggio di certo psicologismo va detto che il biografismo spesso determina la postura autoriale, lo stile, parte dell’opera, ma non andiamo oltre: il pessimismo cosmico di Leopardi non scaturisce totalmente dal fatto che fosse gobbo, anche se in certa parte ci può influire. Ritornando alla contemporaneità, questo disinteresse totale nei confronti della poesia va avanti da decenni; uno dei segni inequivocabili è che la poesia, almeno quella italiana, sia totalmente fuori dallo show business. La realtà è che la poesia non rientra nel mondo dello spettacolo. Tutti sono artisti nel mondo dello spettacolo, ma per un poeta o una poetessa non c’è mai posto. Nessun poeta di belle speranze ha un agente, un manager. Nessuno caga i poeti. Come distinguere poi il buono dal mediocre? Un tempo l’unico posto concesso dalla televisione generalista, parlo di anni fa, era alla Corrida: qualche spazio veniva lasciato a certi dilettanti allo sbaraglio, che si esponevano al pubblico ludibrio. Ma la stessa televisione generalista ha spesso dileggiato il mondo dell’arte. Vi ricordate quando anni fa Ezio Greggio faceva vedere un quadro e poi sentenziava scherzosamente “tavanata galattica”. La cultura, l’arte, vere o presunte, dovevano sempre subire la presa in giro in nome di una presunta superiorità goliardica. Ogni pretesto, ironico o no, era un modo per dare addosso all’arte. C’era comunque un altro modo di ammazzare l’arte ed era quello di trattarla in modo noioso e soporifero, come accadeva spesso in RAI anni fa. Talvolta oggi si ha l’impressione che qualche poeta cerchi a tutti i costi l’occasione buona per rientrare nel mondo dello spettacolo, cercando di tirare per la giacchetta alcuni cosiddetti vip. Affari loro! Si accontentino pure delle briciole di visibilità che il mondo delle cosiddette “star” danno loro! Eppure un poeta autentico non dovrebbe ambire alla fama a tutti i costi. È vero che per ogni autore esiste il diritto/dovere di essere conosciuto. Ma ciò richiederebbe un minimo di etica, di dignità, di coerenza! Capisco che vivere una vita in perfetto anonimato e con scarsissima riconoscibilità può rovinare il carattere o addirittura la psiche. È altrettanto vero che bisognerebbe avere un minimo di saggezza per godersi pienamente l’anonimato, che – diciamocelo onestamente – la poesia dà. Alcuni/e invece non si accorgono di questi benefici. In definitiva minore è il rumore del mondo circostante e più facile è raccogliersi in meditazione o ammirare le bellezze della natura. Non a tutti capita di essere citati dalla Isoardi per lasciare Salvini come accadde a Gio Evan, che a onor del vero poeta non è e infatti la critica letteraria non lo considera minimamente, nonostante la notorietà (ma tante persone si accontentano beatamente dei surrogati della poesia). Comunque è meglio così. I poeti non avranno gruppi di ammiratrici né bagni di folla, ma possono fare anche giri in centro senza essere disturbati. È vero che un poeta qualsiasi non gode di alcun privilegio, però non ha neanche hater e stalker. Alla stragrande maggioranza dei poeti e delle poetesse non tocca il benessere materiale, a meno che non abbiano una famiglia agiata alle spalle. Pubblicare, andare alle conferenze, incontrarsi con altri letterati, comprarsi libri per rimanere aggiornati sono cose che hanno un costo. È rarissimo che uno con la poesia faccia pari. Di solito ci rimette. E allora vi chiederete voi chi lo fa fare ai poeti? Semplicemente la passione, l’abnegazione, l’amore per la poesia. In fondo oggi tutti sono poeti e nessuno è poeta. Una volta un cantautore diceva molto snobisticamente che oggi scrive poesie anche la casalinga di Voghera. In quel che diceva in un modo molto sbagliato forse un fondo di verità c’era. Di sicuro oggi il tasso di scolarizzazione è aumentato rispetto a qualche decennio fa. La produzione poetica è cresciuta di pari passo. Ci sono talmente tanti premi inutili e talmente tante case editrici non selettive che le cosiddette persone comuni non sanno distinguere chi ci marcia su e chi vale. Per non sbagliare si affidano ai mass media. Così acquista credibilità solo chi viene visto in televisione. Ma i poeti non vengono invitati in televisione di solito; se va di lusso al poeta o alla poetessa viene dato lo spazio di un minuto su RAI3 in tarda serata o di notte. La verità è che la poesia non fa ascolti. Molto probabilmente decenni fa davano spazio a Montale, Ungaretti, Pasolini perché non c’era l’audience e poi i tempi sono cambiati, per alcune cose in peggio e per altre in meglio. Parliamoci chiaro: è mortificante per una poetessa avere studiato, letto, scritto per una vita e non essere considerata dai mass media, mentre la showgirl svampita, dopo qualche passaggio televisivo, ha notorietà e soldi che lei non ha mai avuto in tutta la sua esistenza. È il mercato, purtroppo. Quando Rino Gaetano cantava “allestite anche le unioni dalle dite di canzoni” erano gli anni ’70. Da anni calciatori e showgirl sono sulle prime pagine dei rotocalchi. Vengono celebrati i loro amorazzi, che talvolta sfociano in un matrimonio. Loro hanno la centralità del gossip. Loro hanno l’esclusiva. Ma vuoi mettere starsene in disparte? Ma vuoi mettere essere sconosciuti ai più? Anche perché essere conosciuti ai più come poeti o poetesse non necessariamente è una bella nomina. Molti concepiscono il poeta come persona astrusa che rincorre le farfalle ed è completamente fuori dal mondo. Per molti romani dell’epoca Amelia Rosselli era solo una che scriveva poesie e intendevano ciò in modo canzonatorio, addirittura spregiativo.

Joyce in “Ritratto dell’artista da giovane” scriveva: “Non servirò ciò in cui non credo più, si chiami questo la casa, la patria o la Chiesa: e tenterò di esprimere me stesso in un qualunque modo di vita o di arte quanto più potrò liberamente e integralmente, adoperando per difendermi le sole armi che mi concedo di usare: il silenzio, l’esilio e l’astuzia”. Queste parole sono completamente estranee a certi poeti e poetesse, presenzialisti/e, sempre pronti/e a declamare i loro versi in questo o quel festival. Alcuni/e sono come la gramigna. Sono ossessivamente presenti. Non possono fare a meno di farsi conoscere nei circoletti. Il massimo della soddisfazione e del narcisismo è quando qualcuno chiede loro degli autografi. Hanno coronato il sogno della vita. Tutto sembra basarsi sulla riconoscibilità immediata. Alcuni/e cercano il riscontro del pubblico. Invece sarebbe meglio dosare le forze, centellinare le presenze, essere più preziosi, farsi desiderare di più. Il rischio, a forza di darsi a tutti, è quello di venire a noia. Il mondo quotidiano però è avaro di gratificazioni e di successo per i poeti. Quando si incontrano i poeti talvolta diventa una piccola gara a chi ce l’ha più lungo o a chi è più bella: io ho pubblicato più copie, io ho pubblicato con una casa editrice importante, io ho pubblicato su più riviste letterarie, io ho vinto più premi, io sono in più antologie scolastiche. La cosa paradossale è che se pubblicamente dichiarano la rimozione dell’io lirico in poesia, nei fatti, nei social, nei loro siti internet, nella vita privata cercano l’affermazione del loro io a tutti i costi.

(Nella foto il festival di Catelporziano)
Mai scoperchiare questo vaso di Pandora perché chi descrive pubblicamente questo stato di cose viene criticato, zittito, biasimato in tutte le forme. Gli anni passano per tutti, ma l’importante per certi poeti è avere qualcosa di cui vantarsi nell’angusto mondo delle patrie lettere. Chi denuncia pubblicamente la situazione comatosa in cui versa la poesia italiana è un frustrato, un deluso, un fallito, un aspirante poeta mai riconosciuto. Alcuni dicono che sono cose vere, però non vanno dette. Personalmente a casa mia meno per meno fa più. Personalmente non mi diverto a constatare questo stato di cose, ma lo faccio per spirito di servizio. Ritengo anche che sia questione di avere un minimo di onestà intellettuale e di dire come vanno le cose. Certo ci sono ripicche, invidie, gelosie, compromessi, conflitti, antipatie, simpatie, favoritismi, ostracismi. Anche i poeti sono esseri umani. Allo stesso tempo come canta De Gregori quando tra “buoni poeti ne trovi uno vero è come andare lontano, viaggiare davvero”. Eppure di poeti e poetesse buoni/e e anche ottimi/e ci sono, esistono. Allo stesso tempo non hanno visibilità né dalla critica né dai mass media. Un tempo i poeti che valevano avevano molta più importanza nella cultura. Oggi invece sono relegati a un ruolo marginale, vengono messi in un angolo nascosto. Non c’e da stupirsi se il cosiddetto popolo non considera i poeti, visto che gli stessi letterati, studiosi e appassionati non ne hanno a cuore. Ci sono troppi addetti ai lavori che si occupano di poesia e non l’amano, anzi l’hanno in odio. Eppure ci sono poeti e poetesse brave che meriterebbero successo, denaro, amore. Il sistema invece li respinge, li ricaccia indietro. E loro si estraniano, non partecipano più. La loro funzione sociale sarebbe quella di combattere il sistema dall’interno.

Tutto ciò viene continuamente disatteso e cosa resta in fondo? Un atteggiarsi anticonformista, una posa composta di dolore talvolta mai provato, un piangersi addosso tra sodali, un’elemosinare goffo di consensi. Comunque talvolta per questo scompenso, per questa scarsa considerazione perenne alcuni, non potendo gridare al mondo quanto valgono, finiscono per immalinconirsi, incattivirsi, imbastardirsi, in taluni casi giungono alla smania di grandezza, alla megalomania, al delirio di onnipotenza. Fondamentale è passare sopra queste debolezze umane, queste piccole inezie e prendere il buono: dai poeti e dalle poetesse non bisogna prendere assolutamente le loro tare psicologiche, invece bisogna esclusivamente amare i loro versi. Forse bisognerebbe ricordarsi più spesso ciò che scriveva Rilke: “l’arte è solo una maniera di vivere, e ci si può preparare a essa vivendo”. Spesso ho constatato che poeti più o meno riconosciuti non avendo l’amore dal pubblico e non avendo talvolta pubblico vivono tra rabbia e rassegnazione, in uno stato caratterizzato da grandi delusioni e piccole illusioni. In fondo qualcuno dirà che la poesia stessa è un’illusione, ma anche la vita e il vivere quotidiano che cosa è basato se non sull’illusione costante che tutto domani possa andare meglio? Siamo costretti a vivere di piccole illusioni. Tutti quanti, poeti e no.
giu 222022

Mentre nel mondo si è discusso in questi ultimi mesi dei problemi con i traduttori europei della poetessa americana Amanda Gorman, in Italia si discute per molto meno e per cose di minore importanza in ambito poetico senza nessuna cassa di risonanza mediatica. "Polemica" deriva da polemos, che anticamente era il demone della guerra: nomen omen. Ultimamente i social si sono scatenati contro la modella Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, che ha pubblicato un libro di versi. Alcuni l'hanno definita una "raccomandata", senza scordarsi che molti vip colgono l'occasione di pubblicare con grandi case editrici, sfruttando la notorietà. Qualcuno a riguardo ha scritto che il problema non sono i fenomeni da circo ma il circo stesso. Indipendentemente dal valore dei versi della Soleri bisogna ricordare l'ingenuità di una ventenne. Una poetessa riconosciuta come Maria Grazia Calandrone vi ha trovato dell'originalità, del buono. Poi c'è stata la polemica indegna e ingiusta sul vitalizio ad Aldo Nove. Anche qui alcuni sui social non hanno risparmiato delle critiche, senza considerare i meriti letterari di Aldo Nove. Ci sono state tempo fa polemiche poetiche sulla paternità dello Slam Poetry, che sarebbe del poeta Lello Voce, qui in Italia. Sempre tempo fa ci sono state polemiche sulla validità letteraria effettiva degli Slam Poetry, considerati dal poeta Matteo Fantuzzi una forma di intrattenimento. Più che polemiche sono stati leggeri disappunti quelli della comunità poetica sulla pubblicazione di un'antologia di poesie curata da Jovanotti, (anche se insieme all'editore Nicola Crocetti) oppure sulla grande notorietà di Franco Arminio, Gio Evan, Guido Catalano. In questi casi nessuno si scanna, facendo duelli all'ultimo sangue su Jovanotti, Arminio, Evan, Catalano. I toni si mantengono nei casi suddetti più leggeri. I social e i blog comunque sono talvolta le sagre delle polemiche al vetriolo, polemiche non fatte per niente ad arte. Anche su litblog importanti come Nazione indiana talvolta le discussioni degeneravano. Alcuni leoni da tastiera si facevano forti dell'anonimato e allora giù battute di dubbio gusto, che rasentavano l'insulto. C'era e c'è ancora chi si firma Pippo, Paperino, Nonna Papera. A volte a forza di fare polemiche letterarie si può addirittura rischiare di essere minacciati di morte. Ma di fatto poi non succede niente. Nessuno picchia nessuno. Nessuno ammazza nessuno. Fortunatamente non finisce come con i rapper americani, dato che qualcuno lì negli States è morto assassinato. C'è comunque chi non la prende affatto bene ed esce dal seminato. Ci sono a ogni modo commentatori di blog professionisti, che passano delle ore a leggere, commentare, controbattere, argomentare. È il gusto primigenio della discussione, intesa come momento di crescita culturale. Talvolta il thread ha esiti imprevedibili. C'è chi va fuori tema oppure chi si fissa su una cosa secondaria. La questione si può fare personale, ci possono essere attacchi privati. Ma sono rimasti pochi i commentatori compulsivi. Di solito le persone oggi manifestano il loro gradimento con un like o un cuoricino. Di solito se scrivono per l'appunto sono laconici e scrivono due righe. Forse è il segno che i blog sono morti o che sono dei moribondi e che oggi non è più di moda commentare su di essi. Di certo non è per mancanza di dialettica. È solo che la maggioranza delle persone non vuole polemiche. Le ritiene inutili. Non dico che sia bene o male, giusto o sbagliato, ma penso che la mia sia un'interpretazione corretta. Nei social divampano di più discussioni, che talvolta sfociano in liti. Ci possono essere discussioni costruttive come quelle sull'autoreferenzialità della poesia italiana, sul fatto che i poeti sono troppi, sull'assenza di pubblico, sulla linea di demarcazione tra poesia e non poesia, sulla fine del postmoderno, sul fatto che si possa parlare o meno di neo-neoavanguardia. Però anche in questi casi la discussione può avere risvolti molto negativi. Succede così che le discussioni poetiche diventano spesso dialoghi socratici incompiuti, in cui c'è solo la pars destruens ma manca la pars costruens. Non si risolve mai il problema. Il rischio è quello di perdersi in questioni di lana caprina e di azzuffarsi per niente. Forse sui social si respira un'aria familiare, ci si sente più a casa, si ha la percezione errata che tutto quello che postiamo non sia pubblico e non sia letto dal prossimo. Forse sui social ci sono più reazioni perché consentono una maggiore reattività. La maggioranza dei poeti, veri o presunti, si chiama però spesso fuori dalle polemiche. Anche se qualcuno li istiga, li aizza non rispondono. Hanno tutto o poco da perdere, ma qualcosa da perdere ce l'hanno. Non vogliono rischiare crisi reputazionali. I poeti cercano nella maggioranza dei casi di non farsi nemici. Ecco allora che cercano di stringere alleanze, che cercano sodalizi, collaborazioni. Nascono simpatie, addirittura amori. Dove non c'è l'amore o la stima viene stipulato di solito il patto di non belligeranza. La comunità poetica è a sua volta suddivisa in diverse fazioni. Ci sono i neolirici, i poeti di ricerca, i performer, etc etc. Si affacciano sulla scena anche gli istantpoets. Ci sarebbero poi i poeti di strada. Di solito cercano di sopportarsi a vicenda, nonostante le insofferenze di qualcuno. L'odio quando viene covato rimane un fiume carsico per questione di desiderabilità sociale, di convenienza, di scaltro opportunismo.
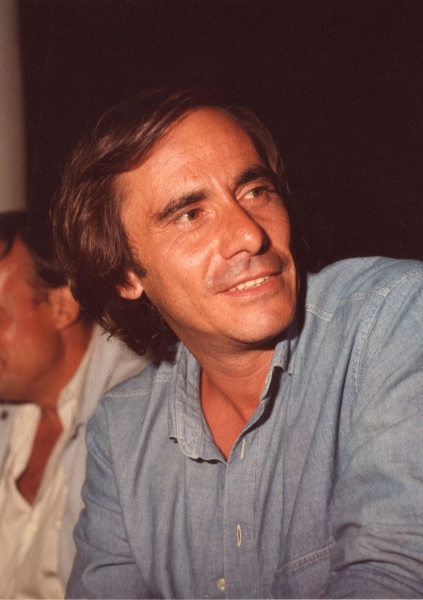
Riguardo ai poeti è vero ancora oggi in parte quel che cantava Roberto Vecchioni:
"I poeti son liberi servi di re e cardinali
Che van ripetendo "Noi siam tutti uguali"
E si tingono di rosso vivo
Ciascuno pensando "Il giorno del Nobel farò l'antidivo"...
...I poeti son giovani stanchi che servon lo Stato
Sputandogli in faccia perché sia dannato
E sbandierano cieli e fontane, messaggi e colombe
A noi le campane, ai ricchi le trombe."

Ma è a mio avviso sempre attuale anche il ritratto che ne fece Francesco De Gregori:
"Vanno a due a due i poeti
Verso chissà che luna
Amano molte cose, forse nessuna
Alcuni sono ipocriti, gelosi come gatti
Scrivono versi apocrifi, faticosi e sciatti
Sognano di vittorie e premi letterari
Pugnalano alle spalle gli amici più cari
Quando ne trovano uno ubriaco in un fosso
Per salvargli la vita gli tirano addosso
Però quando si impegnano lo fanno veramente
Convinti come sono di servire alla gente
Firmano grandi appelli per la guerra e la fame
Vecchi mosconi ipocriti, vecchie puttane. "
Naturalmente un'altra discussione ancora aperta e interminabile è se la canzone d'autore possa essere considerata poesia o meno.
Ma potremmo citare a questo proposito il già classico Dino Campana, che scriveva: "Vo alla latrina e vomito (verità). / Letteratura nazionale / Industria del cadavere. / Si Salvi Chi Può".
Ritornando alla questione delle polemiche, le liti tra letterati, poeti, amanti della poesia sono rare ma accadono. Non sono all'ordine del giorno. Non sono la normalità, ma accadono. Uno si arrabbia, perde le staffe, ci può rimettere a lungo termine in salute. Gli attacchi personali così come le diatribe possono generare ansia ma anche rabbia incontrollata. Croce scriveva: "la polemica mi rinfresca il sangue". In realtà a molti di solito lo può avvelenare il sangue. Oppure uno può fregarsene quasi totalmente o addirittura accettare a malincuore e con rassegnazione questo stato di cose. Ci sono inoltre le shit storm. Viene presa di mira una persona, viene accerchiata virtualmente, fioccano una serie inenarrabili di critiche di bassa lega, di commenti negativi e faziosi, se non di insulti. La diffusione di responsabilità sembra legittimare tutto ciò. Alcuni non percepiscono il discrimine tra un sano diritto di critica e la diffamazione aggravata online. Un tempo esistevano i troll che non lesinavano punzecchiature, toni scherzosi, deridendo chi prendevano di mira. Oggi ho la netta sensazione che la situazione sia degenerata. Ci sono polemiche che generano attriti, antipatie tra appartenenti alla comunità poetica oppure ci sono anche attriti, antipatie preesistenti che generano nuove polemiche. Comunque dovendo rinunciare alle risse dei talk show non avendo tale possibilità mediatica i poeti, veri o presunti, si devono accontentare di quello che passa il web. Se uno assurge a un minimo di notorietà si presentano gli ammiratori acritici e gli hater. Poi non è solamente questione di talento, di pubbliche relazioni, di fortuna critica. Come scriveva Alberto Arbasino: “In Italia c'è un momento stregato in cui si passa dalla categoria di bella promessa a quella di solito stronzo. Soltanto a pochi fortunati l'età concede poi di accedere alla dignità di venerato maestro.” Ma la comunità poetica va detto che è un grande calderone. Chi può a pieno diritto dire di appartenervi? Tutti e nessuno, ovvero poeti e letterati effettivi, aspiranti, sedicenti. È tanto opinabile quanto arbitrario stabilire chi è un poeta. Basta aver pubblicato un libro, seppur a pagamento o esserselo autopubblicato? Bisogna aver vinto un premio purchessia, anche quello della propria parrocchia o del circolo letterario a cui si è iscritti? Bisogna avere pubblicato solo su litblog, riviste letterarie? Oppure possono fregiarsi del titolo di poeti e poetesse solo coloro che pubblicano con grandi case editrici? È vero che il web è la fossa del leone e i nuovi leoni ora sono i social. La critica è quasi inerme, sta sulla difensiva, arroccata nella qualità. Perfino gli editori però controllano la popolarità sui social, il numero di follower degli aspiranti poeti, che ormai devono essere webpoet. Dopo tanto odio ecco che arriva il giusto riconoscimento dopo una sudata carriera letteraria; ecco un profluvio, una massa di necrologi, di attestati di stima, di elogi sperticati al momento della dipartita: una vera e propria celebrazione in pompa magna che durerà pochissimo e non lascerà alcuna traccia perché ormai niente lascia più traccia sui social, come scriveva oggi il poeta Luca Alvino. E allora cosa è che resta se resta? Resta la grande poesia e restano i grandi poeti. Come scrisse Alfonso Berardinelli: "Io non credo nella poesia. Credo soltanto in quelle poesie che mi fanno credere in loro. Se convince il lettore, la poesia non ha bisogno di essere difesa".
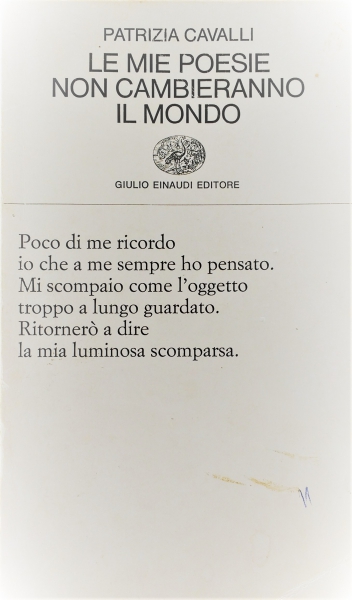
È morta una grande poetessa come Patrizia Cavalli il 21 giugno. Non ho scritto nessuna riga su Facebook. Non ne aveva bisogno. Quando era in vita ho acquistato alcuni suoi libri. Quello che potevo fare l'ho fatto. Era il minimo indispensabile, ma non la conoscevo ed ero impossibilitato a fare di più. Adesso non piango lacrime di coccodrillo né fingo che fosse una persona amica. Restano dentro me alcuni suoi versi e forse non è poco. Scusate se non sono falso e scrivo a ciglio asciutto. Spetta ad altri più titolati di me o anche più vicini a lei scriverne e parlarne. Una mia commemorazione fatta, lodandola come poetessa sarebbe inopportuna e fuori luogo. I coccodrilli li scriva chi di mestiere. E scrivo ciò senza voglia di fare polemica; ci mancherebbe.
giu 222022

La fantascienza, nonostante i capolavori di Asimov e P. Dick, è stata per molto tempo considerata un genere minore. Eppure descrive le nostre paure, le nostre angosce, anticipa i tempi, ci proietta nel futuro. Non tratta solo delle invasioni degli alieni o di macchine del tempo. Talvolta alcuni racconti sono incentrati sullo straniamento, inteso come rovesciamento di prospettiva: si veda ad esempio il celebre racconto breve di F. Brown “La sentinella”. La fantascienza talvolta è il futuribile e stimola la fantasia, che è fondamentale per la conoscenza umana. Anche la letteratura combinatoria di Perec, Queneau, Calvino può stimolare l’immaginazione. E che dire dei celebri racconti di Borges o di Augusto Monterroso? Anche questa letteratura come la fantascienza si volge agli infiniti possibili, descrive universi paralleli. Per Popper la scienza è fatta di congetture e confutazioni. Gli scienziati devono usare la fantasia per formulare ipotesi. Lo stesso Einstein sosteneva che “la logica porta da a a b, mentre l’immaginazione porta ovunque”. La scienza per noi uomini comuni procede dall’ignoto al noto, ma per i ricercatori procede dal certo (i dati) al probabile (le scoperte, le nuove teorie). La fantascienza ci mostra “Le meraviglie del possibile” (dal titolo di una celebre antologia di racconti). Possiamo esercitare la nostra fantasia, ma oggi non sappiamo come nascono certe intuizioni. È difficile essere individui veramente completi o come si suol dire saper utilizzare entrambi gli emisferi. Alcune persone giungono all’insight, riescono a ristrutturare cognitivamente un problema e a risolverlo, ma non sappiamo il motivo. Possiamo per ogni scoperta scientifica descrivere l’intuizione che ha portato alla soluzione, ma non possiamo definire in modo esaustivo e calzante l’intuizione: ogni definizione generica per ora è astrusa. Forse potremmo dire che l’intuizione è una illuminazione, un salto intellettivo fondamentale per il problem solving. Niente di più. Possiamo solo affermare che noi esseri umani siamo fortunati perché i nostri stati mentali corrispondono con la realtà. Possiamo anche affermare che non sappiamo se il progresso sia infinito perché non sappiamo se la conoscenza umana sia infinita. Realisticamente potremmo dire che se non sappiamo risolvere certi rompicapo per un meccanismo di compensazione vorrà dire che ne sapremo risolvere altri. Un’altra cosa da tenere presente è che bisogna sempre usare il rasoio di Occam: non si deve moltiplicare gli enti. Lo stesso Einstein era dell’idea che si doveva togliere, levare. Infatti affermò che bisogna rendere le cose nel modo più semplice possibile ma senza semplificarle. Gianni Rodari ha scritto una grammatica della fantasia, analizzando tutti gli usi della parola e tanti modi per inventarsi storie. In ambito scientifico e nella psicologia del pensiero sono state scritte migliaia di guide alla creatività, ma questa rimane allo stato attuale delle conoscenze un mistero. Per Enrico Fermi la creatività scientifica poteva essere stimolata cercando di fare stime approssimative e insolite come ad esempio cercare di calcolare quanti accordatori di pianoforti c’erano in un paese di un certo numero di abitanti o come calcolare quante bevande di una certa marca vendesse in una settimana un negozio di alimentari in una certa città. Molto spesso i suoi studenti rimanevano spiazzati dalle sue domande. Solo pochi dimostravano una certa capacità analitica. L’analisi di un problema può essere nota. Sappiamo quali sono le regole della logica deduttiva e induttiva. La questione controversa è come giungere alla sintesi e non all’analisi. Secondo Piaget per risolvere i rompicapo scientifici bisogna avvalersi del pensiero ipotetico-deduttivo, si deve cioè pensare a ogni possibile combinazione e a ogni possibile aspetto del problema. In una parola sola bisognerebbe vagliare tutte le ipotesi. Secondo alcuni psicologi la creatività può essere stimolata con il brainstorming, la meditazione, il training autogeno, delle lunghe camminate, il bere caffè, stare a contatto con la natura. Talvolta si tratta di riformulare il problema, altre volte si deve cercare nuove associazioni idee. Molto spesso bisogna chiedersi cosa succederebbe se si facesse in un altro modo, ma ciò che è difficile è trovare il modo giusto. Talvolta si ha la sensazione che alcuni scienziati si inventino col senno del poi nuove teorie della conoscenza scientifica. La stessa epistemologia può essere illuminante come filosofia della scienza, ma può lasciare a desiderare come metodologia della ricerca scientifica. Si pensi solo a Lakatos che teorizza l’anarchia metodologica. Insomma si brancola ancora nel buio o quantomeno si procede a tentoni in un terreno accidentato. C’è anche chi ritiene che la creatività non esista o che sia una terra di nessuno e che non si debba fare una mitologia del lampo di genio. Per queste persone sarebbe solo questione di fortuna e come pensava Pasteur “la fortuna aiuta le menti preparate”. Sicuramente gli scienziati procedono per prove ed errori. In fondo i comportamentisti scoprirono che anche questa era una forma di apprendimento efficace.

Dopo aver accennato molto sinteticamente alla relazione tra scienza e fantascienza, vorrei trattare del genere distopico, in particolare del genere post-apocalittico, anche se non sono un cultore della materia. Alcune volte certe distopie si sono avverate, ma vorrei ora parlare di alcuni dubbi che ho su certi romanzi e certi film. Ci siamo evoluti culturalmente ma non cerebralmente rispetto a migliaia di anni fa. Per creare utensili tipici degli uomini primitivi ci vogliono oggi pazienza certosina e ore di lavoro. Hanno fatto degli esperimenti con degli studenti universitari. Si pensi che non è affatto semplice accendere il fuoco senza fiammiferi, senza accendino o senza gas. Siamo come si suol dire dei nani sulle spalle dei giganti. Tutte le conquiste della nostra civiltà occidentale, ovvero tutti gli artefatti della tecnologia li diamo per scontati, eppure senza di essi non avremmo mai avuto la nostra zona di comfort, la nostra qualità della vita e la nostra aspettativa di vita. Essere umani significa vivere in società e avvalersi delle competenze altrui. Tutto questo mi ricorda un racconto breve di Calvino in cui il protagonista non sa allacciarsi le scarpe e ha bisogno di qualcuno per questo. Nessuno di noi è veramente autosufficiente. Bisognerebbe ricordarselo più spesso. Queste cose mi sembrano in genere sottovalutate o addirittura non prese in esame dagli scrittori che si immaginano scenari post-apocalittici. Gli stessi scrittori molto spesso non ci forniscono motivi plausibili per cui uno o pochissimi sono sopravvissuti e invece il resto dell’umanità no. Mi sembrano a mio modesto avviso ipotesi illogiche, poco realistiche e oserei definirle impossibili. Qualcuno potrebbe chiamarle controfattuali. Insomma per scenario post-apocalittico si intende la fine dell’umanità meno uno o meno pochissimi: un controsenso se pensiamo a rigor di logica. Così come nei libri di questo genere gli autori non si soffermano mai sulle conseguenze psicologiche che avrebbe la deprivazione sociale del protagonista o dei protagonisti. Uno scenario post-apocalittico potrebbe avere dei risvolti positivi dal punto di vista ecologico, ma nutro dei seri dubbi che potrebbe averli dal punto di vista antropologico. Però è solo questione di punti di vista. Siamo nell’ambito dell’opinabile. Nessuno sa con certezza cosa accadrebbe e come reagirebbero i sopravvissuti. Queste sono le critiche che faccio io. Naturalmente siamo nel genere fantascientifico che non è solo science fiction ma in cui si può conciliare l’inconciliabile, immaginare l’inimmaginabile; un genere che è contrassegnato anche dal gusto del paradosso. Comunque io nutrirò sempre delle perplessità riguardo a questo genere. Spesso viene trattato uno scampolo di umanità sopravvissuta a una catastrofe superficialmente dal punto di vista umano. Non è questione in questi casi di immaginare per assurdo, attività più che lecita. Anche quando si vuole descrivere un universo parallelo lo si deve però fare in modo completo e senza tralasciare elementi essenziali. Spesso nella fattispecie vengono omesse alcune qualità e caratteristiche fondamentali, imprescindibili dell’essere umano. Ammettiamo pure che tutto sia possibile (anche l’impossibile) nel futuribile, ma l’essere umano dovrebbe essere considerato ancora umano. Come scrisse Terenzio: “sono uomo, niente di ciò ch’è umano ritengo estraneo a me”. A mio modesto avviso i libri di questo genere non contemplano a sufficienza l’interdipendenza degli esseri umani, solo per fare un esempio. Purtroppo gli ingegneri hanno bisogno di medici, i medici hanno bisogno di ingegneri, ma anche i barbieri hanno bisogno di altri barbieri, i medici hanno bisogno di altri medici, i preti hanno bisogno di altri preti, gli psichiatri di altri psichiatri supervisori, eccetera eccetera. Qualsiasi comunità si basa sulla divisione del lavoro, che significa anche suddivisione delle competenze. Senza uno straccio di comunità il singolo individuo vivrebbe pochissimo. La cosiddetta “sospensione di incredulità” a mio avviso deve essere supportata da conoscenze scientifiche e da una ricostruzione attendibile dal punto di vista psicologico, sociologico, antropologico. Questa formula “sospensione di incredulità” può significare anche credere all’incredibile, esattamente come una religione (solo che la fantascienza fino ad ora non ha mai fatto miracoli). Qui forse non si tratta più di ragionare, criticare costruttivamente. Il vero discrimine forse è quello di credere o non credere. Più esattamente lo scrittore in questi casi immagina per assurdo e il lettore crede per assurdo. Tutti i cultori della fantascienza hanno il diritto di ragionare per assurdo. E gli altri? I miscredenti non possono ragionare in modo non dico razionale ma ragionevole? È forse da stolti per esempio cercare l’intellegibile in questo mondo assurdo? Calvino inoltre sosteneva che la creatività fosse costituita da una fetta di pane con la marmellata: mi dispiace ma spesso trovo questo genere troppo melenso e senza adeguate infrastrutture. È vero che in caso di scenario post-apocalittico le strutture economiche e le sovrastrutture ideologiche verrebbero meno ma le infrastrutture psichiche ad esempio rimarrebbero. Bisogna considerare ciò. Altrimenti la rappresentazione è distorta e falsa. Altrimenti “l’esperimento mentale” e l’esercizio di immaginazione servono a poco. Molto probabilmente siamo tutti o quasi “polli di allevamento” come cantava Gaber. Non resisteremmo che qualche giorno in uno scenario del genere. Molto probabilmente non sapremmo far fronte alle emergenze e ai pericoli della natura. Fanno corsi di sopravvivenza per manager, reality televisivi in cui i partecipanti vivono per qualche giorno in situazioni estreme. Però ci sono sempre tutor oppure delle troupe che li supportano. Se questi soggetti fossero lasciati soli a sé stessi avrebbero vita molto breve. Se si pensa invece al genere post-apocalittico come critica all’antropocentrismo e alla società attuale a mio modesto avviso ciò può essere più utile. Ritengo anche che questo genere potrebbe far scaturire degli interrogativi di fondo interessanti: che ne sarebbe in condizioni così estreme di tutte le mutazioni antropologiche e dell’uomo postumano? Cosa succederebbe all’uomo non più inserito in una società fondata sulla creazione di falsi bisogni come scriveva Marx? Cosa sarebbe veramente necessario? Ma mi chiedo anche se abbiamo veramente bisogno di essere stimolati dalla fantascienza per porsi questi interrogativi. In fondo per riflettere sul destino del nostro pianeta basta leggere una intervista di un astronauta, che in orbita ha provato dolore per questo mondo e ha sentito un vero legame con la Terra. Abbiamo veramente bisogno del genere post-apocalittico per meditare su una umanità veramente autentica e su una esistenza veramente autentica? Nello scenario post-apocalittico che cosa resta dell’uomo? Non c’è più ricambio cellulare e non rimarrà più niente della pelle morta nel corpo del pianeta. A mio avviso non vengono prese in esame tutte le caratteristiche umane in modo veritiero. Vengono per così dire falsate. Per analizzare e descrivere la natura umana e le dinamiche sociali, anche quelle di poche persone, a mio avviso non bisogna pensare l’homo homini lupus e neanche l’homo homini deus ma semplicemente l’homo homini homo. Mi sembra che alcune problematiche dell’essere umano vengano tralasciate in certi romanzi e in certi film. Forse lo fanno per questione di sintesi, forse rispettare i canoni della letterarietà. La casistica della vita allo stato brado non è infinita ma quasi. Forse lo fanno per esigenze di spazio o per non essere particolarmente crudi. Forse certi dettagli non interesserebbero che pochi lettori e preferiscono sorvolare. Ci sono ancora oggi popoli che vivono in tribù allo stato quasi primitivo. Forse è più educativo leggere qualcosa sui loro usi e costumi che leggere una distopia. Però naturalmente è una mia opinione, senza nulla togliere alle visioni e alle intuizioni degli scrittori di fantascienza. Infine vorrei sottolineare che di solito gli scrittori di fantascienza talvolta sono degli scienziati ma di solito hanno scarse conoscenze sociologiche, psicologiche, antropologiche. Infine faccio una considerazione molto amara. Per quel che mi riguarda sono dell’idea che la cosiddetta normalità ci sta conducendo all’estinzione della specie. I cosiddetti folli al massimo commettono qualche omicidio o suicidio: roba da niente al confronto! Per non parlare poi della cosiddetta demopatia strettamente connessa all’oligarchia patologica (ed entrambe ampiamente tollerate)! La normalità tanto sbandierata non esiste di fatto. Questo è un mondo folle e di folli. Quando c’erano i manicomi qualcuno diceva e scriveva che i pazzi erano fuori. Siamo così sicuri che i normali siano veramente normali e i folli veramente follii? Per il momento sono solo apocalittico e non ancora post-apocalittico.
giu 222022
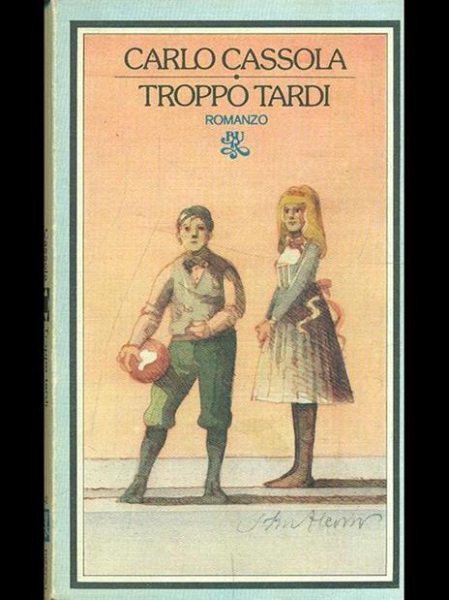
È ormai caduto nel dimenticatoio Carlo Cassola, che ha vinto a suo tempo premi letterari importanti come lo Strega e il Bagutta. Non rientra ormai nei canoni letterari. Gli italianisti a stento lo citano. Il suo nome e i suoi romanzi sono caduti nell'oblio. Eppure negli anni '60 e' 70 aveva una grande popolarità e un vasto consenso. Le sue opere avevano avuto notevole risonanza nel pubblico. Come scrive Cassola non è esatta l'equazione successo=demerito, ancora in voga oggi e utilizzata da tanti critici letterari. Qualcuno però, soprattutto in Toscana, lo ricorda ancora Cassola. Recentemente la tratta ferroviaria Cecina-Saline, di cui aveva scritto in "Ferrovia locale" è assurta alla cronaca per delle iniziative culturali in memoria dello scrittore, che era nato a Roma ma toscano d'adozione, tanto è vero che aveva ambientato molti romanzi nell'entroterra pisano. Nel 2020 l'università Cattolica ha istituito un premio di laurea in memoria di Cassola. La biblioteca comunale degli Intronati di Siena ha allestito una mostra bibliografica in suo ricordo.
I letterati non sono mai stati benevoli con lui. Alcuni critici hanno visto nella sua narrativa il ritorno al grado zero della scrittura. Altri però hanno evidenziato l'influsso delle epifanie di Joyce. Cassola è stato uno scrittore coerente stilisticamente e politicamente. I suoi libri erano letteratura ma erano anche best seller. La neoavanguardia lo accusò di essere la Liala del '63, ma lui con stile ed educazione andava a braccetto con Sanguineti. Pasolini lo criticò perché i suoi libri erano un ritorno al realismo. Nei suoi romanzi non ci sono le tematiche comuni a tanta narrativa in auge all'epoca: la nevrosi, l'alienazione, l'incomunicabilità, l'inettitudine. Erano tutti argomenti, considerati di primaria importanza per gli artisti. Lui si astiene da tanta intellettualità. Nel Novecento letterario il mondo e anche la psiche sono costituiti da frammenti eterogenei e la verità umana si trova solo nel dettaglio. La verità si fa puntiforme. I romanzi del ’900 sono i segni di una crisi profonda. Cito tra tutti “L’uomo senza qualità” di Musil, “Oblomov” di Goncarov, “Auto da fé” di Canetti, “La cognizione del dolore” di Gadda, “La coscienza di Zeno” di Svevo. Ma di esempi se ne potrebbero fare altri.

(Nella foto Carlo Cassola)
Cassola invece privilegia il grigiore dell'esistenza, le vite comuni, connotate dall'insensatezza. Il poeta Carlo Bordini diceva che c'era della narratività nella sua poesia e della poesia nella sua narrativa. Anche in Cassola in fondo troviamo una commistione di generi. Non c'è una prosa lirica, una prosa poetica, ma la poesia della quotidianità. Spesso sono narrati fattarelli insignificanti di personaggi umili e dimessi con un lessico comune. La trama è scarna, mai avvincente, mai ricca di colpi di scena. I grandi eventi, la storia stanno molto spesso sullo sfondo. Eppure si percepisce la lunga mano sapiente di Cassola che orchestra e dirige tutto fin nei minimi dettagli: un grande narratore acuto e consapevole. Nessuna traccia comunque di quella che oggi chiameremo realtà aumentata o iperrealismo. L'acme della vita sta nei vagiti, negli orgasmi, nei rantoli. Ma nessuno sa con certezza quali sono gli istanti decisivi, i momenti topici del percorso. È anche questo che vuole dirci lo scrittore, che rimuove l'inconscio e non cerca mai di fare la rivoluzione: in vita sua ha già fatto la Resistenza e questo è più che sufficiente. Quindi non è mai stato velleitario né demagogo.
"Troppo tardi" è ambientato a Roma ai tempi del fascismo. Tratta di due fratelli adolescenti, Anna e Giorgio, abbandonati dal padre. I due hanno un rapporto ambivalente come si usa tra fratelli. La madre ha una mentalità comune, tiene molto al decoro piccolo-borghese. Vivono in una appartamento in affitto nel quartiere Prati. I due vengono mandati a scuola, ma Anna decide di interrompere gli studi di stenografia perché è svogliata. Non sa quello che vuole. Alcuni giorni si veste per passare inosservata, altri giorni si veste in modo vistoso per attirare l'attenzione. Il romanzo per la maggior parte è essenziale e dialogico. Nelle conversazioni tra ragazze si parla di questioni amorose, di confidenze. Anna è irrequieta, vorrebbe vivere "cento vite". Ma deve stare attenta perché basta accettare un invito in macchina da un medico per rischiare seriamente di venire abusata. Il dottore infatti la porta in campagna in un luogo appartato, ma lei riesce a opporsi efficacemente. Giorgio fa le sue congetture sulle ragazze. Cerca di trovare differenze di costume tra quelle che lavorano e quelle che studiano, pensa che le ragazze delle grandi città siano tutte poco serie: insomma pensieri e pregiudizi ricorrenti nei ragazzi di ogni generazione. Cassola si fa sfuggire un commento, un'osservazione amara, mette in bocca ai suoi personaggi una sentenza inoppugnabile: nella vita è solo questione di soldi, coi soldi si può essere generosi o farsi perdonare tutto. Su tutto prevale la cupidigia, il culto del denaro e un’etica del lavoro, che se analizzata risulta riprofevole. La trilogia di Mastronardi ad esempio (“Il maestro di Vigevano”, “Il calzolaio di Vigevano”, “il meridionale di Vigevano”) è eloquente a riguardo, illustra chiaramente la grettezza e l’arrivismo della borghesia votata esclusivamente al profitto. Ma quelli descritti da Cassola erano anche i tempi in cui una ragazza se usciva la sera e fumava le sigarette destava scalpore e scandalo nei perbenisti. C'era una ristrettezza di vedute all'epoca. Poco era consentito e molto era tabù. Anna si sposa incautamente e frettolosamente con un avvocato di mezza età di Recanati, che ha conosciuto a una festa. Eppure prima aveva conosciuto Ferruccio, amico di suo fratello, con cui c'era stata un'amicizia affettuosa senza intimità. L'unica affinità elettiva tra Anna e il suo marito era che entrambi si annoiavano a quella festa. Il suo fratello si sposa senza pensarci troppo con l'incoscienza della gioventù. Si può affermare che come i protagonisti di "Delitto e castigo" di Dostoevskij e di "I sotterranei del Vaticano" di Gide compiono l'omicidio assurdo allo stesso modo in questo romanzo i due fratelli compiono un gesto assurdo sposandosi entrambi in modo avventato. Ma la guerra inizia a trasformare le vite dei protagonisti. Il marito di Anna va in guerra e di lui per diverso tempo non si hanno più notizie. Anna e Ferruccio diventano amanti. Ferruccio si mette a fare il giornalista. Giorgio perde l'impiego perché scoperto in combutta coi repubblichini. A tratti il romanzo diventa concettuale, soprattutto quando Ferruccio, amante di Anna, decide che vuole fare lo scrittore, decide di spendere gran parte del suo stipendio in libri ed allora vengono fatte delle riflessioni intellettuali sui romanzi del Novecento. La digressione però non annoia. Il marito di Anna ritorna e chiede la separazione. Ferruccio poi capisce di non amare più Anna perché si invaghisce di una ragazza molto più giovane. Cassola si dimostra maestro a rivelare le contraddizioni dell'animo, ormai insanabili dei suoi personaggi. In fondo se i lettori dell'epoca si appassionavano per le vicissitudini narrate nei suoi libri qualche motivazione più che plausibile c'era, ovvero il fatto di essere letteratura di consumo di alta qualità per quei tempi. Infine come nel romanzo "L'antagonista", che Cassola considerava la sua miglior opera, anche qui c'è un duello a distanza tra due maschi, che si contendono una donna.

(Nella foto Davide Morelli con l'amico di infanzia Emanuele Morelli dopo tre birre)
Ricapitolando e facendo una breve sintesi dei romanzi italiani sul nazifascismo e sulla seconda guerra mondiale abbiamo:
"Uomini e no" di Vittorini: la Resistenza a Milano e la rappresaglia dei tedeschi
"La storia" della Morante: romanzo corale, crudo, ambientato a Roma, criticato anche per la descrizione della crudezza della Resistenza
"Il giardino dei Finzi Contini" di Bassani : la condizione degli ebrei a Ferrara
"Se questo è un uomo" di Primo Levi: il lager
"Cristo si è fermato a Eboli" di Carlo Levi: il confino
"Il sentiero dei nidi di ragno" di Calvino: la Resistenza vista con gli occhi di un bambino
"Il partigiano Johnny" di Fenoglio: la presa di Alba e la Resistenza nelle Langhe
"Lessico famigliare" della Ginzburg: l'attività antifascista e gli intellettuali antifascisti
"La polvere sull'erba" di Bevilacqua: il triangolo rosso in Emilia
"Il sergente nella neve" di Mario Rigoni Stern: la ritirata in Russia
"La ragazza di Bube" di Cassola: ex partigiano che uccide il figlio di un carabiniere
"Il clandestino" di Mario Tobino: la lotta partigiana in Versilia
"L'ombra delle colline" di Arpino: l'uccisione di un tedesco da parte di un bambino
"L'Agnese va a morire" di Renata Viganò: la staffetta partigiana
"La casa in collina" di Pavese: la fuga e il rifugio dai bombardamenti nazisti
"Troppo tardi" di Cassola: la storia di un fratello, di una sorella e dei suoi due amori ai tempi del fascismo e della guerra.
giu 222022

Questo libro della scrittrice canadese, premio Nobel per la letteratura nel 2013, è una raccolta di 9 racconti. C'è del vitalismo più o meno disperato nei racconti della Munro, che ha un tipo di scrittura che riesce ad aderire alla vita. Coincide, corrisponde perfettamente senza espedienti e infingimenti. Riesce a coinvolgere il lettore con la sua scrittura. Riesce a parlare con il cuore in mano. Uno dei maggior pregi nei testi è l'immediatezza, la scorrevolezza. La scrittrice ha uno sguardo profondo e partecipe sulla condizione umana, è una indagatrice della natura umana. Il suo stile è asciutto e impeccabile. Ogni suo racconto è un microcosmo. Nel primo Johanna riceve delle false lettere d'amore, ingannata da due ragazzine. Va a comprare un abito da sposa e la negoziante è soddisfatta di averglielo venduto perché così per quel giorno ha giustificato la sua esistenza. Tutto ciò fa pensare alla romana di Moravia secondo cui ognuno è ciò che fa. La commerciante aveva trovato la sua ragion d'essere, il suo motivo di esistere in una cittadina, che rappresenta qualsiasi mondo concentrazionario. Questa frase della Munro è già di per sé molto azzeccata e appropriata perché in America è davvero così: nella società utilitaristica, pragmatica, tutti devono avere un ruolo ben preciso, disegnato (altrimenti si finisce per essere come nella poesia disperata "College all'angolo della via" di Kenneth Patchen, in cui il protagonista non è mai stato niente, nemmeno soldato). È un dramma in America non fare niente, non occuparsi di niente. La Munro lo esprime molto bene in una sola frase, messa in bocca a una negoziante in crisi con scarsa clientela. Nel racconto "Ponte galleggiante" Jinny, donna sposata e malata di tumore, riesce a ravvivare l'esistenza baciando un ragazzo. In "Conforto" Nina ha una doppia vita e si divide tra il marito padrone e l'amante. Ma forse il racconto che rende meglio l'intensità, il dolore e la drammaticità della vita è "The Bear Came Over the Mountain", in cui viene descritta la relazione tra un marito ed una moglie, che sta perdendo la ragione. Viene insomma trattato il tema della demenza senile. E la domande che sorgono spontanee sono che cosa resta della persona dopo l'insorgenza della malattia e cosa resta conseguentemente dell'amore tra i due. Questo racconto ha avuto una trasposizione cinematografica: Away from Her (Lontano da lei), diretto da Sarah Polley. La Munro sembra un fiume in piena. I suoi testi non sembrano pensati e ripensati, corretti e modificati. Sembrano tutti pubblicati alla prima o al massimo alla seconda stesura. Se sono stati modificati molto probabilmente ha tolto e non aggiunto perché in questi racconti si tratta di levare più che di battere. Non bisogna guardare quindi alla forma mentis dell'autore. D'altronde in un romanzo o in una raccolta di racconti non bisogna cercare le congetture filosofiche, le digressioni pseudo-psicanalitiche o le descrizioni di paesaggi o città. Tutto ciò annoia a lungo termine. Bisogna cercare invece chi riesce a raggiungere la vita o quantomeno si sforza di farlo.

La Munro riesce a descrivere gli eventi, a riportare casomai le conversazioni e a narrare gli stati d'animo nel modo più realistico possibile. Allo stesso tempo dimostra di avere una invidiabile capacità introspettiva. Molti romanzi, anche dei capolavori, se li paragono ai racconti della Munro, mi sembrano artefatti. La scrittrice canadese forse era così vitale ed esuberante con la penna perché nella realtà la vita sfuggiva di mano. Forse è questo il motivo: nella realtà non era assolutamente padrona della sua vita, che forse sembrava seguire logiche e automatismi inspiegabili. D'altronde tutto questo è comprensibile perché il vitalismo è sempre stato contrapposto al meccanicismo. La Munro è intellettuale, lucida e sobria. Il suo vitalismo non è fittizio ma è sempre autentico. Non c'è niente di posticcio. Un'altra cosa che mi piace della Munro è che non si è messa a studiare la vita in modo calcolatore e a tavolino ma sembra perfettamente che si sia messa a narrare in modo occasionale. Sembra che abbia vissuto le sue peripezie e ogni tanto abbia fatto una pausa tra una fatica e un'altra per annotarla sul suo taccuino. La scrittrice ci racconta la vita quotidiana con i suoi drammi ed allo stesso tempo non crea altre realtà: è testimone Impareggiabile delle sua epoca, restituisce senza sconti e senza finzioni la cruda verità umana. Dramma dopo dramma purtroppo l'esistenza diventata tragedia. La vita sembra scorrere tranquilla fino all'evento irreparabile, al guasto irreversibile. È questo forse il messaggio. La Munro riesce a narrarlo magistralmente nelle più svariate sfaccettature. Riesce a fornirci una visione altra della vita, che erompe dal contingente. Tutto questo non è poco. Anzi è merce rara in un libro di narrativa.
I romanzi per molti hanno una sovrastruttura intellettuale e un intreccio che i racconti non avranno mai. Per molti i romanzi comprendono una maggiore cura nel descrivere ambienti e personaggi, soprattutto nel delineare la psicologia dei personaggi. Ogni racconto della Munro invece è un romanzo in miniatura. Lo scrittore Aldo Busi spesso ha dichiarato che in Italia esistono molti poeti, molti scrittori di racconti ma pochi sono i veri romanzieri. Molti artisti secondo Busi sarebbero dei romanzieri mancati. Il romanzo, facendo queste considerazioni, sarebbe quindi più complesso di una raccolta di racconti: più complesso da scrivere, da leggere, da analizzare, da recensire. Necessiterebbe di una sovrastruttura e di una architettura. Ma poi ne siamo così sicuri? Ad esempio "Casa d'altri" di Silvio D'Arzo (pseudonimo) che cosa è esattamente? Un racconto lungo? Un romanzo breve? Un ibrido particolarissimo? Una eccezione che conferma le regole suddette? Ai letterati e ai critici letterari l'ardua sentenza. Ma perché disprezzare il racconto? Perché considerarlo un genere minore? Non suscita forse emozioni? Non fa scaturire riflessioni e pensieri? Una raccolta di racconti fantastici non può trattare di universi paralleli come un romanzo di fantascienza? Una raccolta di racconti non può forse essere un'opera aperta? Non può essere un'opera di avanguardia? Non può trattare tematiche importanti? Non può far vedere le cose da una prospettiva insolita? Non ci vuole forse anche una certa abilità nello scrivere racconti? Inoltre c'è anche chi sostiene che il romanzo non abbia più un senso. Già le avanguardie avevano decretato la morte del romanzo. Secondo Milan Kundera la morte del romanzo è già avvenuta e nessuno ne è rimasto colpito o scandalizzato. Il romanzo secondo il famoso scrittore rappresenta la complessità del mondo e dell'esistenza; i mass media che invece dominano il pianeta tendono a dare una visione univoca e ipersemplificata della vita. In buona parte dei casi il racconto probabilmente è una storia breve. Uno dei maestri indiscussi del racconto nel novecento è R. Carver. Naturalmente i racconti fantastici di Borges sono esemplari. Ma sono particolari: anzi, oserei dire unici nel loro genere. Sono però da leggere anche i racconti di S.Beckett e di Salinger ("I nove racconti"). Parlo sempre di autori del Novecento. In Italia invece i grandi scrittori di racconti sono a mio parere Dino Buzzati ("I sessanta racconti), Cesare Pavese ("Feria d'agosto", "Fallimenti"), Silvio D'Arzo ("L'aria della sera e altri racconti"), Giorgio Manganelli ("Centuria"), Del Giudice ("Il museo di Reims"), Italo Calvino ("Ultimo viene il corvo"), Antonio Delfini ("Il ricordo della Basca"), Tommaso Landolfi. Comunque questi sono gli autori che bisogna leggere e con cui bisogna fare i conti se si vuole iniziare a scrivere o solo a capire qualcosa di racconti. Discorso a parte merita Silvio D'Arzo, molto stimato dalla critica letteraria e anche da Montale, che in vita pubblicò solo tre libri senza alcuna gloria e fu un anonimo professore. Morì a soli trentadue anni. Altro discorso a parte anche per un altro irregolare delle patrie lettere: Antonio Delfini, che riuscì a passare alla storia anche come poeta irriverente e al di fuori della retorica e degli stilemi del tempo. Con il suo capolavoro "Poesie della fine del mondo, del prima e del dopo" riuscì nell'impresa di scrivere un anticanzoniere. La donna un tempo amata non era più idealizzata e neanche mitizzata, come avevano fatto per secoli in poesia e nella letteratura. Fino a pochi anni fa esisteva il premio Antonio Delfini che era dedicato alla poesia. Oggi non ho più notizie di questo premio, un tempo prestigioso. Comunque sembrerebbe che con il passare degli anni di questo singolare personaggio anticonformista sia rimasto più il poeta che lo scrittore. La Munro sicuramente va letta assieme a questi scrittori sopracitati. Purtroppo però il Nobel alla Munro, che è una delle migliori scrittrici del mondo di racconti brevi, non ha determinato una ripresa della lettura e quindi un aumento di vendite di raccolte di racconti in Italia. Purtroppo qui in Italia il genere dei racconti è considerato frutto di un'arte minore. Un pregiudizio che porta anche le case editrici a pubblicare poche raccolte di racconti, di solito solo di autori già affermati. Questa è un'amara constatazione di fatto, è pura realtà, non certo un'opinione.
giu 212022 "Sulla violenza? Non si può rispondere a un mondo assurdo con un gesto assurdo" (Davide Morelli alla terza birra in un bar imprecisato)

Per Dario Fo intellettuale è colui che ha un rapporto dialettico con la realtà. Bisogna notare che molti si credono intellettuali perché intrattengono soltanto un apparente rapporto dialettico con altri intellettuali. Invece il rapporto dialettico deve essere innanzitutto con la realtà. Mi sembra appropriata e calzante come definizione, quella di Dario Fo. Premetto che di carne da mettere al fuoco ce ne sarebbe tanta. Cercherò di essere il più sintetico possibile. Ma il problema principale non è tanto dare una definizione di intellettuale o di cultura quanto quello del ruolo dell'intellettuale, ovvero se deve essere impegnato o disimpegnato. Può arrivare per esempio a uccidere per cambiare la società? Il filosofo Popper sembra risolvere la questione, quando ne "La società aperta e i suoi nemici" scrive che l'omicidio è legittimo se la vittima è un dittatore.
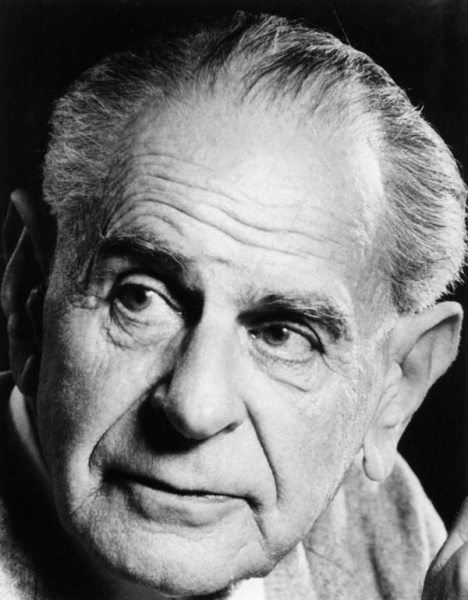
(Nella foto Popper)
Parafrasando Pavese, secondo cui ognuno ha una ragione valida per uccidersi, oserei dire che, seguendo Popper, ognuno potrebbe avere una valida ragione per uccidere. Perché non uccidere degli oligarchi sanguinari o dei governanti democratici ma lestofanti e corrotti? In fondo ogni intellettuale potrebbe dichiararsi rivoluzionario e decidere di uccidere. Però viene da chiedersi anche se un artista può essere ritenuto tale se ha commesso un'azione riprovevole. Caravaggio fu un assassino. D'Annunzio e i futuristi ebbero delle responsabilità per l'entrata in guerra dell'Italia. Croce in "Etica e politica" faceva una netta distinzione tra arte e vita. Quasimodo invece pensava che chi avesse fatto la spia per i fascisti in guerra non potesse scrivere poesie. Prendiamo il caso del celebre Marco Paolini. Ha tamponato una macchina, uccidendo una donna. È risultato negativo all'alcol test e non era al cellulare. Tutto è accaduto involontariamente. Dovremmo forse condannarlo ed ergerci a giudici? Non l'ha fatto apposta. Paghi pure in sede civile e penale (i giudici ci sono per questo), ma eticamente potremmo forse condannarlo? La risposta certa è no. Comunque ritorniamo all'omicidio volontario. Ognuno avrebbe una ragione valida per uccidere. Ognuno potrebbe avere una giusta causa. Secondo la celebre opera teatrale di Sartre per fare la rivoluzione d'altronde bisogna "sporcarsi le mani". E che dire di coloro che subiscono un'ingiustizia o degli intellettuali che potrebbero diventare giustizieri? Non avrebbero i familiari delle vittime, per esempio, tutto il diritto di passare alle vie di fatto? E che dire dell'atto gratuito di "Delitto e castigo" o del Lafcadio di Gide? Qualcuno potrebbe giustificare anche chi spara a caso sulla folla. In fondo forse ogni incontro non è un numero random e il mondo non è forse un generatore di numeri casuali? Però dovremmo ricordarci come disse Sanguineti che sparare sulla folla non può essere considerato un gesto d'avanguardia. Potremmo pensare alla teoria di Ivan Karamazov secondo cui "se Dio non c'è tutto è permesso". Però non sempre è così perché i nichilisti russi non furono mai sanguinari, anche se come Bazarov non credevano nei vecchi valori, credevano nella scienza e disprezzavano l'umanesimo. Non è poi assolutamente detto che tutti gli artisti innovatori siano automaticamente dei rivoluzionari: non tutta l'avanguardia è calda come si suol dire, cioè legata alla contestazione e alla rivolta. Per i cristiani non si dovrebbe agire "occhio per occhio" e ogni omicidio dovrebbe essere considerato un deicidio. La società occidentale teoricamente ha come principio la sacralità della vita. Specifichiamo meglio: ha a cuore la vita dei propri cittadini, mentre se ne strafotte dei cittadini del terzo mondo (penso di poterlo scrivere senza essere accusato di terzomondismo). Gli intellettuali non possono arrogarsi il diritto di uccidere in nome di nobili principi, sostituendosi a Dio o giustificandosi dicendo che è un sacrificio necessario. Devono essere biofili e non necrofili, anche se c'è stato in passato chi seguendo Marx ha ucciso per trasformare la realtà o chi ha ucciso seguendo Nietzsche per una trasmutazione dei valori. Diciamocelo francamente, le ideologie covavano della violenza. La volontà di potenza era insita in ogni ideologia, anche in quella marxista. La violenza esiste anche nel liberalismo, quando esporta a ogni costo la democrazia o quando i governanti non attuano un valido welfare. La violenza è in ogni sistema di pensiero perché anche se esso non è violento sono in un certo qual modo violenti gli uomini che lo mettono in pratica. Questo sistema però può anche essere combattuto civilmente dall'interno e a questo proposito essere militanti non significa essere capziosi e neanche faziosi, bollando gli altri come piccolo-borghesi, romantici o reazionari. La realtà non si suddivide in falchi e colombe e non sempre la vita è un gioco a somma zero. E allora un intellettuale deve abbracciare l'engagement? Deve essere così impegnato politicamente da prendere le armi?

(Nella foto Camus)
La risposta a tutto ciò è l'introduzione de "L'uomo in rivolta" in cui Camus scrive che bisogna opporsi al "delitto logico", quello dovuto all'azione dell'ideologia. Sempre Camus scrive che "al tempo della negazione bisognava trattare del suicidio. Nell'epoca dell'ideologia bisogna discutere di omicidio". Il grande scrittore afferma anche che in quegli anni "il delitto è legge". La formula di Camus è la seguente: "mi rivolto, dunque siamo". Per Camus la rivolta deve essere metafisica, artistica: l'uomo non deve esercitare violenza nei confronti dei suoi simili. Secondo Camus gli uomini devono affratellarsi dopo aver compreso l'assurdità del mondo e della vita.

(Nella foto Sartre)
Dopo la pubblicazione de "L'uomo in rivolta", scaturirà una polemica, assai complessa e articolata, all'ultimo sangue tra Camus, Sartre e altri intellettuali francesi. Sartre e Camus non saranno più amici per divergenza di vedute. Alla base di tutto c'è una netta contrapposizione tra chi è filosovietico come Sartre e chi no come Camus. Solo con la morte prematura di quest'ultimo si placheranno gli animi. Comunque tutti dovremmo rileggere continuamente il saggio di Moravia "L'uomo come fine". C'è scritto tutto lì. È un libro smilzo, profondo, chiaro e comprensibile. Purtroppo l'uomo è un mezzo e il consumismo, l'utile, la tecnica, il progresso, l'affermazione sugli altri sono i soli fini.
giu 212022
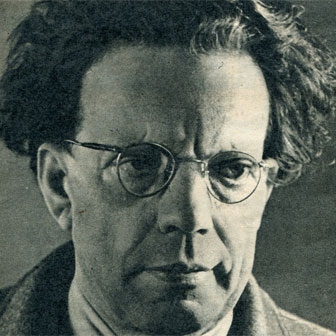
(Nella foto Papini)
"Un uomo finito" è l'opera più celebre di Papini (1881-1956), pubblicata dalla libreria della Voce nel 1913, ristampata più volte e tradotta in tutto il mondo. Come hanno scritto in molti è a metà strada tra l'autobiografia e il diario. In questo libro sono riassunte le vicissitudini, le sfide intellettuali, i percorsi mentali, l'iter creativo, gli stati e gli strati psichici di Papini. In queste pagine sono racchiusi l'impegno e la vitalità dello scrittore fiorentino, che esplora da par suo il proprio Sé. Grazie alla sua onestà intellettuale riesce a essere chiaro, lucido, disincantato e non lascia mai spazio a errori di interpretazioni. Si dimostra capace di introspezione e allo stesso tempo di riflessione senza vana gloria, senza alcuna accortezza. Non si lascia abbindolare dalla memoria che spesso migliora il passato e lo mistifica, presentandolo come molto diverso da quello che è stato realmente. Papini si dimostra per quello che è e per quello che è stato, senza filtri, maschere o inganni. Il lettore avverte che si trova al cospetto della testimonianza di un artista memorabile, di una coscienza che, pur tra errori e pecche, ha sempre cercato di essere attenta a tutte le problematiche del suo tempo. In questa opera c'è tutto Papini: scontroso, ieratico, pensoso, tormentato, inquieto, cinico, autoesaltato, sconfitto, ambizioso oltremodo. In 50 brevi capitoli sono descritti i suoi primi trenta anni di vita. Innanzitutto esordisce scrivendo che non ha mai avuto fanciullezza. È nato povero e fin dai primi anni è sempre stato solo, schivo, appartato. Da bambino subiva angherie e umiliazioni da parte dei coetanei, che oggi definiremmo atti di bullismo. La sua vita fu sempre contraddistinta dalla "smania di sapere". Iniziò a formarsi con la libreria di soli cento volumi del babbo e poi accrebbe il suo sapere andando nelle librerie aperte a tutti, dove però potevano entrare solo le persone che avevano più di sedici anni. L'adolescenza fu vissuta tra la campagna e la biblioteca. Le umiliazioni, i complessi, le frustrazioni per un meccanismo di compensazione, descritto da Adler (secondo cui dietro a un complesso di superiorità si celerebbe sempre un complesso di inferiorità), faranno scaturire in lui la smania di grandezza, la voglia irrefrenabile di essere tutto, di sapere tutto. Un poco impropriamente questo atteggiamento mentale e esistenziale viene chiamato da alcuni complesso di Dio, cioè il desiderio di voler annientare Dio e di farne le veci, di sostituirsi a una divinità che sembra assente o indifferente. Ma siamo tutti esseri umani e dall'onnipotenza si finisce sempre nel senso di impotenza. A tratti sembra che lo scrittore fiorentino non avesse coscienza del suo declino, della sua decadenza, della sua mortalità. Tutti ci domandiamo come il cyborg di Blade runner quale è il trucco per non spegnersi, per non guastarsi. Ma essere immortali forse non è la soluzione. La letteratura con Dorian Gray e il Faust ci avverte che non sarebbe una buona cosa. Forse Papini aveva coscienza di avere scritto opere immortali. Vivere comporta però delle contrarietà. Come scrisse Alessandro Morandotti "tutto sarebbe più semplice se nascessimo con le istruzioni per l'uso e la data di scadenza". Però certe cose di fondamentale importanza purtroppo non è dato saperle. A Papini queste questioni stavano molto a cuore, eppure, nonostante il suo grande acume, non trovò mai la soluzione. Infatti sono cose che ci trascendono. Ma ritorniamo al libro. Per Papini come per Sartre gli altri sono l'inferno. Cerca conforto nelle opere dei grandi autori già morti e disprezza "i piccoli vivi". La sua vita è stata vissuta pienamente, oserei dire, è stata vissuta a tratti titanicamente, per alcuni anni all'insegna del superomismo. Non ha mai risparmiato energie. La sua gioventù è stata caratterizzata dal furore idealistico, dall'ubriacatura ideologica, dall'entusiasmo intellettuale, così come nella sua maturità si è distinto per il fervore cattolico. Ma Papini molto probabilmente era un maniaco-depressivo. A dimostrazione di queste dinamiche psichiche e di questo disturbo dell'umore c'è la sua dichiarazione di scrivere "per sfogo". Da voler essere un semidio onnipotente e onnisciente, eccolo piombare nel ripiegamento interiore, nel crollo psichico, nella "discesa", nella malattia, nella depressione. Probabilmente se fosse vissuto oggigiorno a Papini gli sarebbe stato diagnosticato un disturbo bipolare, avrebbe fatto analisi, avrebbe assunto giornalmente una pasticca di Depakin e non avrebbe scritto niente di memorabile. Non so se a volte sia meglio la stabilità psichica o la gloria postuma?!? Papini ad ogni modo è un genio che ha il dubbio di essere "un imbecille", "un ignorante", che non ha la minima conoscenza di sé stesso né degli altri. È un uomo in fin dei conti che ha chiesto l'impossibile a sé stesso e agli altri. Nonostante alcune sue tare come i pregiudizi nei confronti delle donne (ma ahimè anche lui era un uomo del suo tempo e certi pregiudizi all'epoca erano diffusi), ritengo che dalla lettura di questa opera si possa trarre beneficio e godimento intellettuale, interiore. A trent'anni nessuno è un uomo finito, nemmeno uno che come Papini ha iniziato molte cose e ha cercato di voler essere tutto vanamente. Questa impresa era destinata comunque al fallimento. Ma dimostrò nel resto della sua vita che aveva ancora molte cose da dire.

(Nella foto Dino Campana)

(Il libro di Mughini in cui tratta della questione Campana, Soffici, Papini)
Piuttosto Papini è stato dimenticato oggi perché su di lui ci sono luci (il suo ingegno fu ineguagliabile) ma anche ombre: 1) fu interventista durante la prima guerra mondiale, anche se poi ebbe grandi rimorsi di coscienza. 2) per molti nascose insieme ad Ardengo Soffici il manoscritto "Il più lungo giorno" di Dino Campana, che il poeta di Marradi aveva dato loro per un giudizio critico. Alcuni intellettuali come il celebre Mughini smentiscono questa versione. Secondo Mughini il manoscritto andò perduto involontariamente. Papini e Soffici erano esenti da colpe secondo questa scuola di pensiero. A ogni modo poi Campana scrisse "I canti orfici", suo capolavoro: comunque sia andata con la riscrittura, come si suol dire, si rifece. Da notare una cosa: Soffici, cugino di Campana, era un letterato famoso in quegli anni e non vedeva di buon occhio le aspirazioni poetiche di Dino. Oggi Soffici è dimenticato, è un minore, mentre quel matto di Campana è celebrato e antologizzato da tutti gli italianisti. Comunque "Il più lungo giorno" ( Riproduzione anastatica del manoscritto ritrovato dei Canti Orfici) fu poi pubblicato da Vallecchi nel 1973 (poi su CD-ROM, 2002).

(Nella foto Ardengo Soffici)
Concludendo, "Un uomo finito" descrive in modo magistrale la giovinezza, la formazione culturale, l'apprendistato, le contraddizioni, le amicizie di un grande intellettuale della sua epoca; un intellettuale che crebbe con Schopenhauer e con Stirner, che fu condizionato da D'Annunzio, che fu da giovane irrazionalista, occultista, nazionalista, idealista, futurista. Con un semplice gioco di parole Papini più che un uomo finito cercò di essere un uomo infinito, ma ciò è impossibile per tutti. Fu un uomo dalle innumerevoli qualità che a forza di volere troppo rischiò banalmente di non stringere nulla, rischiò di essere un uomo senza qualità, un Ulrich come tanti. L'interrogativo che lo porta a scrivere questa opera, ovvero "la vita è degna di essere vissuta?", dopo averla letta, non può che trovare risposta affermativa.
giu 212022
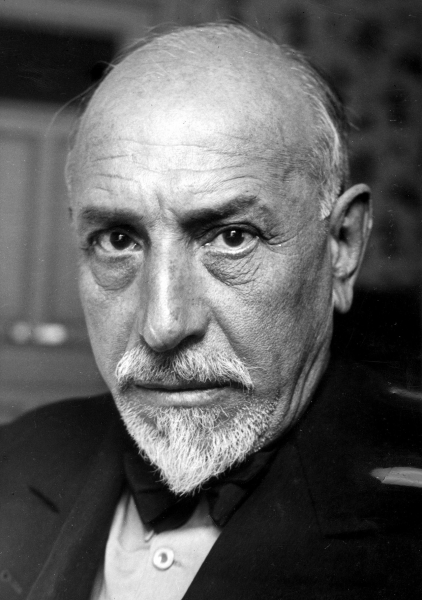
La questione principale di questo romanzo di Pirandello è come possa esistere una parte del proprio self inconoscibile ai propri occhi. La topica del naso, l’ombra di Genge, le sopracciglia circonflesse portano il Moscarda a uno slittamento della propria coscienza. Il protagonista vorrebbe porsi fuori di sé per osservarsi e riappropriarsi delle immagini che gli altri hanno di lui, per ricomporre definitivamente con questa serie di frammenti il proprio io. Moscarda scopre che gli altri vedono una parte di sé stesso che lui non può vedere e nel procedere in questa analisi si accorge che gli altri non percepiscono soltanto delle semplici immagini, a seconda delle angolazioni e delle prospettive da cui lo osservano, ma anche la sua maschera sociale, la “Persona”, che indossa. La tematica centrale di questo romanzo riguarda la scoperta da parte dell’io del protagonista che altre identità con le loro percezioni possono scoprire i suoi punti deboli, i suoi difetti, i suoi lati oscuri di cui lui può addirittura ignorare l’esistenza. Ma gli interrogativi che suscitano questo romanzo allora sono: ma gli altri possono davvero - come ritiene Pirandello – conoscere più del soggetto? La conoscenza degli altri riguardo ad un individuo (in questo caso Moscarda) supera quindi l’autoconoscenza, l’autoconsapevolezza e l’autocoscienza dell’individuo stesso? La telecamera può essere considerata lo specchio moderno di Moscarda. Meglio ancora, è come se fosse un enorme specchio circolare, che può rimandare immagini di tutte le parti del corpo, di tutte le movenze e di tutte le posture dell’individuo. Rivedersi in un filmato di una telecamera, può allora essere un’esperienza non dico traumatica, ma spesso deludente: ci si accorge che la propria voce può essere più baritonale di quello che credevamo, che di profilo il nostro naso risulta più pronunciato di quello che pensavamo, che ripresi di spalle siamo più curvi di quello che credevamo, etc etc. La telecamera è come un grande occhio esterno che ci può analizzare e registrare da tutte le possibili angolazioni.

Anche gli altri che scrutano Moscarda sono occhi esterni, che hanno la stessa possibilità della telecamera di vedere e registrare da tutte le prospettive. Ma viene da chiedersi: la loro registrazione è altrettanto fedele e oggettiva? Inoltre le riprese della telecamera possono indicarci se siamo o meno telegenici, ma la telecamera non ricompone tutte le immagini di noi stessi e non si fa un’opinione globale, come fanno gli altri. La telecamera è un punto di partenza per l’autoconoscenza della propria corporeità, non della nostra identità psichica, sociale, culturale, come invece sono gli altri per noi. E’ stato il fondatore della psicologia americana William James a dare un contributo notevole a riguardo. Il Sé di ogni persona possiede fondamentalmente due dimensioni: l’io (ovvero tutte le capacità di autoconoscenza: il conoscitore del Sé) e il Me (ovvero tutti quegli attributi e quei tratti di personalità che l’Io riesce a conoscere dell’individuo: il conosciuto del Sé). James fa un’ulteriore distinzione per quel che riguarda il conosciuto del Sé: esiste un Me materiale (tutto ciò che l’individuo conosce del proprio corpo, dei propri oggetti, della propria casa, degli ambienti in cui vive), un Me sociale (tutte le rappresentazioni sociali che gli altri hanno dell’individuo), un Me spirituale (tutto ciò che l’individuo conosce della propria personalità, della propria interiorità e della propria identità psichica). Considerando queste distinzioni di William James ci accorgiamo allora che nel romanzo di Pirandello il protagonista inizia il proprio percorso di autoconoscenza dal Me materiale, continua con l’esplorare il Me sociale, per approdare infine al Me spirituale. L’originalità e la genialità dell’opera di Pirandello è aver posto l’accento su questo fatto: l’io (il conoscitore) non riuscirà mai a sapere tutto del Sé perché questo avrà sempre zone inesplorate ed inesplorabili, che non potranno mai far parte dei vari Me (ossia del conosciuto). Esisteranno sempre regioni della psiche in cui dominano incontrastati ciò che è rimosso, ciò che è represso e quello che è semplicemente non conoscibile dal soggetto.

Ma oltre a aver affrontato questo problema il romanzo di Pirandello fa scaturire anche una domanda fondamentale: gli altri, avendo possibilità di osservare da prospettive sconosciute all’individuo e dall’esterno un individuo, possono potenzialmente conoscere più di quello che una persona conosce di sé stessa, essendo questa più continua e dettagliata nell’osservazione e nello studio di se stessa? In definitiva: è maggiore fonte di conoscenza riguardo alla propria individualità l’esterno o l’interno? La moderna psicologia a riguardo ci fa sapere che c’è una continua interazione tra interno ed esterno: un incessante interscambio tra intrapsichico ed interpsichico. Addirittura secondo la teoria dell’immagine l’idea che ci facciamo di noi stessi dipende in modo determinante dalla considerazione e dalla stima che gli altri hanno di noi. Secondo questa teoria sviluppata da Beach e Mitchell anche le decisioni che prendiamo nel corso della vita non sono basate tanto su un’analisi dei costi e dei benefici, quanto piuttosto dall’insieme di valori, norme, credenze, aspettative: insomma dalla concezione che noi abbiamo di noi stessi. Però allo stesso tempo gli psicologi sociali ci indicano che, quando noi stessi giudichiamo gli altri o quando gli altri giudicano noi, il giudizio spesso è errato, semplicistico, perché esistono nella mente umana scorciatoie cognitive errate, tratti impliciti di personalità, correlazioni illusorie, stereotipi infondati che possono portare a pareri erronei sulla persona o sulle persone osservate. Siamo cattivi giudici degli altri e gli altri sono cattivi giudici di noi stessi. Ma Pirandello è anche un anticipatore dei tempi odierni: è riuscito a intuire la frammentarietà dell’Io, problema reale dell’epoca moderna, se si pensa alla pericolosa sindrome che ne è scaturita, ovverosia la personalità multipla. Nonostante questa continua interazione o interdipendenza tra intrapsichico ed interpersonale l’assurdo inteso alla Camus dell’opera di Pirandello rimane però inalterato. L’uomo continuerà ancora a cercare di estrapolare dalle relazioni dal mondo esterno per assurgere a un principio chiarificatore, a una sintesi che possa cogliere e abbracciare la totalità della propria essenza. Nonostante ciò “l’assurdo” (che si verifica quando l’intelligenza dell’uomo si accorge di essere alle prese con la realtà che la supera) rimarrà una categoria astorica dell’umanità, perché il mondo esterno neanche in futuro sarà completamente raffigurabile e l’interno rimarrà per certi versi ancora inafferrabile, indicibile, inconoscibile.
giu 202022 PREMESSA:
Il gruppo 63 propose la riduzione dell'io ilirico in poesia. Oggi alcuni letterati vorrebbero eliminarlo, rimuoverlo. Io o mondo? Piuttosto io e mondo, visto che tra io e mondo c'è un'interazione continua. Ma se cognitivamdnte io e mondo possono coesistere, letterariamente di solito c'è una prevalenza.
NOTA BENE:
L’io lirico è la voce interiore nella poesia. Non è detto che coincida sempre con l’io empirico, ovvero con l’autore in carne e ossa. L’io lirico può essere anche in un certo qual modo fittizio. Si veda ad esempio Pessoa e i suoi eteronimi. L’io lirico può essere anche un alter ego.
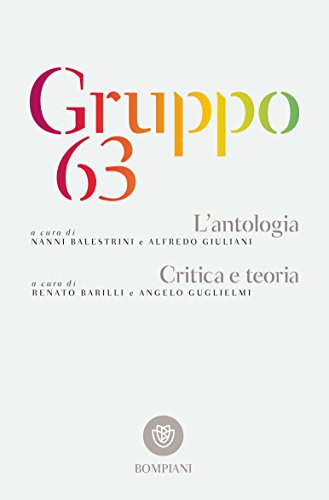
Gadda scrive ne "La cognizione del dolore": "[…] l'io, io!… il più lurido di tutti i pronomi!… I pronomi! Sono i pidocchi del pensiero. Quando il pensiero ha i pidocchi, si gratta come tutti quelli che hanno i pidocchi… e nelle unghie, allora… ci ritrova i pronomi: i pronomi di persona". Però Gadda lo fa dire al protagonista, suo alter ego nevrotico, in una crisi parossistica. Non dimentichiamo che Gadda era notoriamente nevrotico, per quanto geniale, e ha messo molto del suo io empirico nevrotico in quel romanzo. Alcuni oggi, che vorrebbero rimuovere l'io lirico, citano questo brano dell'ingegnere. Inoltre per Gadda tutti i pronomi sono "pidocchi del pensiero", per cui non ci sarebbe via di uscita. Ogni narrazione sarebbe perciò tarata a priori. Infine queste frasi non vanno decontestualizzate. Estrapolare delle frasi dal loro contesto può essere fuorviante e indurre in errore. Si tratta pur sempre di un romanzo, "La cognizione del dolore", che ha senza ombra di dubbio un suo contenuto di verità, ma che è anche creazione di un mondo fittizio e di personaggi immaginari grotteschi, paradossali.
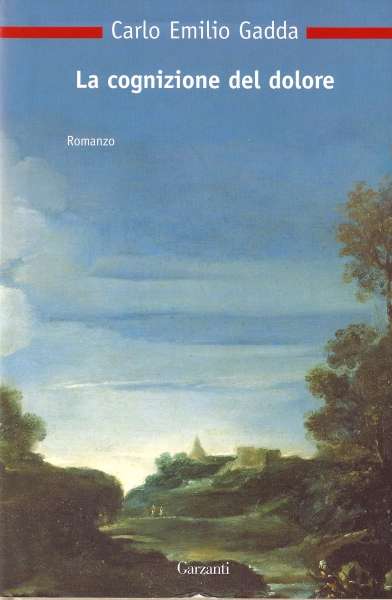
Il problema è quanto della propria nevrosi, delle proprie fratture, dei propri vuoti uno riversi nella propria opera e ciò non è necessariamente detto che sia un male. Chi impone che l'impersonalità e il distanziamento siano degli obblighi della narrazione? E la narrazione di Gadda può essere forse presa di esempio? Bisogna sempre stare attenti quando si cita a non farlo a sproposito, a non strumentalizzare la fobia dell'io di Gadda (capisco che ognuno voglia portare acqua al suo mulino). Qui non si tratta di canoni della letterarietà, ma di una difesa a oltranza di quel poco che resta del soggetto freudiano (visto e considerato che il soggetto cartesiano è stato distrutto dai maestri del sospetto e del cogito, ergo sum resta solo il coito, ergo sum). A ogni modo ognuno è sempre circondato da sé stesso, come scriveva Sartre, indipendentemente dagli escamotage narrativi. A proposito di io e scrittura, oltre al celebre detto "Conosci te stesso", Gramsci in un articolo citava Novalis, che a sua volta scriveva: «Il supremo problema della cultura è di impadronirsi del proprio io trascendentale, di essere nello stesso tempo l’io del proprio io. Perciò sorprende poco la mancanza di senso e intelligenza completa degli altri. Senza una perfetta comprensione di noi, non si potranno veramente conoscere gli altri». Mi sembra che questa citazione sia appropriata e di non tirare per la giacchetta nessuno. Insomma sono necessarie anche l'autoconoscenza, l'autodeterminazione. Per decenni l'intimismo ha fatto da padrone nella cosiddetta poesia lirica. Attualmente in Italia alcuni letterati vogliono rimuovere l'io lirico e demonizzano l'io in senso lato. Voler rimuovere l'io lirico significa non poter scrivere in prima persona nelle poesie, essendo costretti a trattare gli altri che possono essere proiezioni del proprio io o riproposizione delle solite figure parentali. Insomma la psicoanalisi ci insegna a ragione che è lecito diffidare anche di chi parla troppo degli altri e che talvolta così facendo finisce per deformarli troppo con la sua lente o per rispecchiare sé stesso. Un'obiezione alla rimozione dell'io lirico: talvolta è difficile dire quanto io ci sia negli altri e quanto gli altri siano nell'io tra identificazioni, proiezioni, interiorizzazioni. Altra obiezione: in poesia come scriveva Zanzotto vige l'eterogenesi dei fini; si cerca una cosa e se ne trova un'altra; così chi cerca l'io trova talvolta il mondo e viceversa. Alcuni sostengono che i poeti contemporanei siano affetti da egolatria. È difficile dire quale sia il discrimine tra normalità e patologia. E poi si pensi al fatto che anche Stendhal scrisse "Ricordi di egotismo". La stessa poesia moderna americana è un continuum ai cui poli opposti ci sono la schiva Emily Dickinson e il titanico Walt Whitman.

(Nella foto Gadda)
Da una parte l'introversione e dall'altra l'estroversione. Prima ancora che un atteggiamento intellettuale, filosofico, letterario, conoscitivo scegliere uno o l'altro di questi poli è questione di personalità. Ci sono introversi ed estroversi. Non c'è niente di giusto o sbagliato. Ci sono pro e contro di entrambe le condizioni esistenziali. Queste due diverse modalità di approcciare la realtà sono frutto prima di tutto questione di personalità. Dalla personalità consegue il modo di interfacciarsi al reale. Come esiste un orientamento sessuale, politico, valoriale esistono anche varie tipologie di personalità. Ma i critici letterari non dovrebbero giudicare il modo in cui gli autori si volgono alla conoscenza. C'è chi sceglie insomma prevalentemente l'interno e chi l'esterno. In alcuni autori gli altri si riflettono in loro stessi e in alcuni autori l'io si riflette negli altri. Si tratta pur sempre di rimandi continui, di un perenne gioco di specchi. Partire dagli altri e finire nell'io o viceversa è solo un punto di partenza. Privilegiare l'io o il mondo non deve essere una posa, basata su premesse teoriche. Ogni autore dovrebbe scegliere in base a ciò che sente, a ciò che ritiene più consono. Trovo che esimersi dal tranciare giudizi approssimativi sia senza dubbio un atto di onestà intellettuale. Trovo anche fuori luogo il fatto che a seconda dello spirito dei tempi sia di moda quando l'intimismo e quando invece gli altri. Un'altra cosa che mi fa sorridere è che alcuni autori postulino la rimozione dell'io e poi scrivano dei romanzi o delle raccolte poetiche autobiografiche. Evidentemente egoriferiti sono sempre gli altri. Non ho mai letto di nessuno che considerava sé stesso egoriferito. In questi ultimi anni in poesia nelle polemiche letterarie evidentemente vince chi dà per primo dell'egoriferito all'altro. È una moda come un'altra. Non è frutto di un'evoluzione stilistica o letteraria. Non è un punto di arrivo della letteratura come vorrebbero far credere alcuni. Un tempo c'era la vecchia disputa molto divisiva tra realisti e idealisti. Il vero atteggiamento conoscitivo equilibrato sarebbe trovare un equilibrio tra io e mondo e questo trascendendo i propri tratti di personalità. Ma ciò è quasi impossibile perché l'io o il mondo sono come calamite. C'è chi è attratto dall'uno e chi dall'altro, molto probabilmente più per attitudine che per scelta, più per natura che per cultura. Kafka sosteneva che tra io e mondo si dovesse scegliere il mondo, ma fece davvero così? Cosa sarebbe dei capolavori di Kafka senza il suo io? Quanto io e quante proiezioni ci sono nelle opere di Kafka?

(Nella foto Kafka)
Un interrogativo che sorge spontaneo è se la propria personalità di base sia un nucleo costante e inalterabile o se invece oggi come oggi sia modificabile. La cosa si complica perché sembra che le vecchie teorie sulla personalità come i tipi psicologici di Jung siano oggi inadeguate per decifrare il Sé così sfuggente dell'uomo contemporaneo. Sembra che entrino in gioco in ognuno di noi anche le cosiddette subpersonalità. Anche gli altri sono però sfuggenti. In ogni caso è vero che cresciamo e maturiamo grazie all'immagine che gli altri hanno di noi, ma è altrettanto vero che per conoscere bene gli altri bisogna conoscere bene sé stessi. È un circolo ermeneutico che dura tutta la vita. Sia la conoscenza di noi stessi che del mondo è sporadica, superficiale, discontinua. Di noi stessi conosciamo la nostra voce interiore, il discorrere tra sé e sé. Degli altri conosciamo una minima parte dei loro comportamenti e delle loro espressioni verbali. Uno dei problemi filosofici ancora irrisolti è come, nonostante i nostri limiti intrinseci, riusciamo a conoscere tutto quello che conosciamo. Avrete capito che la questione dell'io in letteratura è un intreccio inestricabile di letterarietà e psicologia. Non può essere altrimenti e le persone ponderate dovrebbero riconoscerlo senza tacciare chi la pensa diversamente di psicologismo. Non vi preoccupate comunque poeti introversi e intimisti: l'io tornerà di nuovo in auge. E poi perché estrovertirsi è necessariamente un bene e concentrarsi su di sé è necessariamente un male? La preghiera, il raccoglimento interiore, la meditazione (senza fare del moralismo) dovrebbero essere allora un male?
giu 202022

Ci sono alcuni studiosi della lingua che pensano che in fatto di linguaggio siamo conservatori. Ciò era un’ipotesi accreditata ai tempi in cui era necessaria un’invasione straniera per il cambiamento di una lingua. Ma oggi? Oggi a mio avviso assistiamo a uno stravolgimento continuo dell’italiano comune, che ci hanno insegnato a scuola. Quante nuove parole ci vengono imposte dal linguaggio omologato dei nuovi mass media, dai gerghi giovanili, dai linguaggi settoriali delle nuove scienze, dall'informatica e dall'economia? Chi parla più oggi veramente italiano? Diciamo che attualmente riusciamo ancora a scrivere in italiano perché forse la sintassi e l’ortografia sono più “salde” della fonetica e del lessico. Nel nostro Paese c’è sempre stata una linea di demarcazione netta tra parlato e scritto. Sono stati pochi gli scrittori che hanno scritto nello stesso modo in cui parlava realmente la popolazione. Scrittori e poeti hanno scelto prevalentemente il toscano. La lingua adoprata dagli intellettuali è stato il volgare di Dante, Petrarca, Boccaccio. Lo stesso Ariosto rivide il suo “Orlando Furioso”, eliminò molti termini padovani e introdusse molti toscanismi. Anche Galilei utilizzò il toscano per la divulgazione scientifica. E’ da secoli che è avvenuta la toscanizzazione della letteratura italiana. Per non parlare poi di Manzoni che andò a sciacquarsi i panni in Arno. Fu proprio Manzoni a capo di una commissione del ministero della Pubblica Istruzione a stabilire che la lingua nazionale dovesse essere il fiorentino. Chiaramente non tutte le caratteristiche del dialetto fiorentino sono diventate lingua nazionale, come per esempio la c intervocalica aspirata, il togliere la desinenza re all’infinito dei verbi, il coniugare noi e il si impersonale. Don Milani anni fa era dell’idea che i poveri rinnovassero la lingua e che i ricchi la cristallizzassero. Ritengo che adesso i nuovi mass media siano gli unici capaci di rinnovare e cristallizzare la lingua italiana. E penso anche che le televisioni soprattutto ci impongano un nuovo italiano: un italiano milanesizzato, che prende spesso a prestito termini dei linguaggi settoriali, espressioni colorite dei gerghi giovanili, inglesismi vari. D'altronde Mediaset è a Cologno Monzese, le grandi case editrici si trovano quasi tutte nel Nord. Alla RAI si adeguano a parlare il milanese. Al Centro e al Sud è rimasto ben poco. Quando i giornalisti televisivi intervistano le persone molto spesso vanno nel centro di Milano. Tutto il resto dell'Italia sembra periferico. Chomsky qualche anno fa sostenne che un dialetto poteva diventare una lingua nazionale grazie ad un esercito. In Italia la lingua nazionale è stata imposta grazie a un’egemonia culturale. Da qui in avanti sarà imposta tramite un’egemonia mediatica (gli scrittori oggi contano ben poco): un'egemonia mediatica, che in fin dei conti rappresenta anche l'egemonia industriale del Nord. Le televisioni generaliste non ci propongono continuamente forse la parlata milanese come dizione corretta dell’italiano? Le show-girl che fanno i corsi di dizione non imparano forse a parlare un milanese privo di termini dialettali? I conduttori non adoprano forse una cadenza milanese o settentrionale? In fondo chi è del Sud e del Centro e vuole entrare a far parte del mondo dello spettacolo deve correggere la sua dizione, come si suol dire.

(Nella foto il poeta fiorentino Mario Luzi)
Oggi se uno va in televisione deve farlo senza inflessione dialettale, a meno che non sia un comico oppure a meno che non sia il familiare di una vittima o un cosiddetto caso umano. Per tutti gli altri non ci sono scusanti. Neanche la parlata toscana è più consentita. È avvenuta da tempo la milanesizzazione della lingua italiana. Oggi un Leopardi con una cadenza marchigiana forse non "bucherebbe" il piccolo schermo. E tutto ciò mi sembra ingiusto e inappropriato. Dirò di più: mi sembra alquanto stupido perché presuppone la concezione implicita che chi risiede al Nord sia superiore a chi vive nelle isole, nel Centro e nel Sud. Eppure il Nord così produttivo per arricchirsi ha avuto bisogno in passato e ancora oggi ha bisogno di tutti gli italiani. Milano sarebbe ben poco se fosse stata solo dei milanesi. Anche Torino sarebbe stata ben poca cosa con i soli torinesi. Infine nascere al Centro o al Sud non è una colpa, così come non è una colpa avere un accento toscano o meridionale.
giu 202022
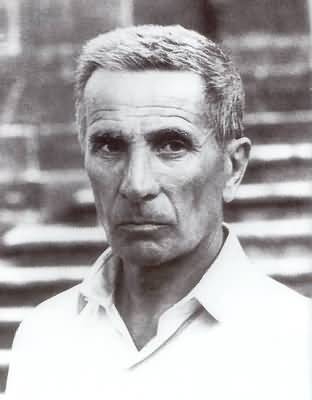
Dino Buzzati è conosciuto soprattutto per il "Il Deserto dei Tartari", in cui il militare Giovanni Drogo è costretto a vivere in una fortezza "esiliato tra ignota gente". La minaccia dell'assedio da parte dei Tartari, l'attesa snervante del protagonista simboleggiano l'ansia metafisica e il pensiero ossessivo della morte. Il finale del romanzo è a sorpresa. È del tutto inatteso. Infatti quando arrivano i Tartari il protagonista sta morendo. Un altro suo capolavoro sono i suoi sessanta racconti. Alcuni critici però sostennero che Buzzati si "kafkasse addosso" e che fosse quindi un manierista di Kafka. Lo scrittore ironizzò su queste accuse dichiarando che "alcuni critici denunciavano colpevoli analogie anche quando spedivo un telegramma o compilavo un modulo Vanoni".
Ma per capire meglio Buzzati bisogna a mio avviso leggere anche i suoi racconti, in cui dettagli apparentemente insignificanti divengono tristi presagi: delle ombre, dei passi, degli scricchiolii sono spesso l'inizio di un capovolgimento di fronte. Ecco quindi che all'improvviso entra in scena l'assurdo. A mio avviso per comprendere pienamente i racconti di Buzzati sono doverose alcune premesse. Per Freud esistono diversi tipi di sogni. Il primo tipo di sogni sono frutto di appagamento di desideri non mascherati. Ad esempio un bambino a cui piacciono le patate può sognare di fare una scorpacciata di patate. Il secondo tipo di sogni sono frutto di soddisfacimento mascherato di fantasie inconsce. Il terzo tipo invece sono sogni di angoscia. I racconti di Buzzati spesso sembrano scaturire da sogni di angoscia o quantomeno sembrano essere dei sogni di angoscia. Ma in questi brani troviamo non solo angoscia e onirismo ma anche mistero e solitudine.

Nei suoi "Sessanta racconti" si mischiano fantastico, realismo, grottesco, gusto del paradosso e metafisica (ricordo che Buzzati fu anche pittore e fu influenzato da De Chirico). Leggendolo abbiamo la dimostrazione che la vera arte nel Novecento non è copia del reale ma trasfigurazione. Lo scrittore bellunese in questo senso voleva evadere dal mondo e restituirgli un universo fittizio. Buzzati fu anche redattore per molti anni del Corriere della Sera e giornalista di cronaca nera.
È proprio analizzando i suoi articoli di nera che si scopre la sua sensibilità. Carlo Bo scriveva a riguardo di Buzzati: "cronista di assoluta fedeltà, ma alla fine andava oltre e scioglieva tutto con il miracolo della poesia". Nei suoi articoli troviamo alcuni delitti, che colpirono l'immaginario collettivo degli italiani: Rita Fort che massacra l'intera famiglia dell'amante che l'ha lasciata, il caso Montesi e lo scandalo conseguente nella democrazia cristiana di allora, la contessa Pia Bellentani che a una festa dell'alta società uccide l'amante. E se talvolta gli assassini non sembrano belve feroci ma persone normali lo scrittore avverte che "l'ombra del male scivola intorno a ciascuno di noi e ci potrebbe toccare". Ma leggere questi articoli significa ritornare indietro nel tempo e constatare che una grande parte di quella cronaca è diventata storia del Novecento. Penso all'aereo della squadra del Torino che si schianta a Superga, il dramma di Marcinelle in cui morirono 139 minatori italiani in Belgio, il disastro del Vajoont del 1963 (quasi 200 morti), la rivolta di San Vittore, la strage di Piazza Fontana. Non ci si può dimenticare di Marcinelle, che è emblematica per quel che riguarda la nostra emigrazione. Per la scarsità di materie prime della nostra nazione il governo italiano decise di stipulare un accordo con il Belgio, secondo cui avrebbe inviato 50000 minatori e avrebbe ricevuto 2 tonnellate di carbone all'anno per ogni lavoratore. I minatori italiani furono costretti a lavorare a 1000 metri di profondità. Il contratto di lavoro non comprendeva la possibilità di dimettersi. I minatori che volevano smettere di lavorare venivano condannati a 5 anni di prigione. Molti lavoratori morirono di cancro al polmone. I più fortunati divennero asmatici. Buzzati descrisse con maestria anche il dramma di Superga. Scrisse che i campioni del Torino fino a pochi giorni prima dominavano i campi di calcio e che la morte in pochi istanti li aveva trasformati. Scrisse: "Esegue balzi così immensi la morte che neppure la nostra immaginazione riesce a starle dietro. Come far capire alle mamme, alle fidanzate, alle sorelle che è meglio non entrare?".
Memorabili e amarissime anche le sue parole sul Vajont: "un sasso è caduto in un bicchiere di acqua e l'acqua è traboccata sulla tovaglia. Tutto qui. Solo che il bicchiere era alto centinaia di metri e il sasso era grande come una montagna e di sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi". Buzzati quindi sapeva essere poetico anche da giornalista senza mai scrivere elzeviri. Possiamo senza ombra di dubbio affermare che il lavoro di giornalista fu fondamentale per la formazione del suo immaginario e della sua poetica, in cui dominò incontrastata l'imperscrutabilità del Fato.
In conclusione Buzzati va letto perché non appartiene a nessuna scuola, non abbraccia nessuna ideologia e si rivela sempre originale e versatile. Riesce a intrecciare realtà e finzione con uno stile efficace e apparentemente semplice. Buzzati riesce a farsi comprendere da tutti ed è sempre distante dalla ricercatezza ad esempio della prosa d'arte. È unico nel suo genere. Infatti ha una fervida immaginazione che gli permette di descrivere le angosce, gli incubi, l'ignoto, come nessun altro narratore italiano nel corso del Novecento. Buzzati all'epoca fu anche ostracizzato da alcuni critici letterari. Eppure nessuno come lui riesce a descrivere i fantasmi della mente, le brutture del quotidiano, l'imponderabile che stravolge l'ordine costituito, il senso di minaccia e l'irrazionalità presenti nell'esistenza umana. Lo scrittore come nessun altro riesce a raccontare storie che si nutrono di caos e assurdo: storie che spesso sono contrassegnate da una cifra trascendente. Questo è il suo lascito.
giu 192022Innanzitutto il corpo. Siamo carnali e mortali. Ecco perché il corpo è un’ossessione, soprattutto per noi occidentali. Il corpo apparentemente è un tramite per il piacere. È lo strumento prediletto per noi occidentali per avere il piacere. La maggioranza dell’io di noi occidentali è corporeo. Stare bene con sé stessi per un adolescente o un giovane significa stare bene e stare bene col proprio corpo, accettarlo. I soldi sono importanti per noi perché cibano, proteggono, salvaguardano il corpo, lo fanno stare bene, lo possono migliorare con la chirurgia, addirittura lo estendono con delle protesi come per esempio la macchina, il computer, etc etc. Al corpo viene attribuita importanza anche in filosofia con Merleau-Ponty perché è esso stesso coscienza ed è grazie al nostro organismo che percepiamo il mondo. Ma Merleau-Ponty è fondamentale anche per la psicologia della Gestalt. Comunque la filosofia del ‘900 è anche materialista, pragmatica, utilitarista, realista, funzionalista e perciò mette in primo piano il corpo. L’idealismo, lo spiritualismo, il cristianesimo vengono relegati ai margini da molti intellettuali. Le fantasie di noi occidentali sono erotiche e riguardano il corpo. Noi occidentali dobbiamo quantificare il piacere, quantificare il corpo. Il corpo nostro interagendo con un altro corpo stimola il nucleo accumbens e viene raggiunto l’orgasmo. Il nostro immaginario viene stimolato dalla pornografia: corpi prestanti che si avvinghiano ad altri corpi prestanti. Viene celebrato il corpo, soprattutto la bellezza del corpo. Ogni bel corpo va mostrato, esibito, messo in evidenza. Ma il corpo viene cristianamente anche mortificato. Il corpo ci ricorda che siamo finiti e determinati biologicamente. Secoli fa le persone si flagellavano, usavano il cilicio sui loro corpi. Adesso il cilicio castiga la psiche con i sensi di colpa, coi rimorsi. Un altro nemico della libertà del corpo, dell’espressività fisica e sessuale è la rispettabilità borghese, il cosiddetto perbenismo. Alice (al secolo Carla Bissi) in una sua canzone scriveva “parenti miei, cinture di castità e di quel poco che resta”. Spesso si ha paura del giudizio dei propri cari e si viene limitati in amore proprio da persone a cui si vuol bene. Si ha meno libertà sessuale. Si guarda anche alla convenienza sociale. Così certi uomini non si fidanzano perché hanno paura di portare a casa dalla madre una donna. Ma vale anche il contrario. Le rispettive famiglie dei due fidanzati mettono alla prova, sotto esame i due. Queste dinamiche psicologiche familiari si ripeteranno in modo più o meno conflittuale per tutta la vita. Oppure alcuni/e sono costretti dalle regole borghesi alla doppia vita. La schizofrenia sessuale/morale di noi italiani si ritrova tutta nel 1975: l’anno del Nobel a Montale, poeta borghese per antonomasia, e anno dell’uccisione di Pasolini, che col corpo e la mente suscitava scandalo, era scandalo.
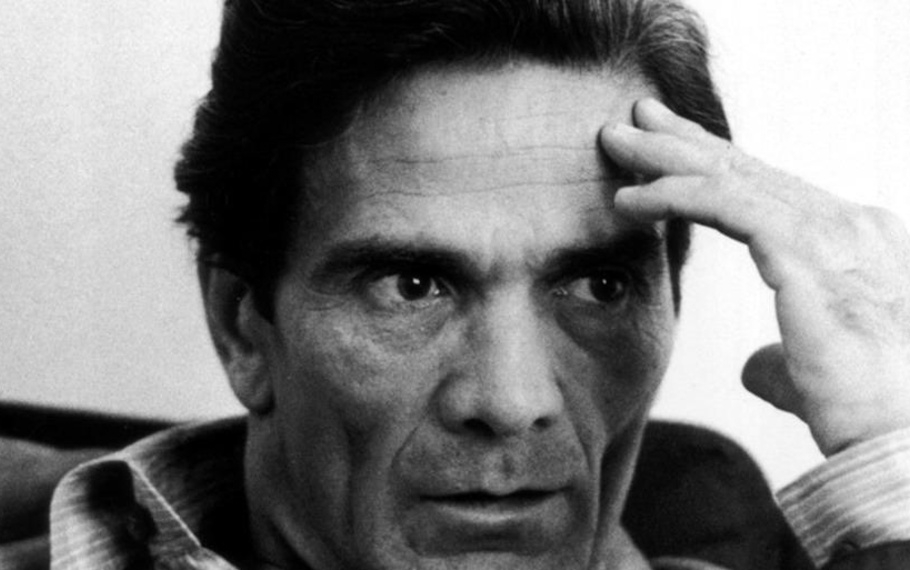
Ancora oggi sembra che si debba scegliere tra Pasolini e Montale, due grandi poeti che si odiarono. Montale soprannominò Pasolini Malvolio in una sua poesia. Pasolini aveva criticato la raccolta Satura perché secondo lui non impegnata socialmente né politicamente, non trattando delle tematiche attuali come la guerra nel Vietnam, etc etc. Montale rispose così:
Non s'è trattato mai d'una mia fuga, Malvolio,
e neanche di un mio flair che annusi il peggio
a mille miglia. Questa è una virtù
che tu possiedi e non t'invidio anche
perchè non potrei trarne vantaggio.
No,
non si trattò mai d'una fuga
ma solo di un rispettabile
prendere le distanze.
Non fu molto difficile dapprima,
quando le separazioni erano nette,
l'orrore da una parte e la decenza,
oh solo una decenza infinitesima
dall'altra parte. No, non fu difficile,
bastava scantonare scolorire,
rendersi invisibili,
forse esserlo. Ma dopo.
Ma dopo che le stalle si vuotarono
l'onore e l'indecenza stretti in un solo patto
fondarono l'ossimoro permanente
e non fu più questione
di fughe e di ripari. Era l'ora
della focomelia concettuale
e il distorto era il dritto, su ogni altro
derisione e silenzio.
Fu la tua ora e non è finita.
Con quale agilità rimescolavi
materialismo storico e pauperismo evangelico,
pornografia e riscatto, nausea per l'odore
di trifola, il denaro che ti giungeva.
No, non hai torto Malvolio, la scienza del cuore
non è ancora nata, ciascuno la inventa come vuole.
Ma lascia andare le fughe ora che appena si può
cercare la speranza nel suo negativo.
Lascia che la mia fuga immobile possa dire
forza a qualcuno o a me stesso che la partita è aperta,
che la partita è chiusa per chi rifiuta
le distanze e s'affretta come tu fai, Malvolio,
perchè sai che domani sarà impossibile anche
alla tua astuzia.
(Diario del '71 e del '72)

Mai come in questo secolo c’è così tanta insoddisfazione sessuale: il desiderio è incessante a causa del bombardamento pornografico a cui siamo sottoposti. Ecco perché la monogamia è un’utopia. Ecco perché come scrissi tempo fa questa è l’epoca in cui gli stessi amanti sono cornuti. È l’epoca del poliamore, della pansessualità ed è totalmente legittimo: lo scrivo senza moralismi. Molti sono dipendenti dal sesso, alcuni vanno a disintossicarsi nelle cliniche. Al sesso, al corpo viene attribuita un’enorme importanza. Anche un intellettuale serissimo come Fortini in "Verifica dei poteri" non può far a meno di trattare dell’emanicipazione sessuale delle impiegate di allora. Ma il desiderio fisiologicamente scema con l’età. Ci sono la menopausa, l’andropausa, i cali del desiderio fisici e psicologici. Alcuni che hanno mancato l’appuntamento con la giovinezza si imbottiscono di Viagra, cercando l’elisir di eterna giovinezza. Passano gli anni. Il padre di un mio carissimo amico gli consigliava sempre di fare sesso, di non aspettare perché si invecchia presto. In là con gli anni spesso si trova il declino inarrestabile o la morte. Si può anche essere impossibilitati a prendere il Viagra per una cardiopatia (la famosa pillola può far male al cuore). Vivere significa per dirla alla Luzi affrontare il corpo oscuro della metamorfosi, prima di tutto le metamorfosi del nostro corpo. Riprendendo una canzone di Piero Pelù il nostro corpo cambia continuamente. Il problema della letteratura italiana è quello di essere troppo incentrata su Dante. La letteratura italiana è più spirituale e idealista; spesso reprime il corpo. Il rapporto tra i sessi viene mitizzato, idealizzato da molti letterati. Voi mi potreste dire: abbiamo anche il Boccaccio. Ma qualche pagina di Boccaccio da sola non basta, finisce per essere innocua, non prepara alla vita vera. Parafrasando il celebre detto neoavanguardistico bisognerebbe fare tutti una salutare gita a Pernumia invece che a Chiasso! Bisognerebbe guardare anche a Ruzzante. Bisognerebbe leggere le sue storie di povera gente veneta. Troppo materialista la popolazione italiana e troppo idealista, etereo il mainstream della letteratura italiana! Nelle scuole italiane dovrebbero far leggere anche Rabelais e Montaigne: tutta gente carnevalesca e che non reprimeva il corpo. Ma Montaigne, Rabelais, Ruzzante sapevano anche ridere di sé stessi e del corpo. In questo periodo siamo in crisi perché il pericolo nucleare minaccia i nostri corpi, le nostre vite. Molti hanno comprato pasticche di iodio per salvaguardare la tiroide da un tumore in caso di radiazioni. Stiamo uscendo dalla pandemia, che ha minacciato i nostri corpi anch’essa. Qualcuno ricordava che dopo la peste molti si diedero alle orge e alcuni vorrebbero farlo anche loro dopo la sconfitta del Coronavirus. Oggi come sempre si inneggia alla corporeità, si celebra la fisicità. Gli uomini devono essere forti, prestanti, aitanti, vigorosi. Le donne devono essere sinuose e longilinee. Chi non rispetta o non si adegua a questi canoni è out. Chi critica tutto ciò è addirittura un nemico da abbattere. Sul corpo vengono costruiti idoli e templi. Bisogna insegnare a ridere del corpo ai ragazzi. Bisogna far leggere gli autori suddetti e non solo Dante, che era senz'altro un genio immenso per strutturare l'aldilà e il Medioevo in terzine incatenate (il primo verso della terzina rima con il terzo verso della stessa terzina, il secondo verso della terzina rima con il primo e il terzo della terzina successiva e così via, ad libitum), endecasillabi quasi tutti canonici (si dicono così gli endecasillabi che hanno l'accento tonico sulla quarta o sulla sesta sillaba oltre che naturalmente sulla decima), in buona parte a maiore (cioè con l'accento tonico sulla sesta sillaba oltre che naturalmente sulla decima). Non si può però far vivere i ragazzi nell'Iperuranio letterario, nel dolce stil novo. Il corpo va affrontato anche in letteratura. Sul corpo c’è tutto un business mondiale. In Occidente esistono due polarità contrapposte: la carnalità e la spiritualità. Si creano così doppiezza, atteggiamenti schizofrenici. Sembra che non si possano coniugare le due cose. Da una parte l’orgasmo e dall’altra l’estasi mistica. Ma c’è chi basa tutto sul sesso e non raggiunge l’orgasmo. C’è chi vuole il rapimento mistico e in realtà riduce tutto alla solita, misera preghiera interessata. Ma siamo sicuri che non ci sia un intreccio tra i due aspetti? Dopo l’Eros sperimentiamo Thanatos. Dopo Thanatos rivogliamo Eros. Le due cose si richiamano a vicenda: la vita nella morte, la morte nella vita.
giu 192022Questi pensieri disincantati e disillusi sono stati scritti nel bel mezzo della pandemia. Sono molto pessimisti perché risentivano del fatto che allora non vedevo assolutamente una via di uscita (se c'è una via di uscita o meno non lo sa però nessuno con certezza). Ne riporto fedelmente i contenuti senza modifiche. Tenete però presente il mio stato d'animo di allora.

La poesia contemporanea italiana è in crisi da decenni. Mi manca comunque il raffronto con le altre nazioni che non conosco. È difficile ad ogni modo giudicare e valutare i poeti. Il grado di oggettività è minimo nella valutazione perché la poesia è anche “parola” (e non solo “langue”), è anche connotazione. Esiste poi la cosiddetta polisemia nella lirica. Inoltre come scrisse Sereni la poesia è “custode non di anni ma di attimi”. È qualcosa di impalpabile. Nessuno può comunque avere pretesa di esaustività nel definire la comunità poetica. Personalmente sono pessimista sulla poesia contemporanea italiana. Forse sono io che chiedo troppo alla poesia. Chiedo che non sia uno sfogatoio e che non abbia carattere privatistico, ma che abbia universalità. Chiedo che non sia pretestuosa né intellettualistica. Chiedo che non crei mondi fittizi, ma che sia in presa diretta con la realtà. Chiedo che non sia finzione e che le sue parole non siano evanescenti. Chiedo che critichi le istituzioni senza cadere in un vuoto ribellismo. Chiedo che sia una forma di arricchimento della personalità. Chiedo che mostri il lato irrazionale in una società basata sul razionalismo. Chiedo una poesia che almeno abbia sullo sfondo le patologie sociali, le sopraffazioni, le ingiustizie. Chiedo che cerchi di dare un senso alla vita. Forse è troppo. E poi cosa è mai questa poesia contemporanea? Ha forse un volto riconoscibile? Cosa c’è dietro un apparente fermento? È difficile offrire una panoramica vasta. Il fenomeno è complesso. Attualmente sono mutate molte cose (c’è stata una pandemia con milioni di morti nel mondo e più di centomila in Italia, c’è una gravissima crisi economica, c’è il debito pubblico alle stelle, eccetera eccetera). Intendiamoci bene: c’è chi fa cose più mostruose o inique di scrivere versi. Al mondo c’è chi ammazza, chi è pedofilo, chi fa il trafficante d’armi. Come può però una poesia, a tratti elitaria e illeggibile come quella contemporanea italiana dire qualcosa ai cittadini? Si possono dire le cose in modo più semplice? Un poeta farebbe sempre meglio a chiedersi: che sto a dire? Come lo sto a dire? Per quanto riguarda la comprensibilità dei testi la Dickinson scriveva che si doveva dire la verità in modo criptico, mentre K. Popper sosteneva che niente è così facile che scrivere in modo difficile e che tutti coloro che scrivono devono porsi come dovere la chiarezza espositiva (però era un filosofo). La realtà in poesia è che i componimenti dovrebbero in teoria cercare sempre di raggiungere i vertici della significazione. Però i poeti spesso cercano termini ricercati, talvolta antiquati, perché li considerano più consoni. I poeti tra gambo e stelo scelgono sempre il secondo vocabolo, anche se non sarebbe necessario. Anche i poeti in fondo hanno il loro gergo. I più dicono di farlo per la eufonia, la musicalità. Io ho i miei dubbi. Mi sembra che Pasolini avesse dichiarato a riguardo che esistesse in poesia un codice classista del linguaggio. Disse che nella sua prima poesia da bambino aveva utilizzato i termini “usignolo” “verzura”, anche se li conosceva vagamente. Comunque è vero che la realtà è complessa e per dirla alla Gadda "la vita è barocca ". L'esistenza è ciò che pensiamo e sentiamo in base a quello che ci accade. Ma stare a raccontare i nostri fatti inessenziali è oggetto di prosa. Esprimere pensieri ed emozioni, costruire simboli, metafore e analogie significa sapersi innalzare dalle cose della vita e fare poesia. La letteratura e con essa la poesia è una forma di conoscenza intuitiva e provvisoria. Non a caso Antonio Pizzuto riassume tutto in questi termini: "A è A, se A è A, finché A è A". Nella poesia il cuore comunque è nella parola ma anche nell'immagine. Spesso fare poesia significa mettere la testa sopra la melma.
La poesia italiana comunque versava già da tempo in gravi condizioni. Che cosa può dire un poeta o una poetessa a persone in difficoltà? Che cosa può dire un poeta o una poetessa a un malato di Covid o a un familiare di una vittima del maledetto virus? Oppure di fronte a un familiare di una vittima sul lavoro? Oppure di fronte alla fame nel mondo? Come verbalizzare e rendere credibile la verbalizzazione del nostro vissuto e delle nostre vicissitudini di fronte ai traumi così devastanti di chi non ha un euro o ha un familiare morto di Covid? Può un poeta trattare delle tragedie altrui, del Covid altrui senza incorrere nella retorica e nella inautenticità? I poeti attualmente non rischiano di scrivere in una lingua morta? La poesia può davvero essere testimonianza di quello che sta accadendo? Questi argomenti non sono assolutamente triti e ritriti. Nessuno ne dibatte oggi. Invece dovrebbero essere studiati attentamente. Prima di difendere strenuamente i poeti, dire che la poesia migliora la vita e salvaguardare la poesia bisogna riflettere a livello ontologico, etico ed epistemologico sulla scrittura in versi. Bisogna come minimo portare avanti dei ragionamenti e vedere quali sono gli ostacoli. Ognuno deve fare i conti con sé stesso, a costo di mettere in crisi certezze ed identità. Non è questione di indicare un approccio rivoluzionario. Nessuno sa quale è la strada migliore da seguire, ma non fare ciò significa mancare di nuovo a un appuntamento fondamentale, quello della storia. Oggi scrivere versi, guardando al proprio ombelico, non è più possibile a mio modesto avviso. C'è il rischio della fine del mondo. Pochi riflettono veramente sulla grave crisi in cui versa il mondo nel cosiddetto Antropocene. Inoltre i poeti dovrebbero chiedersi se davvero ne vale la pena, visto che non ci guadagnano e che la gloria nella maggioranza dei casi si fa attendere. Dovrebbero farsi un esame di coscienza, che è allo stesso tempo sia un atto di onestà intellettuale che un atto di umiltà. Ciò nonostante molti non si pongono queste domande essenziali. In molti predomina il narcisismo e il compiacimento. La visibilità è scarsissima, risibile in questa arte. Alcuni sono frustrati e soffrono di smanie di grandezza. Per un meccanismo di compensazione si autoingannano, mentendo a sé stessi. La poesia ha una scarsa condizione in questa società capitalistica e tecnologica. Che fare allora? Fare la rivoluzione? Diventare uomini in rivolta? Essere tecnofobi? Rifiutare tutti i paradigmi scientifici e le conquiste della scienza? Ritornare allo stato di natura? Un poeta o una poetessa dovrebbe chiedersi se è degno di nota come poetica e come stile, se è valido veramente sia da un punto di vista contenutistico che formalistico. Qualcuno potrebbe obiettare ciò che scrivo e sostenere che ognuno deve fare la sua parte. Ma i poeti possono reggere l’onda d’urto del Covid per esempio?
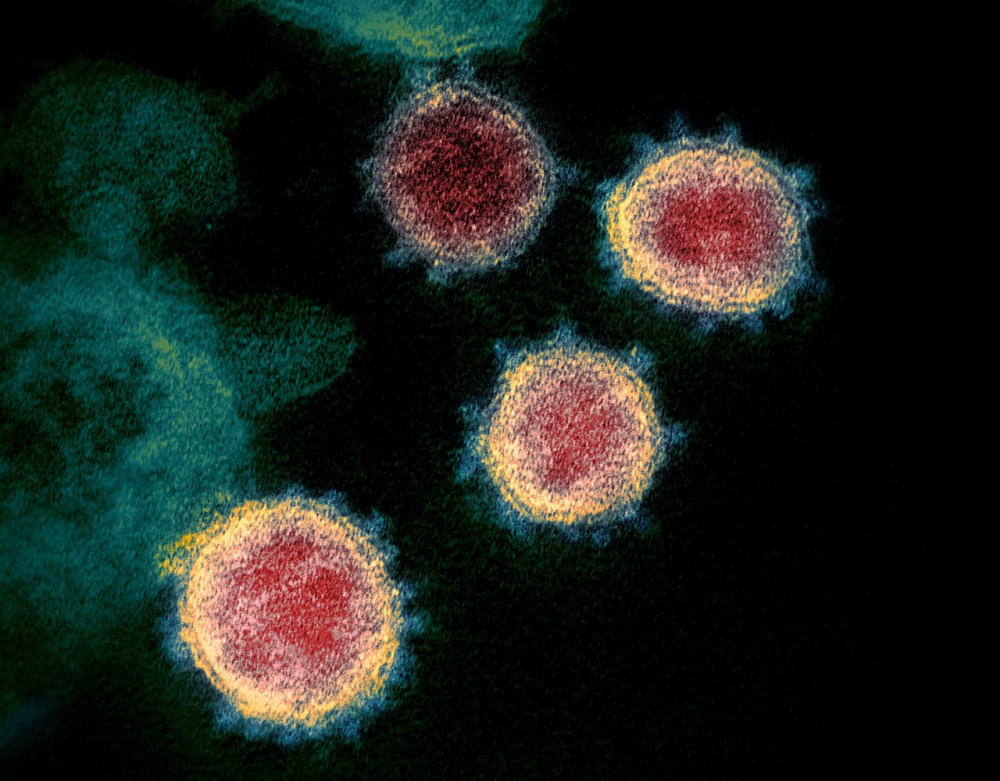
Il rischio infine è che la poesia in Italia diventi ancora più marginale di quello che è già. Una domanda sorge allora spontanea: cosa può fare di fronte alla pandemia e alla conseguente crisi economica la poesia italiana, già precedentemente poverissima ancella della società attuale? Questi sono gli interrogativi cruciali. Sicuramente la poesia italiana sopravviverà. Non lo metto in dubbio. La poesia morirà con l’ultimo uomo. Non voglio disquisire se la poesia salvi l’uomo oppure no. A proposito del fatto che la poesia non vende e delle classifiche dei libri fatte solo in base alle vendite ricordo cosa dichiarò Arbasino in una intervista, ovvero che non si può considerare McDonald’s il miglior ristorante del mondo perché la maggioranza lo frequenta. Ritorniamo al binomio pandemia/poesia. Non si può fare finta di niente e mettersi delle fette di prosciutto sugli occhi. Cito testualmente Adorno: “Scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie e ciò avvelena la consapevolezza stessa del perché è divenuto impossibile oggi scrivere poesia.” (Theodor Adorno, “Critica della cultura e società”). Valgono anche oggi le parole di Adorno? È meglio a mio modesto avviso per molti “poeti”, per dirla alla Freud, abbandonare il principio di piacere e abbracciare il principio di realtà. Ognuno prima di scrivere si autovaluti con la coscienziosità del buon padre di famiglia e l’onestà intellettuale di un critico disincantato, smaliziato. Nessuno ora può esimersi dall’esame di realtà. Questa situazione, la crisi del mondo attuale, da qualsiasi punto di vista la si guardi, è tragica. È una situazione che nientifica, nullifica la fruizione di ogni esperienza estetica. Questo è il problema principale, che va affrontato seriamente. Non ci sono scappatoie né vie di uscita. Non si può eludere. Non si può girare intorno, a meno che uno non viva in un mondo tutto suo e che si accontenti di tanto in tanto di un trafiletto in cronaca locale o di vincere un premio ininfluente di un paesino sperduto. Siamo franchi; non sono più i poeti a suggestionare ma la TV, gli influencer e i guru della crescita personale, della programmazione neurolinguistica, del neuromarketing. Oggi al massimo i poeti si autosuggestionano. Non tutte le parole scritte diventano poesia, come non tutte le pietre lanciate rimbalzano sull'acqua. La stragrande maggioranza delle parole si inabissano subito. In ogni caso tutti i pensieri scritti finiscono in una serie di cerchi concentrici, scaturiti dal sasso che finisce nello stagno. Ogni poeta è come un sasso che alza il livello dello stagno, dando il suo apporto culturale. I poeti degni di nota sono sassi che sono rimbalzati sullo specchio d'acqua. Ma sono eccezioni. Probabilmente tutto è vanità (come è scritto nell'Ecclesiaste) e tutto è inutile (come scriveva Guido Morselli nel suo diario). C’è chi per soddisfare il suo bisogno di immortalità fa figli e chi per trascendere la sua morte scrive versi. Io non farò nessuna delle due cose. Un tempo scrivevo versi. Ma ora non più. Cosa significa poi pubblicare poesie sul web? Sono forse messaggi in bottiglie nell’oceano in un tempo in cui tutti lasciano messaggi nelle bottiglie? Viene da chiedersi se da questa passione si può trarre giovamento e se con essa si possa raggiungere il famoso benessere psicologico. È soggettivo. Ci sono anche qui le contrarietà e non solo le soddisfazioni. È questione di fare una analisi costi/benefici. C’è anche chi si accontenta di qualche contentino, di pochissimo, quasi di nulla. Ma forse è soprattutto questione di buonsenso. Bisognerebbe forse raccogliere l'esortazione del grande Fortini: "Non muta nulla. Nulla è sicuro, ma scrivi". Però non c’è solo il benessere psicologico di chi scrive ma anche di chi legge e ciò non è un fattore secondario, anzi dovrebbe avere la priorità assoluta. La poesia infine può contribuire alla felicità come una bella passeggiata, qualche carezza al cane, una cena tra amici. Sono molteplici le occasioni che ci possono rendere felici. Personalmente guarderò in disparte. Leggere poesia e osservare la comunità poetica è una singolare e strana avventura.
Davide Morelli – 6/7 gennaio 2021
giu 192022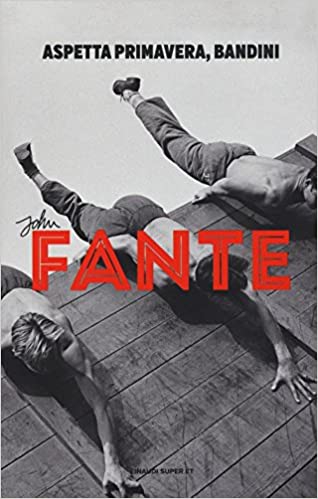
John Fante è uno scrittore originale e di talento. Ciò nonostante per molto tempo è stato un autore di nicchia. Essendo italoamericano è stato considerato marginale sia dai critici letterari americani che da quelli italiani: troppo italiano per gli americani, troppo americano per gli italiani. Fu Vittorini che lo fece conoscere agli italiani negli anni '40, mentre in America solo negli anni ’80 ci fu la sua riscoperta grazie a Bukowski, che lo considerò suo maestro per aver saputo conciliare nella sua prosa ironia e dolore. In Francia recentemente è divenuto un caso letterario. Fante era figlio di un abruzzese, emigrato in America ad inizio ’900. Nacque in Colorado. Lavorò per Hollywood e trascorse alcuni periodi della sua vita in Italia perché fece lo sceneggiatore per Dino De Laurentis. Il diabete gli procurò la cecità nella maturità e successivamente l’amputazione delle gambe. Morì nel 1983. Il libro che gli dette più soddisfazioni economiche fu Full of Life (“Una vita piena”), da cui fu tratto anche un film.
Tempi difficili per gli immigrati durante l’infanzia e l’adolescenza di Fante. Gli Stati Uniti non ebbero una legge sull’immigrazione fino al 1875. La legge del 1875 e le successive fino al 1921 non misero limiti all’ingresso di immigrati. L’opinione pubblica però esigeva una migliore “qualità” per quel che riguardava l’immigrazione. Gli Stati Uniti così decisero di sottoporre ai test d’intelligenza gli immigrati perché l’opinione pubblica ravvisava la minaccia di un “imbastardimento della razza americana”. I risultati dei test d’intelligenza "decretarono" la "superiorità intellettuale" del gruppo nordico. La legge del 1924 concedeva a tutti i nordici di entrare in America, ma stabiliva una quota del 2% per coloro che erano alpini e mediterranei (per cui anche gli italiani). Chiaramente oggi sappiamo che esistono le differenze di intelligenza, ma anche che non sono così quantificabili come alcuni psicologi avevano voluto far credere con i test. Il Q.I serve soprattutto come strumento diagnostico per vedere se un bambino soffre di ritardo mentale o per constatare se una persona che ha avuto un trauma cranico ha perso delle facoltà intellettive oppure come "indicazione di massima" per l'orientamento scolastico. .Inoltre come ha dimostrato Kamin nel libro "Scienza e poli del Q.I" i dati furono falsificati. Ma quello che ci interessa è l’atteggiamento xenofobo dell’opinione pubblica americana in quel determinato periodo. Tempi difficili per gli immigrati italiani quindi e Fante ce lo racconta approfonditamente nei suoi libri. Spesso infatti troviamo riportati nelle sue opere i pregiudizi dei nativi americani sugli italiani. Nei romanzi di Fante c’è la netta contrapposizione tra emarginati ed integrati: tra gli immigrati italiani (che sognano il benessere economico e vivono in povertà) e gli americani, che vivono dignitosamente. “Aspetta primavera, Bandini” è il suo primo romanzo. Con esso inizia la saga della famiglia Bandini, una famiglia di poveri immigrati italiani. L’eteronimo di Fante è Arturo Bandini, un adolescente di quattordici anni. I suoi fratelli August e Federico hanno rispettivamente undici ed otto anni. Svevo, il padre, è un muratore e un dongiovanni, che se la fa con una ricca vedova, che gli ha dato da rifare un caminetto della sua villa. E’ un uomo molto orgoglioso, che accetta malamente le incombenze della sua vita grama: il mutuo della casa, periodi di disoccupazione, i debiti da saldare. E’ molto legato al suo amico Rocco, che è stato in gioventù suo compagno di avventure. La madre Maria invece è una donna molto devota: sgrana il rosario e prega per la sua famiglia continuamente. Perdona sempre tutto al marito, accetta anche i suoi adulteri e le sue frequenti fughe da casa con rassegnazione. Il marito Svevo se ne va da casa per alcuni giorni, anche quando arriva la lettera di Donna Toscana, sua suocera, che lo considera un fallito e compatisce la figlia per la vita di miserie che è costretta a fare. Nonostante la famiglia Bandini spenda più di quello che guadagna, il figlio Arturo con l’incoscienza dell’adolescente trova il modo di rubare alla madre i soldi per andare al cinema. Arturo è innamorato di Rosa Pinelli, una sua compagna di classe, che però muore di polmonite. Il momento più poetico del libro è proprio quando Arturo viene a conoscenza della scomparsa della ragazza. Questo romanzo si legge tutto d’un fiato. E’ adatto a persone di tutte le età. La prosa è scorrevole. Non si rintracciano mai durante tutta l’opera intellettualismi e filosofemi. Leggere Fante dunque. Leggere Fante è interessante perché ci riporta indietro nel tempo: ci fa ricordare come eravamo. Ci fa comprendere le grandi difficoltà a cui andarono incontro coloro che emigrarono in America. E tutto questo ci viene raccontato con umorismo e con acume.
giu 192022

Bukowski dissacra il sogno americano. La sua è una critica feroce all’America benestante, puritana, conservatrice; una presa di posizione destabilizzante nei confronti dell’America del consumismo e del conformismo. Ce lo dice senza giri di parole in una sua poesia: l’uomo di oggi è merce deperibile. Lo scrittore americano è un ribelle solitario, che svela il grottesco della società a stelle e strisce. E' per questa ragione che in America è rimasto sempre underground e invece in Francia e in Germania ha avuto grande successo. Bukowski svela gli scheletri dell’armadio della rispettabilità borghese. I personaggi dei suoi libri sono assurdi e la loro grama esistenza può apparire talvolta al lettore insensata e vuota. Troviamo, quando va bene, mariti ubriachi e mogli brontolone affacciate alla ringhiera, affittacamere spilorce e maleodoranti. E tutti indistintamente che cercano di ammazzare il tempo, mentre aspettano di morire. Bukowski è troppo vecchio per appartenere alla beat generation e troppo originale per classificarlo in qualsiasi altra scuola poetica. Per alcuni versi potremmo definire lo scrittore erede di Fante o almeno potremmo dire che ha un debito nei suoi confronti. Infatti lui stesso ha dichiarato a riguardo di Fante: ”Ecco, finalmente uno scrittore che non aveva paura delle emozioni. Ironia e dolore erano intrecciati tra loro con straordinaria semplicità”. Bukowski dice no all’impegno politico, no all’establishment letterario. E' un uomo a mani vuote, senza alcuna certezza né ideologia. Per quanto riguarda ogni presa di posizione politica, Bukowski ci ricorda che gli uomini non sono mai forti come le loro idee. L’unica rivoluzione che forse potrebbe fare è quella dei barboni, che lui immagina nel suo racconto “La vendetta dei dannati” in “Niente canzoni d’amore”. Inoltre in un suo libro di poesie “Si prega di allegare 10 dollari per ogni poesia inviata” scrive a proposito dell'élite culturale : "Dire che sono un poeta mi mette in compagnia di grafomani matti e rincoglioniti che si mascherano da grandi saggi”. L'originalità delle sue poesie sta nel fatto che non c'è distanza tra l'espressione poetica e la lingua ordinaria americana. Lo stile colloquiale di intonazione bassa con cui si rivolge al lettore è rassicurante, però quando meno te lo aspetti ecco che Bukowski colpisce con la sua sicura fulmineità. E' singolare il suo modo di evocare la condizione umana: quello di Bukowski evoca una storia d'uomo disilluso che, assunta liricamente, desta risonanze in tutti ed esprime efficacemente il malessere di un'epoca. Un altro aspetto interessante è che troviamo uomini in carne ed ossa, non cifre e segni. La sua non è una poesia intellettualistica. Kerouac aveva scritto su un rotolo di carta telescrivente “On the road”. Vi narrava con un ritmo febbrile le peripezie di due giovani che percorrevano gli Stati Uniti da costa a costa. Ma in Kerouac c’era il desiderio di avventura, la voglia di esplorare il mondo e di effettuare un viaggio interiore tra Jazz, droghe, alcol. In Bukowski prevale invece una mistura sapiente di disincanto, cinismo, autoironia. In W. Burroughs ci imbattiamo in scenari onirici e psichedelici, che mettono a dura prova l’immagine prefabbricata dell’America. Troviamo le sue esperienze da tossicomane, gli allucinogeni, gli spacciatori, gli alcolizzati e una moltitudine di trasgressori e trasgressioni. Ma in Burroughs è rintracciabile anche la paranoia, il tema ricorrente della cospirazione, la presenza più o meno discreta del “Demoralizzatore totale”. In Bukowski invece no. Il nostro non perde mai il contatto con la realtà. Ci sorprende per il suo sguardo diretto alle cose quotidiane, per la sua immediatezza nel coglierne i tratti essenziali. Nei suoi testi non ci sono né allusioni, né allegorie. Ogni suo libro nel suo insieme è così chiaro, che si può abbracciarlo tutto con un solo pensiero. Nei suoi libri troviamo innanzitutto le sue più grandi passioni: la musica classica e la letteratura. Gli ambienti descritti nei suoi racconti e nelle sue poesie sono il bar, la strada, l’ospedale, l’ippodromo, la squallida stanza d’albergo, il manicomio, la bettola in cui è costretto a vivere. La cosa che più impressiona di Bukowski è l’occhio mirifico, la non comune capacità di cogliere il dettaglio di ogni ambiente e di ogni personaggio. Le sue storie poi spiazzano, perché sono vere eppure all’apparenza inverosimili. Un’altra qualità è la battuta sferzante, l’aforisma tagliente, che spesso al momento giusto riesce a riassumere e allo stesso tempo a sdrammatizzare la situazione paradossale in cui si trovano i personaggi. Ma questo non è ancora tutto. Il personaggio Bukowski entra prepotentemente in ogni suo racconto con le sue contraddizioni e i suoi vizi. Un personaggio dedito agli eccessi (all’alcool, all’erotismo sfrenato e sfacciato, talvolta alle risse). Insomma individualismo e bohème, o per dirla in termini italiani genio e sregolatezza.

Lo scrittore usa spesso a questo proposito il suo alter ego Henry Chinaski, che come lui ha lavorato alle poste. E’ un personaggio bifronte: a tratti si comporta come un ragazzino a tratti rivela una saggezza illuminante. E’ un uomo conflittuale, mai pienamente risolto, le cui storie senza uscita alimentano continuamente il suo disagio esistenziale. Bukowski dimostra il talento di fare della propria esperienza personale motivo e pretesto di condizioni più universali. Un tema che più volte Bukowski mette a fuoco è il rapporto difficile con le donne: sembra misogino e maschilista, eppure ha bisogno di relazioni a lungo termine con le donne: relazioni che non riesce a far durare a lungo per i suoi scatti d’ira e per i suoi umori altalenanti. Nelle sue vicissitudini sentimentali regnano incontrastate incomunicabilità ed estraneità reciproca. La donna non è mai idealizzata, contemplata. Non è mai fatta simbolo di niente. Eppure nella sua vita sarà proprio una sua donna, Linda Lee a mettere freno agli impulsi distruttivi dello scrittore. Gli farà ridurre l’assunzione di alcol, lo metterà a dieta, lo incoraggerà ad andare tutti i giorni alle corse dei cavalli per distrarsi e a non alzarsi mai prima di mezzogiorno. Bukowski mette a nudo i difetti delle donne con un certo sarcasmo. Però allo stesso tempo mette a nudo anche i suoi difetti e i suoi limiti di uomo. E questa sincerità disarmante da sola è rara e preziosa tra tutti gli scrittori esistiti ed esistenti
giu 192022
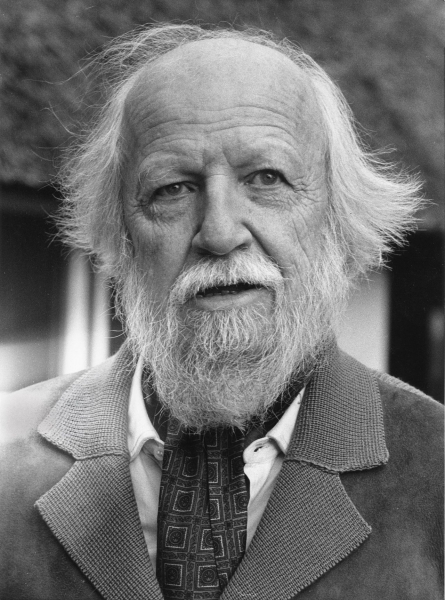
Questo capolavoro della letteratura inglese fu pubblicato nel 1954, grazie all’interessamento di T. S. Eliot. Il successo editoriale fu gigantesco: 14 milioni di copie vendute in Inghilterra. Quest’opera ha avuto diverse trasposizioni cinematografiche. Il primo film sul “Signore delle mosche” è del 1963 ad opera del regista Peter Brook.
Il libro non è altro che una favola moderna. Un gruppo di ragazzi sopravvive a un incidente aereo e finisce su un’isola disabitata. Il cuore dell’isola è costituito da una macchia fitta, ricca di frutti e maiali. C’è anche una montagna da cui possono scrutare l’orizzonte e guardare se passano le navi. I ragazzi hanno solo un barlume di speranza che possano portarli in salvo gli adulti perché durante il conflitto mondiale è esplosa la bomba atomica. Gli adolescenti devono adattarsi alla vita dell’isola: devono costruire rifugi, andare a caccia, fare delle leggi, eleggere un capo, tenere vivo il fuoco. Naturalmente dovranno fare tutto da soli perché non c’è la supervisione di nessun adulto. inizialmente viene eletto capo Ralph, il cui tipo di organizzazione simboleggia un’ideale di società democratica, in cui ognuno lavora per il benessere collettivo. Il capo ed i consiglieri possiedono la conchiglia, che rappresenta la conoscenza e la saggezza. Successivamente però si impone la società di Jack, basata sull’obbedienza e la subordinazione: una vera e propria dittatura. I due gruppi si scontrano e nella lotta muoiono due bambini: Simone e Piggy. Il microcosmo isolato dal mondo reale ed occasione per una rinascita dell’umanità diviene quindi un’ulteriore conferma della malvagità del genere umano: i bambini sono regrediti dalla civiltà alla barbarie.
A questo romanzo naturalmente sono state date le più svariate interpretazioni. C’è chi ha ritenuto che fosse un’allegoria religiosa, a causa del titolo. Infatti “Signore delle mosche” è uno dei tanti appellativi del diavolo. C’è chi invece ha posto l’accento sulla lotta tra il bene ed il male, cioè tra Ralph e Jack. Altri hanno visto nel romanzo il simbolo di quel che era accaduto nella seconda guerra mondiale ed hanno intuito in Jack il carisma e la forza di persuasione di Hitler.
Certamente da questo libro si possono comprendere tre concetti basilari su cui si fondano tutte le opere di Golding: 1) l'autore scrisse in un periodo della letteratura inglese, chiamato epoca tra il realismo e il modernismo. E lo scrittore riuscì ad essere sia REALISTA (perchè anche se questa storia è completamente inventata potrebbe sempre accadere) che MODERNISTA (perché fece largo uso di metafore, simboli ed allegorie) 2) il suo pessimismo riguardo la natura umana, dovuto al fatto che vide direttamente gli orrori della seconda guerra mondiale, perché fu ufficiale della marina britannica 3) la sua totale sfiducia nel sistema scolastico inglese. Questo libro infatti può essere anche inteso come una critica distruttiva nei confronti degli agenti di socializzazione dell’Inghilterra di quel tempo. I ragazzi del “Signore delle mosche” sono già andati a scuola, sono già stati deformati dalla scuola britannica. Sono già stati temprati dalla severa disciplina e dalle norme ottuse di quel periodo. Golding non a caso fu maestro e subì l’influsso della pedagogia steineriana. Steiner fu il fondatore dell’antroposofia, che potremmo definire una scienza dello spirito. Come educatore il filosofo Steiner fu straordinario. La sua pedagogia non si basa su nessuna imposizione e su nessuna ricetta. Lascia spazio alla creatività dell’insegnante, che a seconda delle sue esigenze e delle esigenze degli allievi può stabilire quali sono i modi più idonei di apprendimento. La pedagogia steineriana sostituì la disciplina ferrea con il calore umano tra allievo ed insegnante, dato che secondo il filosofo non bisognava educare solo la testa del bambino, ma anche l’intero corpo. Chiaramente Golding avendo in mente Steiner non poteva che essere contrarissimo al modo di insegnare della maggior parte degli insegnanti inglesi, così freddi ed impostati.
giu 182022
(Nella foto Davide Morelli con l'amico di infanzia Emanuele Morelli in un selfie a Marina di Cecina. Il brufolo sulla fronte ora non c'è più. Ah ah ah!!!)
Alla voce "recensione " sulla "Treccani" si trova scritto: "1. (filol.) [fase del lavoro di edizione critica consistente nella scelta della lezione ritenuta migliore tra le varianti messe in luce dalla collazione: r. chiusa, aperta] ≈ recensio. 2. (estens.) [esame critico, in forma di articolo, di un'opera di recente pubblicazione e, anche, articolo che commenta spettacoli, film, mostre e sim.: fare, scrivere una r. favorevole, severa] ≈ ‖ articolo, commento, critica, giudizio, presentazione, scheda.". Una recensione quindi è una critica, un commento, un giudizio critico. Ma chi può scriverla? Tutti o solo gli addetti ai lavori? Tutti o solo chi se ne intende? E chi se ne intende?
Il poeta e professore Valerio Magrelli (a scanso di equivoci molto bravo come poeta) in una intervista a Fabio Fazio sosteneva (si spera in modo provocatorio) riguardo a chi poteva commentare un libro: "Ecco, io proporrei il sistema delle ore di lettura, come i piloti d’aereo. Quando si può pilotare un jumbo? Quando, per ricorrere a un’iperbole, si sono fatte 8000 ore di volo. Quando puoi scrivere il tuo parere su un libro? Quando hai letto 8000 libri di teoria, di narrativa, di poesia; altrimenti non puoi parlare. Io non voglio sapere i pareri dei lettori, non mi interessano: deve essere vietato al lettore di parlare. Ma parto dalla grande idea di Borges per cui io vado molto più fiero del mio lavoro di lettore che di quello di scrittore. Essere lettori è una cosa importantissima". Ma forse ci sono anche persone che sanno pilotare un aereo senza aver fatto 8000 ore di volo. Le capacità critiche sono date solamente dal numero di libri letti? Non è questa di Magrelli un'idea classista della letteratura? Non è un modo di fare e di dire respingente o evitante? Giustamente a mio modesto o immodesto avviso il professore e poeta Dante Maffia, candidato più volte al Nobel della letteratura, scrive sul sito letterario La presenza di Érato: "Evidentemente lui può, e anche Fazio può, perché gli ottomila volumi li hanno letti. Mi domando: li hanno digeriti? Perché i libri non basta leggerli, bisogna capirli e questo può avvenire se si riesce a stabilire con loro una certa complicità, se si riesce a entrare nelle pagine senza pregiudizi e senza spocchia, ascoltando gli autori senza sovrapporsi, senza pretendere di farli passare per la cruna del proprio ago per renderli un’appendice di se stessi. E poi… se uno di libri ne ha letto settemila e ottocento? Ma che razza di ragionamenti sono questi? Magrelli mi pare che abbia visitato in Russia la biblioteca di Boris Pasternak che raccoglie poche centinaia di volumi, quelli amati, letti (e digeriti). Un’altra delle biblioteche che ha dato cibo a Singer è di circa trecento volumi, tanto che, quando gli fu assegnato il Premio Nobel, i giornalisti, andati a intervistarlo, gli domandarono più volte dove fosse il resto dei suoi libri". Aggiungo io che la biblioteca di Petrarca ad Arquà fosse di circa 500 volumi e quella di Montaigne nella sua torre di 1000. Io di libri ne ho letti solo 3000-3500. Nella mia biblioteca attuale ce ne sono circa 1200-1300. 900 libri li ho buttati via per il trasloco. Erano troppo malandati. La biblioteca comunale non voleva i libri sottolineati. Altri 150 li ho donati alla biblioteca comunale. Molti libri letti li ho presi a prestito dalla biblioteca comunale. Non li ho comprati. Io perciò secondo Magrelli non avrei voce in capitolo. Ma "esisto anche io, malgrado le apparenze" scriveva il cantautore e poeta livornese Piero Ciampi!

(Nella foto Il poeta Valerio Magrelli. Da Wikipedia)
Veniamo a me. Ho recensito diversi libri in questi ultimi anni. Ho recensito libri di grandi autori, di autori affermati e di emergenti. A volte mi chiedo: ma se qualcuno mi facesse il terzo grado su tutte le mie recensioni cosa saprei dire? In questo caso non si tratta di problemi di apprendimento, ma di mantenere intatte le nozioni. Potrei trovarmi in difficoltà. Qualcuno potrebbe obiettare: caro Davide, scusa non richiesta accusa manifesta e poi chiedermi perché metto le mani avanti. Sarebbe impossibile per me a ogni modo ricordarmi con dovizia di particolare tutti i libri recensiti. Forse è un'impresa impossibile per ogni recensore che si rispetti. Comunque chiedo venia. Io scrivo una recensione e poi vado oltre, passo oltre. Parlando in generale, la memoria a breve termine ha i suoi limiti. Come dimostrò lo psicologo Miller nel 1956 con il suo saggio breve "Il magico numero sette, più o meno due" tutti riusciamo a memorizzare dai 5 ai 9 (di solito 7) elementi (che in psicologia si chiamano item). L'ippocampo è la parte del nostro cervello, a forma di cavalluccio marino, adibita al passaggio dei dati dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine. Le persone possono avere problemi di apprendimento quando l'ippocampo è danneggiato per un trauma cranico dopo un incidente stradale per esempio o se hanno lesioni microcorticali ad esso a causa di anni di grave alcolismo o perché sono tossicodipendenti. Si parla in questi casi di amnesia anterograda oppure di psicosi di Korsakoff. Uno dei problemi maggiori per tutti è l'oblio, se non si ripassa continuamente i libri letti. Un altro difetto della memoria è l'interferenza, ovvero non sempre le nozioni vengono interiorizzate, integrate tra di loro e quindi si disturbano. Inoltre libro scaccia libro talvolta, ovvero per acquisire nuove nozioni si dimenticano quelle precedenti. E allora per evitare ciò bisognerebbe rimanere forse alle quattro cose basilari delle scuole elementari? Evidentemente no perché non ci sarebbe progresso. Comunque non preoccupatevi nessuno finisce "out of memory" perché, se è vero che la memoria a breve termine ha dei limiti per tutti, quella a lungo termine è un pozzo senza fondo. E poi viene da chiedersi se sia meglio acquisire nuove conoscenze o approfondire le conoscenze già fatte nostre. Nel dubbio spesso finiamo per fossilizzarci sulle poche cose che sappiamo. A ogni modo talvolta le tracce mnestiche scompaiono. Ma non tutto è perduto! Talvolta basta riprendere da dove avevamo lasciato. Cosa sarei in grado di ricordare e di rispondere se qualcuno mi domandasse delle mie recensioni? Di poche mi ricordo i particolarial 100%. . Ho in mente vagamente il senso del libro. Dovrei rileggere la recensione che ho scritto e poi sarei in grado di spiegare cosa intendevo dire. Non recensisco tutti i libri che leggo. Sarebbe un'impresa impossibile. Recensire? Di solito rispondo come Bartleby: "I would prefer not to". Di solito preferisco fare considerazioni di carattere generale magari citando in qua e in là alcuni libri letti. Bisognerebbe sapere di cosa si scrive. Bisognerebbe scrivere di ciò che sappiamo. In realtà le nostre conoscenze non sono stabili; la nostra mente è un flusso inarrestabile. I nostri pensieri cambiano. Il nostro sapere lo stesso. La nostra in(cultura) vera o fasulla è dinamica. A volte mi immagino che esistano gli avvocati del diavolo del buon recensore o presunto tale. Mi immagino una mia vecchia insegnante di italiano che mi "inchioda" perennemente ai primi due temi del primo quadrimestre del primo anno in cui mi dava 4 e mezzo. Immagino che sia la mia inquisitrice e che mi dica che la mia scrittura è tempo perso. Immagino che mi dica che sono un incapace, un inconcludente e quello che non ho fatto nella vita è l'ennesimo risultato di come andavo male alle superiori, senza considerare la mia svogliatezza e la mia crisi interiore di quegli anni. Immagino che mi dica; tutte scuse Morelli! Immagino che mi dica: tu per me sarai sempre quel quattordicenne che mi guardava e a stento tratteneva il pianto per quelle gravi insufficienze a causa di quei temi così puerili. Non si può allora migliorare? Comunque non vorrei fare lo psicodramma di Moreno. E ad ogni modo perché dovrebbe esserci tanto accanimento nei confronti di un recensore tra i tanti? Mica si parla di beatificazione! Io recensisco talvolta libri hic et nunc. Questo é quanto. È chiaro che in quel momento conosco ciò di cui sto scrivendo. Cerco di farlo nel migliore dei modi, non tralasciando niente al caso. Poi leggo molto e diverse cose me le dimentico. Nessuno, arrivato a 50 anni, ha una memoria di ferro. Quindi potrei avere delle difficoltà se qualcuno valutasse ciò che so in questo momento di tutte le mie recensioni. Abbiate pietà: sono un semplice essere umano e non un automa perfetto. Poi non prendiamoci in giro: gli insegnanti delle superiori o i professori universitari ripassano la lezione e studiano il giorno prima di spiegare in classe o in aula. Nessuno, come si suol dire in Toscana, ha la scienza infusa, in questo caso la letteratura infusa. Se i professori venissero interrogati a tradimento, di sorpresa, potrebbero essere messi in difficoltà anche loro. Non solo ma per una recensione per la rivista letteraria Atelier mi ci vuole diverse ore a scriverla. Di solito scrivo 100, 150, 200 parole di getto. Quindi spengo il tablet e mi metto a pensare cosa dovrei ancora scrivere. Penso, aspetto un'altra idea. Quando finisco mi metto a limare. Pensavo di essere un deficiente a metterci così tanto tempo. Invece poi ho sentito un'intervista alla RAI del critico letterario Walter Pedullà, in cui diceva che ogni recensione gli costava ore di lavoro e fatica. Ritornando alla questione della memoria, perché comunque una nozione resti nella mente, per giungere al passaggio dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine, bisogna reiterarla, ovvero ripeterla mentalmente. Ci sono persone che studiano a voce alta, cioè ogni giorno dopo aver letto attentamente, provano a richiamare dalla memoria i nuovi input culturali. Altri invece studiano insieme a un compagno/a per ripassare e si fanno le domande a vicenda per sapere cosa si ricordano. Ma tutto questo può essere fatica sprecata se uno studente non sa su cosa vertono le domande degli insegnanti. Deve quindi conoscere cosa vuole sapere l'insegnante. La memoria può fare brutti tiri a chiunque, a meno che uno non abbia una memoria fotografica (ma si contano sulle dita di una mano). Decenni fa dicevano di questi individui così portati a ricordare che avevano una memoria eidetica. Va ricordato che per Husserl l'intuizione eidetica permette agli uomini di percepire una melodia e non solo delle singole note. Comunque decenni fa tutto era eidetico perché Husserl era di moda! Certo i trucchi per risolvere gli inconvenienti della memoria ci sono. Esiste la mnemotecnica. Molto semplicemente Pietro Citati, normalista e grande critico letterario, dichiarò che ogni volta che doveva dare un'intervista si preparava sempre ripassando il suo saggio su cui gli avrebbero fatto domande. Si preparava quindi come fosse un esame. A volte parlando in pubblico può sopraggiungere il timor panico e allora l'ansia può obnubilare la mente. In questi casi uno, sopraffatto dall'ansia, può richiamare nozioni alla rinfusa oppure può interrompersi il collegamento tra memoria e linguaggio, finendo per essere preda di un blackout quasi totale, ovvero la classica scena muta. Al contrario ci sono anche memorie prodigiose. Ma spesso un'ottima memoria è frutto di esercizio continuo, a meno che uno non soffra di amnesia. La verità è che certe cose le sapevo quando ho scritto la recensione. La questione di fondo è se la recensione è copiata o meno. Ci sono programmi informatici ad hoc per verificare se è stata copiata. Dire o scrivere che tizio ha copiato è diffamatorio, se non si mostra dove ha copiato, portando le prove oggettive. Importante è che la recensione sia originale. Intendiamoci comunque: recensire non mi pesa, però non date tutto per scontato perché è un impegno. Potrei anche non farlo. Quindi non diamo niente per scontato. Una recensione non è altro che una serie articolata di piccole opinioni. Non si può ricordare tutto. L'importante è essere onesti intellettualmente. Non bisogna mentire. Io per esempio scrivo solo di libri che mi sono piaciuti. Evito sempre le stroncature. Inoltre quali sono i pericoli da evitare? Per la studiosa e poetessa Carmen Gallo un recensore non deve essere un "autore mascherato". Per altri è necessario evitare di recensirsi a vicenda, ovvero fare le recensioni incrociate: quello che la professoressa e poetessa Gilda Policastro chiama ironicamente un 69 critico. Ritornando a me, non posso ricordarmi per filo e per segno tutte le mie recensioni. In definitiva ogni tanto recensisco qualche libro e cerco di farlo con cognizione di causa. Non mi risulta che per recensire bisogna essere professori universitari di letteratura. È sufficiente essere dei lettori forti o quantomeno attento. Ben vengano i recensori dilettanti. Magari sono improvvisati, però sono più sinceri. A volte i critici letterari evitano guai, hanno delle limitazioni. Insomma sono sicuramente meno liberi dei recensori qualsiasi di cui il web è una fucina inesauribile. Ciò non va preso in modo negativo: significa che i libri destano ancora interesse, che possono fare tendenza. Una delle cose da evitare naturalmente è il "recensionismo compulsivo", termine nato da un video su Youtube di Roberto Mercadini, riguardante il delirio delle recensioni su Amazon Libri Perciò potrei affermare di non sparare sul recensore! E poi perché un recensore senza infamia e senza lode, senza arte né parte deve rendere a tutti i costi conto a voi? Non è un recensore qualsiasi la causa dei vostri problemi!
N.B: tra i miei libri letti ci sono circa 60/70 classici Bompiani e Meridiani Mondadori, acquistati e in buona parte presi a prestito. In ogni opera omnia ci sono decine di opere. Quindi il numero esatto dei libri letti a onor del vero sarebbe maggiore. La mia è solo una stima per difetto.
giu 172022

(Nella foto Davide Morelli a Marina di Cecina)
"Il poeta sei tu che leggi” si trova scritto dappertutto ormai. È scritto anche sul Lungotevere Vaticano. Lo scrivono in tanti sul web. Sembra che la paternità sia da attribuirsi al poeta di strada Ivan Tresoldi, certamente un personaggio creativo. Il vero autore sarebbe quindi il lettore. Sarebbe lui il maggior costruttore di significato, il vero responsabile del senso ultimo del testo. Di fronte all'ambiguità semantica è proprio il lettore che decide cosa significhi questa o quell'opera. Una parola, una frase, un intero testo possono avere significati diversi a seconda del contesto (inteso in senso lato) e della sensibilità individuale. Ogni testo in un certo qual modo è polisemico. La stessa connotazione, quella che Umberto Eco definiva come la coloritura emotiva di ogni parola, di ogni frase varia da persona a persona. La denotazione non è oggettiva (nel senso che non è oggettuale come le cose nella scienza), ma è certa perché convenzionale. La denotazione è decisa dalla comunità linguistica. La connotazione è incerta perché soggettiva. Ogni testo quindi dipende anche, forse soprattutto, dallo stato mentale, dall'umore, dallo stato d'animo del lettore in quel particolare frangente. Era questo il punto debole dello strutturalismo, prima ancora che Chomsky parlasse di psicolinguistica. Possiamo perciò anche essere d'accordo. Gli artisti inoltre non esistono senza pubblico. I poeti non esistono senza lettori. Adam Smith ne "La ricchezza delle nazioni" considerava gli artisti degli assistiti. In quell'epoca la maggioranza erano cortigiani oppure secoli prima per esempio pittori e scultori venivano finanziati da dei mecenati o avevano come committente la Chiesa. Oggi gli artisti sono assistiti dai loro ammiratori, estimatori, seguaci. Aveva capito tutto il cantautore Claudio Rocchi quando gli chiedevano l'autografo, lui chiedeva le generalità del richiedente e poi firmava con il nome e cognome del suo fan. Senza il pubblico l'artista non ha modo di esistere. Oggi è poeta chi legge. Al bando quindi il copyright, i diritti di autore, l'autorialità. In questo modo nessuno è più autore e tutti sono autori. Ma io mi domando: se uno non legge cosa è? Molto probabilmente molti non vogliono leggere perché non vogliono essere poeti. Di solito comunque leggono poesia soprattutto gli aspiranti poeti, coloro che vogliono diventare poeti. Come esistono le preghiere interessate anche queste sono letture interessate in un certo modo. Tuttavia "il poeta sei tu che leggi" significa senza ombra di dubbio che non si può essere poeti senza essere lettori forti. Ma la situazione è a ogni modo desolante in Italia. Certamente i giornali non aiutano. La cosiddetta terza pagina viene sempre messa in ennesima pagina. Sono anche scomparsi e non più sostituiti grandi maestri dell'elzeviro. Non scrivono più ormai Luca Goldoni, Alberto Arbasino, Pier Francesco Listri, Luigi Maria Personè. Mi ricordo che anni fa mi incuriosivano molto gli aneddoti letterari di quest'ultimo, morto centenario, grande letterato, che aveva conosciuto tutti i più grandi letterati del Novecento italiano e non. Poi le terze pagine dei quotidiani trattano di società, mondo dello spettacolo, tendenze. Trattano spesso di cose futili, leggere, tanto per intrattenere più che per acculturare, se va bene per informare più che per formare. Ma i direttori dei giornali sono messi alle strette e loro, se interpellati a riguardo, direbbero prontamente: i quotidiani vendono sempre meno copie e bisogna dare ai lettori ciò che vogliono. Il potere in questo modo si deresponsabilizza tramite la presunzione di ignoranza del popolo. Così facendo il popolo non si accultura. Inoltre come ho sempre avuto modo di dire: oggi tutto è cultura tranne la cultura. C'è spazio per tutti in televisione tranne che per la letteratura, la poesia, la scrittura. Eppure la fruizione culturale è aumentata notevolmente in questi anni. Ma la cultura è noiosa, soporifera. La scuola non aiuta. I programmi ministeriali sono quelli che sono. Poi con la vecchia retorica che non bisogna dare la pappa pronta diversi critici letterari si sono dimostrati criptici, oscuri, allontanando di fatto le persone dalla cultura. Diversi letterati non vogliono correre il rischio della banalizzazione, della volgarizzazione, neanche quando di tratta di un'utile semplificazione. Anche in letteratura bisognerebbe utilizzare il rasoio di Occam, ovvero non moltiplicare gli enti inutili. Invece sembra che diversi letterati abbiano a cuore il loro gergo specialistico e allora usano grecismi, latinismi, inglesismi, francesismi. La cultura diventa talvolta perciò un fardello pesante. Ci sono ancora oggi diversi letterati, che pur essendo politicamente progressisti, hanno una concezione elitaria e snobistica della letteratura, nutrendo talvolta dei pregiudizi nei confronti della cosiddetta gente. Insomma secondo costoro la letteratura deve essere difficile, non alla portata di tutti. Un tempo il preside della facoltà di ingegneria di Pisa, Piero Villaggio, amava dire "ingegneria deve essere difficile" agli studenti che si lamentavano della severità dei docenti. Ogni ingegnere ha delle responsabilità civili, sociali, etiche, umane. Deve saper fare bene i calcoli per non far crollare i ponti o se è un ingegnere gestionale deve saper fare i conti per non far fallire un'impresa. Ma un letterato ha soprattutto il dovere di farsi capire ai più. Così scriveva Claudio Chieffo: "Dicevano gli antichi che non c'è nulla di peggio di un popolo che dimentica i suoi poeti; e invece c'è di peggio: un poeta che dimentica il suo popolo". In un certo qual modo diversi letterati complicano le cose; sono esoterici, nel senso più deteriore del termine. Ma a questo proposito secondo una scuola di pensiero nessun uomo è depositario di grandi verità. Le cose della vita sono sempre quelle trite e ritrite. I letterati sono uomini come gli altri. Invece secondo un'altra scuola di pensiero non si può spolpare la letteratura perché poi alla fine ci resta un torsolo di mela. Secondo questi pensatori aveva ragione Cioran quando scriveva che se togliessimo il belletto alla letteratura non resterebbe niente. La domanda da un milione di dollari è la seguente: si può rappresentare la vita anche in modo comprensibile ai più oppure bisogna riprodurla fedelmente nella sua complessità? E ancora i letterati devono abbassarsi al livello del pubblico o devono cercare di elevarlo? Meglio arrivare a tutti o invece essere per pochi eletti? Nel frattempo la poesia è di nicchia. Di solito le espressioni "nicchia di mercato" o "mercato di nicchia" possono avere anche molti risvolti positivi. Si sente dire che nel mondo economico c'è parecchia crisi, ma tizio e caio hanno trovato una bella nicchia di mercato e si sono arricchiti. Non fatevi illusioni: la poesia è una nicchia di mercato che non vende, non arricchisce, se non interiormente. Eppure le facoltà umanistiche sono sovraffollate. Mai tarpare le ali. Mai uccidere i sogni. Ci penserà poi la realtà a disilludere, a deludere, a disincantare. Un altro problema è che oggi tutti sono poeti tranne i poeti. Sono poeti i cuochi, i cantanti, gli influencer, i lestofanti, i piacioni, gli addetti alle pubbliche relazioni, i latin lover e gli arrivisti vari. La poesia sembra essere di tutti, tranne che dei poeti. E i veri poeti? Non pervenuti. Lasciano poche tracce di sé. Disseminano i loro versi in angoli remoti del web. Pubblicano libricini che vendono poco o addirittura pochissimo. La poesia d'altronde è di tutti o di nessuno. Parafrasando un celebre detto, la poesia è quella cosa che tutti pensano di sapere che cosa sia. In tutta onestà penso che valga la regola opposta e inversa: nessuno può sapere con certezza che cosa sia la poesia. Quindi, concludendo, è vero: il poeta sei tu che leggi, a patto che tu legga e legga roba buona.
giu 172022

Ungaretti dovrebbe essere un modello per i poeti contemporanei spesso illeggibili perché incomprensibili. Ognuno, dopo aver finito di scrivere una raccolta poetica, dovrebbe rileggere "Allegria", che si caratterizza per i versicoli immediati. Dovrebbe essere la prova del nove per tutti i poeti. Allo stesso modo ogni romanziere dovrebbe, dopo ogni sua fatica letteraria, rileggere "Se questo è un uomo" e "Una giornata di Ivan Denisovič" perché questi due capolavori riescono a coniugare anche essi sostanzialità e testimonianza. Poi magari ogni scrittore potrebbe decidere se pubblicare o rivedere di nuovo il lavoro. Ma ritorniamo a Ungaretti. Sono talmente dirette e spontanee le sue liriche, che riescono a spiazzare e a colpire favorevolmente anche i lettori più snob, abituati alla poesia del Novecento che si distingue per essere così intellettuale! Ungaretti è agli antipodi di poeti così ricercati come Eliot e Pound. Riesce a semplificare il linguaggio e a essere scarno ed essenziale. Nei suoi versi troviamo tutta la sua vita di esule che si forma culturalmente a Parigi (conoscendo Apollinaire e Picasso) e che combatte sul Carso. Queste sue poesie sono testimonianza ineguagliabile della guerra. Sono prive delle descrizioni e dell'eloquenza della lirica di quegli anni. Non vi sono leziosismi. Sono frutto di un'ispirazione, che trascende la metrica, la retorica e l'estetica. Non vi venga in mente che le sue poesie scaturissero solo da intuizioni, seppure formidabili. C'era del lavoro alle spalle. Erano state molte le varianti e le revisioni prima delle versioni definitive. A onor del vero bisogna anche ricordare che il poeta distrusse le tradizionali forme poetiche nelle prime liriche, ma successivamente dimostrò di saper utilizzare anche versi canonici come novenari ed endecasillabi. Forse oseremmo troppo a scrivere che fu una sorta di cubista della poesia nella sua prima fase. Come ebbe a scrivere Ungaretti per essere poeti è necessaria non solo la pazienza, la conoscenza della tradizione, l'intelletto. Bisogna anche saper fare i conti con il mistero che alberga in ogni animo: soltanto così una poesia può diventare unica come la sua. Ungaretti, quando scrisse i suoi primi innovativi versicoli, aveva appreso la lezione dei simbolisti francesi. Ma Ungaretti era completamente originale. Aveva subito saputo distinguersi dai suoi illustri predecessori. Era un predestinato della poesia. Lo stesso Thomas Merton scrisse che Ungaretti era sconvolgente e che la sua intensità annientava. Alcuni suoi versi rimarranno per sempre nella memoria di molti: "m'illumino d'immenso", "è il mio cuore il paese più straziato", "si sta/come d'autunno/ sugli alberi/ le foglie", "Di che reggimento siete/ fratelli?", "Non sono mai stato/ tanto/ attaccato alla vita", "tra un fiore colto e l'altro donato/ l'inesprimibile nulla". Queste illuminazioni esprimono in modo impareggiabile la precarietà e la fragilità proprie di chi combatte in una guerra assurda. Ungaretti aveva combattuto la grande guerra e per capire quanto fu devastante la prima guerra mondiale non bisogna andare molto lontano: basta andare a visitare Asiago, che fu completamente rasa al suolo in quegli anni. Ungaretti viaggiò molto. Visse molto. Soffrì molto. Non soltanto per l'esperienza della guerra ma anche per la morte del figlioletto di nove anni a cui dedicò la raccolta "Giorno per giorno". Il poeta si chiedeva come era possibile continuare a vivere e a fare le cose di ogni giorno quando non poteva più vedere il suo bambino, la cui voce non avrebbe udito più. Scrisse Ungaretti: "E t'amo, t'amo, ed è continuo schianto!...". Nella sua vita il poeta sperimentò i dolori più terribili: gli orrori della guerra e la scomparsa del figlioletto. Ma Ungaretti riuscì a non lasciarsi mai sopraffare dalle avversità e dai tristi eventi. Riuscì sempre a superare questi periodi di crisi, testimoniando con i suoi versi le tragedie vissute. La follia della guerra riuscì a vincerla confidando nell'uomo: credendo nella fraternità. Il dolore atroce per la perdita del figlio lo sconfisse non solo con la terapia della scrittura ma anche con la religiosità. Non auguro a nessuno di provare i dolori di Ungaretti. Dovrebbe però essere preso di esempio per la sua semplicità, che è mai scontata e non scade mai in banalità. Il Nostro scrisse in modo apparentemente semplice ed è comprensibile a tutti. Ma non lasciatevi ingannare. Ungaretti era anche un profondo conoscitore della lingua e della poesia. C'è chi potrebbe pensare che molti sarebbero in grado di scrivere come Ungaretti ma è un giudizio affrettato dovuto a pura superficialità e faciloneria: pensarla così è pura ingratitudine nei confronti di uno dei più grandi poeti del Novecento. Comunque Ungaretti fu il primo a scrivere in quel modo così breve e coinciso. Nel peggiore dei casi gli vanno riconosciute in tutta onestà sia la bravura che la grande originalità.
giu 172022

Quasimodo, nonostante le sue sperimentazioni e le sue revisioni stilistiche, fu sempre legato alla tradizione, grazie alla musicalità dei suoi versi e al suo classicismo (non a caso tradusse i lirici greci). Inizialmente il poeta cantò il mito della Sicilia, la nostalgia e lo sradicamento dalla sua terra; nelle sue prime raccolte rievocò l'infanzia e i paesaggi che lo avevano visto nascere e crescere. In quegli anni fu ermetico. Alcuni lo hanno considerato un caposcuola, mentre altri solo un fiancheggiatore di questa corrente letteraria. Coloro che lo criticano negativamente per questa sua adesione dovrebbero però ricordarsi che erano gli anni della formazione del suo immaginario e del suo apprendistato poetico: non era ancora nella fase della maturità.
L'ermetismo aveva il grande pregio di proporre "la letteratura come vita" e di opporsi all'autoesaltazione, all'enfasi, alla megalomania di D'Annunzio. Alcuni critici però hanno sempre accusato gli ermetici di essere oscuri e di utilizzare un linguaggio allusivo. Ma Quasimodo anche in questo suo periodo non fece mai un utilizzo eccessivo dell'analogia. Poteva sembrare di primo acchito non totalmente originale, eppure successivamente si dimostrò unico sia dal punto di vista espressivo che per quel che riguarda la visione del mondo.
Il poeta seppe distaccarsi dalla retorica di Carducci, dall'estetismo e dall'irrazionalismo di D'Annunzio, dall'intimismo e dalla stanchezza di vivere dei crepuscolari, dall'esaltazione del progresso dei futuristi, dal nazionalismo di altri artisti; il poeta siciliano non scavò mai nella parola e non distrusse il verso come fece Ungaretti; non distrusse mai le strutture logiche e sintattiche; non si abbandonò all'estetismo; non si lasciò corrodere dall'autodistruzione e dalla nevrosi; non fu mai preda dell'intellettualismo e ricordo che per esempio per Croce l'autentica poesia era priva di sovrastrutture ideologiche, di allegorie, di tematiche filosofiche e teologiche. Quindi secondo i canoni estetici crociani i suoi componimenti erano poesia. Il grande critico letterario Oreste Macrì scrisse un saggio sulla "poetica della parola" di Quasimodo. Come poeta sono pochissimi coloro che lo giudicano in modo negativo. Come uomo all'epoca alcuni lo criticarono per non aver partecipato alla Resistenza. Ma come scrisse lo stesso Quasimodo "il poeta modifica il mondo" e non è detto che lo possa fare soltanto con l'impegno politico-sociale, ma lo può fare anche con i suoi versi. Dopo la fase ermetica non scrisse più dell'Eden perduto ma trattò della sofferenza dell'uomo in guerra. Quasimodo dimostrò di saper compiere un'evoluzione dal punto di vista umano, affrontando nuove tematiche. Aveva sempre nostalgia di casa, ma non era più il paesaggio siciliano a avere la meglio: era piuttosto la coscienza civile ad essere presente in ogni lirica. Il poeta non poteva stare nella sua torre eburnea, ma doveva esprimere sentimenti come solidarietà, partecipazione emotiva, fraternità. Evitò così di descrivere l'incomunicabilità e divenne forse il più comunicativo dei poeti del Novecento, addirittura forse più di Ungaretti: sicuramente uno dei più semplici e più comprensibili a leggersi, il più efficace a descrivere la crisi esistenziale dell'uomo moderno conseguente alla tragedia e all'orrore della guerra. I suoi messaggi erano chiari ed espliciti.
Come non ricordare la lirica "Uomo del mio tempo", in cui scrive che l'uomo è sempre lo stesso di quando usava la pietra e la fionda e che ora utilizza le sue scienze esatte per sterminare i suoi simili? Oppure come scordarsi "Alle fronde dei salici" che necessita di una parafrasi solo se letta da un bambino delle elementari o al massimo delle scuole medie inferiori? Oppure come non ricordarsi la lirica "Quasi un epigramma" in cui definisce la società moderna come "la civiltà dell'atomo"? Non era forse questa poesia civile? Non era questo un lirismo fatto da parole semplici che potevano arrivare a tutti? Ancora memorabili i versi di "Lamento per il Sud" in cui descrive un Sud dove si moriva di stenti e nonostante ciò ancora bello e incontaminato, a differenza di un Nord industrializzato e già inquinato. La lirica più celebre di tutte è senza ombra di dubbio "Ed è subito sera" perché in pochissimi versi sono rappresentate sia la solitudine dell'uomo contemporaneo che la brevità della vita e lo scorrere inesorabile del tempo. A mio modesto avviso il poeta cercò sempre di descrivere l'enigmaticità e il non senso di un mondo sfuggente e colmo di brutture: una società di massa desacralizzata ("senza Cristo") in preda alla barbarie. Da ricordare anche che dopo la fine del conflitto mondiale si avvicinò al neorealismo e si mostrò critico nei confronti del boom economico e del consumismo. Con queste poche righe non voglio assolutamente spiegare Quasimodo. Posso solo interpretare i suoi versi e voglio farlo da dilettante senza seguire le regole, i criteri e i metodi dei critici di professione. Comunque per avere più chiara la sua poetica ricordo che fu proprio Quasimodo nel suo saggio "Discorso sulla poesia" a scrivere che "la poesia si trasforma in etica, proprio per la sua resa di bellezza".
giu 172022

Montale nacque nel 1896 a Genova e morì a Milano nel 1981. Nell'adolescenza e nella giovinezza trascorse le estati a Monterosso, dove faceva bagni e gite con Anna degli Uberti, che forse si può identificare con Annetta, la prima presenza femminile della sua poesia.
È proprio a Monterosso (alle Cinque Terre) che si formò come poeta autodidatta e fu proprio questo paese a essere fondamentale nel suo immaginario. La critica ormai ha sistemato Montale assieme a Ungaretti (la poesia pura) e Saba (la poesia onesta). Oppure talvolta ha proposto una nuova triade: Montale, Ungaretti, Quasimodo (caposcuola dell'ermetismo).
A mio modesto avviso, queste collocazioni lasciano il tempo che trovano. Gli stessi critici un tempo proponevano la triade Carducci, Pascoli, D'Annunzio. Comunque Montale non fu mai legato a alcuna scuola o ad alcun ismo letterario. Possiamo solo affermare con certezza che in gioventù i suoi modelli di riferimento furono Foscolo, Leopardi, Manzoni. Gli Ossi di seppia furono pubblicati da Gobetti nel 1925 e dimostrano una grande originalità perché si distanziano dall'opera dannunziana Alcyone.
Lo stesso Montale definì la poesia degli Ossi controeloquente e per nulla aulica. Il premio Nobel non a caso predilige i limoni ai bossi ligustri dei poeti laureati. La poesia degli Ossi permette di dire soltanto "ciò che non siamo, ciò che non vogliamo". Nella sua prima raccolta poetica troviamo come protagonista l'aridità del paesaggio ligure: non troviamo neanche sullo sfondo i grandi eventi storici o le ideologie, anche se Montale firmò in seguito il manifesto degli intellettuali antifascisti e si oppose quindi alle "stalle di Augia". Gli stessi Ossi di seppia, che sono detriti in balia della corrente e che poi restano inermi sulla spiaggia, non simboleggiano altro che la condizione umana. L'agave abbarbicata allo scoglio in fondo non rappresenta altro che l'isolamento del poeta. La natura soffre; lo stesso essere umano soffre e non può far altro che testimoniare la propria sofferenza ("il male di vivere").
La poesia montaliana si contraddistingue per il descrittivismo, la capacità di creare oggetti-emblemi e di mitizzare i luoghi della sua giovinezza. Ma è allo stesso tempo anche una poesia che rappresenta la crisi esistenziale di Montale, le sue disarmonie, il suo disagio, la precarietà della vita, l'inautenticità dell'esistenza: in definitiva il suo rapporto problematico con la realtà. La sua poetica non consiste quindi in una pura nominazione e i suoi componimenti non sono semplici esercizi di stile, nonostante la sua giovane età. Montale inoltre non ha e non offre mai speranze, illusioni e neanche metafisiche consolatorie (i morti per Montale perdurano soltanto nella memoria dei vivi. Non c'è alcun aldilà): "è della razza di chi rimane a terra", anche se è alla ricerca di un varco (alcuni critici hanno considerato per tale ragione il poeta comunque pervaso da un'ansia metafisica). Forse anche per questo è stato accusato di immobilismo esistenziale (è lui stesso Arsenio) nel corso della sua carriera poetica, oltre al fatto che è sempre stato etichettato come il poeta borghese per antonomasia. Per alcuni critici era non credente e borghese: perciò incapace di evolversi e destinato a ripetere le stesse tematiche.
Comunque gli Ossi di seppia forse restano il vertice della poesia montaliana: l'esito più alto.
Non voglio trattare delle innovazioni metriche ed espressive della poesia di Montale. Sono state scritte molte pagine di critica letteraria riguardanti la metafisica montaliana dell’ “anello che non tiene” e del “male di vivere”. Sono stati versati fiumi di inchiostro sul fatto che non ebbe certezza della realtà né dell’esistenza e che non riuscì mai a conciliarsi con sé stesso. Forse per queste ragioni la sua poesia è un’interrogazione delle cose ed è costituita da oggetti che divengono simboli. Ma non è mai puro esercizio di nominazione né vano tentativo di giungere alla soglia del dicibile. Il poeta è teso verso l’essenziale, evita inutili orpelli. Non a caso il poeta degli “Ossi di seppia” nel 1946 aveva sostenuto in “Intervista immaginaria” che la poesia era apporto di conoscenza e non più mera rappresentazione. Questa sua affermazione si può considerare una dichiarazione di intenti a cui seppe rimanere fedele e coerente negli anni successivi. Montale aveva intuito che gli oggetti potevano inviare dei segnali da decifrare e che in essi ci fossero dei significati profondi da cogliere, evitando di cacciarsi in zone inesplorate ai più e di dare forma alla materia informe e indifferenziata dell’inconscio. Ecco allora che Montale cerca la verità nel dettaglio. La cerca nella traccia di lumaca, nello smeriglio di vetro. Non esclude dalla sua indagine nemmeno lo stuzzicadenti e la briciola, perché anche queste “possono dirci qualcosa”. La verità è sotto ai nostri occhi, nelle nostre mani. E’ come una cosa che non riusciamo a trovare, l’abbiamo cercata in tutti gli angoli tranne che nelle nostre mani. Ma allo stesso tempo Montale ci dice che “è inafferrabile e sguscia come un’anguilla”. Esistono però delle persone che sono in grado di aiutarci nella ricerca della verità. E’ il caso di Esterina, che salva dal “delirio di immobilità” Arsenio e tutti coloro che appartengono alla “razza di chi rimane a terra”. Nel lessico poetico di Montale compare in più occasioni il termine “agnizione”, che significa riconoscimento. Grazie ad Esterina il poeta giunge all’agnizione, alla rivelazione esistenziale, all'illuminazione interiore. Tramite quelle che Holderlin definiva “divinità terrestri” Montale giunge alle sue formule poetiche, alle sue celebri sentenze. Queste “divinità terrestri” sono state naturalmente persone in carne ed ossa, ma hanno incontrato un grande poeta che è riuscito a vagheggiarle e trasfigurarle. Forse idealizzandole. Alcune di queste celebri epifanie montaliane furono vissute a Monterosso. Recentemente, naturalmente prima della pandemia, sono stato a visitare le Cinque Terre, che dal 1997 sono diventate patrimonio dell'umanità. Sono rimasto deluso perché i borghi erano sovraffollati. Era pieno di turisti stranieri, che erano in gran parte arrivati con il traghetto da La Spezia. I parcheggi erano tutti a pagamento e nonostante questo non si trovava un posto. I ristoranti erano affollati. I negozi alimentari, i bar, le pizzerie a taglio erano prese d'assalto. Il turismo di massa arricchisce i liguri ma salvaguarda forse il territorio? Un tempo forse era un'ingiustizia che tale natura incontaminata fosse privilegio di pochi (quando non c'erano ancora le autostrade, i traghetti, le ferrovie). Quando ci sono andato era una calca, un caos. Non esiste una via di mezzo? Il consumismo e il turismo mordi e fuggi forse finiranno per deturpare anche le Cinque Terre. Per la tutela di quei borghi dovrebbe essere preferito un turismo di qualità a un turismo di quantità. Il rischio è che i vandali oppure più probabilmente i maleducati rovinino tutto.
giu 162022
Silvio D'Arzo con "Casa d'altri" fonde armoniosamente il minimalismo esistenziale (ovvero la noia, la povertà di stimoli, di relazioni sociali) e il minimalismo narrativo. Secondo molti critici di oggi e secondo molti esponenti della neoavanguardia si può scrivere anche di niente, senza una trama avvincente, addirittura senza una trama. È proprio questo un modo per mettere alla prova e vedere chi è un autentico narratore e chi no. D'Arzo ha superato brillantemente questo esame. Il racconto, definito perfetto da Montale e il più bel racconto italiano del Novecento da diversi critici letterari, si può riassumere tutto con queste parole: "Un'assurda vecchia: un assurdo prete: tutta un'assurda storia da un soldo". È un racconto di poche decine di pagine, scritto con grazia, leggerezza e maestria, che si legge tutto d'un fiato. D'Arzo non ha avuto il tempo, essendo morto di leucemia a soli 32 anni, di scrivere il romanzo della sua generazione come voleva e neppure di veder pubblicata da una importante casa editrice i suoi racconti. Lo scrittore ha creato il suo capolavoro "Casa d'altri" sul finire della sua vita, nei suoi ultimi mesi. D'Arzo era troppo versato nella letteratura inglese e scriveva in modo lineare, mentre la vita è complessa e contraddittoria: questo potranno obiettare coloro che hanno dimenticato il grande narratore emiliano e lo hanno relegato ai margini della letteratura italiana del Novecento. D'Arzo arriva al conquibus, arriva subito al dunque, non complica ulteriormente le cose già complicate di per sé, arriva come si suol dire al nervo delle cose, non si perde in preamboli, digressioni, astrazioni: questo possono affermare con buona ragione i suoi estimatori, infischiandosene dei canoni e della fortuna critica. Pavese, direttore dell'Einaudi, rifiutò di pubblicare "Casa d'altri", ma forse più che per motivi letterari e stilistici per ragioni prettamente esistenziali perché il tema del suicidio era un suo nervo scoperto, qualcosa che gli procurava angoscia, un vero fantasma della sua mente fin da tempi immemorabili ed insospettabili, come si può desumere leggendo il suo diario. Uno scrittore può prediligere la materia inanimata, gli altri o sé stesso. Ci sono incognite e incertezze per ognuna delle tre vie. L'importante è che, indipendentemente dalla sua scelta, si tratti di predilezioni e non di ossessioni, altrimenti uno diventa monotematico. Ma non ci sono solo queste tre dimensioni del reale. Ci sono anche lo spazio, il tempo, gli accadimenti del mondo. Tutte queste dimensioni interagiscono tra di loro. Tutto dipende dall'osservatore, dal sistema di riferimento come in fisica, ma anche dal termine di paragone. La scrittura infatti è sempre paragone, accostamento, nel caso più semplice similitudine. D'Arzo è esemplare nel trattare tutti i piani della realtà e ad intrecciarli in modo poetico ed enigmatico. Ma torniamo al suo capolavoro "Casa d'altri".
C'è chi ha a noia la vita perché ha vissuto troppo o troppo poco. Una vita noiosa è altamente stereotipata, ripetitiva, alienante. C'è la depressione endogena. C'è la depressione reattiva, causata da traumi ed eventi spiacevoli. Nel caso specifico alla donna protagonista del racconto mancano le occasioni, gli eventi, una vita accettabile. Ma c'è anche la noia che assale, la monotonia che non riesce a scalfire. Sembra una montagna insormontabile per Zelinda, vedova e lavandaia. Lo spleen di Baudelaire, l'assurdo di Camus, l'anello che non tiene e il male di vivere di Montale: i riferimenti gnoseologici e culturali possono essere molti per D`Arzo. Il peso di vivere per Zelinda si fa intollerabile. La vita si presenta a lei sempre nello stesso modo: la trafila di giorni sempre uguali, le stesse cose da fare, la solita routine. Ma è anche una vita di stenti, una vita fatta di fatica, "una vita da capra".
Scrive DArzo: "Con due si cerca meglio la verità". Nietzsche scriveva che uno solo ha sempre torto, ma con due inizia la verità. Di certo gli interrogativi incessanti di Zelinda sono un fardello troppo ingombrante e troppo peso per portarli da sola.
Non trova più ragion di essere. È disperata perché ha perso speranza. Ma nel racconto D'Arzo si sofferma più sugli interrogativi angoscianti, sul suo rovello interiore causato da essi, che sul vuoto esistenziale della donna. La domanda cruciale è se può finire prima la sua vita. Il prete non trova parole. Abbiamo due protagonisti: una vedova stanca di vivere, un prete di campagna e sullo sfondo Montelice, un paese in cui non accade mai niente ("sette case addossate..due strade, un cortile che chiamano piazza,uno stagno e un canale e montagna quanta ne vuoi. Che fanno qui a Montelice? vivono e basta e poi muoiono..qui non succede niente di niente…gli uomini al pascolo..le donne a far legna..in strada una vecchia o una capra o nemmeno quello..l’inverno dura mezzo anno. due mesi continui di pioggia, due tre mesi di neve-neve. non succede niente di niente solo che nevica e piove e la gente nelle stalle a guardare la pioggia e la neve come i muli e le capre.."). Da una parte Zelinda, ovvero la credente con il suo dubbio incessante, e dall'altra il prete, con la sua dottrina, ma anche le sue perplessità. È un dialogo tra due fedeli, tra due fedi. Da un lato l'interrogativo della donna, dall'altro il prete, per cui diventa una ossessione, un cruccio, un enigma la vita di Zelinda. Entrambi sono attraversati da esitazioni. Ci si può uccidere? È questa la domanda di Zelinda al prete. Ma è questa la risposta che deve dare la letteratura. Vale la pena vivere? I suicidi sono degli impazienti scriveva Bufalino. Vale la pena pazientare? Secondo la religione cristiana il suicidio è un atto di natura violenta contro sé stessi, è l'omicidio di sé stessi. Tutte le religioni condannano il suicidio. Secondo la moderna psichiatria la stragrande maggioranza dei suicidi sono depressi e la depressione può essere curata con gli psicofarmaci e la psicoterapia. Ma ai tempi di Silvio D'Arzo queste cose non si sapevano. Di solito si cerca sempre di rimandare. Si cerca addirittura di procrastinare l'improcrastinabile. Bisogna non pensare alla morte per vivere pienamente. Bisogna pregare per salvarsi. Ma perché pensare egoisticamente alla propria salvezza individuale? Come scrive Camus a cosa serve la mia salvezza se non si salva l'umanità? Se ognuno ha le sue certamente le sue colpe, ma anche le sue giustificazioni, i suoi alibi e la possibilità di espiare allora forse sarebbe meglio sperare in un Dio talmente misericordioso da lasciare l'inferno vuoto come teorizzato da taluni teologi.
Il suicidio è talvolta questione di un istante. Il suicida per alcuni resta prigioniero di un istante, in cui azzera ogni possibilità, ogni speranza. In questo racconto invece il suicidio sembra invece il frutto di una scelta maturata da tempo e ben ponderata.
La Chiesa ammette eccezioni? Zelinda considera il suo un caso particolare. Non ha più vitalità. Non ha più voglia di vivere. E allora chiede se se ne può andare anzitempo in punta di piedi. Ritiene di aver già mangiato il suo pane, di sapere come sia la vita. Ritiene che non ci sia più niente da conoscere e da vivere. Ha fatto il suo bilancio esistenziale. Ha tirato le sue somme. Dalle cose che le sono capitate, dalle persone che ha incontrato, dalla vita che ha fatto, dalla porzione di mondo e di realtà che ha vissuto, ha tratto le sue conclusioni: non vale più la pena vivere. È una considerazione personale che per lei diventa certezza assoluta. La sorte ormai per lei non ha più niente in serbo. Non ci sarà più nessuna sorpresa. La vita per lei sarà sempre la stessa e lei non ne può più. Zelinda si è scordata che anche la vita più arida, più grama può essere riscattata, può essere un dono. Ma lei si considera una donna di 63 anni che è ormai senza futuro. Che cosa possono fare le parole di fronte a questo dramma? Che cosa può fare la religione incarnata qui da un prete? Ma qui il dramma è doppio. Anche il prete ormai è un sacerdote da sagre di paese. È prossimo alla pensione, al congedo, all'addio, alla morte. Tutto questo si svolge in un piccolo paese, in un piccolo mondo angusto. D'Arzo narra l'inenarrabile, due vite avvolte dall'insensatezza, dall'assurdità di esistere. Il linguaggio è povero di figure retoriche, ma l'intera vicenda è una macrometafora della vita e della morte, che si intrecciano in modo indissolubile.
D'Arzo è implacabile. Crea un congegno perfetto. Scrive in modo essenziale l'essenziale della vita e della morte. Toglie nello stile e nella trama ogni orpello, ogni ridondanza. Leva tutto il superfluo. Rimane per queste poche pagine il mistero che ci irretisce e ci incupisce, la sospensione. Le vite degli uomini sono tutte diverse. La sofferenza, le vicissitudini, la stanchezza di esistere non sono uguali per tutti. Alcuni vengono messi più alla prova dalla vita di altri. Secondo la teologia cristiana il suo disegno è imperscrutabile, sfugge alla logica umana, ma Dio valuta ogni caso in modo equanime, soppesando tutto, qualsiasi cosa. "Ognuno ha una ragione valida per uccidersi", scriveva Pavese. Ma si uccidono solo coloro la cui sofferenza interiore per stati d'animo o eventi nefasti ha sorpassato ogni livello di sopportazione. Se si mette sul piatto della bilancia ci sono svariate ragioni per uccidersi e svariate ragioni per continuare a vivere. Viene considerato razionale continuare a vivere. Ma è pura convenzione. Allo stesso modo viene considerato più coraggioso continuare a vivere che farla finita. Si ritiene a torto o a ragione che quando una persona si uccida o tenti di uccidersi perda il senno della ragione. D'altronde la cultura e la società devono essere biofile. Non si può fare altrimenti. Condannare il gesto estremo è un modo per dissuadere gli indecisi o coloro che si trovano in difficoltà. È un modo per interrompere l'emulazione dell'estremo gesto. Condannare il suicidio è un modo per mandare avanti il mondo, pur ammettendo la pietà cristiana per la vittima. Alla domanda di Zelinda c'è la risposta secca del prete: non sono ammesse eccezioni. Il prete risponde che per la morte propria e altrui non si decide noi, ma decide Dio. Nessuno può anticipare i tempi. Nessuno deve disperare. Zelinda però viene trovata morta. Nessuno sa se l'ha fatta finita. Forse lo scrittore emiliano lascia alla fine alla donna la libertà di autodeterminarsi. Il prete è prossimo a lasciare il paese per tornare a casa. Ma è forse la casa del Padre? Ad ogni modo il prete, che rappresenta la religione, esce sconfitto. Sicuramente la pecorella smarrita non è tornata nell'ovile. Ma probabilmente dall'ovile, dalla ortodossia religiosa si era allontanata solo con i pensieri, con i tarli della sua mente. Sorge spontanea una domanda, leggendo D'Arzo: è giusto che Dio condanni Zelinda, che ha vissuto una vita irreprensibile per una sola cattiva azione e che ha fatto del male solo a sé stessa? Dio non potrebbe fare un'eccezione ai suoi regolamenti o alle sue presunte regole? La risposta di qualsiasi prete probabilmente è che bisogna vivere cristianamente fino alla fine, fino in fondo. Il racconto di D'Arzo tratta di una situazione senza uscita, ma nessuno sa se nella vita alla fine c'è una via di uscita oppure no. Grazie alla fede si può credere all'aldilà e alla salvezza, ma la logica umana, i fatti e la scienza lasciano in sospeso la questione proprio come D`Arzo. La vecchia è morta, le cose vanno come al solito, sta “per venire la morta stagione, gli sterpi secchi, le passere uccise dal freddo, la notte che arriva alle sei, i fossi ghiacciati, i vecchi che se ne muoiono in fila…”. Talvolta la vita sembra un contorno sfumato, una domanda mal posta, un'occasione mancata. Eppure sono tante le sfaccettature della vita. Siamo così presi e immersi dalla quotidianità che ci dimentichiamo che è un dono: forse è questo il vero messaggio dello scrittore.
giu 162022
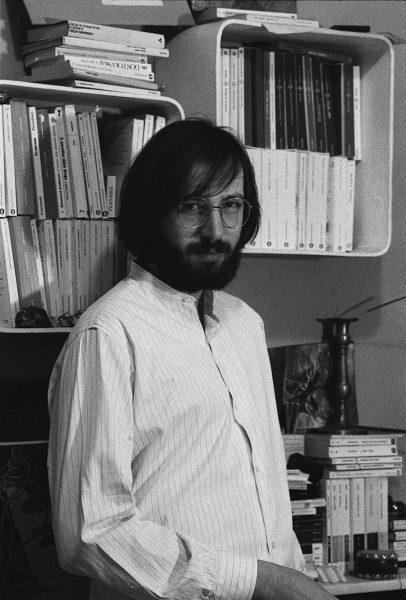
Pier Vittorio Tondelli muore di Aids nel 1991 a soli 36 anni. E’ stato scrittore prolifico e famoso, viaggiatore instancabile e acuto osservatore delle mode e dei costumi degli anni Ottanta. E’ ancora difficile fare un bilancio obiettivo sulla sua opera. Tondelli esordisce nel 1980 con “Altri libertini”, sequestrato per oscenità e poi assolto con formula ampia.
Il processo giudiziario e la straordinaria novità del libro lo portano al successo; vende 200000 copie. Tondelli diventa così, senza volerlo, lo scrittore di una generazione, quella del '77. Con il suo primo libro riesce a dare voce a gay, travestiti, drogati e studenti fuori sede.
Nel suo secondo libro “Pao Pao” invece tratta di una caserma di soldati, delle loro peripezie sotto la naia. Mette in luce sia il cameratismo tra commilitoni che il nonnismo. Infatti Tondelli stesso dichiarò che sotto naia vige “una giustizia tribale e assoluta, tollerata dalle gerarchie che fingono di non vedere, finché non scappa il morto”. In tutta l’opera si nota il contrasto tra l’istituzione (con le sue pratiche burocratiche e le sue norme rigide) e la spontaneità dei ragazzi.
Anche in un altro suo romanzo “Rimini” il punto di vista è collettivo, come nei precedenti. Tondelli vuole mettere in mostra “la carnevalata estiva” della riviera romagnola. Le storie dei ragazzi si intrecciano nella notte. Nonostante il continuo ribaltamento del giorno con la notte, le trasgressioni, il sesso nessuno di loro troverà quel qualcosa di cui è alla ricerca. Nel suo ultimo romanzo “Camere separate” non abbiamo il dinamismo dei precedenti. Si tratta infatti di un libro intimista, in cui prevalgono lo scoramento e la solitudine del trentenne Leo. Il protagonista cerca di rielaborare il lutto del suo compagno Thomas.
Una cosa che contraddistingue Tondelli rispetto a molti altri della sua generazione è il rifiuto di ogni ideologia. Forse è per questo motivo che nonostante il successo editoriale e le opinioni benevole della critica più avanzata non gli è mai stato conferito un premio letterario. “Linea d’ombra” e il Gruppo 63 sottovalutarono sempre il suo talento. Diversi critici hanno esaminato l’opera omnia di Tondelli. Tra questi spicca il gesuita Antonio Spadaro, fondatore di Bomba Carta, che ha notato l’apertura alla trascendenza e una spiccata sensibilità religiosa nella seconda produzione di Tondelli.
Già Bonura aveva intuito questo lato religioso dello scrittore di Correggio. Un dato di fatto incontestabile della religiosità di Tondelli è per esempio l’intervista a Carlo Coccioli. Si può essere d’accordo o meno, ma il lavoro di Antonio Spadaro merita rispetto: ha passato sette anni della sua vita a leggere tutto quello che Tondelli aveva scritto. Ha letto anche tutti i suoi appunti, tutte le sue annotazioni diaristiche, tutti i libri che aveva letto Tondelli. Ha sentito tutti i suoi amici e conoscenti.
Un altro aspetto innovativo di Tondelli è la mancanza di ogni accademismo. Nella maggior parte dei suoi libri adotta il gergo giovanile. Tondelli non è libresco, il suo stile è antiletterario. Ma d’altronde - viene da chiedersi - in base a quali valori si giudica la letterarietà di un testo? In base forse ai canoni estetici, ormai antiquati, che furono ad esempio di Pascoli? Uno dei punti fermi di Tondelli è la narrativa di Silvio D’Arzo, che nella sua breve esistenza scrisse “Casa d’altri” e “L’aria della sera”. Silvio D’Arzo, anch’egli emiliano, negli anni ’20 ha uno stile originale, antinaturalista e minimalista, agli antipodi rispetto al verismo piccolo-borghese tanto in voga all’epoca. Ma ritorniamo al nostro.
A questo aspetto si aggiunga lo stile postmoderno di Tondelli, per cui nelle sue pagine si trovano brani di canzoni rock, citazioni letterarie, esclamazioni dialettali, musica pop, cinema americano, beat generation. Ma non è tutto. Tondelli cerca il ritmo della frase, che deve possedere una sua musicalità. Tondelli è maestro di quella che lui chiama “la letteratura emotiva”. Tramite questo ritmo del linguaggio parlato riesce a catturare il lettore, a fargli leggere tutto d’un fiato la pagina scritta.
La tematica centrale dei libri di Tondelli è la fuga, l’emancipazione dalla provincia asfittica. Lo scrittore scrive che l’unico modo di uscire dalla Peyton Place della provincia è Kerouac. Infatti i protagonisti giovanili dei suoi racconti girano tutta l’Europa: Londra, Berlino, Amsterdam, Barcellona. Ma sono fughe a breve termine, una sorta di “mordi e fuggi” per poi ritornare alla tanto maledetta provincia. D’altronde a queste piccole evasioni c’è solo un’altra alternativa: quella del weekend postmoderno, che in fondo è una pseudo libertà.
Oltre alle opere letterarie abbiamo anche l’attività editoriale di Tondelli. Con il progetto “Under 25” seleziona i racconti della nuova generazione. Sceglie quelli che lui definisce gli scarti che si discostano dalla norma. Tra gli autori di questi racconti prescelti, Silvia Balestra. Una ultima nota infine sul suo "Weekend postmoderno", un libro imprescindibile per chi voglia capire gli anni Ottanta italiani. Questo libro è probabilmente una miscellanea di scritti fondamentali per sapere cosa sono stati quegli anni.
giu 162022

"Forse un mattino andando in un’aria di vetro,
arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo:
il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro
di me, con un terrore di ubriaco.
Poi come su uno schermo, s’accamperanno di gatto
alberi, case, colli per l’inganno consueto.
Ma sarà troppo tardi; ed io me n’andrò zitto
tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.”
Il poeta immagina di camminare al mattino in un’aria cristallina, rarefatta. Tutto a un tratto immagina di volgersi e vedere il nulla. Lo scrittore Italo Calvino, in occasione della celebrazione degli ottanta anni di Montale, ha fornito una spiegazione originale, a tratti alquanto suggestiva di questa poesia. Per Calvino il cardine della lirica è l’espressione “Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me”. Calvino scrive che la mancanza di un occhio dietro la nuca è sempre stato un limite percettivo per l’uomo. Sostiene però che una delle invenzioni più strabilianti della tecnologia moderna sia lo specchietto retrovisore delle automobili perché permette di vedere il campo posteriore, prima di allora invisibile. Eppure nonostante queste argomentazioni scrive che il poeta anche con uno specchietto retrovisore vedrebbe alle sue spalle “una voragine vuota senza limiti”. Calvino cita un animaletto mitologico nella zoologia fantastica di Borges: l’hyde-behind. Nei boschi i taglialegna per quanto possono voltarsi velocemente non potranno mai vedere davvero l’hyde-behind. Secondo Calvino nella poesia il protagonista riuscirebbe a scorgere l’hyde-behind nella sua vera essenza, ovvero il nulla. Per quanto questa analisi sia creativa e suggestiva, ritengo che non corrisponda assolutamente al vero. Secondo l’interpretazione di Calvino il tema principale della lirica sarebbe percettivo-conoscitivo. Intendiamoci: se fosse unicamente un problema percettivo si tratterebbe di una zona morta della percezione, di quella che gli esperti del settore chiamano macchia cieca. Il tema principale di “Forse un mattino andando” secondo Calvino è come possa esistere una porzione di reale inconoscibile o almeno sconosciuta ai propri occhi e infine alla propria coscienza. “L’uomo che si volta” e vede il nulla alle sue spalle, riesce forse a girarsi più rapidamente della messa a fuoco del suo campo visivo, che per questo motivo in quel determinato frangente non è ancora abbastanza nitido ed esteso da fornire immagini dell’ambiente circostante. Percepisce il nulla o meglio “il nulla che c’è”. Quel vuoto sarebbe quindi la risultante di un suo corto circuito mentale, di cui è cosciente, così come è consapevole qualsiasi persona, quando chiude gli occhi abbacinati dal sole, che i fosfeni sono barlumi causati da una reazione chimica delle pupille, quindi da un atto individuale, soggettivo. Secondo l’interpretazione di Calvino l’uomo che si volta non lascia il tempo alle immagini di accamparsi sulla superficie bidimensionale delle retine, oppure il suo voltarsi repentino è più veloce dell’impulso nervoso (ma quando mai?), che trasporta l’input sensoriale tramite il nervo ottico alla corteccia visiva. Comunque sia l’interpretazione di Calvino della poesia porta a concludere che “l’uomo che si volta” ha scoperto un’antinomia della percezione, una fallacia ottica, che arresta in quel momento il desiderio di conoscere e di esperire, infatti si ritrae e si ripiega su sé stesso, nel suo segreto. Tutto questo è basato su un presupposto: ogni uomo nel corso della sua vita servendosi di inferenze visive riesce a creare delle invarianti percettive, e insieme a queste un mondo fenomenologico completo e coerente. La certezza soggettiva della coerenza di questo mondo va in frantumi nella poesia di Montale. Ma Calvino non ne fa solo una questione percettiva, ma anche conoscitiva. Infatti scrive che quel qualcosa che avviene non riguarda il nervo ottico, bensì il cervello umano. Invece io penso che la vera tematica di questo “Osso di seppia” sia esistenziale e metafisica, non percettivo-conoscitiva. A mio avviso “il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me” riveste la stessa connotazione esistenziale di altre espressioni montaliane come “la maglia rotta nella rete” e “l’anello che non tiene”. A mio avviso Montale in questa poesia rifiuta “l’inganno consueto” della molteplicità fenomenica. Rifiuta qualsiasi rappresentazione gnoseologica del mondo. A favore di questa mia presa di posizione cito un’intervista radiofonica di Montale del 1976 in cui dichiarava: “avendo sentito fin dalla nascita una totale disarmonia con la realtà che mi circondava, la materia della mia ispirazione non poteva essere che quella disarmonia…..Ritengo che si tratti di un inadattamento…”. Il critico Contini scrive a proposito della condizione esistenziale di Montale: “la differenza costitutitva fra Montale e i suoi coetanei sta in ciò che questi sono in pace con la realtà, mentre Montale non ha certezza del reale”. Il critico A.Jacomuzzi invece scrive: “mentre nell’ambito e nella tradizione della poesia pura la condizione metafisica è essenzialmente un dato acquisito, una ipotesi non verificata, in Montale essa si atteggia come problema, come un dato da interrogare, un significato da cogliere”. Il senso di questa poesia di Montale per me è la sua disillusione, il suo disincanto nei confronti della realtà fenomenica. Montale non è certo dell’esistenza delle cose, fino a quando non coglie uno slancio vitale nelle sue muse. La sola immanenza non gli è affatto sufficiente. Ecco perché crede ciecamente - come dichiarò in una sua intervista - che “immanenza e trascendenza non sono separabili”. Questo incontro tra immanenza e trascendenza riesce ad esperirlo solo in rari momenti, quando riesce a trasfigurare una figura femminile, a vedere nella donna la personificazione di una cifra sovrasensibile. Ma se questa agnizione da un lato lo gratifica, dall’altro si accorge di non possedere quello slancio vitale della figura femminile e di appartenere alla “razza idiota degli eletti” (“Ti guardiamo noi della razza/ di chi rimane a terra”). In mancanza di questa idealizzazione della donna, di questa epifania fulminea Montale vedrebbe “il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me”. A controprova di questa mia supposizione esiste una poesia di Satura II, intitolata “Gli uomini che si voltano” in cui è scritto:”non apparirai più dal portello/ dall’aliscafo o da fondali d’alghe,/ sommozzatrice di fangose rapide/ per dare un senso al nulla. Scenderai/ sulle scale automatiche dei templi di Mercurio/ tra cadaveri in maschera,/ tu la sola vivente,/ e non ti chiederai se fu inganno”. Nel seguito di questa lirica Montale scrive: “Sono colui/ che ha veduto un istante e tanto basta….”. Montale quindi non cerca in modo categorico la descrizione della complessità del mondo. Non cerca di creare un modello in miniatura dello scibile umano. Non ha mai inteso la letteratura come fonte di Conoscenza razionale. Nel poeta ha sempre prevalso lo scetticismo nei confronti di qualsivoglia raffigurazione della realtà. Da questo punto di vista ha sempre abbandonato ogni minima speranza di certezza e ha sempre navigato nel mare aperto del dubbio. A mio avviso il suo interesse esclusivo è stato quello di trovare il punto d’incontro tra immanenza e trascendenza nella donna. Verrebbe ora da chiedersi: come mai Montale non ha mai idealizzato la Mosca, ovvero sua moglie? Probabilmente perché ricercare in lei l’anello di congiunzione tra umano e divino, avrebbe comportato considerarla una sorta di divinità. Montale scrive sulla Mosca, solo al momento della sua scomparsa. Per dirla alla Klein scrive per rielaborare il lutto. Secondo la Klein infatti ogni artista crea perché avverte il senso d’angoscia di una separazione (reale o fittizia), vissuta come perdita di sé e dell’altra persona. Nel discorso amoroso R.Barthes ci ricorda che “c’è sempre una persona a cui ci si rivolge, anche se questa persona è solo allo stato di fantasma”. Gli Xenia e i Mottetti di Montale possono allora essere considerati una sorta di surrogato dell'”oggetto transizionale” - per usare il termine di Winnicott - perché permettono al poeta di riappropriarsi di una immagine a lui cara, pur vivendo al contempo in modo cosciente e realistico la perdita terrena della mosca. Petrarca e Dante hanno angelicato Laura e Beatrice. I loro amori non corrisposti hanno fatto soffrire loro le pene dell’inferno. Ma nonostante ciò nei brevi componimenti dedicati alla consorte scomparsa non esiste traccia di idealizzazione della donna e neanche di compiacimento del dolore. Le muse di Montale non sono donne irraggiungibili e neanche la propria donna. Le sue muse sono amiche (Arletta, Clizia) e diventano muse solo in determinati e rari istanti. E senza queste muse “intermittenti”, da cui è sentimentalmente distaccato, Montale vedrebbe il nulla alle sue spalle ed il vuoto dietro di sé. Sono queste presenze raramente angelicate, che lo salvano dal nichilismo e dalla negazione del reale.
giu 162022
_0_o.jpg)
Borges è stato il più grande scrittore e poeta argentino del Novecento. La sua cultura è stata enciclopedica. La sua memoria è stata prodigiosa. Forse talvolta Borges ha avuto paura di essere come il suo Funes. Ricordo che per il Funes la memoria sprovvista di filtro e incapace di oblio era diventata "un deposito di rifiuti" e aveva reso il personaggio sovraccarico di letture e di sensazioni al punto da non riuscire più a pensare. Forse questa era una sua ossessione. Di sicuro sappiamo di altre sue ossessioni. Per esempio odiava il calcio perché aveva paura delle folle. Aveva l'ossessione degli specchi perché moltiplicavano l'uomo e la copula. A qualcuno talvolta Borges potrebbe apparire come un reazionario. Ma se è vero che non si impegnò mai in politica, è altrettanto vero che fu cieco per buona parte della sua vita. Infatti perse la vista sia perché affetto da una grave forma di miopia, sia perché leggeva forsennatamente. Va ricordato anche che per Borges il miglior assetto politico e sociale era quello che conciliava il massimo della libertà individuale con un minimo di governo. Non un reazionario quindi, ma un intellettuale disincantato.
I suoi scritti sono colmi di miti, metafore, paradossi. La sua è una letteratura fantastica. D'altronde la letteratura nell'antichità era sempre fantastica: era innanzitutto cosmogonia e mitologia. I maestri di Borges sono stati Dante, Kafka, Pascal, Whitman, Cervantes, Keats, Valery. Borges è stato anche un profondo conoscitore della letteratura orientale, tanto è vero che nei suoi saggi fa più volte riferimento alle "Mille e una notte". È grazie alla vastità delle sue letture che creerà il racconto "La ricerca di Averroè", in cui narra di questo medico arabo che chiuso nell'ambito dell'Islam cerca di tradurre le parole "commedia" e "tragedia" da uno scritto di Aristotele. Lo scrittore argentino in poche pagine mette in evidenza magistralmente i limiti gnoseologici della traduzione perché Averroè lavora vanamente e non conosce minimamente il contesto storico e culturale dell'antica Grecia. Borges non disdegna neanche la filosofia. Infatti da Berkeley prenderà a prestito l'idea di un Dio che sogna il mondo, mentre da Platone riprenderà la concezione del tempo come "immagine mobile dell'eternità". Inoltre nella sua raccolta di saggi "Discussioni" illustrerà in modo illuminante uno dei cardini della filosofia di Nietzsche: l'eterno ritorno. Si veda a questo proposito il tempo circolare. Secondo questo principio l'universo sarebbe composto da quanti d'energia illimitati per la mente umana ma non infiniti. Una volta esauritesi tutte le combinazioni tra i quanti di energia si ripeterebbero gli eventi. Questa idea è alla base dell'arte combinatoria di Borges. Una delle sue tematiche di fondo infatti è che la casistica del mondo è vasta ma limitata. Ecco spiegato perché nei suoi racconti fantastici esistono personaggi che a distanza di secoli commettono le stesse azioni o creano le stesse opere. Da qui deriva la concezione borgesiana secondo cui "nessuno è qualcuno e ciascuno è tutti", espressa nel suo racconto "L'immortale" nell' "Aleph". Partendo quindi dal presupposto che siamo sempre gli stessi e viviamo svariate vite possiamo essere in tempi diversi santi e assassini, scrittori e analfabeti, guerrieri o codardi. Perderemmo quindi la nostra individualità. Perderemmo i meriti e i demeriti della singola esistenza.
La biblioteca, la sfera e il labirinto sono i simboli più importanti dell'opera narrativa di Borges. Per quanto riguarda la produzione poetica i simboli che spiccano sono la rosa e la tigre. In "Finzioni" la biblioteca di Babele è "una sfera il cui centro esatto è qualsiasi esagono e la cui circonferenza è inaccessibile". I bibliotecari che vivono tutta la vita in un angolo della biblioteca sono alla perenne ricerca del "libro totale", ovvero dell'opera che può racchiudere il significato ultimo. Borges ci dice che i bibliotecari alla fine si scoraggiano perché nessuno riesce a trovarlo. Trovare quel libro significherebbe carpire il segreto dell'esistenza. Ma lo scrittore ci fa sapere che probabilmente la razza umana si estinguerà e la biblioteca sopravviverà ai suoi lettori. La biblioteca è quindi il simbolo della conoscenza universale. Veniamo invece alla sfera, ovvero all'Aleph. Questo ultimo è "il luogo dove si trovano, senza confondersi, tutti i luoghi della terra, visti da tutti gli angoli". La sfera quindi è per Borges il luogo che permette all'uomo di travalicare gli angusti limiti della propria percezione visiva e della propria corporeità. Se la biblioteca è simbolo della conoscenza, invece la sfera è simbolo dell'esperienza, a mio modesto avviso. Per Borges il libro è sempre stato un labirinto di simboli: un'opera aperta in cui il lettore può scegliere tra diverse alternative. Se il labirinto però sembra descrivere il groviglio inestricabile dell'esistenza umana dobbiamo riferire che è per Borges un simbolo di vita e non di morte. Infatti nell' "Aleph", più esattamente nel racconto "I due re e i due labirinti", due sovrani si sfidano tra loro. Il primo rinchiude il secondo nel labirinto, ma quest'ultimo riesce a uscirvi. Il re fuggito dal labirinto invece fa prigioniero l'altro e lo mette nel deserto in cui morirà di fame. Borges in definitiva ci insegna che l'uomo senza l'attività simbolica sarebbe niente. In fondo per gli antropologi l'uomo è giunto alla civiltà quando è iniziato il culto dei morti: riti e pratiche che senza capacità simboliche non sarebbero esistite. Borges ci ricorda anche che la vita umana è una vita in profondità. Io suggerisco di leggerlo perché in particolare "Finzioni" e "Aleph" smuovono la mente e stimolano la creatività. Borges ha questo grande pregio: fa scattare sempre le molle dell'immaginazione, partendo sempre da presupposti logici e razionali.
giu 152022
_0_o.jpg)
(Nella foto Salinger)
Cosa ci vuole per essere uno scrittore o un poeta? Quali sono i requisiti indispensabili? È difficile dirlo. Visto che non ci sono due scrittori uguali a questo mondo è quasi impossibile fare una ricetta con tutti gli ingredienti. Uno scrittore deve avere una discreta conoscenza della lingua, essere un minimo acculturato, sapersi districare tra i concetti. Uno scrittore deve essere intelligente? Secondo le più recenti scoperte psicologiche il quoziente di intelligenza non è più considerato un tratto stabile della personalità di un soggetto. Può variare in base all'ambiente, agli stimoli culturali ricevuti, può essere abbassato provvisoriamente da periodi di depressione. Inoltre ci sono problemi epistemologici riguardo al Q.I.
I test sono una misura indiretta soggettiva, ovvero risentono della definizione operativa che gli ideatori del test danno (la distinzione tra misura diretta e misura indiretta è la prima cosa che si trova nei libri di fisica. Riguarda proprio il primo capitolo di molti manuali). I test sono una misura grossolana del pensiero convergente, ovvero misurano in modo approssimativo la logica deduttiva comune. Sono fallibili e perfettibili. Ma esiste anche il pensiero divergente un poco più correlato alla creatività. Inoltre i test di intelligenza non sono "culture free", come gli psicologi vorrebbero far credere. Dipendono anche dalla cultura degli ideatori. Non si può quindi valutare l'intelligenza di un soggetto a prescindere dalla sua cultura. Infine ogni concezione di intelligenza è relativa all'appartenenza di una certa cultura, di una certa società. Poi ci sono persone creative, autistiche o altro che hanno un'intelligenza particolare, che non si presta a essere misurata con i test. È quindi importante il Q.I per uno scrittore? Salinger aveva solo un Q.I di 104 punti (solo 4 punti superiore alla media, ovvero nella media). Lucio Dalla che era un geniale cantautore da piccolo era risultato un ritardato mentale secondo i test di intelligenza. È importante allora come si utilizza il proprio Q.I? Senz'altro, ma il Q.I non appartiene a una scienza esatta. Importante è valutare le opere di uno scrittore, di un poeta. Bisogna quindi valutare unicamente Salinger per i "Nove racconti" e per "Il giovane Holden". Bisogna valutare la bravura di Lucio Dalla per le sue canzoni. Tutto il resto è pettegolezzo, ignoranza, disinformazione. Per alcuni bisognerebbe sfruttare non solo la propria intelligenza ma anche quella degli amici o degli altri letterati. In questo caso il dialogo, il confronto sarebbe utile. Per Aldo Busi bisognerebbe sfruttare anche la stupidità propria e dei conoscenti. A ogni modo la scrittura è ritenuta da alcuni una intelligenza, nel senso di una particolare forma di intelligenza. Se il Q.I (condizione limitata dell'intelligenza umana) è poligenico, cioè dipende grossomodo da poco più di un migliaio di geni, il talento artistico è ancora più complesso, per nulla misurabile, in parte sfuggente. Concludendo un poeta o uno scrittore non necessariamente devono essere persone straordinarie, avere chissà quale capacità incredibili. Basta che non siano persone dalle potenzialità quasi totalmente inespresse. Basta che usino un poco il loro intelletto. Non c'è bisogno di essere veggenti, come volevano certi poeti maledetti. Non c'è neanche bisogno di saper parlare 50 lingue, come faceva Rimbaud. Un altro piccolo appunto: un conto è essere persone "medie" (anche se essere medi è un'astrazione generica e poco attendibile) e un altro è l'artista che ha una scrittura basata tutta sulla medietà, ovvero su un linguaggio semplice e comprensibile. Ci vuole anche talento e sforzo per essere chiari. Ma come scriveva in una sua poesia Luciano Erba, tanto per ironizzare un poco:
In medio stat vitium
"Sei di quelli che ai test
danno segni contraddittori
ma di certo
né genio né idiota
e allora?
Un pover'uomo
perseguitato dai geni e dagli idioti."
Cosa ci vuole per diventare uno scrittore allora? Il famigerato pezzo di carta? Può aiutare, ma anche questo non è indispensabile. Montale, Quasimodo, Deledda, Dario Fo, etc etc erano autodidatti. È vero che un laureato in lettere o un dottore di ricerca in italianistica hanno delle conoscenze più organiche. Ma la scuola italiana è pur sempre umanistica e la fruizione della cultura oggi ha raggiunto livelli insperati rispetto a qualche decennio fa.
Ci vuole un poco di sana pazzia allora? Può aiutare, ma non è anch'essa indispensabile. A onor del vero c'è una correlazione significativa tra depressione, ciclotimia, disturbo bipolare e creatività artistica. Ma non tutti gli artisti soffrono di disturbi di umore. Disturbi mentali più gravi invece toglierebbero alla creatività, porterebbero all'inattività in quei periodi di scarsa lucidità, soffocherebbero per quei periodi di crisi la creatività sul nascere. Comunque se la scrittura può essere una buona autoanalisi non deve sostituire psicofarmaci e sedute psicoterapiche in caso di bisogno. È molto difficile superare un trauma con la sola scrittura. Quasi impossibile. Non ci si può affidare unicamente alla propria scrittura, a sé stessi. Significa chiedere troppo a sé stessi.
Ci vogliono dei maestri allora? Senza una piccola dose di talento in partenza nessuno fa niente. Il talento però deve essere anche coltivato soprattutto con letture e talvolta con frequentazioni. Talvolta ci possono però non solo momenti di crescita ma anche motivi di attrito, dispersione di energie, manifestazione di idiosincrasie, etc etc. Gli incontri possono rivelarsi improduttivi o controproducenti. È vero che un maestro può aiutare nella carriera letteraria e che da ogni incontro di persona si possono ricevere degli input culturali. Ma leggere assiduamente può essere più formativo.
Ci vogliono le frequentazioni con altri letterati o aspiranti artisti? Può darsi. A patto che non siano conoscenze nocive o dispersive. Fare cricca può servire a fare carriera letteraria. Ma ciò non è richiesto per crescere umanamente, spiritualmente e per avere una maggiore consapevolezza esistenziale.
Ci vuole la partecipazione di scuole di scrittura? Se si hanno soldi da spendere possono servire, possono aiutare a migliorare. Ma bisogna avere capacità di discernimento e sapere valutare le scuole farlocche e quelle serie. Saper distinguere il buono dal cattivo non è affatto scontato. A ogni modo nemmeno le peggiori scuole di scrittura rovinano il carattere delle persone. Qualche insegnamento utile si può sempre trarre.
Ci vuole una grande oratoria, una bella parlantina per essere scrittore? Può aiutare molto perché tutti o quasi valutano le persone in base alla sottocultura televisiva, in cui conta molto parlare velocemente anche senza dire niente di interessante. Ma per scrivere bene un autore deve soltanto scrivere bene. Sembrerà tautologico, ma è così senza ombra di dubbio. Calvino e De André non erano grandi oratori. E che cosa importa in fin dei conti? Non guardiamo in base alle apparenze, alle prime impressioni. Uno scrittore deve fare lo scrittore e non l'avvocato penalista. Ancora una volta cerchiamo di giudicare in base alle opere.
Uno scrittore deve aver letto migliaia di libri? In un certo qual modo non può essere naif. Anche se non è un grande intellettuale, un buon livello di acculturazione e di intellettualità deve averlo. Deve sapere un minimo le regole del gioco, i canoni, la storia della letteratura, la conoscenza della tradizione almeno a grandi linee.
Uno scrittore o un poeta deve forse aderire a un ismo, a una corrente artistica? Fondamentale è che abbia una visione del mondo e di conseguenza una poetica, da cui scaturisca uno stile.
Cosa ci vuole per essere scrittore o poeta? Per usare una formula stantia però sempre valida: tradizione+innovazione. Non bisogna essere epigoni, manieristi. Ma nemmeno bisogna ricercare a tutti i costi l'originalità, finendo solamente nell'eccentricità.
Di cosa ha bisogno uno scrittore o un poeta? Di conoscere un poco sé stesso, gli altri, il mondo. Ha bisogno di trovare delle idee. Bisogna che stia in ascolto di sé stesso, degli altri, del mondo. Deve saper cogliere i segnali che le cose della vita e del mondo gli inviano, deve saperle recepire.
Di cosa ha bisogno uno scrittore? Per dirla alla Montale delle "occasioni". Ci sono luoghi, persone, situazioni e istanti che ispirano la scrittura. Ci sono vite più interessanti e più ricche di occasioni, di opportunità poetiche e altre meno. Ma c'è bisogno allora di una vita inimitabile dannunziana? Può essere molto rischioso e portare all'autodistruzione. È vero che prima bisogna vivere, quindi filosofare e scrivere. Ma bisogna anche dimostrare un minimo di accortezza nella vita di tutti i giorni. In pratica la sregolatezza dei sensi porta di sicuro all'imbruttimento spirituale oltre che a un possibile arricchimento esperienziale. Meglio sapersi controllare, darsi delle regole. Cosa deve cercare un poeta o uno scrittore? Rimbaud cercò per tutta la sua vita sia una formula appropriata per l'esistenza che un luogo idoneo per vivere. Andiamo oltre. Come scrive in un suo post su Facebook il poeta Luca Alvino ogni scrittore o poeta è come un commerciante, che ogni giorno deve andare in negozio a vedere se vende qualcosa. Anche Moravia sosteneva che non bisognasse aspettare l'ispirazione, ma che ogni giorno bisognasse obbligarsi a scrivere per qualche ora. Bisogna costringersi, vincere il terrore della pagina bianca.
Di cosa ha bisogno un poeta o uno scrittore? Di essere riconosciuto come tale dalla critica o almeno dalla comunità letteraria. Il talento però, come ho scritto più volte, non sempre è riconosciuto e riconoscibile. Ma si può anche scrivere senza che il mondo si accorga di noi. Pessoa, Pascal, Tomasi di Lampedusa, Guido Morselli non pubblicarono i loro capolavori in vita. Socrate non lasciò niente di scritto. Non è necessario pubblicare a ogni costo secondo una scuola di pensiero. Secondo un'altra scuola c'è il diritto/dovere di un autore di farsi conoscere. È chiaro che ci vorrebbe un pubblico, ma siamo in Italia: pochi leggono e per i miracoli nessuno è ancora attrezzato. Come scrive magistralmente Massimiliano Parente: "Cogito ergo sum, ergo scrivo, ergo mi autopubblico, ergo mi autoleggo e chi s'è visto s'è visto. Stringi stringi: che bisogno c'è dell'editore? Mi pubblico io. Che bisogno c'è del lettore? Mi leggo io".
Di cosa ha bisogno uno scrittore o un poeta? Della libertà interiore, sociale, politica, umana per scrivere. Per scrivere liberamente bisogna vivere in una democrazia e non tutti in questo mondo vivono in una democrazia. Non scordiamocelo mai quando ci lamentiamo delle nostre difficoltà, vere o presunte.
giu 152022

Questo libro raccoglie i Quaderni in cui il grande critico letterario Debenedetti stendeva le sue lezioni universitarie. La presentazione è di Eugenio Montale. Alla fine del libro si possono trovare le note, in cui sono elencati tutti i riferimenti bibliografici, e il repertorio di autori, opere, personaggi e periodici citati. Debenedetti si interroga sul concetto di contemporaneità. Analizza le epifanie di Joyce, le intermittenze del cuore e la memoria involontaria di Proust, il fu Mattia Pascal di Pirandello. Compara e accosta Italo Svevo a Joyce e Proust, Moravia a Pasternak. Ricorda il lavoro del critico Renato Serra. Studia le opere di Tozzi. Questi Quaderni sono un’ulteriore conferma del rigore e delle capacità analitiche di Debenedetti, che seppe per primo comprendere l’influenza delle scienze umane (la psicologia del profondo e la sociologia) e della microfisica nella letteratura moderna. Debenedetti è un profondo conoscitore della psicanalisi di Freud, della psicologia analitica di Jung e della fisica delle particelle. Tuttavia non c’è traccia di scientismo nel suo lavoro. Non gli interessa la ricerca totale dell’oggettività, che anni dopo sarà propria della critica strutturalista e della semiologia, che cercheranno di condannare all’oblio l’intuizionismo crociano. Debenedetti è consapevole che le intermittenze del cuore, le epifanie, l’assurdo, l’informe, il grottesco dei personaggi in sciopero degli antiromanzi non devono essere compresi tramite l’analisi delle ideologie e delle sovrastrutture. Bisogna comprendere soprattutto le infrastrutture della psiche. Lo studio della letteratura moderna non necessita di una logica positivista: Debenedetti ci avverte che la scienza moderna è entrata nella letteratura, ma non per questo egli utilizza la metodologia e l’epistemologia delle scienza per comprendere la letteratura moderna. Il grande critico ci avverte che nel panorama letterario, dopo la crisi irreversibile del naturalismo, all’improvviso è presente un ospite invisibile, un’entità del sottosuolo: l’inconscio. Epifanie, intermittenze del cuore, illuminazioni interiori, piccole rivelazioni, conflitti interiori, dissolvenze non si possono spiegare adoprando i sillogismi. La nevrosi non si può comprendere con l’ausilio della logica deduttiva, che cercherà sempre di occultare e rimuovere l’ineffabile. Debenedetti ci insegna che i comportamenti dei personaggi dei nuovi romanzi non sono la risultante dell’ideologia. Sono sintomi di un malessere che si è impadronito dell’uomo contemporaneo. Debenedetti per fare una disamina di tutto ciò si serve di un approccio interdisciplinare: non ha un metodo definito, ma allo stesso tempo ha molti metodi. Nella letteratura compare il personaggio-uomo perché la teoria dei quanta e il principio di indeterminazione spazzano via il meccanicismo e i rapporti di causa-effetto. Irrompe sulla scena un nuovo concetto: la probabilità. Ecco allora che qualsiasi azione, qualsiasi comportamento, qualsiasi evento è in sé aleatorio. Non può più esistere nessuna trama, nessuna narrazione come nei secoli scorsi. L’uomo è un essere indeterminato. Si sa ciò che è più probabile e ciò che è improbabile. Ma anche l’improbabile può avverarsi e il probabile non accadere. E se l’uomo è fatto di atomi…. allora perché la sua vita e il suo nucleo non possono essere governati dalle stesse leggi della microfisica? I conflitti sociali ed economici, gli stessi eventi storici apparentemente sembrano scaturiti dal “sovrumano”. Ma se dietro il “sovrumano” si celasse “l’infraumano”? La cultura e le stesse istituzioni sono forse preda dell’infra? L’illusione antropocentrica si dissolve in un istante, indipendentemente dal fatto che la microfisica sia il motivo profondo di una nuova dimensione antropologica dell’uomo oppure l’elemento per un parallelismo efficacissimo. Il discorso di Debenedetti, che sembrava essere solo letterario, ci porta a interrogarci anche sulle dinamiche sociali ed economiche dell’epoca moderna. D’altronde Debedenedetti per comprendere una realtà così frammentaria e irrazionale come quella del Novecento non poteva certo servirsi dell’idealismo crociano né delle filosofie irrazionali. Il grande critico ebbe il merito di capire che anche l’irrazionalità di quella realtà aveva una sua logica. La letteratura del’900 ha come protagonista l’inetto. Ma il romanzo non esiste più. I critici letterari lo chiameranno antiromanzo: un’opera d’arte così innovativa da trascendere sia la logica del mercato editoriale che quella del classico. Gli studiosi scriveranno che i romanzieri vanno a caccia di epifanie delle epifanie, di “infra della psiche”. Scopriranno che le intermittenze del cuore di Proust si fermano molto più in superficie delle rivelazioni microscopiche di Joyce, Musil, Svevo e Pirandello. Mai gli scrittori hanno scandagliato così a fondo nell’animo umano. Mai come ne l’900 hanno scavato così in profondità. Giacomo Debenedetti illuminerà tutti con il suo saggio sul personaggio-uomo, in cui riuscirà a conciliare Freud e principio di indeterminazione, inconscio e microfisica.
L’io nelle pagine memorabili della letteratura del’900 non si ripiega su se stesso, ma addirittura si frantuma. Le categorie d’analisi e la logica ordinaria scompaiono, si eclissano. E’ il congedo del “penso, dunque sono”. Scompare il soggetto, ma non la soggettività. Quel che resta comunque è il vuoto al centro e mille schegge di interiorità nelle immediate vicinanze, che tramite sensazioni e percezioni distorte e pensieri di pensieri sconnessi rivelano non più il volto dell’uomo, ma un uomo contemporaneo ormai senza più volto. La tesi di Ortega y Gasset, esposta nel suo saggio “La disumanizzazione dell’arte” trova più di una conferma. La nuova letteratura è impopolare, la grande massa è distante dalle opere letterarie, non le ama perché queste fanno una radiografia dell’uomo moderno. Molti romanzi moderni si presentano spesso al primo colpo d’occhio e alla prima lettura superficiale come una semplice finzione, come la pura e semplice rappresentazione di un gioco. In realtà svelano il malessere dell’uomo contemporaneo. Quel che poteva sembrare inverosimile e grottesco in ultima analisi non è altro che la nuda e cruda verità umana. E il lettore si trova disarmato di fronte ad una descrizione così puntigliosa ed esatta delle sue conversazioni e di ciò che pensa tra sé e sé, in definitiva di se stesso.
P.s: secondo il principio di indeterminazione non si può sapere contemporaneamente la velocità di un elettrone e la sua posizione. Secondo questo principio inoltre ogni volta che osserviamo qualcosa in modo infinitesimale modifichiamo la "scena".
giu 152022

Ha perfettamente ragione Milan Kundera, quando scrive nel suo saggio "L'arte del romanzo", che il romanzo è soprattutto complessità. Questa opera è impegnativa per la molteplicità di temi filosofici, politici, morali, scientifici, religiosi trattati. Il lettore si trova di fronte a molti spunti di riflessione. L'autore infatti ha adoprato tutta la sua cultura per descrivere tutte le correnti di pensiero dell'epoca. Mann nella lezione per gli studenti dell'Università di Princeton dichiarò che questo è un romanzo del tempo in due sensi: "Anzitutto sul piano storico, in quanto cerca di delineare l'interiore immagine di un'epoca, quella dell'anteguerra europeo; in secondo luogo, però, perché suo argomento è il tempo puro, e questo oggetto è trattato non solo come esperienza del protagonista, ma anche in e per se stesso". Riguardo al primo punto Zecchi nel saggio "L'artista armato contro i crimini della modernità" sottolinea che la posizione assunta da Settembrini, ovvero che il nichilismo potesse essere contrastato con le scienze esatte in sinergia con le scienze dello spirito, sia stata una idea diffusa agli inizi del Novecento. Poi giunse Husserl a spiegare che il progresso scientifico aveva allontanato l'uomo dal "mondo della vita", facendogli perdere la visione globale del mondo e facendogli dimenticare l'interiorità. Per quel che riguarda l'argomento del tempo puro, ricordo che il protagonista mediterà più volte su di esso, chiedendosi quale sia l'organo specifico del cervello che che ci fa intuire lo scorrere degli istanti. Comunque iniziamo con la trama del romanzo che è semplice. Nel libro i protagonisti sono statici. Il romanzo fu ispirato da un fatto realmente accaduto a Mann. Egli stesso visse per tre settimane in un sanatorio, dove sua moglie fu curata per sei mesi. Anche Castorp, il protagonista, deve trascorrerci inizialmente solo tre settimane per far visita a suo cugino che soffre di tisi. Ma il giovane ingegnere Castorp per delle complicazioni alle vie polmonari finirà per trascorrere ben sette anni nel sanatorio svizzero. In quel periodo si innamorerà di una ragazza russa a cui si dichiarerà e che gli concederà un bacio sulle labbra. Qui avrà modo anche di conoscere il letterato Settembrini e il gesuita Naphta. Settembrini è carducciano, massone, volterriano. Naphta è un nichilista, un conservatore. Il primo è un razionalista. Il secondo invece è un irrazionalista. Castorp ascolta sempre le loro discussioni colte ed oscilla continuamente tra i due poli di questi suoi precettori. Oscilla tra l'evasione dell'arte e lo spirito religioso, tra l'impegno pratico e il riconoscimento della decadenza dei valori, tra rivoluzione e conservazione. Comprendere queste due posizioni non è facile perché contengono delle contraddizioni interne e delle antinomie. Le argomentazioni sono complesse e rappresentano tutte le scuole di pensiero dell'epoca. Ma questi due personaggi sono complessi anche perché sono incoerenti. Settembrini dichiara che a volte bisogna utilizzare la violenza, eppure quando si trova a duellare con Naphta non mira all'avversario ma spara in aria. Quest'ultimo decanta il misticismo cristiano e ciò nonostante soccombe alle proprie tare esistenziali e si suicida. Altro aspetto rilevante del libro è che tutti i personaggi sono borghesi e Mann riesce a fare un'analisi spietata della borghesia della sua epoca. Come ebbe modo di scrivere Lukacs nella prefazione alle novelle, lo scrittore fu testimone e giudice della decadenza borghese. Nel saggio "Mann e la tragedia dell'arte moderna" Lukacs scrive che Mann è uno dei grandi esponenti del realismo critico e che riesce a svelare tutte le problematiche della società borghese, rappresentando l'apice del pensiero progressista di questa. Altro aspetto importante del romanzo è il rapporto stretto tra voglia di conoscere e malattia. Se da un lato la malattia è disumana perché umilia l'uomo, dall'altro lato è occasione per Castorp per approfondire determinati argomenti che nella civiltà frenetica della pianura non avrebbe mai minimamente trattato. La sofferenza quindi aiuta ad aumentare la consapevolezza. La malattia è fonte di umanità, di conoscenza e di saggezza. Inoltre con il cristianesimo comunista di Naphta, Mann è riuscito ad intuire una delle possibilità della politica del Novecento. L'unione del cristianesimo con il marxismo in Italia fu pensata da molti, anche dallo stesso Pasolini. In America Latina fu anche applicata da preti rivoluzionari come Ernesto Cardenal, ministro della cultura del governo sandinista. Mann non era marxista, ma grazie al suo acume aveva intuito cosa sarebbe potuto accadere. A onor del vero va detto comunque che più che l'unione tra cristianesimo e marxismo si verificò almeno in Italia quella tra cattolicesimo e comunismo. Da notare infine che anche il romanzo "Diceria dell'untore" di Bufalino tratta di un sanatorio per malati di tisi, anche se è ambientato nel dopoguerra, il protagonista è un reduce, non ci sono conversazioni così impegnate e in primo piano c'è una storia di amore che finirà con la morte della donna. "La montagna incantata" è quindi completamente diverso dal libro di Bufalino. È innanzitutto un complesso romanzo di formazione, che riesce a essere sia pedagogico che ironico. Bisogna ricordare anche che a Mann ci vollero dodici anni per completare questo capolavoro: niente a che vedere con certi scrittori di oggi, che pubblicano un libro commerciale all'anno. In conclusione molti libri sono da leggere. Questo romanzo per i suddetti motivi è anche da rileggere.
giu 152022
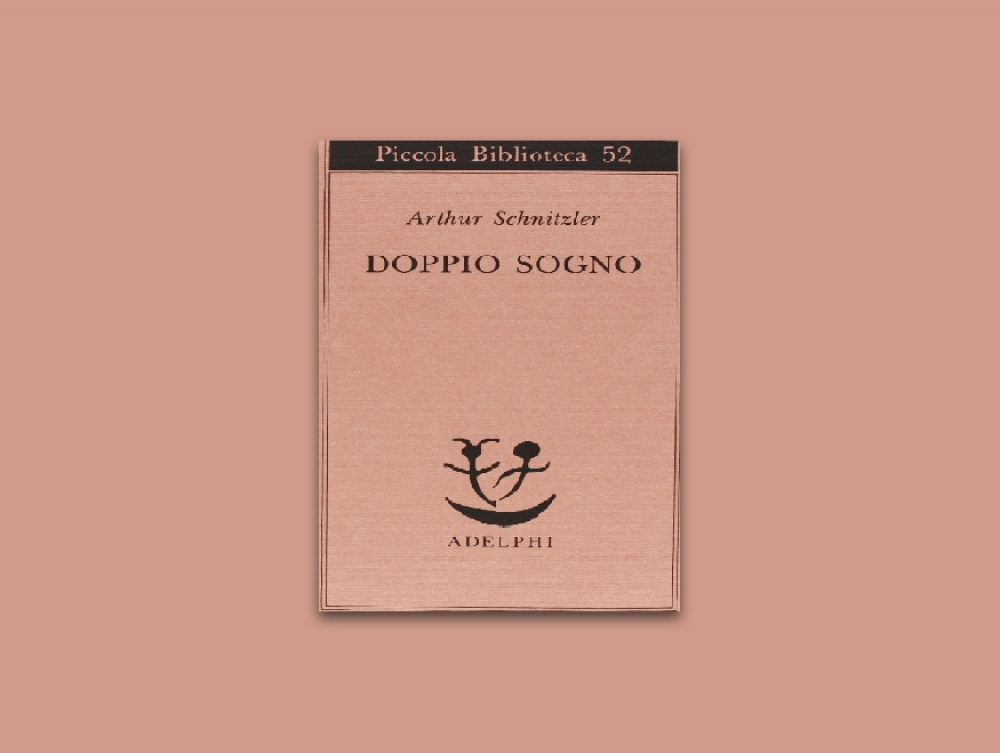
Questo piccolo capolavoro narra del rapporto complesso tra un medico e sua moglie. Sono una coppia giovane e felice, però lui rimarrà turbato, dopo che si raccontano l’un l’altra fantasie e segreti, che prima di allora avevano tenuto per sé. All’inizio viene descritta una scena, simbolo di un'atmosfera borghese e rassicurante: la loro figlia piccola, a cui viene letta una fiaba dai genitori, viene poi messa a letto dalla governante. Ma il giovane medico Fridolin deve uscire quella sera per recarsi da un paziente, che versa in gravi condizioni. Una volta giunto a destinazione trova l’uomo già morto e viene sedotto dalla figlia del defunto davanti alla salma. Dovrebbe tornare a casa, ma finisce per vagare tutta la notte. Si fa sedurre da una passeggiatrice, che lo porta nella sua casa, ma con cui non conclude niente. Entra in un caffè notturno e qui incontra un suo vecchio compagno di università, che ora fa il pianista. Quest’ultimo gli racconta che quella stessa notte dovrà suonare a una festa da ballo con gli occhi bendati, anzi riesce a guardare “nello specchio attraverso il fazzoletto di seta nera che copre gli occhi”. Non conosce i partecipanti della festa mascherata, né il proprietario. Fridolin rimane affascinato dalla strana storia ed esprime il desiderio di voler entrare nella villa dei misteri. Il pianista gli risponde che deve procurarsi un saio scuro e una mascherina nera. Il medico allora si reca dal mascheraio, dove ha modo di imbattersi nella piccola Pierette, forse una pazza, che viene sorpresa con due signori nel negozio.
Fridolin riesce ad entrare nella villa, ma viene smascherato. Sapeva la parola d’ingresso, ma non la parola d’ordine della casa. L’attende una punizione estremamente severa, forse dovrà pagare con la vita stessa, ma una donna lo riscatta e si dichiara di tutti. Successivamente scopre che la donna, che si è sacrificata per lui, ha pagato con la vita. Nonostante il medico viva queste esperienze al limite da solo, va detto che nelle donne, che incontra, ricerca sempre ossessivamente la moglie.
Questo romanzo breve è stato reso famoso dalla trasposizione cinematografica di Kubrick dal titolo “Eyes wide shut”. Il film però non è totalmente fedele al libro. Kubrick infatti ambienta la vicenda nella New York dei nostri giorni, mentre invece nell’opera originale ci imbattiamo nella Vienna di fine secolo. L’alta società di Vienna in quel periodo si dedicava all’edonismo sfrenato con frequenti feste di ballo forse perché non voleva affrontare direttamente i grandi cambiamenti culturali, sociali e politici di quell’epoca di transizione. Schnitzler prende spunto da questo atteggiamento mentale, assai diffuso al tempo, per indagare sulla natura umana e sui meandri della psiche, riuscendo ad esplorare zone d’ombra che nessun altro scrittore era mai riuscito a cogliere pienamente.
L’interrogativo di fondo è se sia opportuno dirsi tutto tra coniugi, rivelarsi anche le fantasie più inconfessabili o se sia meglio far prevalere il non detto. La scelta cruciale è tra l’incomunicabilità all’interno della coppia e quella che lo psicologo Bergler definiva “la delusione rispetto all’ideale dell’io”. Quest’ultima espressione significa che una persona può subire una ferita nell’animo, constatando lo scarto significativo tra l’idealizzazione del partner e l’effettivo modo di essere della persona amata. Come se non bastasse la rivelazione di fantasie sessuali può far scaturire la gelosia da parte di entrambi. Nell’opera di Schnitzler il protagonista Fridolin, dopo aver ascoltato le fantasie e i sogni della compagna, subisce uno smacco notevole, sia perché capisce la complessità delle dinamiche del desiderio femminile, sia perché implicitamente ritiene scontato un monopolio sessuale nei confronti della moglie, ritiene di avere un diritto di proprietà su di essa. Lo stesso sentimento di gelosia che prova è difficile da decifrare: è un impasto, una commistione tra desiderio di possesso esclusivo e angoscia per una possibile separazione dal proprio oggetto di amore. Ma quando una coppia inizia un percorso di conoscenza e di autoanalisi così intimo il rischio è che uno dei due scambi le fantasie dell'altra metà per tradimenti effettivamente avvenuti e mascherati sotto forma di desideri mai messi in pratica. Schnitzler è geniale ad evidenziare le contraddizioni insanabili all'interno della coppia.
Questa opera di Schnitzler potrebbe essere interpretata secondo certi criteri freudiani. Ma è altrettanto vero che Schnitzler non fu mai debitore di Freud. Entrambi giunsero alle solite conclusioni, però tramite mezzi diversi: Freud con l’analisi, l’artista con “l’autopercezione”.
Freud nei “Tre saggi sulla teoria sessuale” sostiene che “l’occhio è come il corrispondente di una zona erogena”. Il piacere di guardare non è altro che una pulsione parziale secondo Freud, che può avere come antagonista solo la vergogna ed il pudore. Il protagonista di "Doppio sogno" è preso dal piacere di guardare tutte le donne nude alla festa mascherata, però questo voyeurismo sconfina e si sublima nell’epistemofilia (nel desiderio di conoscere e di indagare la realtà). Il medico Fridolin infatti vuole conoscere le fantasie erotiche della moglie e vuole sapere chi sono le persone che hanno partecipato alla festa. Non a caso l’ultima parte del libro tratta proprio dell’investigazione privata del medico per smascherare i responsabili di quell’orgia.
Da notare inoltre il conflitto intrapsichico del protagonista maschile tra erotismo e pulsione di morte: da una parte questa forza primaria che dovrebbe unire e legare e dall’altra una tempesta che dissolve le relazioni e distrugge i legami.
Infine un’ultima considerazione: Schnitzler con questo libro sembra volerci dire che fare un’analisi dei desideri all’interno di una coppia non è detto che sia un requisito indispensabile per due sposi, anzi talvolta può rivelarsi controproducente ed inquietante.
Lo stesso Adler, fondatore della Società di psicologia individuale, riteneva che la cooperazione fosse un presupposto fondamentale per il benessere della coppia piuttosto che il soddisfacimento della pulsione sessuale o lo scandagliare i desideri repressi dell'altra metà. Ognuno dei due partner, secondo lo psicologo, deve sentirsi parte di un tutto, deve imparare a fare le cose in due, nonostante che la società educhi al lavoro individuale e raramente al lavoro di gruppo, ma mai al lavoro di coppia. I matrimoni infelici nascono quando uno dei due vuole sempre ricevere qualcosa, senza dare niente in cambio. Per Adler quindi il matrimonio è un compito comune. Emblematica a questo riguardo la singolare tradizione in una regione della Germania, che ci narra Adler. Per testare se dei fidanzati possono realizzare un matrimonio felice devono tagliare insieme un tronco d’albero con una sega con due manici. Per realizzare efficacemente questo lavoro ci vogliono coesione ed affiatamento; infatti se i due non si agiscono in modo sincronico e complementare non concludono niente.
Per Adler quindi è fondamentale la cooperazione, piuttosto che il sesso ed i desideri sessuali. E non è assolutamente detto che ricercare la cooperazione sia più difficile che trovare la fiducia reciproca per svelare le proprie fantasie.
giu 142022
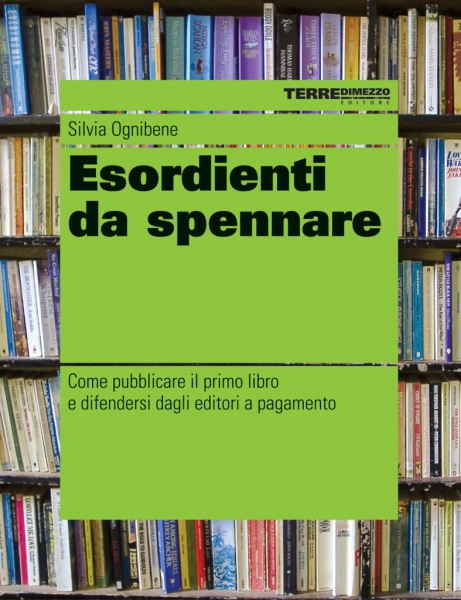
È necessario pubblicare? Non basta accontentarsi di pubblicare qualcosa sul web o su qualche rivista letteraria? È davvero necessaria la pubblicazione cartacea? E se la risposta è affermativa allora è meglio il self publishing o l'eap (ovvero editoria a pagamento? Nel primo caso le spese sono più contenute. Nel secondo talvolta si tratta di vanity press, come dicono gli inglesi, ovvero della pubblicazione basata su lusinghe e vanità. In ogni caso si è autori a proprie spese, come li definiva Umberto Eco. Quando però qualcuno sborsa tremila euro per pubblicare un libro di poesia di solito la casa editrice gli garantisce una maggiore legittimazione culturale, che spesso porta all'autore una maggiore visibilità, almeno online. Un blog letterario o una rivista online sono molto più propensi a recensire positivamente un libro di poesia pubblicato a pagamento rispetto a un autore inedito, che invia loro tramite email in allegato la sua raccolta poetica. Dietro a tutto questo c'è in piccola parte egocentrismo e ipocrisia, ma dall'altro lato è un modo per difendere il business delle piccole o medie case editrici che pubblicano a pagamento chiunque si rivolga loro oppure solo gli esordienti. Insomma non sputiamo a priori o per partito preso su questa seppur minuscola parte di prodotto interno lordo. Onestamente, pubblicare a pagamento non significa spesso aver passato una selezione. Si può notare dalla grande velocità con cui molte di queste case editrici rispondono agli aspiranti poeti, elogiandoli. Non c'è niente di illegale però nell'editoria a pagamento. La legge, rimasta agli anni Quaranta, recita che la casa editrice si accolla le spese, salvo accordi diversi. Nonostante tutto l'Associazione Italiana Editori recentemente si è proposta di "rimuovere gli ostacoli allo sviluppo di un moderno mercato editoriale". C'è anche chi sbandiera la sua diversità, sostenendo che è una casa editrice no eap, mentre poi tramite inganno chiede contributo. Nel mondo dell'editoria a pagamento c'è anche molta improvvisazione: si va da chi non distribuisce il libro a chi addirittura talvolta non fa il deposito legale, cosa di cui dovrebbe occuparsene esclusivamente la casa editrice. C'è chi comunque condanna l'eap a spada tratta, come se fosse il maggior male del mondo, come se fosse una truffa. Si tratta invece di un accordo perfettamente legale. È vero che spesso è basato su premesse false, ovvero che per pubblicare bisogna sempre pagare, che la pubblicazione diventerà il trampolino di lancio, che garantirà una grande carriera letteraria. Ma oltre ai critici, ai detrattori ci sono coloro che la vedono un male minore, che dicono che molti autori affermati hanno tirato fuori di tasca i soldi per pubblicare, citando grandi nomi della letteratura alla rinfusa. È anche vero che se un aspirante poeta aspetta che lo pubblichino l'Einaudi, la Crocetti, la Garzanti, lo Specchio Mondadori, Feltrinelli, Donzelli potrebbe morire inedito, vista la selezione/scrematura di queste case editrici. E allora che deve fare un autore? Qualsiasi scelta è rispettabile. L'importante è non illudersi. Pubblicare, pagando 100 copie a 12 euro l'una presso una casa editrice piccola, indipendente, di buona qualità può essere un costo tutto sommato contenuto oltre che un buon modo di farsi conoscere. Ma mai riporre troppe illusioni. Pensare a torto che ciò garantirebbe di entrare in una ristretta cerchia escludeva di letterati è fuori luogo. Personalmente sono realista: sono un lettore forte e so che ci sono molti autori bravi che pubblicano a pagamento in un'epoca in cui le grandi case editrici ormai corteggiano senza pudore influencer e vip di ogni tipo. La poesia non vende o comunque il mercato è di nicchia. Writer’s Dream, una comunità virtuale, che aiutava a far crescere "la cultura editoriale" degli italiani ha chiuso i battenti. Oggi rimane un archivio online con tutte le case editrici totalmente a pagamento e quelle a doppio binario, che pubblicano gratis i nomi già affermati, mentre fanno pagare gli esordienti. Forse è stata chiusa l'attività di questa comunità perché troppo scomoda, perché faceva troppi nomi, perché c'era il rischio di cause legali. Anche Scrittori in causa, fondato dalla scrittrice Caterina Cutolo, che forniva assistenza legale agli scrittori, ha chiuso per mancanza di mezzi economici. Queste cose la dicono lunga sulla triste condizione in cui versa il mondo della scrittura italiana. Ma poi in fondo che c'è di male nel pubblicare a pagamento? Non è mica un delitto? Uno potrà vantarsene con gli amici, magari fare qualche conquista amorosa, avrà la soddisfazione di avere in uno scaffale della libreria del suo paese il suo libro, magari dopo averne donate qualche copia al commerciante suddetto! La cosiddetta gente comune di solito non sa niente di questa pratica dell'editoria a pagamento: pensa addirittura che un poeta o uno scrittore sconosciuto vi guadagni! Realisticamente parlando a ogni modo gli editori devono far quadrare i conti. Quindi sono legittimati a vendere con quasi ogni escamotage commerciale. Devono tirare avanti l'azienda. Poco importa purtroppo che il cosiddetto scouting risenta della qualità. Ma dopo essersi accaparrati un influencer o un vip gli editori possono farlo crescere. Tutti abbiamo dei margini di miglioramento, dovuti all'universale neuroplasticità umana. Ci sono persone con lesioni cerebrali (con la compromissione di buona parte di un emisfero), che riescono a recuperare le loro abilità intellettive. Figuriamoci se una persona qualsiasi senza lesioni o deficit cognitivi non può migliorarsi e crescere culturalmente grazie all'esercizio, allo studio continuo! Cosa importante per le case editrici in questo caso è la fama pregressa, ovvero il brand. Per il resto a un vip si può sempre affiancare editor (tutti he hanno bisogno), ghost writer, mentori, guide spirituali e chi più ne ha più ne metta per migliorare il suo talento. Se sei un poeta anonimo che non ha seguito nessuno comprerà il tuo libro. Sempre più case editrici guardano la popolarità sui social che ha un potenziale autore per ragionare sul possibile riscontro di vendite che può avere. Ma la cosa che maggiormente mi chiedo è quando uno scritto smette di essere uno sfogo con un valore umano e sociologico e inizia a essere letteratura? Oppure come distinguere la letteratura vera da un intellettualismo astruso? Non è affatto facile e a onor del vero siamo nell'ambito dell'opinabile. Con questo non voglio intendere che non esistono criteri, ma ricordiamoci che anche la medicina è una scienza, pur tuttavia non sempre i medici sono concordi nella diagnosi e nella cura. Di certo gli aspiranti poeti per pubblicare devono disporre di un gruzzoletto, di qualche risparmio nella maggioranza dei casi. A volte certi curriculum poetici sono fatti di autopubblicazioni o di pubblicazioni a pagamento. Allora non era più saggio forse rivolgersi a una tipografia, come facevano un tempo e poi distribuire spontaneamente ai pochi cari e ai conoscenti i versi? Come dicono i fondatori di Writer's Dream oggi le nuove generazioni si muovono nel mondo del direct publishing, sui social per esempio. Sarebbe bello se il crowdfunding funzionasse in Italia. Sarebbe bello se questa "forma di microfinanziamento dal basso", così definita da Wikipedia, funzionasse anche per la poesia italiana. Il fatto compiuto è che molti aspirano a diventare poeti, ignorando che i veri poeti spesso fanno una vita osteggiata talvolta dai propri cari, sbeffeggiata dai conoscenti: una vita di sacrifici, povertà, scarsa fama, caratterizzata da tante incomprensioni. Solo poeti e aspiranti poeti possono leggere i versi di uno anonimo, che non arriverà mai alla cosiddetta gente comune, dato che gli italiani non amano la poesia contemporanea e non si fidano assolutamente degli aspiranti o sedicenti poeti. Se un cantautore famoso e riconosciuto come Guccini definisce la sua fama "una gloria da stronzi" che cosa è allora il quasi-anonimato in cui vengono rilegati poeti spesso di grande qualità, ma spesso sconosciuti al grande pubblico? È legittimo aspirare alla povertà, a tutte queste rinunce per un sogno adolescenziale o giovanile? Il gioco vale forse la candela? Nella stragrande maggioranza dei casi carneadi si nasce, naturalmente si muore e si resta carneadi anche da morti. A onor del vero di solito ci sono solo due modi per farsi pagare come poeti ed è scrivere canzoni oppure non andare più a capo, come dichiarò Aldo Nove a Maria Grazia Calandrone, e scrivere romanzi. Questa è un'epoca che premia i falsi poeti e quelli veri nella migliore delle ipotesi sono costretti a scendere a compromessi, a scendere a patti con questa realtà, snaturandosi. Ecco perché diversi poeti e diverse poetesse soffrono il soffribile perché sentono minacciate la loro natura e il loro modo di essere. Ma salvaguardarli è quasi impossibile. Fare corsi di autodifesa per poeti non è possibile. A questo mondo i poeti devono imparare a difendersi da soli con le loro forze. Editoria a pagamento oppure no. Illusioni o ambizioni sbagliate oppure no.
giu 142022

Reno Bromuro (Paduli, 2 luglio 1932 – Roma, 12 giugno 2009) è stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale italiano. Nel 1957 ha fondato a Napoli il "Centro Sperimentale di Ricerca per un Teatro Neorealista". Nel 1970, ha fondato a Roma la Compagnia di Prosa "I Corinti". Ha lavorato in teatro con i giovanissimi della Scuola Media Statale San Giorgio di Fregene. È stato anche giornalista e critico letterario. Ha pubblicato numerose raccolte poetiche. Ha vinto numerosi primi premi per la Poesia, per la Narrativa, la Saggistica e il Giornalismo. Non l'ho mai conosciuto personalmente. Non ho mai interagito con lui. Leggevo però nel 2001, 2002, 2003 le sue riflessioni e il suo almanacco del giorno su una mailing list che ora non esiste più, ovvero Nonsolopoesia. Bromuro spiccava per la sua cultura, il suo talento, ma anche per il fatto di essere un operatore culturale instancabile, sia nella vita reale che su Internet. Il web allora era agli albori. La maggioranza dei siti che trattavano di poesia erano amatoriali, gestiti dagli studenti o da semplici appassionati. Molte case editrici, molti scrittori, molti intellettuali snobbavano Internet. Allora io avevo un sito di poesia su Geocities, ma c'era anche chi lo faceva su Digiland, su Lycos, su Blogspot, insomma sui vari portali che offrivano hosting gratis. Bastava conoscere i rudimenti di Html e smanettare un poco. Mi colpì la competenza di Bromuro. Lessi attentamente il suo saggio intitolato "Il racket nell'arte e il valore umano della poesia". Leggendolo, avevo la conferma di una cosa, che avevo solo grossolanamente e vagamente intuito. Esisteva la cosiddetta mafia nel mondo della poesia. Era una mafia che non uccideva le persone ma ignorava il talento, lo mortificava giorno dopo giorno, infine lo uccideva e con esso assassinava la poesia. Non bastava la mancanza di talento degli aspiranti poeti (aspirazione legittima quella di essere poeti) che erano soprattutto poeti della domenica che infestavano il web. No. Erano anche i letterati e gli addetti ai lavori a giocare sporco. Qualcuno poteva giustificare tutto ciò col fatto che dovesse compiersi una selezione artistica, che la poesia non era per tutti, che l'arte non era esclusiva o inclusiva ma solo meritocratica. Eppure bastava leggere Bukowski per capire che la tendenza a fare cricca era un fenomeno non dico universale ma tipicamente occidentale. A cosa era dovuto tutto ciò? Forse a quella che Bromuro definiva "mercificazione dell'inutile"? Nel frattempo leggevo le poesie e gli scritti di Bromuro. Era un artista a tutto tondo oltre che un intellettuale senza fronzoli, che parlava chiaro e non si perdeva in intellettualismi. Aveva incorporato, interiorizzato la lezione di Popper sulla chiarezza espositiva non come qualità rara ma come dovere di tutti gli scriventi. Nei suoi saggi, nelle sue prefazioni, nelle sue recensioni riusciva a essere concettuale senza mai semplificare e ridurre alla banalità, ma anche senza essere troppo concettoso e difficile. Bromuro era un letterato che sapeva rivolgersi a tutti e farsi comprendere da tutti o perlomeno dai più. Eppure a distanza di 13 anni dalla morte ci restano testimonianza del suo ottimo ingegno alcuni siti a cui collaborava (compreso Letteratour) e alcuni suoi libri. Per il resto il mondo letterario ha ripagato con l'indifferenza e l'oblio questo artista, forse perché troppo scomodo e capace di denunciare cose che non si potevano dire né scrivere. Qualche potente delle patrie lettere avrà tirato un sospiro di sollievo alla sua dipartita ("A pensare male si fa peccato ma ci si indovina sempre" sosteneva Andreotti). Ma non è prettamente una questione artistica o totalmente artistica oppure riguardante la politica culturale. È prima di tutto una questione di coscienza e Bromuro era in pace con la sua. A volte mi sembra che i poeti contemporanei siano come dei polli che si azzuffano per poco becchime che elargisce loro il potere. Di poesia non si campa e allora molti si impiegano in professioni intellettuali, talvolta scendendo a dei compromessi. Contano le pubbliche relazioni anche nel mondo poetico. I poeti cercano sodalizi, appoggi da critici, cardinali, giornalisti. Bromuro non cercava conoscenze altolocate, ma si sapeva mettere a disposizione di tutti, ritenendo irrinunciabili l'onestà intellettuale e la sua dignità umana. Alle moine, gli arrufianamenti, i favoritismi lui opponeva le sue argomentazioni lucide. Una cosa che mi ha colpito è che in lui non c'era traccia di pressapochismo o di sfoggio di cultura. Sapeva ciò che scriveva. Non faceva l'erudito. Ma era colto e su questo personalmente non avevo dubbi. La sua cultura era pervasa al contempo da rigore e umanità. So che incoraggiava anche tutti gli artisti. Si prendeva a cuore della poesia degli altri, non solo della sua. Non vedeva come alcuni la poesia come una gara, una competizione a chi pubblica più libri o a chi vince più premi, anche se poi la poesia italiana era ed è soprattutto una PREMIOPOLI! Come mi disse lo scrittore lucchese Vittorio Baccelli in diversi casi i giurati dei premi con le tasse di iscrizione al concorso pagavano le cene al ristorante con la "ganza", ovvero con l'amante. Insomma nel migliore dei casi per quanto riguarda i premi c'era un poco di malafede, un piccolo abuso di credulità popolare oltre che un modo ignobile di speculare su chi vuole sentirsi artista. Nel peggiore dei casi può essere come per il premio Grinzane Cavour e lo scandalo che ne è conseguito. Fu la guardia di finanza, nel corso dell’inchiesta sulle vessazioni al domestico del patron Soria, a interessarsi dei conti del premio letterario e a certificare malversazioni dei contributi che gli enti pubblici fornivano al premio letterario: denaro che Soria usava anche per sé. Poi ci sono altri importanti premi che scompaiono per la morte della fondatrice o per delle incomprensioni, come nel caso del premio Montale, presieduto dalla poetessa Maria Luisa Spaziani. Ma veniamo a cose più importanti.

(Nella foto Vittorio Baccelli)
Occupiamoci di un altro artista. Vittorio Baccelli (Lucca, 12 ottobre 1941 – Lucca, 23 ottobre 2011) è stato uno scrittore italiano di letteratura fantastica. Anche lui è un artista ormai dimenticato. Ma perché un poeta viene dimenticato? In vita un poeta può essere stato oggetto di ostracismo artistico. Può essere soggetto da morto di damnatio memoriae. Ma spesso molti poeti finiscono nella dimenticanza per disinteresse generale. I poeti viventi spesso non guardano indietro, non sono riconoscenti a chi li ha preceduti. Si tratta talvolta di mancanza di sensibilità culturale e di ingratitudine. Ma tutto ciò ritorna al mittente perché siamo tutti mortali Oppure forse i letterari viventi non sono malvagi. Semplicemente sono in tutte altre faccende affaccendati. Sono occupati nella stragrande maggioranza del tempo a promuovere sé stessi e non hanno spazio né tempo per gli altri. Forse c'è questo alla base del racket dell'arte. Forse alla base di tutto c'è una mancata predisposizione all'ascolto delle voci altrui. Qualcuno sostiene che quando un poeta muore aumenta la sua quotazione o che addirittura un poeta morto è una iattura infinita perché ruba la scena a quelli ancora in vita. Ma sono prese di posizione e polemiche forse un poco ingenerose se non talvolta pretestuose. A ogni modo come scrisse la poetessa Vivian Lamarque, tanto per tagliare la testa al toro: "PS.: Siamo poeti/ vogliateci bene da vivi di più/ da morti di meno/ che tanto non lo sapremo". Vi consiglio, come per Reno Bromuro, di fare ricerche su Google anche su Vittorio Baccelli. Troverete anche il suo sito su Interfree. Ebbi modo di intervistarlo nel 2005. Rimasi anche in questo caso favorevolmente colpito. Era un vulcano di idee. Anche in questo caso, come per Bromuro, Baccelli era entusiasta del web. Aveva fiducia in questo nuovo mondo virtuale. Lo vedeva come una grande opportunità, un nuovo modo di farsi conoscere. Accettò di buon grado di farsi intervistare da me. Pubblicai l'intervista sul mio sito, ma nel 2009 Geocities chiuse, il mio PC fu attaccato da un virus. Insomma per farla breve persi integralmente tutti i contenuti di quel dialogo fitto. La cosa mi dispiacere perché Baccelli non era stato laconico, non mi aveva snobbato. Piuttosto aveva risposto a tutte le domande in modo molto esauriente. Baccelli era un artista e intellettuale di talento, ma forse è stato dimenticato anche perché non allineato politicamente: da giovane era stato di destra, nella maturità era un radicale. Inoltre era uno che non le mandava a dire. Aveva il coraggio delle sue idee. Come ebbe modo di scrivere Bartolomeo Di Monaco non aveva peli sulla lingua. Consiglio a tutti di leggere i suoi racconti brevi. Sono scritti in modo magistrale. Essenziali, mai sciatti; una prosa ideata e orchestrata da una mano sapiente. Baccelli aveva conseguito una laurea in lettere a Pisa e una in scienze umane a Urbino. Giocava con i riferimenti letterari. C'erano dei cenni autobiografici nei suoi racconti, ma oltre alla testimonianza di vita la sua scrittura si caratterizzava per uno sperimentalismo di alto livello, in cui la speculazione intellettuale non era mai fine a sé stessa. Era un maestro impareggiabile della narrativa. Non ebbe mai la tentazione di scrivere un romanzo, ma raccolte di racconti come "Storie di fine millennio" sono la prova inconfutabile della sua bravura. Scrisse inoltre un libro sul grande scienziato Nicola Tesla. Baccelli era stato anche un protagonista della Mail Art o arte postale. Riporto fedelmente la definizione della Treccani a figuardo: "Movimento artistico che si realizza nell'invio per posta di materiali come francobolli, cartoline, buste, lettere, pacchi e simili rielaborati artisticamente e indirizzati a uno o più destinatari. ♦ Due lettere identiche, una datata Parigi e una Torino, firmate dalla stessa Gina Pane e contenenti un identico messaggio: «Qui tutto somiglia a lì». Un terzo telegramma, con cui Bernard Auriard invita: «Immaginate neon rosa pallido preoccupazione temporanea». Sono tutte opere d'arte, e rappresentano l'ultimissima scemenza: la «mail art» o arte postale. Convinti che l'arte sia ormai antiarte, e l'opera assenza d'opera, certi artisti giocosi ne avevano già fatte di tutti i colori: Vittor Pisani aveva esposto in galleria soltanto se stesso; Kounellìs aveva esposto alcuni cavalli (molto indisciplinati e sudicioni) , esibito in una mostra unicamente il proprio pappagallo (più mite, ma sboccatissimo) e alla fine radunato dieci ragazzini suonatori di flauto incaricandoli di eseguire, ad una certa ora, un concerto di una sola nota. Al confronto, assicura il critico francese Jean Clair, l'arte postale è molto più impegnativa: «Ormai nessuno si dedica alla corrispondenza, la lettera è divenuta lettera morta», spiega. «Nel momento in cui la gente abbandona il mezzo postale, gli artisti se ne impadroniscono. (Lietta Tornabuoni, Stampa sera, 29 marzo 1972, p. 3, Aggiornatissimo)". Baccelli fu anche la risposta encomiabile ai molti che sottovalutavano la fantascienza italiana. Come ebbe a riportare in un suo libro lo stesso Baccelli: "A Lucca Comics (allora si chiamava “Salone dei comics”), alla fine degli anni ’70 nel corso di un’intervista nella quale gli si chiedeva perché non pubblicasse mai autori italiani e perché le storie di fantascienza non erano mai ambientate in Italia, Carlo Fruttero che all’epoca assieme a Lucentini era curatore di Urania, per esprimere efficacemente il concetto che la fantascienza italiana mai avrebbe avuto la possibilità di competere con quella americana e, per proclamare una sorta d’incapacità congenita da parte degli scrittori italiani ad essere buoni autori di fantascienza, dichiarò pubblicamente che un disco volante avrebbe plausibilmente potuto atterrare a New York, a Londra, a Pechino, a Mosca, ma a Lucca mai!". E Baccelli nel corso della sua vita fece il possibile per smentire questo luogo comune, che era anche una concezione limitata e limitante di un intero genere letterario. In questo caso Baccelli si dimostrò un pioniere lungimirante. Non aveva paura ad andare contro gli stilemi letterari imposti dall'alto. Baccelli come Bromuro erano perfettamente consapevoli dei canoni e delle mode letterarie imperanti, ma incuranti di tutto scrivevano come si sentivano, erano alieni da ogni conformismo. Entrambi inoltre cercavano con la loro arte di aderire alla vita. Anche Baccelli come Bromuro cercava di divulgare il sapere, di diffondere le idee, tant'è che negli anni Settanta aveva collaborato a diverse riviste cartacee e nei primi anni Duemila era diventato una presenza assidua di molti siti letterari. Mi chiedo talvolta perché mi sono imbattuto in questi due autori, degni di ogni rispetto e stima. Forse tutto ha un senso. Forse il mio piccolo compito era constatare il loro valore e scriverne qui in questa sede. Tra tanti presunti o sedicenti poeti che avanzavano pretese Baccelli e Bromuro volevano che fossero riconosciuti legittimamente i loro meriti e le loro capacità. Nel magazzino della memoria di chi si occupa di poesia italiana di questi ultimi anni ci dovrebbe essere un posto per tutti e due. Non è assolutamente giusto che cali definitivamente il sipario, che venga premuto il tasto delete su questi due artisti. Che si sappia almeno che sono esistiti! Che di sappia qualcosa di loro! Che il loro lavoro non sia stato inutile! E se è vero che non c'è memoria senza oblio è anche vero che ricordarli entrambi sarebbe almeno utile per chi non ne sa niente di loro. Ci sono ancora diversi angoli del web in cui trovare i loro scritti gratuitamente. Che almeno le loro vite non siano state vane! Concludendo, Paduli e Lucca dovrebbero avere la sensibilità di onorare la memoria di Bromuro e Baccelli. Almeno questi sarebbero due atti dovuti, anche se tardivi.
giu 142022
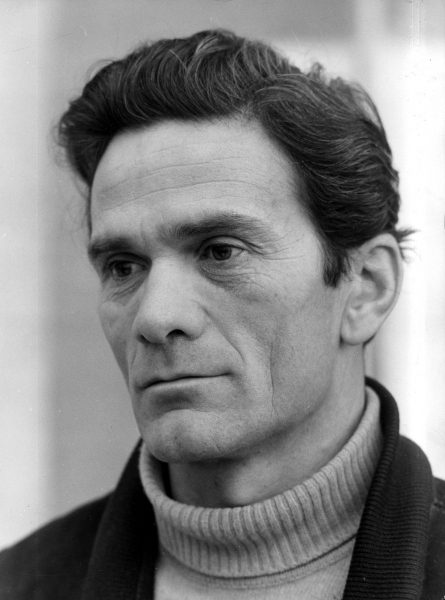
2 Novembre 1975. Pasolini viene assassinato vicino a un campetto di calcio all'idroscalo di Ostia. Riceve percosse, bastonate e agonizzante viene travolto più volte con la sua stessa auto. I capelli intrisi di sangue. Le tracce di pneumatici segnano la sua schiena. Le dita della mano sinistra fratturate. Dieci costole fratturate. Il cuore scoppiato. E' irriconoscibile, tant'è vero che la donna che scopre il suo cadavere e avverte la polizia di primo acchito aveva pensato che fosse un sacco di stracci. Muore quella notte uno dei più grandi intellettuali dell’epoca. Non solo, ma anche uno degli intellettuali più scomodi che la letteratura del ’900 possa annoverare. Oggi a molti anni dalla sua scomparsa sarebbe l'ora di smettere di demonizzarlo o al contrario di mitizzarlo per cercare nel modo più obiettivo di valutare la portata del suo testamento e di analizzare il suo iter creativo. E' stato ammazzato e quindi potremmo mitizzarlo quanto vogliamo, diranno i più. Non sappiamo ancora chi è stato veramente e soprattutto quanti sono stati, però sappiamo sicuramente chi è stato a linciarlo quando era in vita, diranno altri: è stata quella borghesia, che secondo Pasolini non era una classe sociale, ma una vera e propria malattia, una serpe covata nel seno della società italiana. A tal riguardo Moravia lo aveva già detto che la borghesia italiana era capace di tutto; bastava volgersi indietro e constatare le responsabilità effettive del ceto borghese nella controriforma e nel fascismo. Il suo omicidio "irrisolto" è una ferita ancora aperta nella società civile, dirà il presidente dell'Arcigay. Personalmente ritengo che mitizzarlo o addirittura santificarlo laicamente, mi si perdoni l'ossimoro, significhi togliere ai più la possibilità di conoscere le sue opere, anche se certamente questo tipo di operazione lo rende maggiormente popolare. Mitizzarlo significa a mio avviso considerarlo un fenomeno da baraccone e diffondere una conoscenza sempre più vaga del suo pensiero e delle sue opere ed è inutile "pubblicizzarlo" come personaggio e riempirsi la bocca di ipotesi più o meno plausibili sulla sua morte, quando invece a molti anni dalla sua morte il poeta e lo scrittore Pasolini non fanno ancora parte dei programmi ministeriali della letteratura italiana delle superiori. Omicidio "irrisolto" dicevo. Sarà Pino Pelosi ad essere condannato per questo omicidio. Ma molte cose non saranno mai chiarite definitivamente.
DELITTO POLITICO ?
Sono in molti ad ipotizzare una pista politica. Il potere perciò avrebbe ucciso il poeta friulano perché dentro di sé sentiva sempre la necessità di dire la verità o quantomeno la sua verità in un paese di intellettuali cortigiani, che stavano sempre dentro il palazzo. Pasolini non era cortigiano e per essere cortigiani non significava necessariamente essere dei fascisti, né dei reazionari, né dei liberali in un dopoguerra in cui si registrava un’egemonia culturale della sinistra. Pasolini era comunista, ma era stato espulso dal partito per delle accuse infondate (per i fatti di Ramuscello per cui venne assolto dal giudice) e per l’omofobia di quegli anni del partito [nota dell’agenzia Fert il 14 Luglio 1960: “La Fert apprende che l’on. Togliatti ha rivolto ai dirigenti dei settori culturali e stampa del partito l’invito ad andare cauti con il considerare Pasolini un fiancheggiatore del partito e nel prenderne le difese. L’iniziativa di Togliatti che riscontra molte contrarietà, parte da due considerazioni. Togliatti non ritiene, a suo giudizio personale, Pasolini un grande scrittore, e anzi il suo giudizio in proposito è piuttosto duro. Infine, egli giudica una cattiva propaganda per il Pci, specialmente per la base, il considerare Pasolini un comunista, dopo che l’attenzione del pubblico, più che sui romanzi dello scrittore, è polarizzata su talune scabrose situazioni in egli si è venuto a trovare fino a provocare l’intervento del magistrato………"].
MAESTRO DEL PENSIERO DELLA SINISTRA ITALIANA?
Solo dopo la sua morte è stato compreso che Pasolini aveva dei meriti culturali indiscussi e che doveva essere considerato legittimamente uno dei maestri di pensiero della sinistra italiana perché come dichiarò Moravia fu il primo poeta a realizzare una poesia civile di sinistra, una poesia senza la retorica ed il trionfalismo di Foscolo, Carducci, D'Annunzio. Pasolini aveva iniziato la sua carriera letteraria con la pubblicazione di "Poesie a Casarsa", liriche osteggiate dal fascismo, che difendeva strenuamente l'italiano e non voleva ammettere a nessun costo l'esistenza di dialetti e particolarismi locali. Va ricordato a tale proposito che a causa del regime il grande critico letterario Gianfranco Contini pubblicò la sua recensione sull'opera, da cui era rimasto favorevolmente colpito, non su "Primato", ma sul "Corriere di Lugano", giornale svizzero. Raggiunse la notorietà nell'ambito della poesia con "Le ceneri di Gramsci" [1957], costituite da undici poemetti, che dopo la "scoperta di Marx" nell'ultima sezione de "L'usignuolo della chiesa cattolica" facevano i conti con l'eredità lasciata appunto da Gramsci, le cui ceneri si trovavano nel cimitero degli inglesi a Roma. Questa raccolta poetica testimoniava la coscienza infelice dei comunisti italiani in un periodo travagliato sia per la condanna di Stalin al XX Congresso del Partito Comunista Sovietico sia per i tristi fatti d'Ungheria. Nelle raccolte poetiche "Le ceneri di Gramsci", "La religione del mio tempo" e "Poesia in forma di rosa" farà la sua comparsa il mondo proletario, nonostante ciò questi componimenti non desteranno nessun scandalo come la narrativa pasoliniana, perchè scritti in un italiano letterario e non nel gergo romanesco della malavita, come in "Ragazzi di vita" e in "Una vita violenta". Qui compaiono spiazzi assolati dove sciami di pischelli rincorrono un pallone, giovani sorridenti e sporchi in sella ai motorini a rincorrere disperatamente la vita, tuguri fatti di calce, autobus affollati, operai dalle canottiere intrise di sudore, garzoni che canticchiano spensierati al lavoro. Anche nei lungometraggi pasoliniani verrà narrato il mondo sottoproletario degli anni '50-60, però questa mondo non verrà solo descritto, ma anche trasfigurato con l'ausilio di citazioni pittoriche (Caravaggio, Mantegna, Masaccio). Intendiamoci: nonostante questa originalità del suo "cinema di poesia" [come lo definirà lui stesso in "Empirismo eretico"] la ricerca espressiva del cineasta sarà tutta tesa verso la realtà perché per l'intellettuale era l'unico ambito in cui poteva confrontarsi con le miserie e gli splendori di quel mondo, in cui poteva relazionarsi all'altro. Per Pasolini i ragazzi di vita non hanno una coscienza di classe, non hanno una religione e sono fuori dalla storia. Non hanno nessuno che possa far valere i loro diritti perché per il poeta la chiesa è il cuore spietato dello stato e anche i politici di nessuno schieramento vogliono rappresentarli. Riguardo alla chiesa come cuore spietato dello stato nel 1958 scrive la poesia "A un Papa" [da "Umiliato e offeso" (epigrammi)]: "Bastava soltanto un tuo gesto, una tua parola,/ perché quei tuoi figli avessero una casa:/ tu non hai fatto un gesto, non hai detto una parola./ Non ti si chiedeva di perdonare Marx! Un'onda/ immensa che si rifrange da millenni di vita/ ti separava da lui, dalla sua religione ma nella tua religione non si parla di pietà?/ Migliaia di uomini sotto il tuo pontificato,/davanti ai tuoi occhi, son vissuti in stabbi e porcili./ Lo sapevi, peccare non significa fare il male:/ non fare il bene, questo significa peccare./ Quanto bene tu potevi fare ! E non l'hai fatto:/ non c'è stato un peccatore più grande di te". E riguardo ai politici Pasolini nella lirica "Terra di lavoro" [da "Le ceneri di Gramsci"] scrive: "....Gli è nemico chi rende/ grazie a Dio per la reazione del vecchio popolo, e gli è nemico/ chi perdona il sangue in nome/ del nuovo popolo...". L'unica consolazione della loro miseria è solo ed unicamente il sesso; solo il sesso comprato a buon mercato per un quarto d'ora può dare al giovane borgataro come al padre di famiglia l'illusione del possesso.
IL COMPAGNO SCOMODO DEL PCI:
Pasolini era un compagno scomodo del Pci, sempre pronto a levare la sua voce contro un partito che a suo avviso si stava istituzionalizzando e i cui vertici si stavano imborghesendo. Non va dimenticato che, nonostante il poeta si dichiarasse marxista, negli ultimi anni della sua vita guardò con simpatia alla sinistra americana progressista, così come non bisogna dimenticare la sua opera “Passione ed ideologia”, in cui questi due termini mai si contrappongono, si confondono e si compenetrano, ma nella quale piuttosto è la passione ad essere conditio sine qua non dell’ideologia. Pasolini oltre ad essere un grande poeta e un grande scrittore era anche un intellettuale lucido e disincantato, le cui analisi e riflessioni originavano da un senso critico ineguagliabile. La sua visionarietà d'artista era tale da portarlo a prevedere con vent'anni di anticipo gli sviluppi della società italica. Per uno come lui uniformarsi ai dettami e alle restrizioni del partito comunista di allora sarebbe equivalso a rinnegare la sua passione ed il suo impegno politico. Non solo, ma aveva anche una onestà intellettuale esemplare. Si pensi solo al fatto che, pur essendo una star televisiva, criticava l’omologazione dovuta a suo avviso a opera della televisione e che sapendo di entrare nelle case di tutti gli italiani nelle trasmissioni televisive a cui prendeva parte non era mai volgare né provocatorio ed addirittura si autocensurava spesso, come ebbe lui stesso modo di dire. Ci si ricordi che più volte dichiarò - lui che era noto al grande pubblico anche per il suo presenzialismo nel piccolo schermo - che la televisione instaurava un rapporto asimmetrico tra personaggio televisivo e spettatore del tipo superiore/inferiore, ma che in un linguaggio più moderno potremmo anche definire del tipo comunicatore/ricevitore passivo. Il suo fu sempre un marxismo critico nei confronti del comunismo ufficiale ed ortodosso. Da intellettuale marxista non si scagliava come prevedibile solo contro la piccola-borghesia, ma anche contro quel conformismo di sinistra, che giorno dopo giorno era stato fagocitato dall’egoismo, dal moralismo, dall’incultura di un benessere economico, così rapido da aver trasformato nel giro di pochi anni completamente il Paese. Ma lo scrittore non criticava solo l’applicazione del marxismo, ma poneva l’accento anche sulle contraddizioni interiori dei marxisti e sulla crisi del marxismo. Pasolini l’aveva intuito che in un paese profondamente cattolico come l’Italia per ogni comunista la coscienza era marxista e l’esistenza invece borghese. Ne "Le ceneri di Gramsci" scriveva: "...e se mi accade/ di amare il mondo non è che per violento/ e ingenuo amore sensuale/ così come, confuso adolescente, un tempo/ l'odiai; se in esso mi feriva il male borghese di me borghese....". Si noti proprio questa ultima espressione: "se in esso mi feriva il male borghese di me borghese". Ma se molti avevano cercato di risolvere la questione cercando di coniugare comunismo e cattolicesimo (da qui il cattocomunismo), il nostro ebbe il merito di essere uno dei pochi che cercò di unire la vera essenza del cristianesimo, ovvero una religiosità che pervadeva in ogni frangente ogni suo sguardo sul mondo, e un marxismo colto e consapevole che il neocapitalismo aveva mutato totalmente il volto alle cose, al punto che la struttura economica sembrava aver inglobato qualsiasi tipo di sovrastruttura ideologica e essersi tramutata in una sovrastruttura anch’essa: l’unica sovrastruttura. Tutto queste senza enfasi e senza mistificazioni di nessuna sorta. Ecco spiegato allora perché nelle analisi pasoliniane il partito comunista veniva considerato facente parte del Potere e perciò mai esentato dalle critiche. Come ebbe modo di dire il politico comunista Edoardo D’Onofrio: “Pasolini non nasconde la verità per carità di partito…”. Il poeta però non rinunciava alla sua fede politica, pur non credendo più nella rivoluzione, né in nessuna palingenesi della società. Pasolini con tutte le sue anomalie e divergenze era un comunista e lo dimostra ad esempio il suo lavoro di critico militante nella rivista "Officina", che diresse con Leonetti e Roversi, e in "Nuovi argomenti", che invece diresse con Moravia. Almeno durante il periodo de "La scoperta di Marx" per l'intellettuale l'essere sociale determinerà la coscienza, la letteratura sarà sinonimo di prassi sociale e la coscienza verrà considerata in ottica leninista come il riflesso della realtà.
”ESPRIMERSI E MORIRE O ESSERE INESPRESSI E IMMORTALI":
D'altronde Pasolini non poteva che essere comunista perché in quegli anni le strade percorribili a livello filosofico erano tre: credere nel marxismo e quindi ritenere che la causa dei mali della società fossero il plusvalore e l'alienazione, schierarsi contro il nichilismo e quindi abbracciare i sistemi di pensiero di Spengler, Junger, Heidegger, oppure rivolgersi al personalismo ontologico, alla democrazia cristiana. Pasolini per la sua aspirazione all'uguaglianza e per la sua vocazione al realismo piuttosto che allo spirito non poteva che scegliere la via marxista. Naturalmente ho scartato per ovvie ragioni l'esistenzialismo perché, laddove gli esistenzialisti vedevano l'angoscia nella scelta, il poeta vedeva la speranza e la possibilità della scelta. Infatti scrisse: "O esprimersi e morire o essere inespressi ed immortali!"; volendo dire che finchè si è in vita la nostra esistenza fortunatamente non ha soluzione di compiutezza e di continuità perché è aperta ad ogni possibilità, mentre solo la morte fa chiarezza, permette una sintesi di ciò che è stato, sceglie gli episodi significativi e memorabili di una vita umana. Essere inespressi significa quindi avere opportunità di scelta e perciò essere vitali. Per Pasolini morte significa compiutezza e compiutezza significa morte. Questo per il nostro era vero sia nel significato letterale che nel significato metaforico. Pasolini, sebbene eretico, a mio avviso a tratti sarà condizionato fortemente dall'influsso dell'estetica marxista e dal fascino delle teorie del grande critico letterario G.Lukacs. Infatti scriverà un dramma borghese solo e soltanto nel 1968, cioè "Teorema". In questa opera un ospite di bell'aspetto getterà scompiglio in una ricca famiglia industriale milanese e scardinerà i codici borghesi del decoro, della rispettabiltà e della morigeratezza. Riguardo al suo rapporto con il comunismo Pasolini in “Uccellacci e uccellini” farà dire al corvo: “Non piango sulla fine delle mie Idee, che certamente verrà qualcun altro a prendere la mia bandiera e a portarla avanti ! Piango su di me……”. Ma intendiamoci: chi ipotizza la pista del delitto politico non ha certo in mente il potere comunista di quegli anni, ma i neofascisti oppure i democristiani, che sarebbero stati mandanti dell’assassinio, utilizzando i fascisti come puri esecutori materiali. Esistono sicuramente degli elementi per avvallare questa tesi. Era un poeta, uno scrittore, un polemista, un regista noto al grande pubblico. Possedeva una grande capacità comunicativa, non si chiudeva in una torre di avorio né si perdeva nel settarismo e nell'intellettualismo, fenomeni così diffusi tra gli intellettuali dell'epoca. Dava fastidio non solo per la contaminazione dei generi, ma anche per il suo sperimentalismo in tutti i campi, per la frequentazione assidua di tutti i generi: dalla poesia, al romanzo, dal giornalismo al cinema, dall'inchiesta sociologica alla polemica televisiva. Se aveva iniziato con la poesia in dialetto friulano e con la poesia civile in una forma metrica tradizionale (ci si ricordi l'uso delle terzine) si era successivamente rivelato un uomo contro in tutte le altre sue opere, tant'è che subì nel corso della sua vita ben 30 processi. Spesso le accuse erano di vilipendio alla religione e di pornografia. Ritengo che la difesa migliore a queste accuse sia stato un intervento del poeta dal titolo "La pornografia è noiosa", nel quale sostiene che nonostante il degrado e la sottocultura di coloro che guardano opere pornografiche, tuttavia bisogna considerare che sono milioni di persone e che anche se fossero tutte persone depravate non è certo eliminando la pornografia che si eliminerebbe la loro depravazione; la loro depravazione repressa potrebbe anche sfociare in qualcosa di diverso e di più pericoloso socialmente; inoltre per il nostro il problema non è tanto nel numero più o meno consistente dei fruitori, né della repressione o meno del fenomeno, ma dell'incapacità o della malafede di coloro che non distinguono tra opera d'arte provocatoria e opera pornografica. Vorrei ora però fare una considerazione a parte; se oltre a leggere le sue opere ci mettiamo anche a rileggerle e a meditare attentamente su di esse ci rendiamo conto che in ognuna ci lasci intravedere le sue potenzialità inespresse. Salta subito all'occhio che debba ancora dare il meglio di sé e che ogni sua opera sua eternamente incompiuta, volutamente lasciata a metà. Da Pasolini molti si aspettavano un'opera folgorante, che aprisse un mondo ed invece in molti rileggendo i suoi lavori si sono accorti che la globalità ed il corpo organico dell'insieme delle sue opere erano il vero e proprio capolavoro. Da lui tutti si aspettavano un Libro Totale.
RIFIUTAVA DI "PRESTARSI ALLA POLITICA":
Successivamente i profondi conoscitori delle sue opere e i lettori più attenti con il passare degli anni si sono accorti che molti tratti e molti passaggi dei suoi pensieri, ritenuti inizialmente oscuri, potevano essere decifrati intuendo la fitta rete di rimandi, che Pasolini aveva lasciato. I suoi messaggi sono chiari in definitiva se si capisce che ogni lavoro può rimandare ad un altro lavoro, che ad esempio una poesia può essere chiarita da una sua intervista e che un intervento polemico può richiamare più o meno direttamente un testo teatrale. Scriveva ogni giorno della sua vita e ogni giorno disseminava tracce per comprendere pienamente le sue raccolte poetiche, i suoi film, i suoi romanzi. Inoltre non era solo un intellettuale. Non era solo un poeta, un critico letterario, un regista cinematografico: era anche politico senza essere fazioso. E non faceva come la maggior parte degli intellettuali, che si prestano alla politica. Non aveva mai ricoperto, dopo la fama nazionale, incarichi di partito. Negli anni '70 divenne corsaro: politico ed intellettuale allo stesso tempo. Naturalmente prima era intellettuale e poi politico. Si schierò contro il potere democristiano dell'epoca e contro l'opposizione, in quanto probabile governo futuro. Riteneva che anche l'opposizione politica su molte questioni rilevanti avesse ormai posizioni simili nella sostanza al potere ufficiale. Riteneva che anche l'opposizione ormai fosse caduta nei retaggi culturali e mentali del neocapitalismo. L'unico legame saldo col partito per tutta la vita forse fu il mito della resistenza. Ma d'altra parte criticava la continuità del partito con la mentalità istituzionale della borghesia. Da questo punto di vista il Pasolini corsaro (ovvero degli scritti corsari e delle lettere luterane) si può considerare come all'opposizione dell'opposizione. Già.....perché quando si è all'opposizione si corre due rischi: la normalizzazione rispetto alla maggioranza e il conformismo dell'anticonformismo. Il primo punto (già accennato prima) era il rischio dei funzionari dell'opposizione, il secondo invece era il rischio dei giovani sessantottini. Pasolini aveva scritto la poesia "Il P.C.I ai giovani!!", in cui criticava aspramente il movimento studentesco, che si rifaceva al maggio francese. Ricordo che dopo gli scontri di Valle Giulia tra studenti universitari contestatori del sistema ed i poliziotti dichiarò apertamente di parteggiare per questi ultimi perché loro non erano i figli di papà, erano poveri ed in questo caso gli studenti ricchi avrebbero dovuto regalare loro dei fiori e non lanciare pietre e sanpietrini. Ma il Pasolini polemista non si fermò certo qui. Scrisse delle "lettere aperte" a Leone. Si schierò contro il divorzio e l'aborto nel referendum del '75. Scrisse saggi contro la televisione. Non solo teorizzò la mutazione antropologica, ma fece anche una polemica con Calvino sul rapporto che intercorreva tra televisione e linguaggio. Per Pasolini la televisione non portava le masse solo a uniformarsi nei comportamenti e nel modo di vestire, ma prima di tutto nel linguaggio. Calvino era più ottimista. Pensava che la televisione avrebbe causato l'eliminazione dell'antilingua (ossia del burocratese, del latinorum, etc etc) e avrebbe portato alla diffusione di termini più che di parole: ovvero di vocaboli precisi, per niente vaghi ed indefiniti. Per Calvino la televisione sarebbe stato uno strumento di diffusione dei vocaboli della scienza moderna e della tecnologia. Pasolini invece vedeva nell'omologazione del linguaggio il disfacimento e la morte dei dialetti. Quindi considerava la televisione come un mezzo che avrebbe spazzato via le tradizioni culturali regionali. Non va dimenticato che vedeva nell'omologazione del linguaggio un antecedente dell'omologazione del pensiero. Inoltre si occupò del caso Lavorini di Viareggio. Si occupò del caso Panagulis, condannato prima alla fucilazione dal regime dei colonnelli greci, poi graziato dalla pena di morte. Infine ebbe modo più volte di profettizzare "il potere industriale transnazionale". Secondo il poeta delle ceneri di Gramsci il neocapitalismo aveva prodotto un "orrendo universo tecnologico" in cui moriva l'individualità... in cui chi era diverso veniva ghettizzato...in cui l'eccesso di informazione giornalistica e televisiva causava la perdita di memoria storica.... in cui la smania del consumo riduceva l'aggressività nella protesta.... in cui si dimenticava le miserie del presente in nome di un ambito mito del benessere. Tutti coloro che propendono per il delitto politico citano sempre il fastidio che gli uomini di potere avrebbero potuto avere con la pubblicazione de "Gli scritti corsari". Negli scritti corsari affrontò diverse tematiche dell’epoca con una forza polemica ed una capacità analitica fuori del comune. Tutti avevano sotto gli occhi l’omologazione culturale, il genocidio culturale e quella che lui chiamava la mutazione antropologica, eppure fu lui il primo a scriverne dettagliatamente. Basta analizzare per sommi capi la società odierna per capire che il poeta delle “Ceneri di Gramsci” non è stato solo un sociologo involontario del proprio tempo, ma anche un profeta, che ha saputo prevedere gli sviluppi dell’Italia che aveva sotto gli occhi. A mio avviso attualmente viviamo in una civiltà dove regna l’omologazione dalle varianti minimali. Tutti comprano gli stessi dieci tipi di automobili, tanto pubblicizzate alla televisione, però allo stesso tempo ognuno sceglie il modello personalizzato in base agli accessori. La televisione in Italia è stata senz'altro un agente catalizzatore dell'unificazione linguistica. Prima di allora solo le persone istruite e colte parlavano e scrivevano nel fiorentino di Dante, Petrarca, Boccaccio (successivamente ripreso ne "I promessi sposi" da Manzoni, che andò "a sciacquarsi i panni in Arno"). Quando la televisione invece entrò nella maggior parte delle case italiane ecco che quell'italiano di Dante divenne popolare. Prima di allora la maggior parte degli italiani pensava e parlava nel dialetto locale. Successivamente però la televisione secondo Pasolini era diventata la causa primaria dell'omologazione. Già nei primi anni '70 l'acuto osservatore delle borgate romane aveva già intuito i cambiamenti sociali e culturali prodotti dalla massificazione televisiva. Aveva iniziato ad accorgersi che tutti i giovani di borgata avevano iniziato a vestire, comportarsi, pensare in modo analogo. Se prima di allora per Pasolini si poteva distinguere un proletario da un borghese, oppure un comunista da un fascista, già agli inizi degli anni '70 non era più possibile: la società italiana si stava già omologando a macchia d'olio. Pasolini prese a prestito la sua MUTAZIONE ANTROPOLOGICA dalla biologia. La mutazione genetica in biologia è determinata dalla variazione prima e dalla fissazione poi. Nel caso della "mutazione antropologica" quindi la variazione delle mode e dei desideri della collettività è decisa prima nei consigli d'amministrazione delle reti televisive nazionali e poi viene fissata nelle menti dei telespettatori con messaggi subliminali e pubblicità. Ma questo non accade solo con la televisione, ma con qualsiasi mezzo dei mass-media (anche giornali e rotocalchi). La società neocapitalista aveva annientato il senso del sacro per rendere tutto “mercificabile”. Dal lato industriale tutto era merce o feticcio, dal lato culturale si registrava secondo Pasolini l'esistenza di due blocchi contrapposti: la borghesia e una parte della borghesia che contestava la borghesia stessi (i giovani studenti). Ai proletari ed ai sottoproletari a suo avviso non restava quindi che un unico dominio, un unico spazio libero: il proprio corpo. Pasolini infatti scrisse: "ciò che resta originario nell'operaio è che ciò che non è verbale: per esempio la sua fisicità, la sua voce, il suo corpo. Il corpo: ecco una terra ancora non colonizzata dal potere". Purtroppo le profezie di Pasolini si sono tutte avverate. L'omologazione ha livellato e appiattito tutto e tutti. Non solo, ma il potere ha proposto e propone ad libitum modelli fisici ed estetici ai più irraggiungibili. Tutto ciò crea ansia per il proprio corpo. Continuamente facciamo raffronti e i termini di paragoni risultano sempre più elevati e più distanti. L'ansia per il proprio corpo invade la nostra mente. Quante ore pensiamo se siamo idonei per questa o quella occasione sociale? Quante ore dedichiamo alla cura del nostro corpo per migliorarlo agli occhi degli altri? Il nostro corpo non è più libero, ma è totalmente occupato dal Potere. Tutte le energie psichiche e tutto il tempo speso per il nostro corpo poteva essere utilizzato per la partecipazione e l'impegno politico oppure per altre cause più nobili, che probabilmente avrebbero dato noia al potere e ai potenti. Penso ai più giovani.
LA MUTAZIONE ANTROPOLOGICA TRANSNAZIONALE:
La televisione, il cinema, i rotocalchi, la moda sono gli agenti primari dell’omologazione giovanile. La televisione soprattutto è la più deleteria da questo punto di vista. I giovani aderiscono biecamente e ciecamente ai modelli propinati dal piccolo schermo e dai suoi palinsesti. Pasolini aveva già intuito questo aspetto. “La mutazione antropologica” transnazionale, i cui dettami e le cui variazioni indicano i gusti, i modelli di comportamento, gli stili di pensiero, è fissata ciclicamente dai mass media. Modelle filiformi e longilinee, attori dal corpo scultoreo, ripresi dai cineasti della pubblicità, inducono i giovani ad un confronto spietato con il proprio corpo ed il proprio volto. Sempre più frequentemente inducono i giovani ad operazioni di chirurgia estetica (lifting, silicone, etc etc) oppure a diete forzate ed ossessive. Nei casi meno preoccupanti i giovani si sottopongono a spossanti ore di body-building per avere un fisico degno di considerazione per i propri coetanei. Magari per avere lo sguardo terso e cristallino di questo o quell’attore si mettono le lenti a contatto azzurre, altri per avere un colorito mediterraneo, una tintarella estiva tutto l’anno si sottopongono ad ore di lampada. Ma nei casi limite? E’ forse un caso che in questi anni rispetto al passato c’è stato un aumento impressionante di casi di anoressia e di bulimia tra le ragazze? Ogni giovane immagina ogni sorta di accorgimento estetico per rendersi più piacevole alla vista dei coetanei, per avere il loro consenso, per non essere “out”. Esiste un edonismo ad immagine e somiglianza dell’omologazione (dato che tutti cercano di migliorarsi esteticamente, prendendo come modelli i protagonisti del mondo di celluloide, i personaggi televisivi, i vip che fanno tendenza). E per edonismo intendo un nuovo tipo di edonismo. Non quello di Sardanapalo, non quello dei personaggi di Rabelais né quello dei vitelloni di Fellini. A mio avviso il culmine dell’edonismo (ossia ricercare il piacere ed evitare il dolore) in questa generazione di giovani è l’apparire: il piacere di apparire belli e prestanti di fronte agli altri. Se per altre generazioni apparire belli era un mezzo per avere altri tipi di piacere (ovvero avere più opportunità ad esempio per un uomo di fare più sesso) oggi il mezzo è diventato il fine: il narcisismo fa da padrone su tutti gli altri piaceri della vita. Piacere agli altri diventa il modo più rassicurante e confortevole di piacere a sé stessi (e da ciò si desume la grande insicurezza dei giovani d’oggi), mentre a mio avviso la maturità consisterebbe nell’accettare prima sé stessi e poi accettare coscientemente il giudizio degli altri. Può sembrare paradossale, ma è così: se continuiamo di questo passo la bellezza non avrà più valore. La bellezza della natura viene deturpata dall’industrializzazione e dall’abusivismo edilizio, la bellezza dei monumenti dai vandali e la bellezza fisica non esisterà più. Dico che la bellezza fisica non esisterà più, continuando in questa direzione, perché qualsiasi tipo di bellezza implica una gamma di possibilità e di diversità dell’esistente. La standardizzazione estetica, grazie alla chirurgia e a ogni sorta di accorgimento artificiale, eliminerà certo i complessi degli adolescenti, però produrrà appiattimento, un noioso livellamento. Non è forse per questo che Dio o chi per lui ha concepito la variabilità genetica degli esseri umani? Ed invece stiamo percorrendo una nuova direzione: tutti uguali nei modi di vestire, presto diventeremo uguali anche nelle fattezze e nelle sembianze: tutti omologati e così sia. Dovremmo al contrario ricordarci che i difetti e le imperfezioni della natura sono termini di paragone che fanno risaltare ed accrescono la bellezza. Senza di questi la bellezza non esisterebbe perché sarebbe pura e semplice normalità. Senza l’oscurità della notte non potremmo cogliere pienamente la bellezza di un’alba. Ma ritorniamo al 1974. Pasolini accusava anche la Dc della distruzione paesaggistica ed urbanistica dell’Italia e di intrallazzare con industriali e banchieri.
IO SO…………..
E per quanto riguardava la strategia della tensione il poeta scrive: ”Io so. Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe (e che in realtà è una serie di golpe istituitasi a sistema di protezione del paese). Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 Dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi dei 1974. Io so i nomi del “vertice” che ha manovrato, dunque, sia i vecchi fascisti ideatori di golpes, sia neofascisti autori materiali delle prime stragi, sia infine, gli “ignoti” autori materiali delle stragi più recenti……Io so i nomi di coloro che, tra una messa e l’altra, hanno dato le disposizioni e assicurato la protezione politica a vecchi generali………Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti (attentati alle istituzioni e stragi) di cui si sono resi colpevoli. Io so. Ma non ho prove. Non ho nemmeno indizi. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace; che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i fatti disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, la follia e il mistero………”. Inoltre Pasolini invitava a riflettere sull’annullamento di tutte le periferie, sull’impoverimento d’espressività linguistica, dovuto sia a una lingua tecnicizzata ormai che alla morte dei dialetti. Interessante anche ciò che il poeta scrive a proposito del rapporto tra chiesa e potere. Secondo Pasolini nel mondo contadino esisteva una stretta relazione tra economia, famiglia e chiesa. Con l’avvento della società industriale i valori del Vangelo sono però stati sostituiti a suo avviso da nuovi valori come l’edonismo sfrenato, il laicismo, una falsa tolleranza. Nell’articolo delle lucciole scrive di due fasi della storia recente: la prima fase, che va dalla fine della guerra alla scomparsa delle lucciole, in cui i valori principali sono l’ordine, la moralità, la chiesa, la patria; la seconda fase, che va dalla scomparsa delle lucciole agli anni'70, in cui questi valori non contano più e sono stati sostituiti da valori laici e consumistici. Particolarmente originale l’analisi del linguaggio dei comportamenti giovanili che fa Pasolini. Per lui infatti i codici fisici e mimici causano comportamenti e il nostro analizza proprio il linguaggio dei comportamenti per risalire ai codici culturali imposti dal potere. Infine è di fondamentale importanza la contrapposizione di due termini, ovvero sviluppo e progresso. Sviluppo significa per Pasolini produzione di beni superflui e aumento illimitato della produzione industriale, invece al termine progresso dà il significato di benessere della collettività, ideato e voluto da persone che non ragionano in base al proprio egoismo. Probabilmente tutti queste intuizioni e questi spunti polemici gli avevano creato dei nemici tra le persone potenti dell'Italia di allora, che forse avevano voluto colpirlo in quei frangenti, in cui era debole e ferocemente solo; notti in cui aveva assoluto bisogno di rompere la solitudine con incontri occasionali e furtivi. Negli ultimi anni della sua vita scriveva sul Corriere della Sera, diretto da Ottone.
L’OMOSESSUALITA’ COME SUO NEMICO:
La sua omosessualità non poteva essere adoprata dai potenti di turno come mezzo di ricatto per zittirlo o almeno indurlo ad essere più accomodante. La sua diversità sessuale era stata origine di sensi di colpa e di angoscia nella giovane età, però successivamente Pasolini aveva accettato questa parte di sé stesso. Nell'adolescenza e nella giovinezza certamente la scoperta della sua diversità era stata un dramma. In una lettera inviata all'amica Silvana Ottieri fine anni '40 scriveva: "E' una cosa scomoda, urtante e inammissibile, ma è così; e io, come te, non mi rassegno.....io ho sofferto il soffribile, non ho mai accettato il mio peccato, non sono mai venuto a patti con la mia natura e non mi ci sono neanche abituato. Io ero nato per essere sereno, equilibrato e naturale: la mia omosessualità era in più, era fuori, non c'entrava con me. Me la sono sempre vista come un nemico, non me la sono mai sentita dentro". Questa presa di coscienza non significava quindi che lo scrittore non si portasse con sé delle contraddizioni insanabili, come ad esempio le dinamiche interne di un complesso edipico non risolto. Infatti al sentimento ambivalente provato nei confronti del padre, prima tenente di fanteria e poi maggiore dell'esercito, contrapponeva un amore smisurato nei riguardi della madre. Il padre secondo il nostro provava risentimento e delusione nei suoi confronti per la sua diversità. In "Ritratti su misura" dichiarò: "Aveva puntato tutto su di me, sulla mia carriera letteraria, fin da quando ero piccolo, dato che ho scritto le mie prime poesie a sette anni: aveva intuito pover'uomo, ma non aveva previsto, con le soddisfazioni, le umiliazioni. Credeva di poter conciliare la vita di un figlio scrittore col suo conformismo". E ancora in un'altra intervista ebbe modo di dire: "La morte di mio fratello e il dolore sovrumano di mia madre; il ritorno di mio padre dalla prigionia: reduce, malato, avvelenato dalla sconfitta del fascismo, in patria, e in famiglia, della lingua italiana; distrutto, feroce, tiranno senza più potere, reso folle dal cattivo vino, sempre più innamorato di mia madre che non l'aveva mai altrettanto amato e ora era, per di più, solo intenta al suo dolore; e a questo si aggiunga il problema della mia vita e della mia carne" ["Al lettore nuovo"]. In "Supplica a mia madre" scrive: "Sei insostituibile. Per questo è dannata/ alla solitudine la vita che mi hai data. / E non voglio essere solo. Ho un'infinita fame /d'amore, dell'amore di corpi senz'anima./ Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu/ sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù". Ed ancora scrive: "Il mio amore è solo/ per la donna: infante e madre". Il poeta Dario Bellezza nel libro "Morte di Pasolini" era dell'avviso che Pasolini potesse amare le donne come uno stilnovista del trecento, ma che sessualmente era incessantemente attratto dai ragazzi delle borgate. In Pasolini si verificò quindi una scissione drastica tra la sfera affettiva e la sfera sessuale. Sentiva una sensazione di fusione talmente profonda nei confronti della madre, da avvertire in questo tipo di affetto il sentore di qualcosa di innaturale. Pasolini per preservare la purezza di questo sentimento nei confronti della donna che lo aveva generato e cresciuto non poteva che distogliere, spostare le sue pulsioni sessuali verso persone del suo stesso sesso. Amare una donna avrebbe significato cercare prima un'altra madre e poi avere un altro termine di paragone per la madre che lo aveva compreso e sostenuto, quando Pasolini - dopo lo scandalo in Friuli e l'espulsione dal partito - era da solo e sentiva gravare su di sè il marchio infamante di Oscar Wilde e di Rimbaud. Il padre al contrario aveva dimenticato Pier Paolo, sconvolto com'era dalla morte del figlio partigiano Guido, ucciso a sua volta dalla Brigata Garibaldi, legata ai partigiani di Tito. Probabilmente furono l'autoritarismo paterno, i continui spostamenti e trasferimenti a causa della sua carriera militare e le continue assenze del padre tra il 1941 ed il 1947 (perché inviato in Africa) a far crescere in lui un desiderio di identificazione con la madre. In questo senso l'intera opera omnia di Pasolini è una continua autoterapia, una incessante automedicazione della propria interiorità e allo stesso tempo è l'unica via per compiere un processo di individuazione, di accoglimento e di accettazione della propria Ombra per dirla alla Jung. I suoi scritti quindi non sono mai lineari, perché comprendono ed esprimono la complessità, la multilateralità e la frammentarietà della sua personalità; e la sua personalità era sfuggente e irrisolta e leggendo le sue pagine della sua totalità psichica è possibile percepire il senso globale, ma è controverso stabilire un'unità indissolubile perché nelle sue espressioni artistiche si avverte il continuo fluire di tutti i suoi stati psichici, mentali ed intellettuali mutevoli e temporanei. Angosce di persecuzione, elementi fantasmatici, nuclei inconsci ed emozioni di tipo depressivo si amalgamano con distinguo intellettuali sottili, con codici culturali dalla natura più disparata: si intrecciano razionalismo, illuminismo, religiosità ed un irrazionalismo, costituito da un vitalismo disperato e da una voglia costante di autodistruzione. In Pasolini non tutto ciò che è reale è razionale. Se è vero che la sua poesia non possiede fortunatamente istanze metafisiche, non è mai un mezzo per questo o quel tipo di filosofia e nemmeno per un eclettismo moderno, è altrettanto vero che con l'insieme dei suoi scritti è difficile fare i conti per quella mistura di sensibilità e conoscenza, per quella contrapposizione tra classico e moderno, per quel suo far ricorso sia alla filologia che all'ermeneutica, intesa in senso lato e quindi nell'accezione più moderna del termine. Nelle migliaia di pagine che ha lasciato ai posteri talvolta solo la sua genialità sembra agire da tessuto connettivo. Comunque il potere non poteva ventilare a Pasolini la minaccia di uno scandalo perché l’uomo Pasolini voleva lo scandalo a tutti i costi e dichiarava ed esibiva la sua diversità e mai e poi mai taceva sulle sue preferenze sessuali e sulla sua vita notturna; non solo, ma lo scrittore sosteneva a ragione che qualsiasi intellettuale che cercasse di dire la sua verità era uno scandalo vivente. In quegli anni il poeta de "Le ceneri di Gramsci" rappresentava un autentico scandalo intellettuale. Ricordo solo che venne accusato di pornografia per il romanzo "Una vita violenta" e di vilipendio alla religione di stato per il film "Ricotta".
IL PIACERE DI PROVOCARE E DI ESSERE PROVOCATO:
Il poeta senz'ombra di dubbio trovava piacere nell’essere provocato da un’opera d’arte, così come amava provocare con le sue opere, perché scandalizzare per lui era una modalità per far scaturire piacere al pubblico. Il poeta a mio avviso voleva essere amato oppure odiato. Non desiderava certo l’indifferenza. Amava che i suoi film fossero contestati dai giovani dell’estrema destra. Quando “Accattone” venne contestato dichiarò che gli italiani erano sempre stati un popolo razzista e che con quel film gli era stata data la possibilità di dimostrare quanto fossero razzisti. Ricordo che in “Accattone” nessuno dei personaggi era attore e tutte le persone che avevano preso parte al film appartenevano al sottoproletariato romano. Per Pasolini lo scandalo che suscitava il film non era tanto la rappresentazione tramite una pellicola del sottoproletariato romano, quanto il fatto che dei sottoproletari rappresentavano sé stessi e nient’altro che sé stessi, che delle persone fossero attori di sé stesse, che nelle scene impersonassero con la mimica, la loro gestualità, la loro parlata nient’altro che la loro condizione di uomini e donne emarginati dal Neocapitalismo ed ancora immuni dai disvalori della borghesia. I suoi romanzi stupivano la critica, figuriamoci se non stupivano il pubblico. E forse la ragione principale per cui stupivano la critica era il fatto che nei suoi romanzi non si poteva fare nessuna commemorazione provvisoria del personaggio-uomo, in quanto incentrati non sull'inettitudine e lo smacco esistenziale di un unico protagonista, ma sul collettivismo e la messa in scena di ragazzi, la cui psicologia era semplice. Nei romanzi di Pasolini il personaggio-uomo non era divenuto personaggio-particella a causa del tramonto dell'Occidente e del famoso principio di indeterminazione di Heisenberg. Lo scrittore friulano non volgeva lo sguardo a Proust, Joyce, Kafka, Svevo e Pirandello. Se spiazzava i più colti figuriamoci quindi lo scandalo che era avvenuto, quando fu pubblicato “Ragazzi di vita” tra il pubblico. Non erano tanto le vicissitudini dei protagonisti, la fine tragica dei ragazzi, né il triste epilogo del romanzo che scandalizzavano, piuttosto l’utilizzo del linguaggio delle borgate. Non erano solo i contenuti e le trame a scatenare reazioni di disapprovazione, ma erano anche e soprattutto le scelte linguistiche innovative che il poeta aveva adoprato nelle sue opere. L’utilizzo di un linguaggio diretto senza alcuna opera di mediazione o di elaborazione critica da parte dell’autore in quel determinato periodo della narrativa italiana non potevano che scandalizzare. Inoltre Pasolini con i suoi romanzi disorientava il pubblico perché aveva apportato delle innovazioni dal punto di vista strutturale del romanzo (in quanto nelle sue opere non c'era un vero e proprio protagonista, ma diversi personaggi; non solo ma c'era anche un contrasto forte tra il gergo delle borgate, il crudo realismo dei personaggi da una parte e dall'altra il lirismo e la sapienza descrittiva dei paesaggi). Un altro aspetto caratterizzante di queste opere di Pasolini era quello di riportare alla luce dei lettori una realtà degradata e diffusa come quella delle borgate romane. Non che il poeta avesse fatto divenire visibile ciò che prima era invisibile, ma aveva fatto riemergere alla coscienza ciò che veniva quotidianamente rimosso dal Potere e dal perbenismo della borghesia. Ma non poteva che essere che così. Il poeta sulla tomba di Gramsci non può che recitare i seguenti versi: "....attratto da una vita proletaria/ a te anteriore, è per me religione/ la sua allegria, non la millenaria/ sua lotta: la sua natura, non la sua / coscienza [.....]". Queste parole sono significative perché da esse si desume l'estraneità reciproca tra sottoproletariato e il partito comunista di allora. I ragazzi di vita non avevano una coscienza politica e non erano inseriti in un quadro istituzionale (lavoro, associazioni), né integrati in una dimensione macrosociale. Forse questo era uno scandalo perché già all'epoca si sapeva che il concetto di Sé è strettamente correlato al mondo sociale e che la dimensione interpsichica è una premessa irrinunciabile di quella intrapsichica. Pasolini aveva descritto in modo dettagliato e reale le esistenze dei sottoproletari, il loro universo di codici sottoculturali amorale prima ancora che immorale. Il senatore M. Montagnana scriveva sulla rivista “Rinascita“ del Pci : “Pasolini riserva le volgarità e le oscenità, le parolacce al mondo della povera gente”. Ritengo che in quegli anni anche persone di sinistra abbiano travisato il senso del romanzo “Una vita violenta”. Probabilmente erano arrabbiati anche per il tipo di rapporto tra il Tommaso di "Una vita violenta" e il Pci, perché costui muore. Questa morte venne forse letta in chiave metaforica, come a dire che, nonostante l'avvicinamento del personaggio sottoproletario il Pci non poteva stabilire con esso nessun rapporto stabile e costruttivo. Se la borghesia incarna il potere e l'ordine costituito, il proletariato una possibile rivoluzione, al mondo contadino ed al mondo sottoproletario non spetta che rimanere ai margini della realtà industriale. Ma mentre si verifica la scomparsa effettiva del mondo contadino, dato che i contadini divengono operai, i sottoproletari restano tali e finiscono per essere una massa pressante di persone, che vivono alla periferia della periferia e che rifiutano i canoni ed i codici di comportamento della borghesia e del proletariato. Pasolini comunque non era classista né la rappresentazione pasoliniana del mondo delle borgate poteva essere politicizzata. Nelle sue opere non si può riscontrare nessun atteggiamento di paternalismo né di bonaria indulgenza nei confronti dei ragazzi del sottoproletariato.
”PIETAS”:
La coscienza di Pasolini era al contrario permeata da una vera pietas, che non scadeva mai nel melenso. Se alcuni hanno ravvisato nei suoi lavori una rappresentazione negativa del sottoproletariato non hanno considerato in film come Accattone che Pasolini aveva come referente il neorealista Rossellini, così come nei suoi romanzi non hanno colto che ogni testo letterario è criticamente ricostruito e che lo scrittore non poteva abbellire la realtà perché sarebbe venuto meno al suo principio di mimesi del reale, al suo intendimento di compiere una semiologia della realtà. Era senz'ombra di dubbio un elemento perturbante nei fruitori di queste sue opere l'impossibilità di distinguere nettamente il suo sguardo poetico al documentarismo sociologico del sottoproletariato degli anni '50-60. Ma forse una cosa molto semplice che disturbava era la mancanza di un finale idilliaco e invece nei due romanzi di Pasolini nessun personaggio riesce a compiere una maturazione, se non culturale, quantomeno psicologica, a causa di una chiusura e di una frattura insanabile tra l'universo statico del sottoproletariato ed il mondo delle persone già integrate. Se i suoi ragazzi di vita ammazzano per avere la grana a tutti i costi per spassarsela ciò non implica che i loro coetanei più ricchi non possano fare altrettanto. Pasolini non svolge l’equazione delinquenza uguale povertà più sfortuna né tantomeno il poeta vuole emendare da colpe o giustificare i suoi ragazzi che compiono azioni criminose. Allo stesso tempo non fa della sociologia marxista a buon mercato quando avviene il massacro del Circeo. Pasolini lo sa bene che non essere pariolini non può preservare dal compiere delitti orrendi e sevizie. L’agiatezza economica non causa necessariamente il nichilismo, che porta a compiere mostruosità all’arancia meccanica. Lo scrittore guarda tutto ciò da un punto di vista meramente antropologico. I giovani sono omologati. Tutti i giovani di qualsiasi classe sociale. L’amoralità giovanile li accomuna e li unisce in un tutto indistinto. Infatti come ha notato il critico letterario G. Scalia l’omologazione della società neocapitalista secondo Pasolini non ci aveva fatti divenire uguali in quanto uguali nei diritti, ma simili nella degradazione. Lo scrittore di “Ragazzi di vita” non si prefigurava nel futuro una società fondata sulla vera libertà, ma su una parvenza di libertà o per meglio dire su una libertà negativa. La stessa evoluzione dei costumi dal poeta non era vista di buon occhio. La libertà sessuale della maggioranza era stata regalata dal Potere per distrarla dai reali problemi del Paese. Era quindi una nuova libertà, tuttavia una tolleranza imposta, che non poteva che causare nevrosi. Pasolini non si era mai riconosciuto in questo tipo di società e allora aveva sentito la necessità di creare il mito contadino, il mito del sottoproletariato ed il mito terzomondista. Nel mondo contadino la vita di ognuno era scandita dall'avvicendarsi delle stagioni, ma con l'avvento della società capitalistica il ciclo della natura era stato soppiantato dal ciclo della produzione industriale. La simbiosi tra Vangelo e civiltà contadina era finita bruscamente. Per Pasolini il mondo contadino simboleggiava la vera essenza del tradizionalismo del Passato, che era latore di universali ed archetipi davvero cristiani. Il mito del mondo contadino per il poeta andava a costituire il nucleo più profondo del cristianesimo. In questo senso ritengo che ci siano almeno delle similitudini tra Pasolini e Tolstoj. Pasolini a tratti sembra un novello Tolstoj, che scrivendo metaforicamente del carro rovesciato della società russa, che grava sui contadini, non si mette a disquisire su quante persone salgono sul carro o su come devono essere posizionate le ruote, ma che evocando con nostalgia il passato invita quasi gli sfruttati a vivere secondo i comandamenti di Dio. Fuor di metafora: l'impostazione marxista è evidente, il consumismo crea nuovi bisogni, ma non soddisfa quelli elementari dei più, la merce diviene feticcio, però non bisogna fare la rivoluzione, ma abbracciare Marx e Cristo. Una volta giunto a Roma lo scrittore aveva bisogno anche del mito del sottoproletariato, cioè di un macrocosmo di individui non ancora contaminati dal Neocapitale. Entrambi i miti pasoliniani possedevano dei caratteri intrinseci e dei significati intimi, che trascendevano la morfologia e la metafisica di un sistema di pensiero. Prima veniva il cuore, poi Pasolini metteva in moto il pensiero, infine ritornava al cuore. Al poeta friulano non restava che attaccarsi con tutta la sua forza e la sua energia creativa al mito del sottoproletariato per cercare di aggrapparsi disperatamente ad un'umanità altra, che non appartenesse a quella massa collettivizzata ed amorfa del proletariato e della borghesia, così come non restava che sperare nel mito terzomondista per pensare ad un altro tipo di sviluppo possibile della società. Ne "La religione del mio tempo" scriveva "Africa! unica mia/ alternativa.....". Se il mito contadino rappresentava il passato ed il mito del sottoproletariato il presente, il mito del terzomondismo invece simboleggiava l'avvenire.
giu 112022 SU CLAUDIO LOLLI
SU CLAUDIO LOLLI
Molti cantautori italiani sono scomparsi prematuramente. Si pensi solo a Fred Buscaglione, Luigi Tenco, Rino Gaetano, Lucio Battisti. Claudio Lolli, uno dei padri della canzone d'autore italiana, è morto a 68 anni nel 2018. È scomparso anzitempo se consideriamo l'aspettativa di vita in Italia, seppur non giovanissimo. Soltanto con la pubblicazione del suo ultimo album è riuscito a vincere la targa Tenco, nonostante avesse frequentato per anni quel palco. Ciò è il segno che la qualità del cantautorato fosse elevata, ma dimostra anche una certa incomprensione, una certa miopia nel giudicare l'arte di Lolli. Qualcuno negli anni Settanta diceva molto malignamente che Lolli istigasse al suicidio, ma era totalmente errato. Invece amava la vita. È del tutto naturale talvolta guardarsi indietro, volgersi dietro, soffermarsi a pensare al tempo trascorso. La malinconia è un sentimento universale, una costante umana e assumono una posa coloro che non ne parlano o fingono di non provarla in nome di una presunta oggettività o in nome di un posticcio stoicismo. Il nostro non era per autodistruzione ma per piacere, peraltro moderato, che amava le sigarette ed il vino. Lolli era un poeta malinconico prestato alla canzone e ispirato da una autentica passione civile. Eppure non si riteneva un poeta. Pensava che la canzone d'autore fosse una supplente della poesia contemporanea. Era da sempre schierato contro la retorica ma anche contro la puerilità delle canzonette. Non cercava mai formule facili né slogan politici, pur essendo dichiaratamente di sinistra. Certe sue canzoni sono dei ritratti memorabili di un'Italia che non esiste più. Lolli è stato cervello acuto e cuore pulsante del movimento studentesco bolognese; mai sdolcinato, mai mellifluo, è rimasto negli anni sempre fedele a sé stesso; ha sempre saputo suscitare emozioni e sentimenti senza mai voler persuadere nessuno. Per dirla con una delle sue ultime canzoni non è stato un uomo senza amore. I suoi testi sono sempre stati incisivi, letterari e pregnanti. Lolli ha cantato il tormento, la disillusione, l'estraneità, l'inadeguatezza della sua generazione, alternandoli a momenti di intimismo. Nonostante il riflusso ed il disastro degli anni Ottanta ha continuato a descrivere i vizi e le virtù della nostra penisola. Anche musicalmente è sempre stato originale, sapendo fondere elementi di jazz con il rock progressive. Per dirla alla Vittorini ci sono due tipi di opere creative: quelle che ci confermano il mondo come noi lo conosciamo e quelle che ci fanno vedere in modo nuovo il mondo. Ebbene Lolli aveva un suo stile unico, inconfondibile e personale. Spicca per il lirismo con cui ha cantato i giovani del '77 e con cui ha cantato la sua Bologna. Era per quanto possibile contro il sistema. Infatti dopo il successo chiuse i rapporti con la EMI, una multinazionale, per approdare a una casa discografica indipendente. Insomma nessuno poteva dargli del venduto in quanto era di specchiata moralità, lontano da ogni tipo di compromesso. Ritornando al discorso della nostalgia, tutt'al più si sarebbe potuto considerare depresso ma non deprimente. Lolli aveva molto da dire e le sue canzoni lo hanno sempre testimoniato. È stato il poeta della generazione bolognese del 1977. Ha cantato le inquietudini, le contraddizioni, le speranze, i sogni di quella generazione. Come ha detto il professor Franco Berardi, detto Bifo, quella generazione, difficilmente inquadrabile ed etichettabile, e con essa Claudio Lolli aveva il merito fondamentale di chiedersi cosa fosse la felicità. Il nostro ha frequentato e influenzato altri cantautori impegnati. Ha insegnato a Vecchioni a strafregarsene dei ritornelli. Si è dedicato con passione all'insegnamento e ha lasciato una traccia indelebile nei suoi studenti. È stato un docente umano, mai fazioso o settario, sempre pronto a formare culturalmente invece che a deformare giovani menti a propria immagine e somiglianza. Era un uomo di parte ma mai fazioso e sempre aperto al confronto, al dialogo. Era perfettamente consapevole che nessuno ha la verità in tasca e che chiunque ha la facoltà di fare la propria scelta di campo. L'insegnamento, peraltro mestiere sempre svolto ottimamente, è stata anche una scelta obbligata per garantirsi uno stipendio fisso e per avere più libertà come cantautore. Claudio Lolli ha raccontato di aver preso la decisione di insegnare dopo aver cantato un pomeriggio in una discoteca di Salerno. Prima ha fatto un lungo viaggio da Bologna a Salerno. Poi ha cantato davanti ad un pubblico disinteressato, impaziente di scendere in pista a fare quattro salti. Capì allora che per garantirsi un futuro doveva insegnare. Lolli raggiunse il culmine del successo con l'album "Ho visto anche degli zingari felici". È nella prima canzone dell'album che tratta delle conflittualità e delle incomprensioni della sua generazione, di quella dei suoi genitori, mentre propone i rom come un mondo altro, che può proporre altri valori e un'altra vita. I rom quindi come realtà alternativa da valutare seriamente e a cui guardare con interesse. Ma in quell'album c'era anche "Anna di Francia" in cui scriveva che l'alternativa non era "solo ideologia ma organizzazione". Aveva naturalmente ragione. Si pensi a quante astruserie e quanti discorsi fumosi la classe operaia era destinata a sorbirsi quando nessun ex operaio sedeva tra gli scranni del parlamento e la vera cultura operaia era un'utopia. Non parliamo poi di una organizzazione umana e scientifica nelle fabbriche italiane, dove si guardava ancora a Taylor e Ford negli anni Settanta, negli anni Ottanta si considerava solo alla produzione di massa, e le scoperte più recenti della psicologia del lavoro non venivano minimamente considerate. Un'altra canzone che fece epoca è Michel, storia di un'amicizia dalla fanciullezza alla giovinezza tra due ragazzi in cui venivano amalgamate invidia, affetto, rivalità, piccoli bisticci. È vero che gli amici di infanzia non ce li scegliamo un poco come i parenti, ma allo stesso tempo sono figure fondamentali che hanno plasmato la nostra personalità di base e fanno parte della nostra esperienza atavica e primordiale. Spesso sono ricordi lontanissimi, che talvolta scacciamo dalla mente, però poi ritornano quando meno ce lo aspettiamo nei nostri sogni. Michel è una storia triste con l'amico che se ne va, la sua madre che muore, l'addio alla stazione. Michel come dichiarò in una intervista Lolli era finito malandato, trasandato, povero in Francia, dalle notizie che aveva avuto. Ma ogni volta che la cantava in un concerto era una pagina memorabile della memoria, era la rievocazione di un'amicizia. In "Venti anni" Lolli testimonia la grandezza e la miseria di quell'età, la condizione esistenziale di chi era giovane allora. In "Borghesia" il cantautore bolognese aveva denunciato la piccolezza e la grettezza di quella classe sociale da cui proveniva. In Lolli troveremo più volte nelle sue canzoni la conflittualità edipica della sua estrazione borghese e della sua formazione intellettuale progressista. Chiunque sia solo e diremmo oggi sfortunato con le donne si riconosce benissimo in "Quelli come noi". In "Piazza bella piazza" viene trattato il tema delle stragi di Stato, nel caso specifico dell'Italicus. La rabbia di chi vive in periferia è descritta magistralmente in "Io ti racconto". Ma il cantautore ha saputo scrivere anche delle belle poesie d'amore come "Donna di fiume" e "Vorrei farti vedere la mia vita". Più recentemente con "Il grande freddo" ha fatto una metafora e allo stesso tempo un resoconto di quella generazione di contestatori. Da notare che il titolo dell'album è un riferimento al film omonimo di Kasdan, in cui degli ex liceali sessantottini si ritrovano quindici anni dopo al funerale di un loro compagno e fanno un bilancio complessivo. Ma in Lolli il discorso poi alla fine si estende a tutta l'umanità e non riguarda solo la sua generazione. È indicativo a riguardo che il cantautore pensi all'amore perduto e sprecato sugli autobus. Oggi Lolli viene riscoperto e giustamente valorizzato però più dagli intellettuali che dai mass media. D'altronde non poteva essere altrimenti per uno che aveva come maestri Dylan, Cohen, Brel, Brassens. Recentemente Luca Carboni ha fatto una cover di "Ho visto anche degli zingari felici". È consigliabile però ascoltare tutte le canzoni di Lolli e non fermarsi alle più celebri. Leggete in rete per farvi un'idea della grande qualità dei suoi testi. Ascoltate su YouTube le sue canzoni. Comprate i suoi CD. Si rimane stupiti della sua precocità artistica. Poco più che ventenne dimostrava già una grande maturità e una grande umanità. Così come ha sempre impressionato la sua prolificità (più di venti album, delle raccolte di racconti, una silloge poetica, un romanzo) e il fatto che non avesse cadute di tono. Allo stesso tempo nelle sue opere troviamo un fil rouge, ma in ognuna di esse si può verificare quanto il cantautore sapesse rinnovarsi e sperimentare artisticamente. Ogni canzone era diversa, ma aveva lo stesso imprinting e lo stesso imprimatur. Il cantautore è stato fratello maggiore, compagno, professore, amico di molti ragazzi. Recentemente hanno preparato un evento intitolato "Da Lolli e dintorni. La poesia civile di Claudio Lolli", a cui hanno preso parte grandi nomi della cultura come Massimo Recalcati, Fulvio Abbate, Alberto Bertoni, Gianni D'Elia, Rossella Postorino. C'è da augurarsi vivamente che Lolli non finisca nel dimenticatoio, come altri nomi validi del cantautorato come Stefano Rosso (per apprezzare veramente Alex Britti bisogna sapere chi era), Claudio Rocchi, Piero Ciampi (d'accordo c'è un premio in sua memoria, ma è troppo poco).
SU GUCCINI
Francesco Guccini è entrato nel mondo della musica prima come autore, per Caterina Caselli, Equipe 84 e Nomadi, che hanno cantato "Auschwitz", "Per fare un uomo", "Dio è morto", "Noi non ci saremo". Guccini prima del successo ha fatto anche il cronista. Per celebrare i suoi 80 anni è uscito "Note di Viaggio - capitolo 2", raccolta di canzoni di Francesco Guccini, interpretate da Zucchero ("Dio è morto"), Fiorella Mannoia ("Signora Bovary"), Emma e Roberto Vecchioni ("Autunno"), Vinicio Capossela ("Vedi cara"), Gianna Nannini ("Quello che non"), Jack Savoretti ("Farewell"), Levante ("Culodritto"), Mahmood ("Luna fortuna"), Petra Magoni ("Canzone di notte n.2"), Ermal Meta ("Acque"), Fabio Ilacqua e Mauro Pagani ("Canzone delle domande consuete") e I Musici ("Migranti"). Il cantautore si è dimostrato longevo per uno che per molto tempo ha fumato due pacchetti di sigarette al giorno, come cantava in "Ho ancora la forza". Più leggendario e poco corrispondente al vero il fatto che si ubriacasse molto. Non è mai stato un alcolizzato. Diciamo che in gioventù è stato a tratti un forte bevitore, un frequentatore come tanti delle osterie di fuori porta. Ad onor del vero in quelle osterie bolognesi negli anni Sessanta facevano anche molta cultura. Guccini frequentò assiduamente l'osteria delle Dame, ideata addirittura da un frate domenicano, e poi anche l'osteria dei Poeti, a cui dedicò anche una canzone leggera, breve ma significativa. Come non ricordare poi l'osteria da Vito, frequentata anche da Gaber, De André, Red Ronnie, Ron, Lucio Dalla? Guccini lì si divertiva ad improvvisare ottave con Roberto Benigni e Umberto Eco. In queste osterie e anche nella sua casa bolognese in via Paolo Fabbri 43 passava il tempo con gli amici, conversando amabilmente e facendo "due canzoni alla leggera". Guccini frequentò anche alcuni poeti contemporanei come Adriano Spatola e Giulia Niccolai. I due poeti del gruppo 63 stavano assieme e sulla fine del loro amore il cantautore scrisse la bellissima "Scirocco" . Guccini è stato anche un talent scout. Il duo comico Gigi ed Andrea ha iniziato a lavorare grazie a lui. Il maestrone è stato anche attore nei film di Pieraccioni. Posso affermare con certezza che in una prefazione di un libro su Camus a proposito dell'incidente stradale fatale, che costò la vita al Nobel francese, erano citati i versi di "Canzone per una amica". Lo stesso Tondelli in un libro cult come Weekend postmoderno riporta fedelmente alcune strofe gucciniane. Dirò di più: negli anni '90 vendevano le maglie con Jim Morrison ritratto ma anche quelle con Guccini. Io sono un estimatore e un affezionato di Guccini da tempo immemorabile. Ricordo che già a quattordici anni mi scervellavo con i suoi testi, anche se Guccini in una intervista dichiarò che le sue canzoni erano per i trentenni, se non mi ricordo male. Forse era questo il suo target ideale ed era uno svantaggio in una industria discografica fatta ad uso e consumo dei quindicenni e delle loro effemeridi. Il cantautore bolognese è sempre stato un personaggio atipico nel panorama della musica leggera italiana. Non è mai sceso a compromessi ed è sempre uno che è sempre stato coerente alle sue idee. Se ne è sempre infischiato di Sanremo, delle rime amore e cuore, dei ritornelli. Non è mai stato commerciale e non ha mai avuto i pregiudizi di chi si sente artista, come cantava in Keaton. È sempre stato critico nei confronti del mondo dello spettacolo, come quando per esempio narrava la storia di Fantoni Cesira. Il pubblico lo ha sempre seguito e i critici musicali lo hanno sempre osannato, tranne Bertoncelli che criticò l'album "Stanze di vita quotidiana" e perciò venne menzionato ne "L'avvelenata". Nonostante ciò i due dopo si riappacificarono e divennero amici. Da un certo punto di vista, nonostante il suo merito indiscusso, è stato anche fortunato perché non sempre in Italia il talento è riconosciuto, come dimostrano i casi di Piero Ciampi, Claudio Lolli, Mario Castelnuovo. Umberto Eco comunque sosteneva che era il più colto dei cantautori. Gaber sosteneva che i bolognesi dovevano tenere stretto un artista come Guccini. Così Gaber dichiarò: "Bolognesi! Ricordatevi: Sting è molto bravo, però tenetevi il vostro Guccini. Uno che è riuscito a scrivere 13 strofe su una locomotiva, può scrivere davvero di tutto". Il celebre italianista e professore Ezio Raimondi lo stimava molto. D'altronde il cantautore è rinomato per la bellezza e la complessità poetica dei suoi testi, alcuni dei quali sono finiti nelle antologie scolastiche di scuola media inferiore. Parla di drammi collettivi senza essere mai retorico, parla d'amore senza mai essere sentimentale. È al tempo stesso politico e privato, esistenziale e metafisico, così completo e versatile come pochi autori di canzoni sanno essere. Guccini non ha mai rinunciato all'impegno, alla dignità letteraria, al diritto di non scadere in semplificazioni e ovvietà. Nelle sue canzoni troviamo citazioni colte, archetipi letterari e mitologici. Mi ricordo che da quindicenne mi colpivano molto alcuni suoi versi, che allo stesso tempo risuonavano nella mia mente profetici ed oscuri. Come in "Canzone della bambina portoghese", quando canta "tutti chiusi in tante celle fanno a chi parla più forte per non dir che stelle e morte fan paura". Guccini è sempre stato impegnato politicamente, anche se come scrive in "Don Chisciotte" ha sempre riconosciuto che "l'ingiustizia non è il solo male che divora il mondo, anche l'anima dell'uomo ha toccato spesso il fondo". La canzone che mi emoziona di più è "Piccola città" perché riesce ad evocare in me sensazioni, pensieri e ricordi. In quella canzone tratta magistralmente della noia del vivere in provincia ma anche dell'amore ed odio, del rapporto conflittuale che molti provano nei confronti dei propri borghi. Guccini mi ricorda anche uno dei miei più grandi innamoramenti non ricambiati. Avevo 20 anni e spasimavo per una ragazza carina, che allo stesso tempo conosceva come me a memoria molte canzoni di Guccini. Comunque mi disse di no. Si è sposata con un altro e ha fatto un figlio. Guccini mi ricorda i miei venti anni persi dietro ad una che non ne voleva proprio sapere: ingenuità ed incoscienza giovanili! La stima incondizionata per il famoso cantautore però è rimasta. Guccini ha ricevuto molti consensi perché è stato il compagno di molte generazioni di giovani. Ha cantato la contestazione con "Dio è morto", con "Eskimo". Ha cantato l'anarchia con "La locomotiva", storia dell'attentato di un ferroviere estremista. Ha cantato con grande sensibilità e umanità gli orrori nazisti con il brano "Auschwitz". Ha cantato l'emigrazione con "Amerigo". Ha cantato l'amore con "Cyrano", "Vorrei", "Farewell", "Vedi Cara", "Autogrill", "Ti ricordi quei giorni". Ha cantato l'amicizia con i brani "Gli amici", "Canzone per Piero", "Incontro" . Guccini ha partecipato molto spesso al premio Tenco. Cantava con Vecchioni, con Ligabue. Il primo gli ha dedicato la bella "Canzone per Francesco" . Il secondo più recentemente gli ha dedicato la ballata "Caro il mio Francesco". Ma si perderebbe il conto di tutte le canzoni che ha scritto Guccini e quelle che ha ispirato e fatto scrivere. Il cantautore ha ricevuto due lauree ad honoris causa ed è stato fatto Ufficiale della Repubblica: non è poi male per uno che è sempre stato contro! Nell'adolescenza e nella prima giovinezza ha vissuto a Modena, poi è vissuto a Bologna (dove ha anche insegnato all'università per stranieri) e ora si è ritirato a Pavana, un paesino ridente nell'Appenino tosco-emiliano, vicino a Porretta Terme. Giornalmente vengono a trovarlo i suoi fan. Ha rinunciato da alcuni anni a tenere concerti. Aveva dei piccoli malori quando teneva un concerto, ma poi dalle visite mediche non risultava niente. Gode ancora di ottima salute e si è dedicato da anni con successo alla scrittura di romanzi. È uno studioso di lessicografia. Ha scritto anche alcuni gialli con Loriano Macchiavelli. Ha dimostrato facilità di scrittura, prolificità e stile anche con i libri.
giu 112022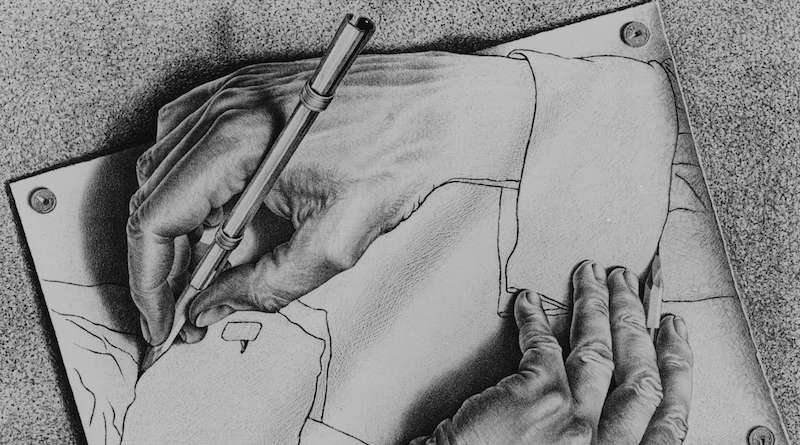 Nell’enciclopedia Treccani alla voce “autofiction” si trova scritto: “Il termine autofiction, coniato nel 1977 dallo scrittore francese Serge Doubrovsky in riferimento al suo romanzo Fils, indica il genere letterario in cui l’autore stesso è il protagonista delle vicende di finzione narrate. Nato con un’esplicita ispirazione psicoanalitica, come indagine sull’inconscio, e utilizzando gli stilemi del nouveau roman, in anni più recenti, con l’arrivo del post moderno, il tema più diffuso nei lavori di a. sembra essere piuttosto il rapporto problematico tra verità e menzogna, tra identità e differenza, in una società dominata dalle immagini tecniche e dai simulacri (in Italia, si veda, per es., il romanzo di Walter Siti, Troppi paradisi, 2006)”.
Nell’enciclopedia Treccani alla voce “autofiction” si trova scritto: “Il termine autofiction, coniato nel 1977 dallo scrittore francese Serge Doubrovsky in riferimento al suo romanzo Fils, indica il genere letterario in cui l’autore stesso è il protagonista delle vicende di finzione narrate. Nato con un’esplicita ispirazione psicoanalitica, come indagine sull’inconscio, e utilizzando gli stilemi del nouveau roman, in anni più recenti, con l’arrivo del post moderno, il tema più diffuso nei lavori di a. sembra essere piuttosto il rapporto problematico tra verità e menzogna, tra identità e differenza, in una società dominata dalle immagini tecniche e dai simulacri (in Italia, si veda, per es., il romanzo di Walter Siti, Troppi paradisi, 2006)”.
Leggevo di recente un articolo del grande poeta e scrittore Roberto Pazzi, in cui si lamentava del fatto che oggi vada per la maggiore l’autofiction (Saviano, Giuseppe Genna, Walter Siti, Teresa Ciabatti, etc) e sia troppo diffuso il “microautobiografismo”. Secondo questa scuola di pensiero troppi autori sono egoriferiti, sono troppo coinvolti emotivamente, non riescono a mettere a distanza le loro cose della vita, non riescono a utilizzare un sufficiente distacco (forse semplifico, ma in realtà certe ragioni vengono sottintese e mai esplicitate da molti). A tale riguardo scrivevo in tempi non sospetti, ovvero 30 anni fa, che la vita è un’immagine che si può mettere a fuoco solo quando si è distanti. Ma secondo un’altra scuola di pensiero “Madame Bovary c’est moi”, così come è sempre valido il detto veneto “pittore parla dei quadri”, ovvero noi stessi siamo la materia che conosciamo (alcuni come il poeta Vittorio Orlando affermano che l’unico progresso è quello interiore). Secondo questa seconda scuola di pensiero perché dovremmo inventare eventi o personaggi quando possiamo prendere a piene mani dalle nostre vite? In fondo mi chiedo io chi ha detto che per passare dal particolare all’universale bisogna per forza trasfigurare e creare? Perché non attingere totalmente o quasi dalle nostre vite? Perché non trattare di noi invece di creare mondi fittizi? Aggiungo anche che le neuroscienze hanno dimostrato, grazie all’utilizzo della risonanza magnetica funzionale, che la mente umana attiva undici aree cerebrali ogni volta che immagina, ma è anche vero che immaginare non è creare ex novo o creare ex nihilo. L’immaginazione umana manipola e combina vecchie immagini. Che poi le immagini mentali ci suggestionino e influenzino direttamente la nostra vita è vero, ma è altrettanto vero che anche l’artista con più immaginazione inizia sempre dal materiale preesistente della sua vita. L’autofiction è perfettamente in linea con tutto ciò. E allora perché deve essere visto male parlare di sé? Perché uno scrittore deve parlare d’altro per poi finire immancabilmente di parlare di sé stesso? Perché fingere totalmente? Perché parlare d’altro!? Perché fare un gioco di sponda? Perché traslare? Perché non affrontare subito e in tutta onestà ciò che ci sta più a cuore o forse ciò che ci riguarda di più, ovvero noi stessi? Chi ha detto poi che dei fatti biografici non possano creare empatia e rispecchiamento? In fondo è sempre difficile stabilire quanto io c’è nel mondo che percepiamo e quanto mondo c’è nel nostro io. Per l’eterogenesi dei fini talvolta chi cerca il mondo trova l’io (le sue proiezioni, i suoi fantasmi psichici) e viceversa chi cerca l’io trova il mondo. Difficile è anche cercare una linea di demarcazione tra io e mondo perché l’interazione è continua, il flusso è ininterrotto. Forse l’autofiction è il punto d’incontro ottimale tra realtà e finzione. Certo parlare di sé significa avere più remore, significa autocensurarsi, avere più inibizioni, andare incontro a disapprovazione sociale, ma è altrettanto vero che scrivere significa mettersi a nudo. Poi ci potrebbero essere delle grane legali a parlare troppo della propria vita. Se uno scrive di fantasia ogni riferimento è puramente casuale. Se il libro è autobiografico ogni riferimento può essere causale e possono perciò fioccare le querele. Forse anche in questo caso l’autofiction è la strada migliore. Però ci sono anche delle controindicazioni: oggi i libri subiscono un editing molto forte in nome del politicamente corretto; questo forse vuol dire che in fondo è più ammissibile per il pubblico una storia inventata con alcune venature maschiliste per esempio che un romanzo autobiografico, dato che nel primo caso uno si può sempre difendere dicendo che punto di vista dell’autore e quello della voce narrante non necessariamente coincidono. Se un lettore moralista vuol pensare male a ogni modo lo farà anche di fronte a una storia erotica inventata di sana pianta, sostenendo che certe cose per scriverle così bene bisogna averle provate. Certamente oggi il gossip letterario è scarso: sono lontani i tempi in cui nei salotti letterari si vociferava che Saba fosse omosessuale per via dell’iniziazione omosessuale del protagonista del suo unico romanzo “Ernesto”. Certo c’è anche chi ce l’ha con l’autofiction perché troppo confessionale, troppo intima. Sarebbe prima di tutto una questione di pudore, di discrezione per taluni, fino a sentenziare che i fatti propri di questo o quell’autore non interessano a nessuno. Ma allo stesso tempo non tutta la fantascienza, non tutto il fantasy o non tutto il realismo magico interessano ai più! Un altro motivo per cui si può criticare l’autofiction è la parte saggistica in ogni suo romanzo oppure quella metaletteraria. Anticamente la prosa doveva essere barocca, a costo, nei casi peggiori, di dimostrare la propria bravura con un periodare involuto. Nel Novecento il miglior prosatore appartenente a questa scuola è stato Giorgio Manganelli, che si caratterizzò sempre per genialità, sperimentalismo, grazia, cultura, immaginazione. Dal punto di vista narrativo “Centuria” e dal punto di vista saggistico “Letteratura come menzogna” ne sono le prove incontestabili. Un tempo c’era inoltre una distinzione netta tra narratori puri (come Pavese, Cassola, Tondelli) e descrittori (primo tra tutti Calvino e i suoi epigoni). Per decenni avuto la meglio i descrittori puri. Oggi invece per pubblicare in una grande casa editrice un romanzo di solito deve avere un taglio descrittivo e a tratti deve essere anche un romanzo saggio. Oppure se un romanziere vuole soddisfare la critica militante può scrivere un romanzo anche senza trama, ma caratterizzato da straniamento (tanto per fare due esempi come nel caso del cavallo narratore in “Cholstomér” di Tolstoj o come in “Sentinella” di Brown, in cui il narratore a sorpresa è un alieno) e pluristilismo. Il flusso di coscienza invece non sembra avere più successo, almeno non ricalcando gli stessi stilemi di Joyce, Faulkner, Woolf, né ricalcando il flusso di coscienza totalmente alterato di Burroughs. C’è anche chi dice comunque che con l’autofiction non hanno inventato niente perché essa esisteva da secoli. C’è infine chi non critica totalmente il genere, ma pensa che l’autofiction dovrebbe essere scritta meglio. Insomma come al solito in molti si azzuffano e i libri non si vendono. In tutta onestà non tutti i dettami della critica devono per forza corrispondere al vero, così come non sempre il successo di un genere decretato dal pubblico deve per forza essere garanzia certificata di chissà quale qualità (Arbasino ricordava che ragionando in questo modo i migliori ristoranti del mondo sarebbero i McDonald’s). Che poi sia che un autore si rivolga all’interno o all’esterno ci sarà pur sempre una concavità o una convessità, una introflessione o una estroflessione: insomma la lente sarà sempre deformante, ci saranno perciò sempre delle deformazioni nell’opera. Che cosa c’è davvero di oggettivo nell’arte e nel mondo interiore? Quando uno studente chiese al grande matematico Caccioppoli quale fosse la legge più vera in assoluto, ebbene lui rispose: “Al cuore non si comanda”. Un altro grande matematico, Galois, fu la dimostrazione che “al cuore non si comanda”: fece un duello per difendere la donna che amava e sempre per amore, questa volta della sua disciplina, rivide e corresse tutti i suoi appunti la notte prima del duello in cui morì. In definitiva mi sembra che queste due scuole di pensiero (pro autofiction o contro) ripropongano in piccola parte l’antica disputa realismo/idealismo. Ritengo che la scelta artistica di trattare di sé o di altri può maturare in base all’introversione/estroversione dell’autore e quindi dalla sua personalità di base. C’è sempre un orientamento verso l’io o il mondo, una predilezione accentuata. Nessuno riesce a stare a metà strada tra queste due polarità. Forse non è una caratteristica umana riuscire a trovare l’equilibrio e anche l’armonia tra le due cose. Ci sono autori che hanno un atteggiamento quasi schizoide sulla polarità da scegliere. Kafka scrisse: “Non esiste altro mondo fuorché il mondo spirituale. Quello che noi chiamiamo mondo sensibile è il Male del mondo spirituale”. Sempre Kafka in “Quaderni in ottavo” scriveva: “Quanto misera è la conoscenza che ho di me stesso, paragonata – poniamo – a quella che ho della mia stanza. Perché? Non esiste un’osservazione del mondo interiore, come ne esiste una del mondo esterno. La psicologia descrittiva è in complesso un antropomorfismo, un modo di intaccare i limiti. Il mondo interiore si può solo vivere, non descrivere. – La psicologia è la descrizione del rispecchiarsi del mondo terreno sulla superficie celeste, o meglio: la descrizione di un rispecchiamento, come ce lo immaginiamo noi, creature impregnate di terra, perché in realtà non c’è alcun rispecchiamento, siamo solo noi che vediamo terra dovunque ci volgiamo”. È difficile trovare l’equilibrio interiore, ma altrettanto è difficile trovare quello artistico. È difficile scegliere dove volgersi, se verso lo scavo di sé o verso l’estensione nel mondo. Ma quale sarebbe l’opposto dell’autofiction? Per esempio la polifonia, descritta da M.Bachtin. Quest’ultimo prendeva come modelli i romanzi dialogici di Dostoevskij. Un romanzo secondo questa scuola sarebbe ben congegnato quando vi sarebbe una molteplicità di punti di vista. Ma viene da pensare anche che una buona autofiction può essere polifonica. Per accontentare pubblico e critica una buona autofiction dovrebbe contenere polifonia (ovvero alterità) e straniamento (ovvero rovesciamento dei punti di vista). A ogni modo non bisogna scegliere in base alle mode del momento, ma in base a ciò che sentiamo noi stessi dentro. Ben sapendo che qualsiasi cosa scegliamo ci sarà qualcuno che ce lo rinfaccerà. Comunque sia, come ha detto Walter Siti: ““Lo stile non si preoccupa del like”. Ma le cose andrebbero bene in Italia se prevalesse realmente l’autofiction di Siti e Genna. In realtà sono egemoni le micronarrazioni degli/delle influencer e anche le autofiction continue dei reality show e dei talk show. In tutta onestà a onor del vero l’autofiction letteraria, croce o delizia, è destinata purtroppo a un pubblico di nicchia. La vera narrazione oggi avviene purtroppo al di fuori della letteratura: il surrogato ha da tempo preso posto ormai dell’originale, il supplente ha sostituito a tempo pieno il titolare. Il pubblico letterario stesso ormai è come una donna che si è innamorata dell’amante e ha lasciato definitivamente il marito. Così vanno le cose.
giu 112022
Attilio Lolini (1939-2017) è stato un ottimo poeta, sconosciuto ai più, mai presenzialista, sempre in disparte, appartato. Eppure con il suo libro “Notizie dalla necropoli” aveva vinto il premio Viareggio, era un autore Einaudi, aveva scritto un libro epistolare con Sebastiano Vassalli. Si era fatto conoscere pubblicando con “Salvo imprevisti”, rivista fondata dalla poetessa Mariella Bettarini. Poi aveva pubblicato alcune sillogi con la piccola casa editrice indipendente ma di qualità “L’obliquo” di Brescia. Era una persona schiva, ieratica. Non cercava la fama a tutti i costi, il successo nazionalpopolare. Da questo punto di vista si può fare un’analogia con il poeta Roberto Roversi, che nonostante la popolarità ottenuta per la collaborazione con Lucio Dalla, collaborava anche a riviste letterarie non sempre rinomate. È stato scritto dalla critica che la poesia loliniana era caratterizzata dalla rabbia e da un maledettismo toscano, che affondava le sue radici nell’anarchismo. Ma questo maledettismo non era mai autocompiacimento né gesto di arruffianamento per compiacere i suoi corregionali; non era mai una politica grezza da abbracciare (come invece certi comici, molto guitti) per piacere ai toscani, che non lo conoscevano. In Lolini non c’era servilismo di nessun tipo nei confronti di nessuno. Sapeva sempre mantenere la sua dignità. C’è chi ha definito la sua poesia come “tragicomica”. Vassalli l’aveva definita come “un frizzante antidoto alla trombonaggine diffusa nel piccolo mondo antico delle patrie lettere” e sempre Vassalli aveva scritto che Lolini non voleva fare nessuna carriera letteraria. Un’altra sua caratteristica era il suo realismo disincantato. Il poeta non frapponeva veli lui e la realtà, ma neanche tra la realtà e il lettore. Era come si suol dire molto diretto e senza filtri. Si può leggere tutto d’un fiato Lolini per poi ritornare a rileggerlo e riflettere sulle sue piccole amare verità. Se è vero che il mondo è fatto di frammenti eterogenei Lolini aveva una certa omogeneità stilistica (che in letteratura si chiama coerenza interna) e prendeva in rassegna molti aspetti della realtà, pur rimanendo fedele a sé stesso. Eppure il poeta si è rinnovato col tempo, ha tradotto nella sua poesia la maturità e la consapevolezza acquisite. Croce o delizia, questo non lo so, ma in “Carte da sandwich” rispetto a “Notizie dalla necropoli” si potevano notare molto meno invettive e più rassegnazione. Per capire Lolini e i suoi versi spesso senza punteggiatura bisogna ricordarsi uno degli Shorts di Auden: “I suoi pensieri vagavano dal sesso a Dio senza punteggiatura” e però considerare che il nostro trattava di tutto, omettendo il sesso (forse perché pudico, forse perché poteva fuorviarlo dalla sua denuncia sociale, dal suo impegno civile, a cui era spesso teso). Uno dei suoi obiettivi era “strapazzare, maltrattare Madame la poesia”. Nei suoi componimenti troviamo barboni, alienati, poveri ed emarginati di ogni risma. Lolini pone l’accento sulle contraddizioni effettive del capitalismo. Il poeta denuncia l'(in)civiltà dei consumi. Qualche piccola contraddizione era insita anche in lui: per esempio era contro i poeti laureati come Montale e pur tuttavia anche lui nelle sue clausole finali dispensava sentenze, piccoli giudizi epigrammatici come il grande poeta ligure negli ultimi anni. Chi vuole fare poesia aforistica in Italia non può prescindere da Lolini. Le sue liriche sono immediate, leggibili, comprensibili, non artefatte, prive di richiami intertestuali, di citazioni colte, di rimandi, di descrizioni prolisse, con cui molti pensano di impreziosire i loro scritti, senza pensare che li appesantiscono e che così facendo allontanano sempre più i lettori. Leggendo Lolini mi chiedo di che cosa è fatto un pensiero umano, di quante sinapsi chimiche ed elettriche, di quante aree cerebrali ci vogliono per una sintesi poetica come la sua, di quale qualità di circuiti neuronali necessitano certe espressioni verbali, certe sequenze rapide di versicoli, certe immagini mentali così limpide e apparentemente semplici. Eppure nonostante questo talento Lolini è vissuto quasi nell’anonimato, senza che nessuno lo lodasse, gli chiedesse un autografo al bar. È la testimonianza più pura che si può vivere senza cercare a tutti i costi un passaggio televisivo né senza stare a idolatrare chi lo ha ottenuto. Inutile sognare la rivoluzione se poi siamo i primi a subire le dinamiche ricattatorie e gli specchietti delle allodole dello show business! Leggendo Lolini si ha modo di riflettere anche su questo. La sua poesia era contrassegnata, nonostante la leggerezza che la pervadeva, da un certo spessore culturale. Non a caso si rifaceva ai libri sapienziali dell’Antico Testamento, come l’Ecclesiaste. Forse non aveva mai cercato la gloria perché sapeva che era tutto vanità di vanità. In fondo sembra dirci Lolini con i suoi versi, con un ghigno beffardo, con un sorriso malcelato che tanto perdere o vincere è uguale, che tanto alla fine saremo tutti sconfitti. Il poeta in questo senso adotta un pessimismo lucido, visto come vanno la vita e il mondo, senza però mai sconfinare nel nichilismo totale. Se tutti sono d’accordo nel constatare che i soldi sono importanti nella vita e fanno la corsa all’oro, il nostro, che esercitò il mestiere di giornalista, ci rammenta che si può anche vivere senza cercare a tutti i costi le comodità del benessere, ma che si può anche vivere all’insegna del minimalismo esistenziale. In un’epoca di crisi economica e di impoverimento generale Lolini ci descrive una vita qualsiasi, senza grandi amori e senza soldi, fatta soprattutto di tanto grigiore, ma ci ricorda, senza atteggiarsi a eroe quotidiano, che non è affatto disdicevole viverla, rifuggendo i mille canti delle sirene. Lolini ci racconta della noia della provincia, di una non vita perlopiù, fatta di giorni sempre uguali e dove non succede mai niente. A che pro viene da chiedersi darsi tanto da fare? In questo senso mi sembra proprio che il vero maledettismo di Lolini sia rintracciabile in quella “indolenza astiosa” di cui parla egregiamente la filosofa Ilaria Gaspari nel suo primo libro “L’etica dell’acquario”, senza scordarsi che in Lolini, essendo senese c’è più gentilezza e meno rissosità e meno rozzezza di un pisano tipico (cosa già notata da Curzio Malaparte). In fondo un toscano molto pigro come Belacqua aveva incantato prima Dante e poi Beckett. Quindi perché un poeta come il nostro non deve incantarci con i suoi flash, i suoi personaggi, la sua solitudine, che non si incaglia mai nel Nulla assoluto? C’è sempre il salvagente dell’ironia a cui si aggrappa. C’è sempre un quid imprecisato e indefinibile che salva Lolini dal Vuoto e dall’abisso. Il poeta non enfatizza mai le debolezze della carne né le vette dello spirito. Dà per scontato che siamo tutti deboli e peccatori, che pochissimi sono i santi e che bisogna avere comprensione per questa povera umanità. C’è nel nostro una grande pietà cristiana, mai manifestata ma sempre implicita, sottintesa, quasi messa tra parentesi. Lolini non prendeva da De André, né viceversa, ma viene spontaneo un accostamento tra i due. Infatti il celebre cantautore scriveva:
“…Se tu penserai e giudicherai
Da buon borghese
Li condannerai a cinquemila anni
Più le spese,
Ma se capirai, se li cercherai
Fino in fondo,
Se non sono gigli son pur sempre figli
Vittime di questo mondo.”
————–
————–
————–
Ma entrambi avevano avuto un esemplare maestro in Umberto Saba, che molto tempo prima di loro in “Città vecchia” scriveva:
————-
————
“Spesso, per ritornare alla mia casa
prendo un’oscura via di città vecchia.
Giallo in qualche pozzanghera si specchia
qualche fanale, e affollata è la strada.
Qui tra la gente che viene che va
dall’osteria alla casa o al lupanare
dove son merci ed uomini il detrito
di un gran porto di mare,
io ritrovo, passando, l’infinito
nell’umiltà.
Qui prostituta e marinaio, il vecchio
che bestemmia, la femmina che bega,
il dragone che siede alla bottega
del friggitore.
la tumultuante giovane impazzita
d’amore,
sono tutte creature della vita
e del dolore;
s’agita in esse, come in me, il Signore.
Qui degli umili sento in compagnia
il mio pensiero farsi
più puro dove più turpe è la via.”
———–
———–
———–
In definitiva Lolini si salva dal precipizio, dopo averlo scrutato per un periodo di tempo indefinito. Ma in lui prevale sempre l’istinto di autoconservazione. Il vero enigma riguardo a Lolini è proprio perché l’impulso vitale avesse la meglio su Thanatos. Forse non c’era un motivo plausibile, una spiegazione logica. A volte la vita va vissuta e amata senza pensarci su e senza chiedersi la ragione. Anche per questo a mio modesto avviso va letto.
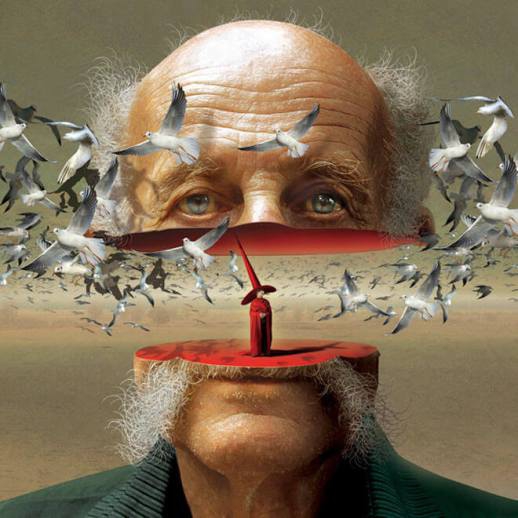



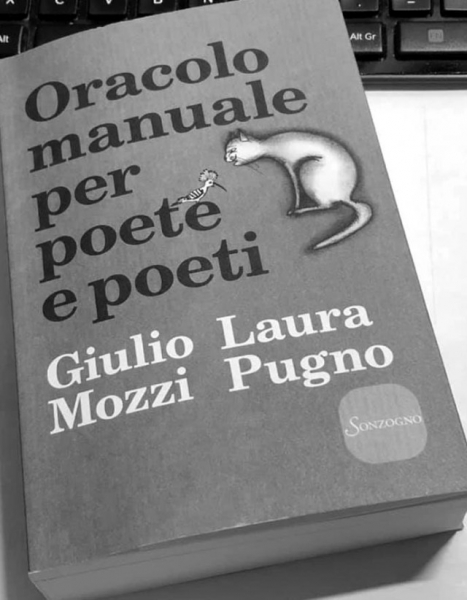



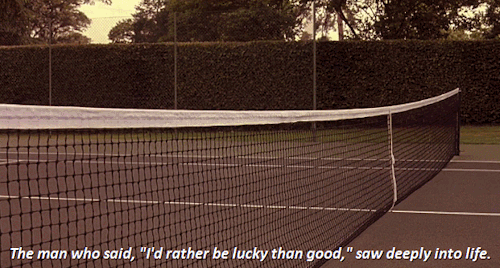
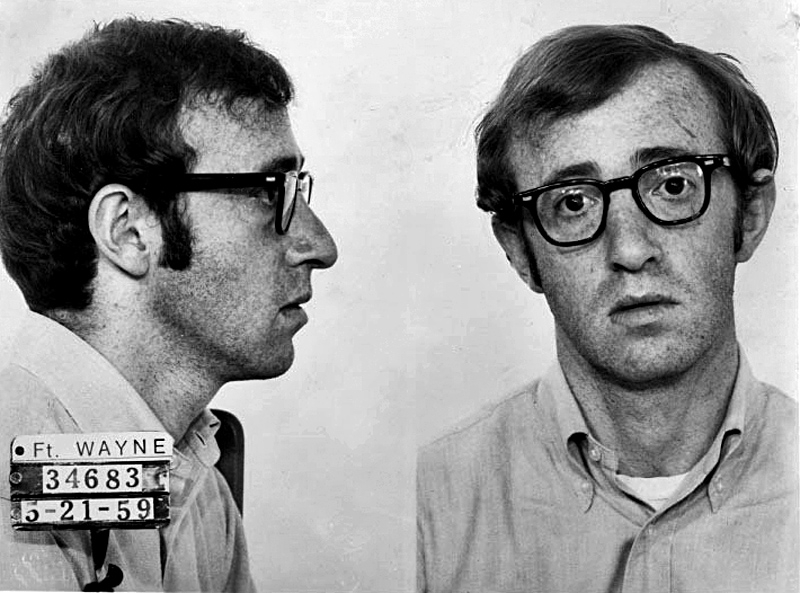

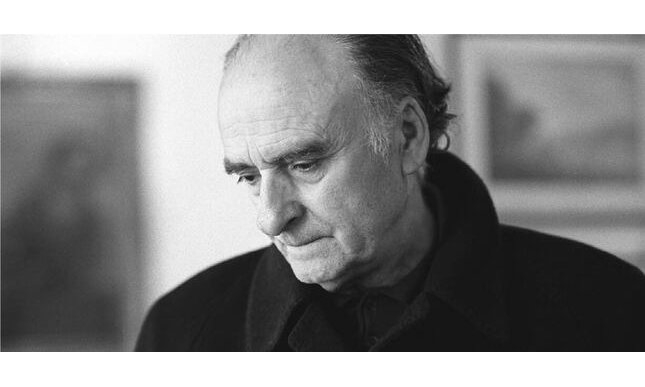

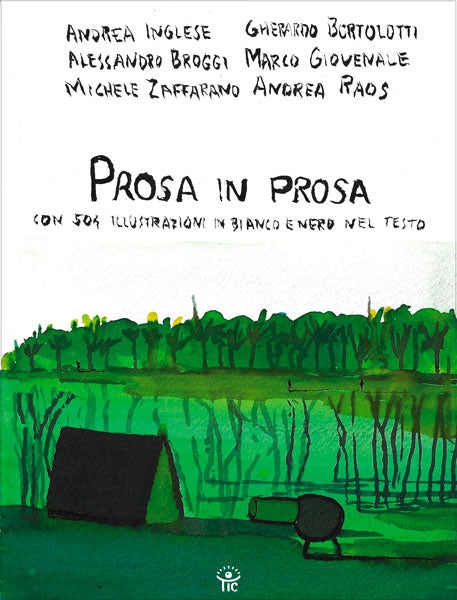
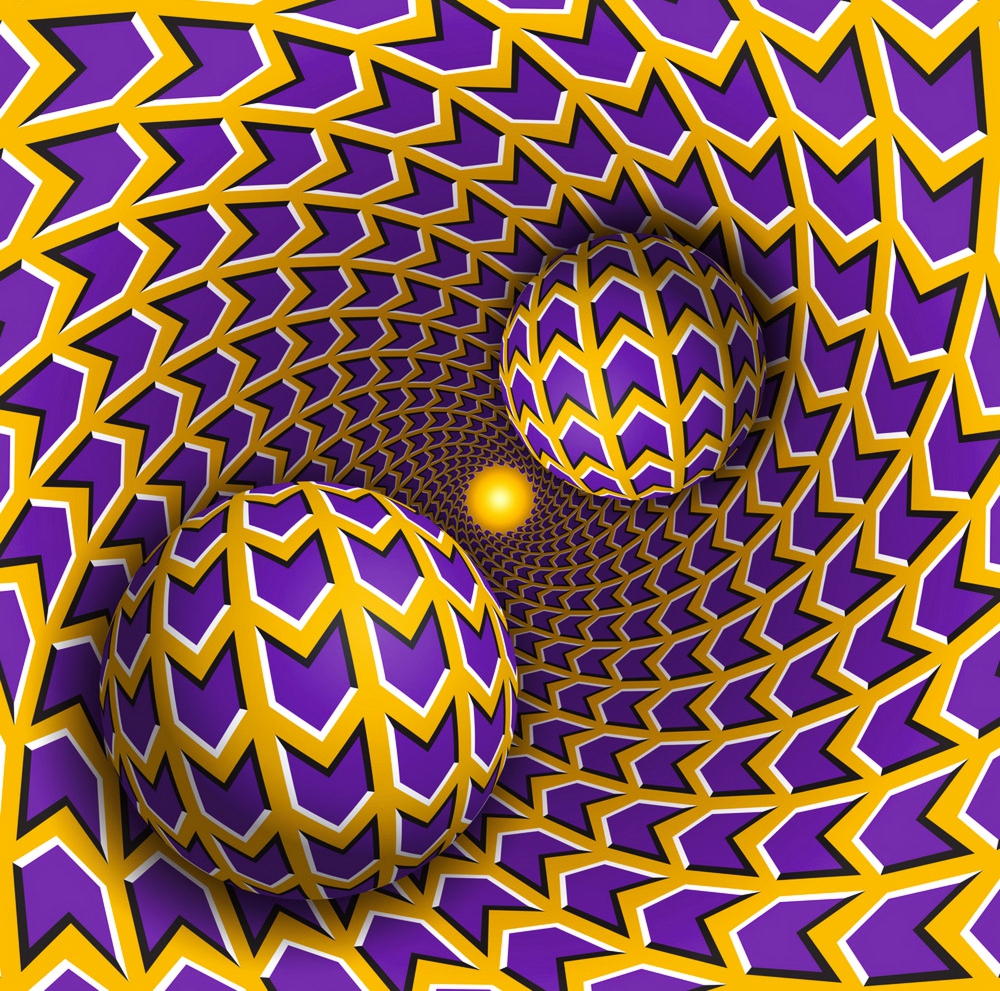

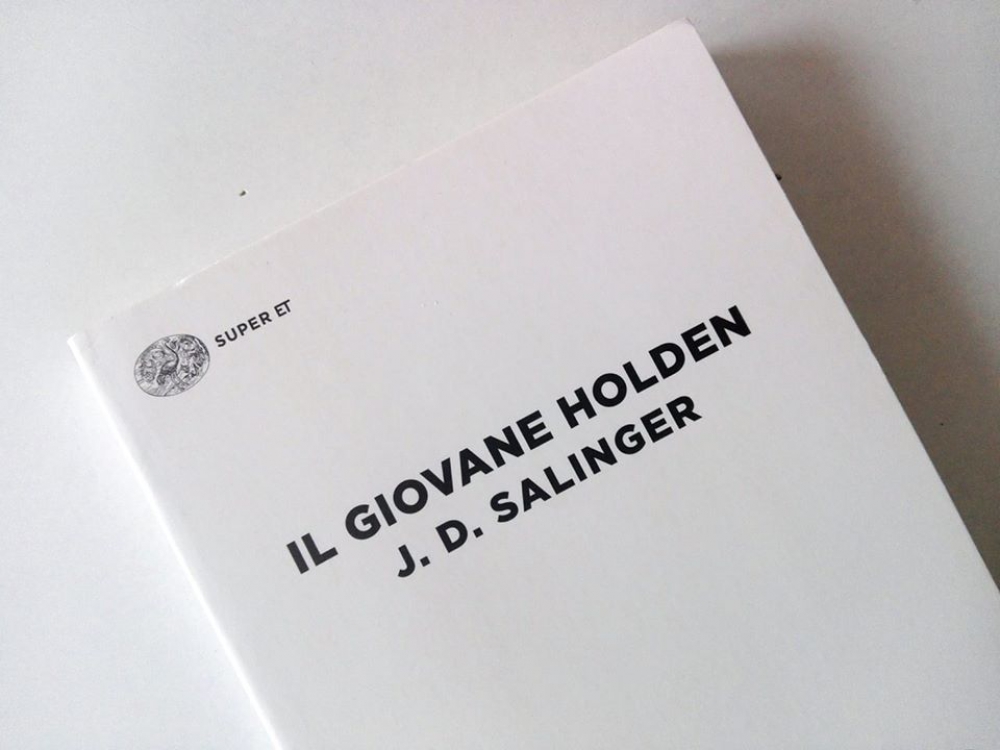








_0_o.jpg)

















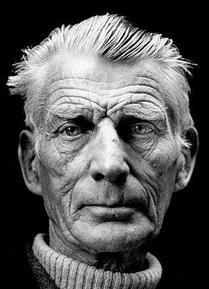






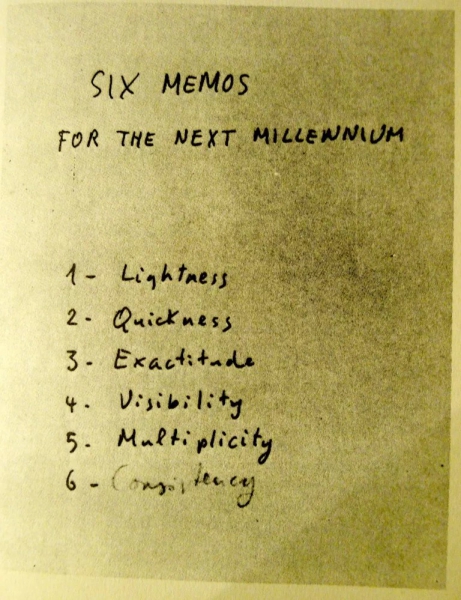




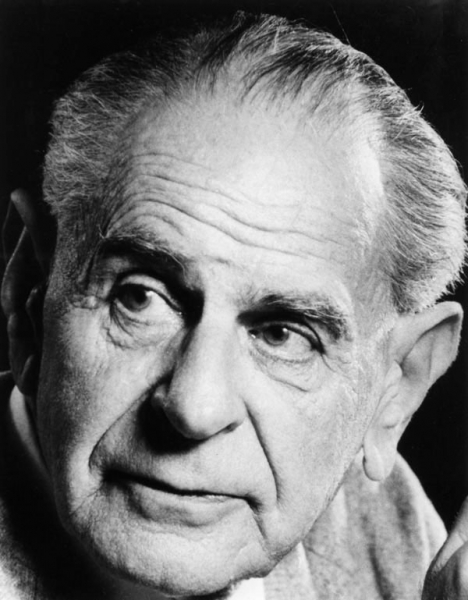
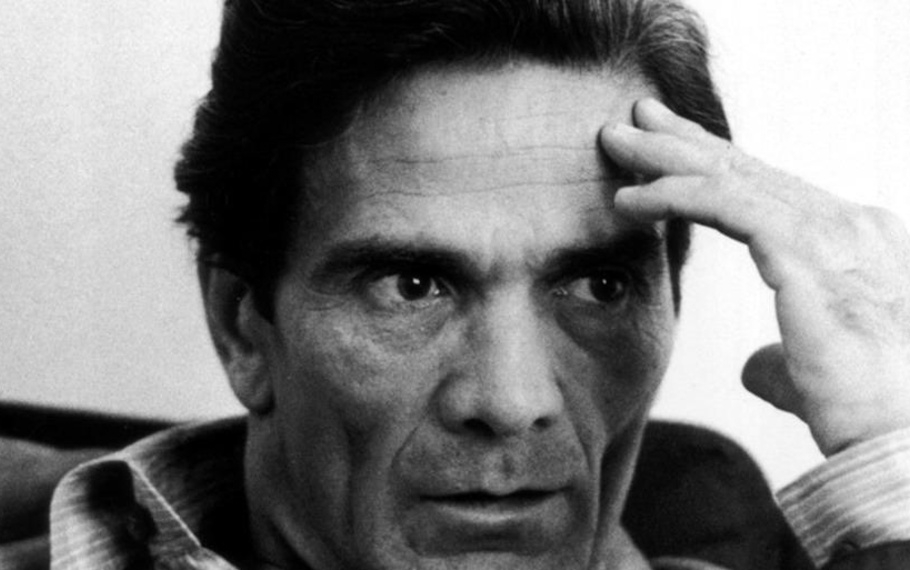

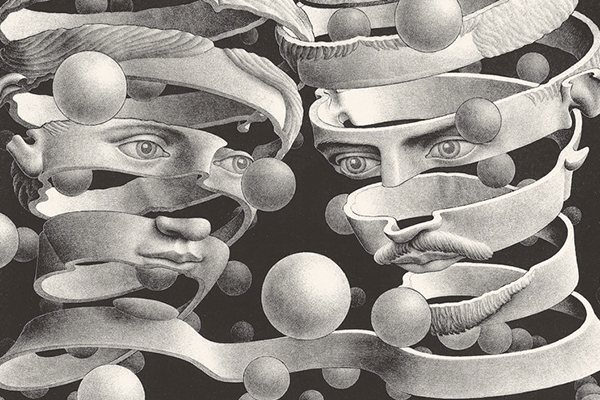
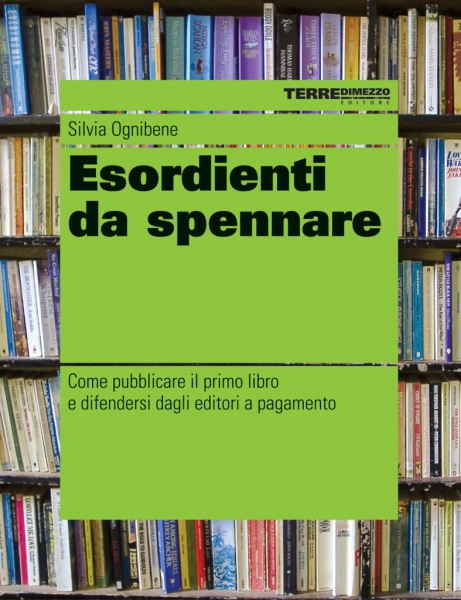
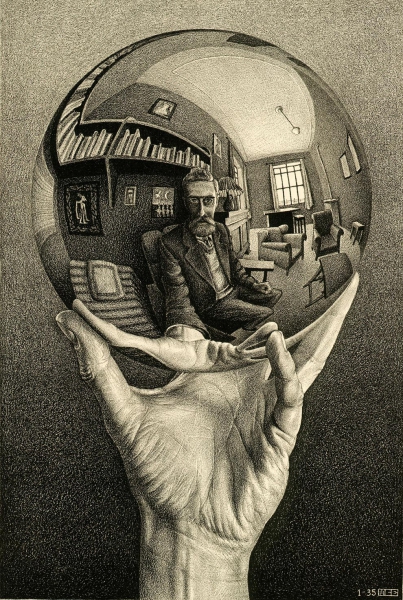






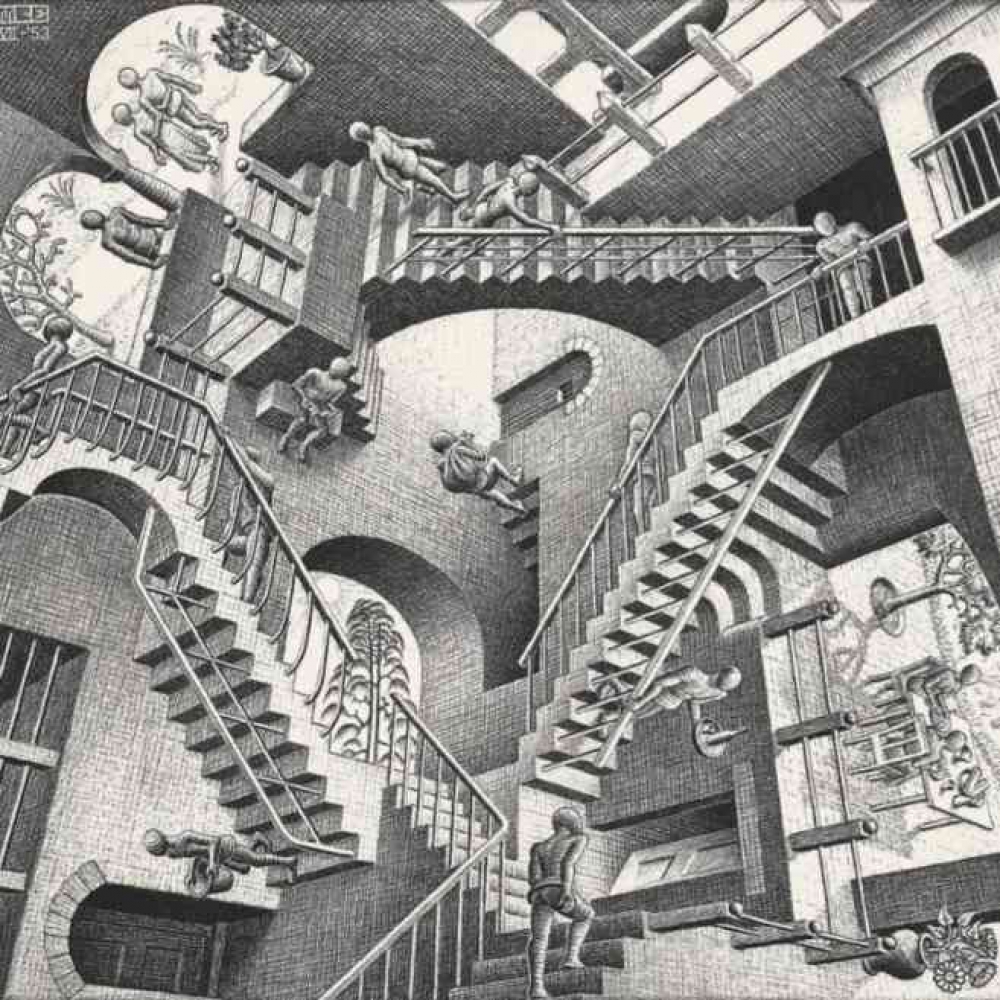






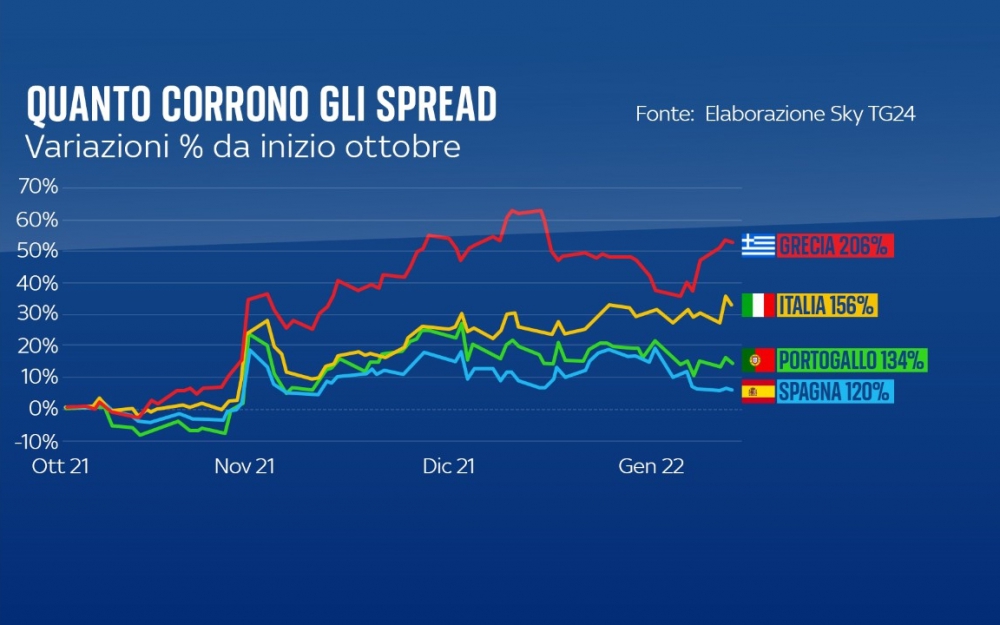






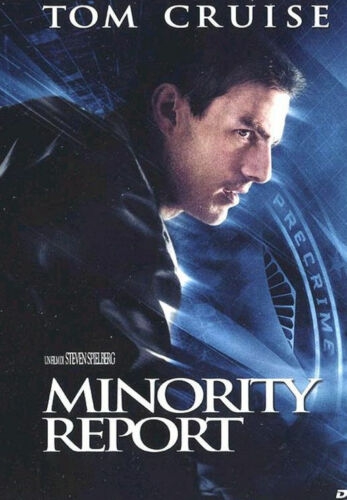










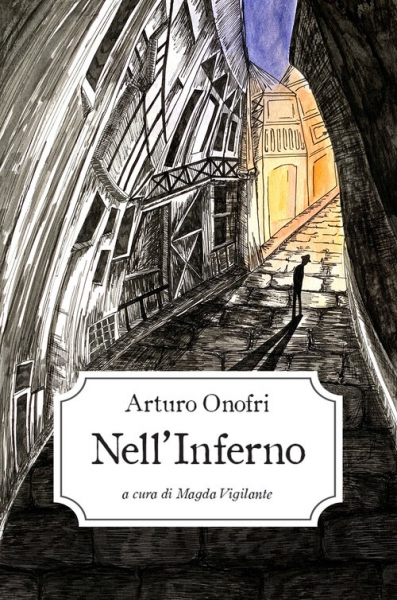


altmann-zweigandrothinostendin1936(cropped)1_0_o.jpg)
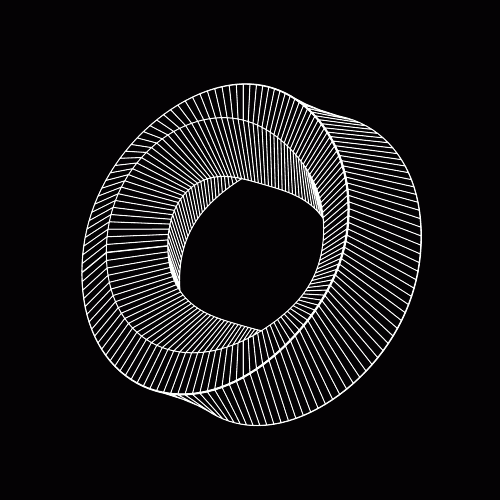
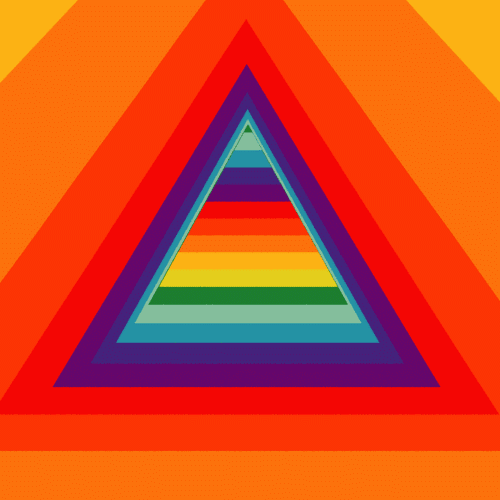



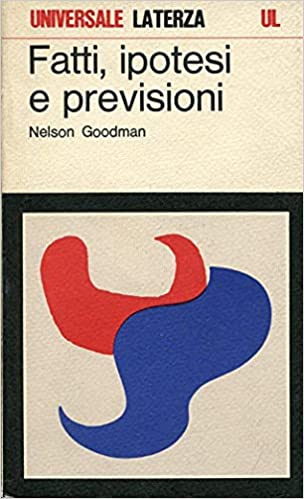

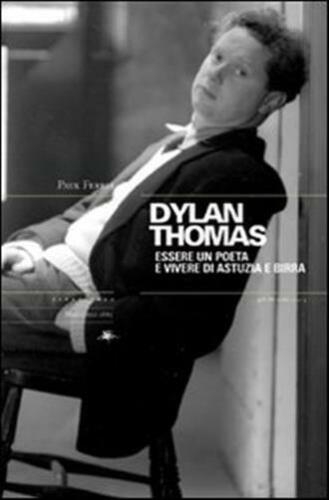









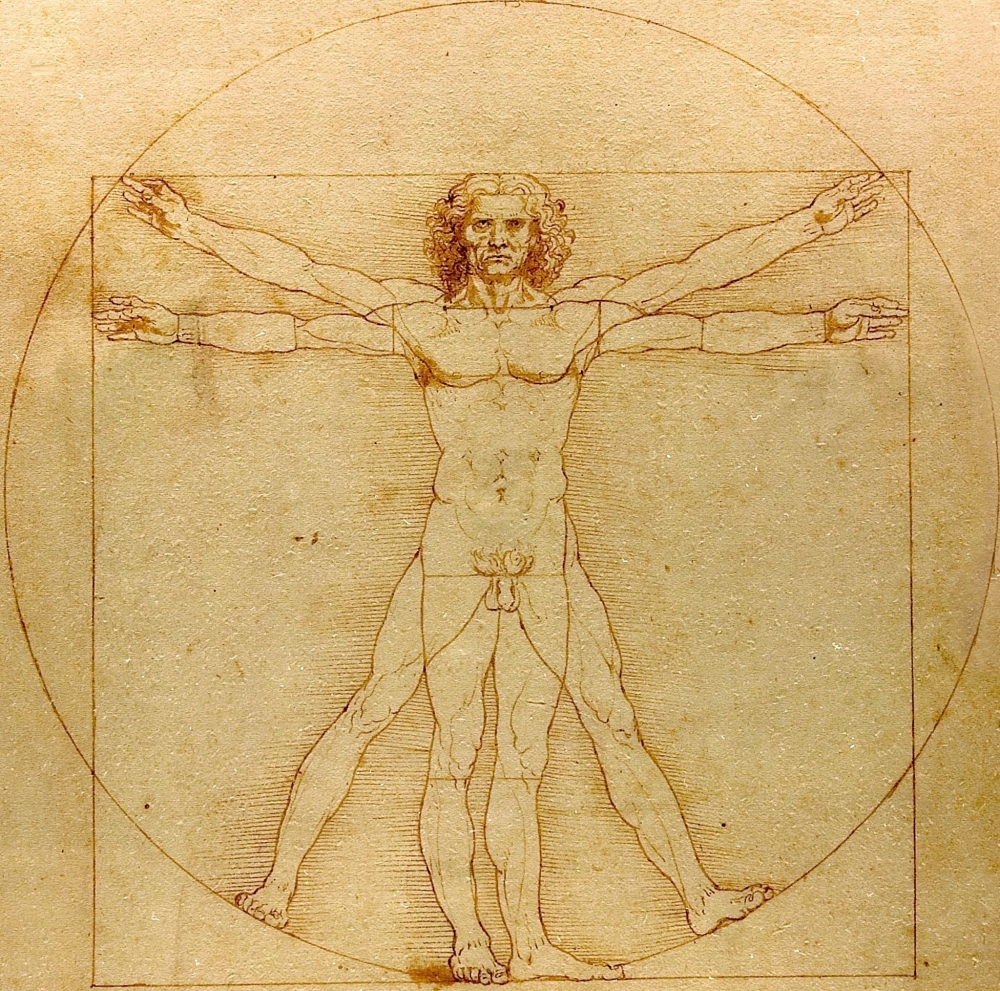












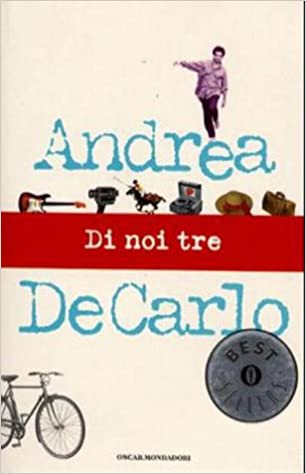
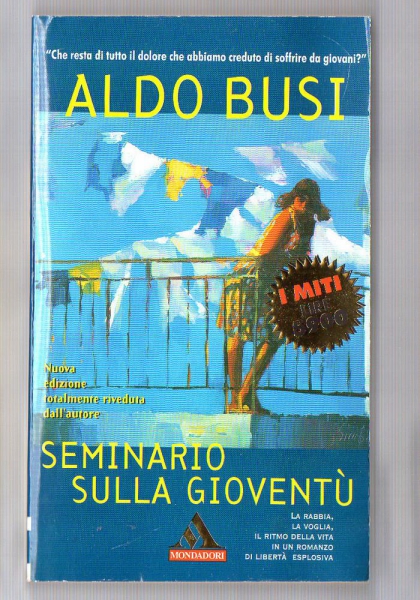




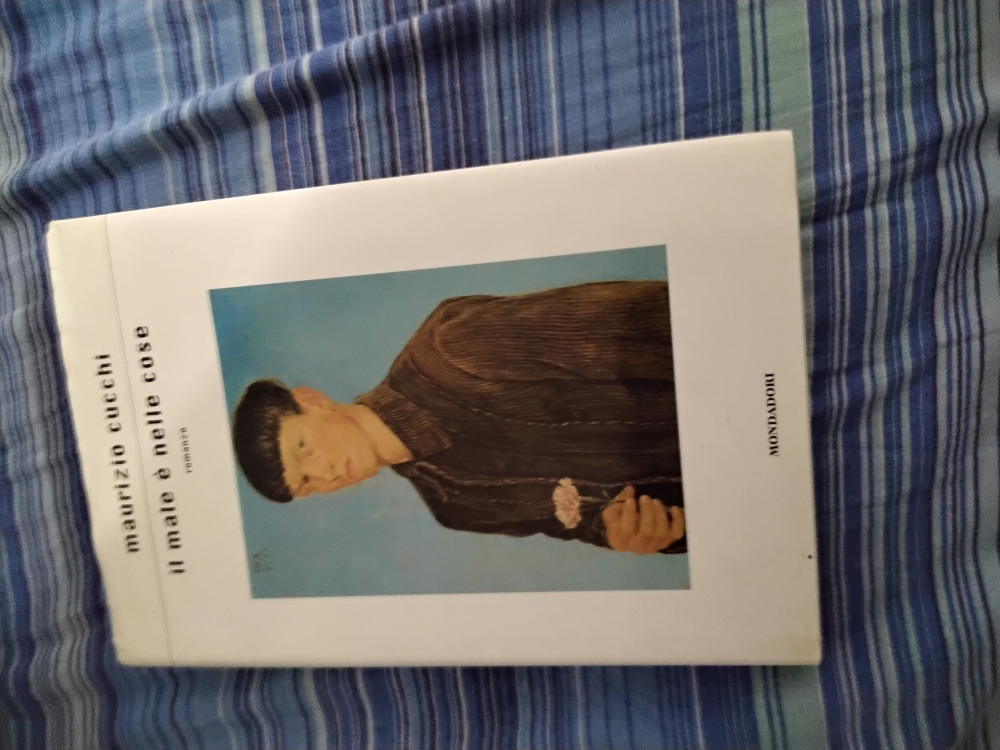




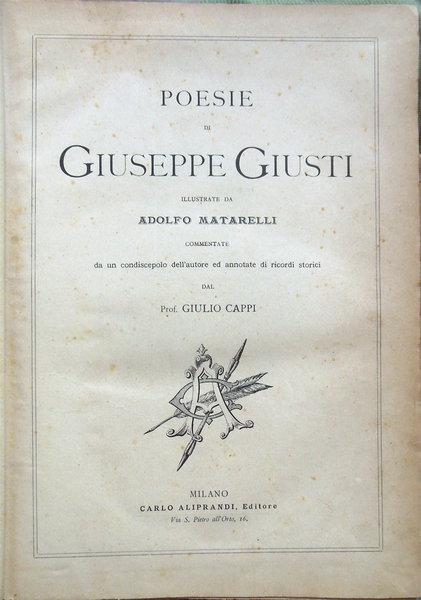




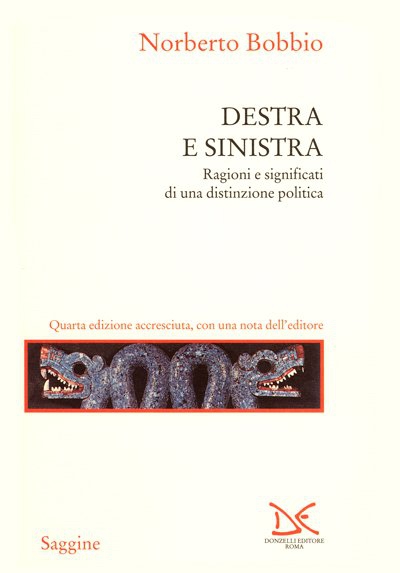



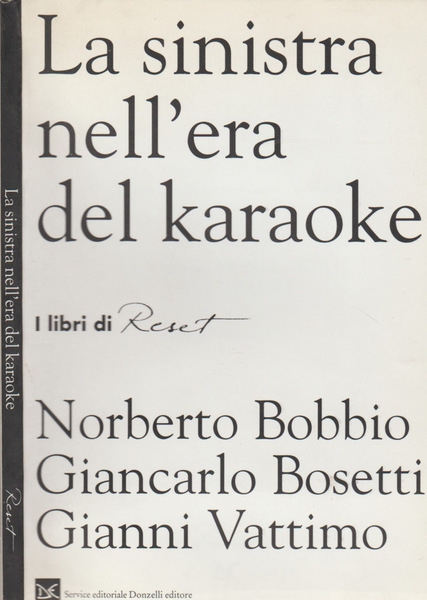


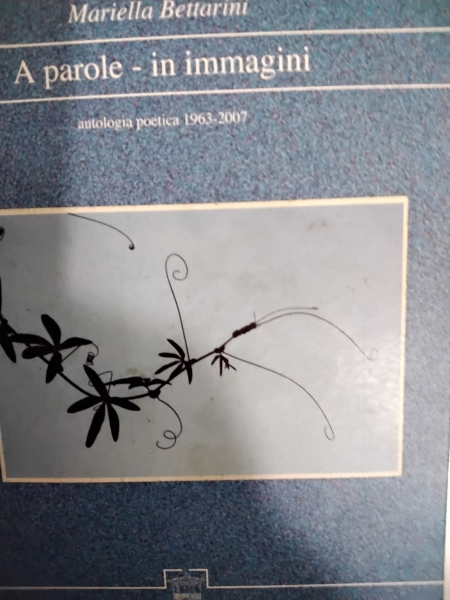






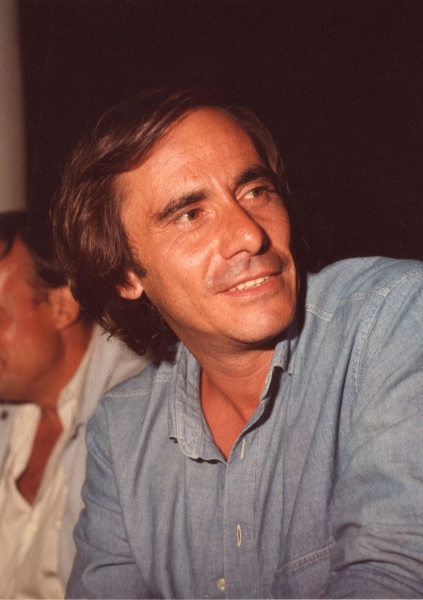

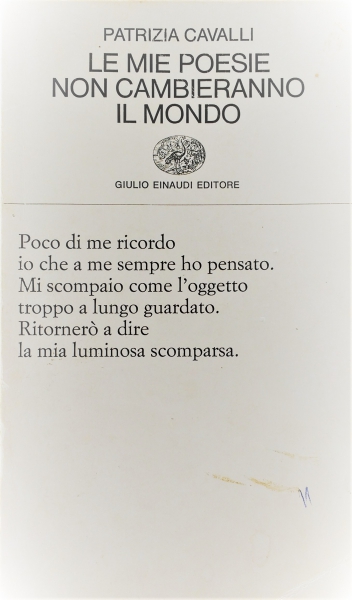


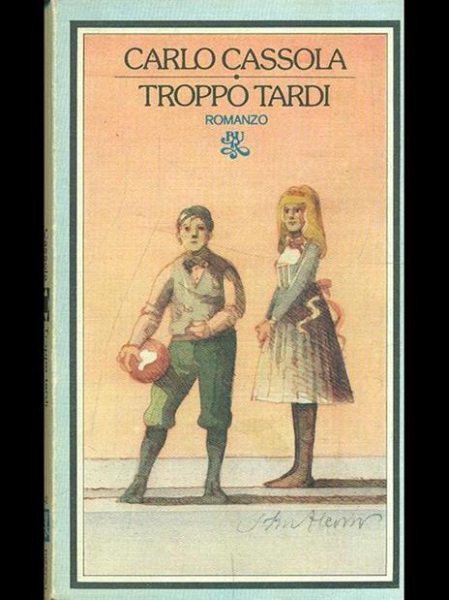





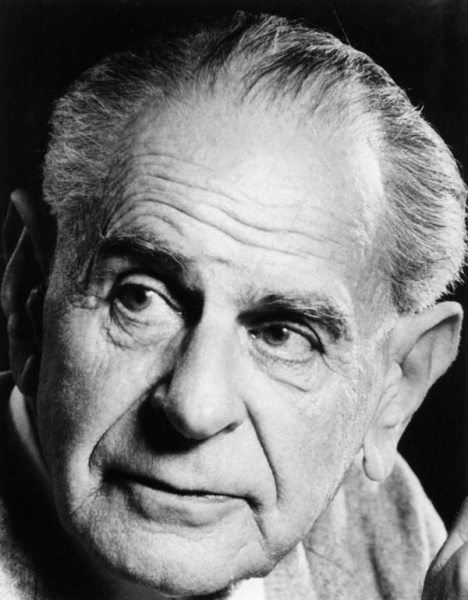


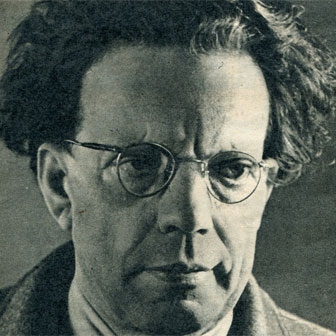



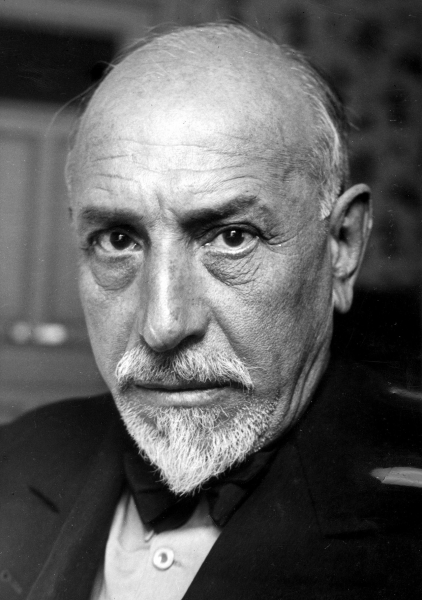


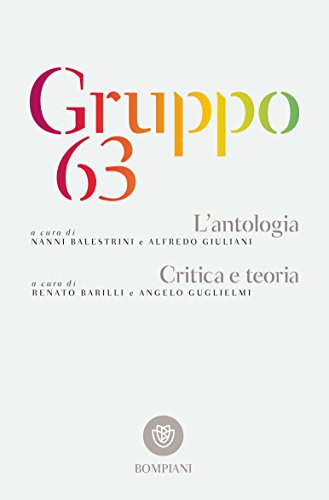
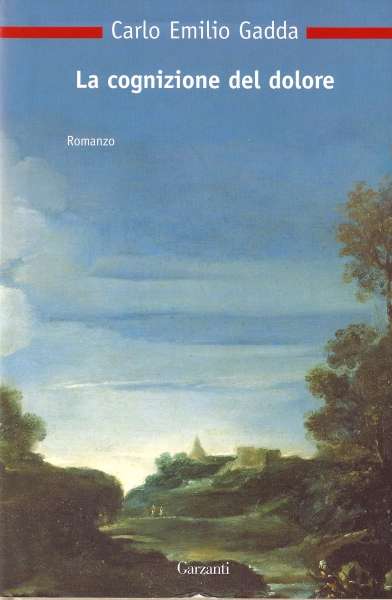



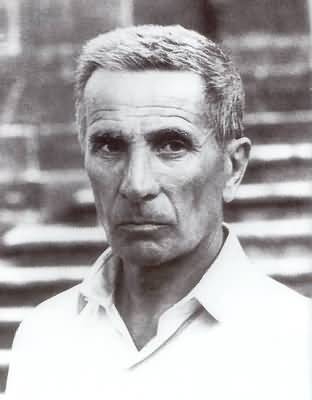



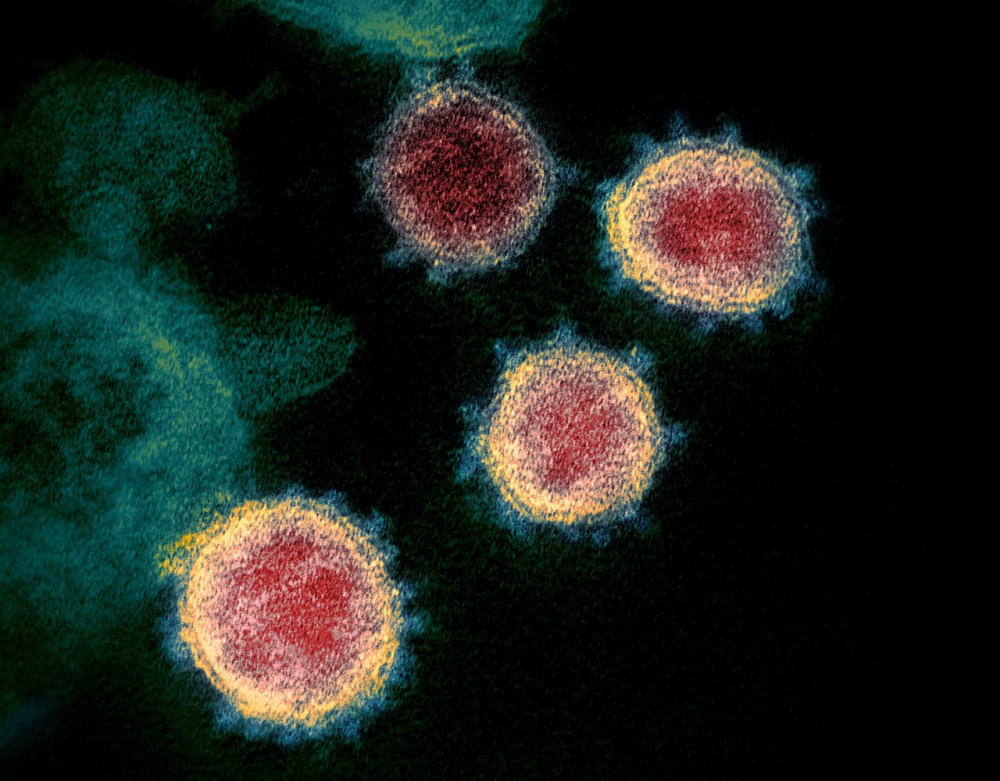
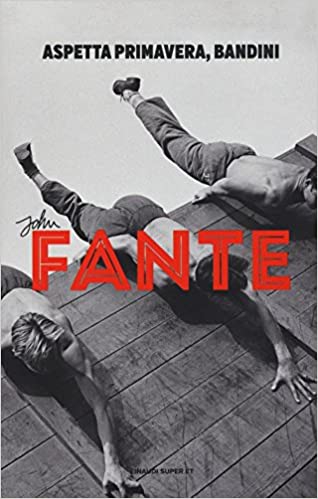


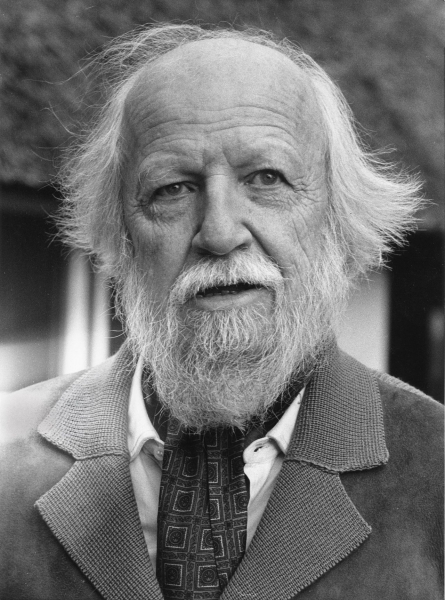







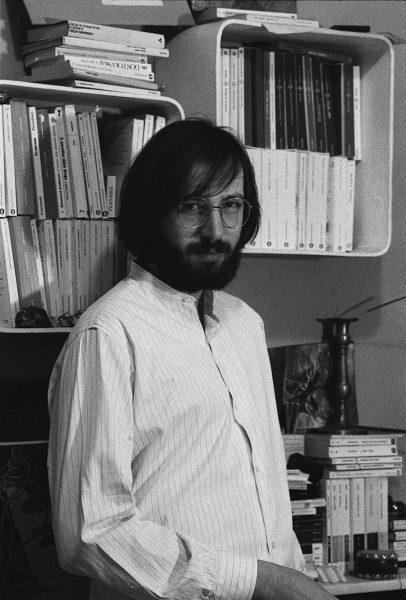
_0_o.jpg)
_0_o.jpg)


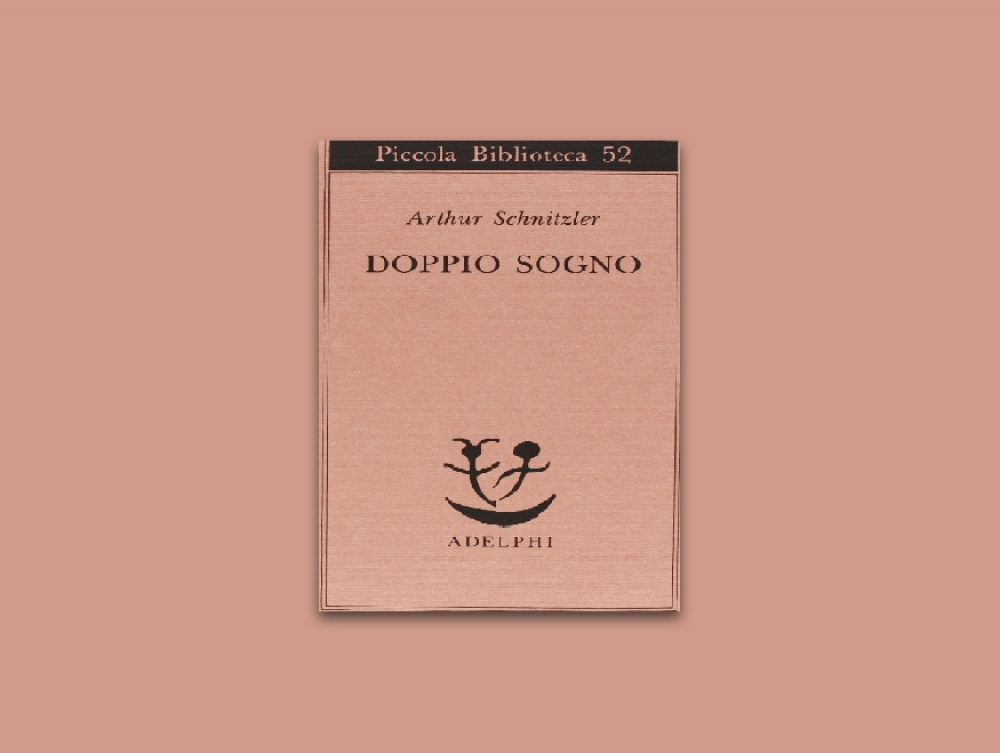


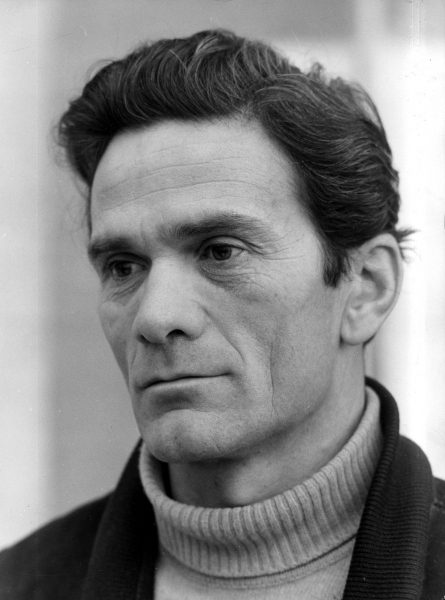
 SU CLAUDIO LOLLI
SU CLAUDIO LOLLI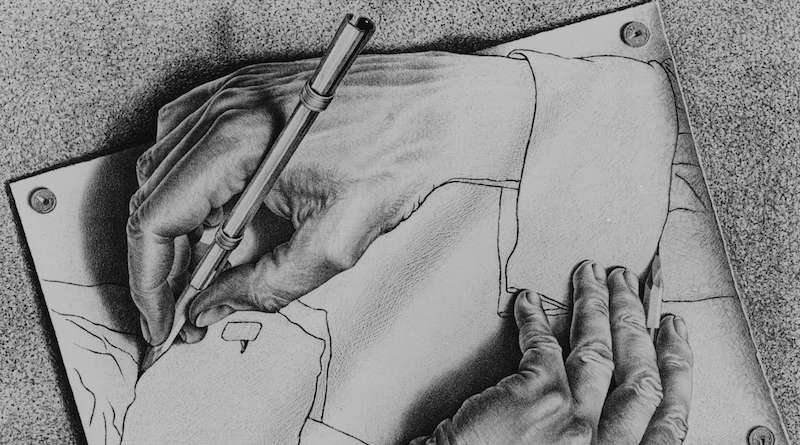 Nell’enciclopedia Treccani alla voce “autofiction” si trova scritto: “Il termine autofiction, coniato nel 1977 dallo scrittore francese Serge Doubrovsky in riferimento al suo romanzo Fils, indica il genere letterario in cui l’autore stesso è il protagonista delle vicende di finzione narrate. Nato con un’esplicita ispirazione psicoanalitica, come indagine sull’inconscio, e utilizzando gli stilemi del nouveau roman, in anni più recenti, con l’arrivo del post moderno, il tema più diffuso nei lavori di a. sembra essere piuttosto il rapporto problematico tra verità e menzogna, tra identità e differenza, in una società dominata dalle immagini tecniche e dai simulacri (in Italia, si veda, per es., il romanzo di Walter Siti, Troppi paradisi, 2006)”.
Nell’enciclopedia Treccani alla voce “autofiction” si trova scritto: “Il termine autofiction, coniato nel 1977 dallo scrittore francese Serge Doubrovsky in riferimento al suo romanzo Fils, indica il genere letterario in cui l’autore stesso è il protagonista delle vicende di finzione narrate. Nato con un’esplicita ispirazione psicoanalitica, come indagine sull’inconscio, e utilizzando gli stilemi del nouveau roman, in anni più recenti, con l’arrivo del post moderno, il tema più diffuso nei lavori di a. sembra essere piuttosto il rapporto problematico tra verità e menzogna, tra identità e differenza, in una società dominata dalle immagini tecniche e dai simulacri (in Italia, si veda, per es., il romanzo di Walter Siti, Troppi paradisi, 2006)”.