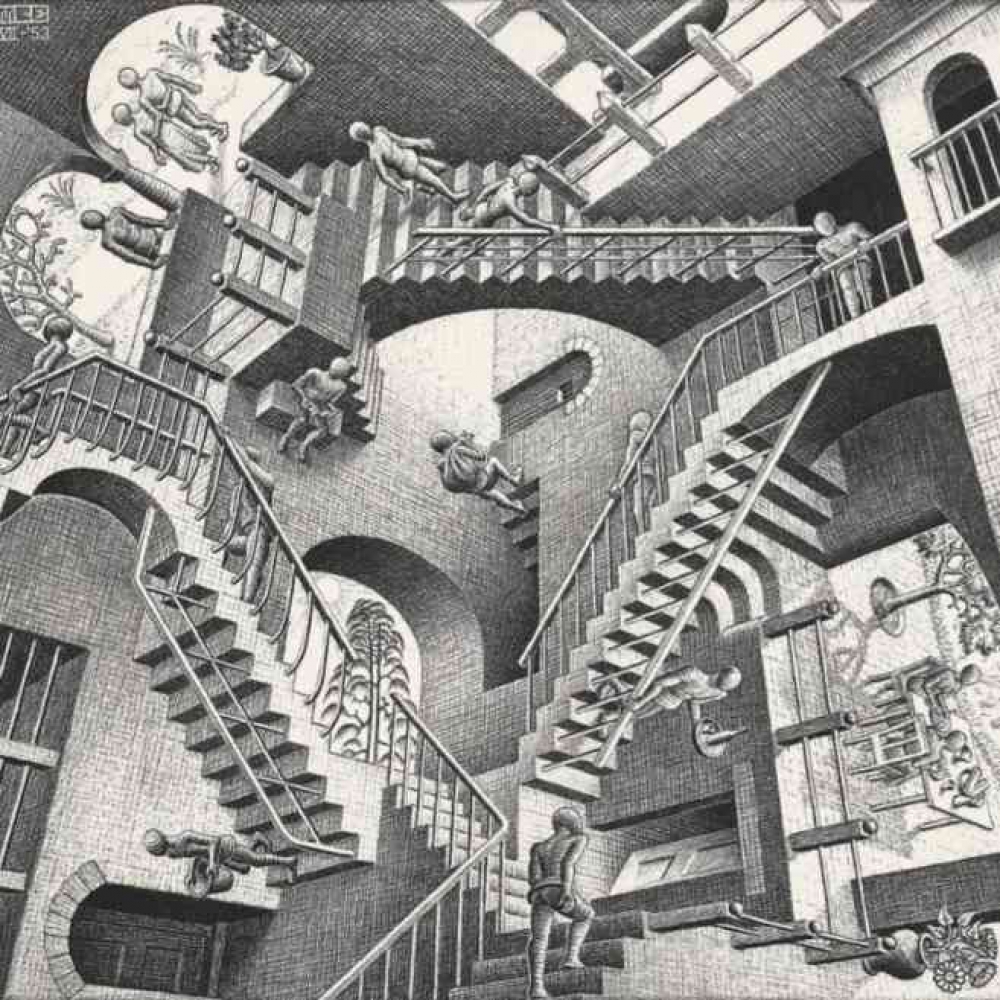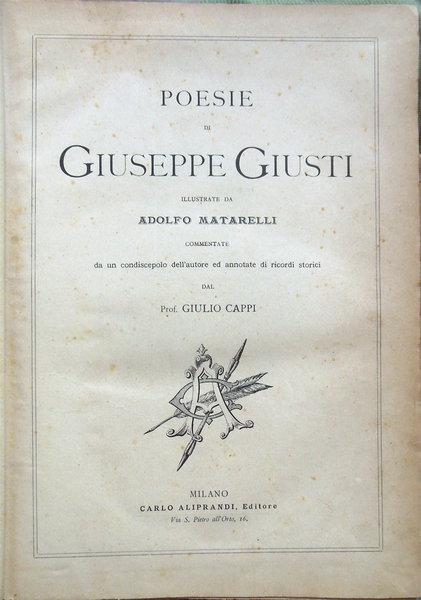ott 012022
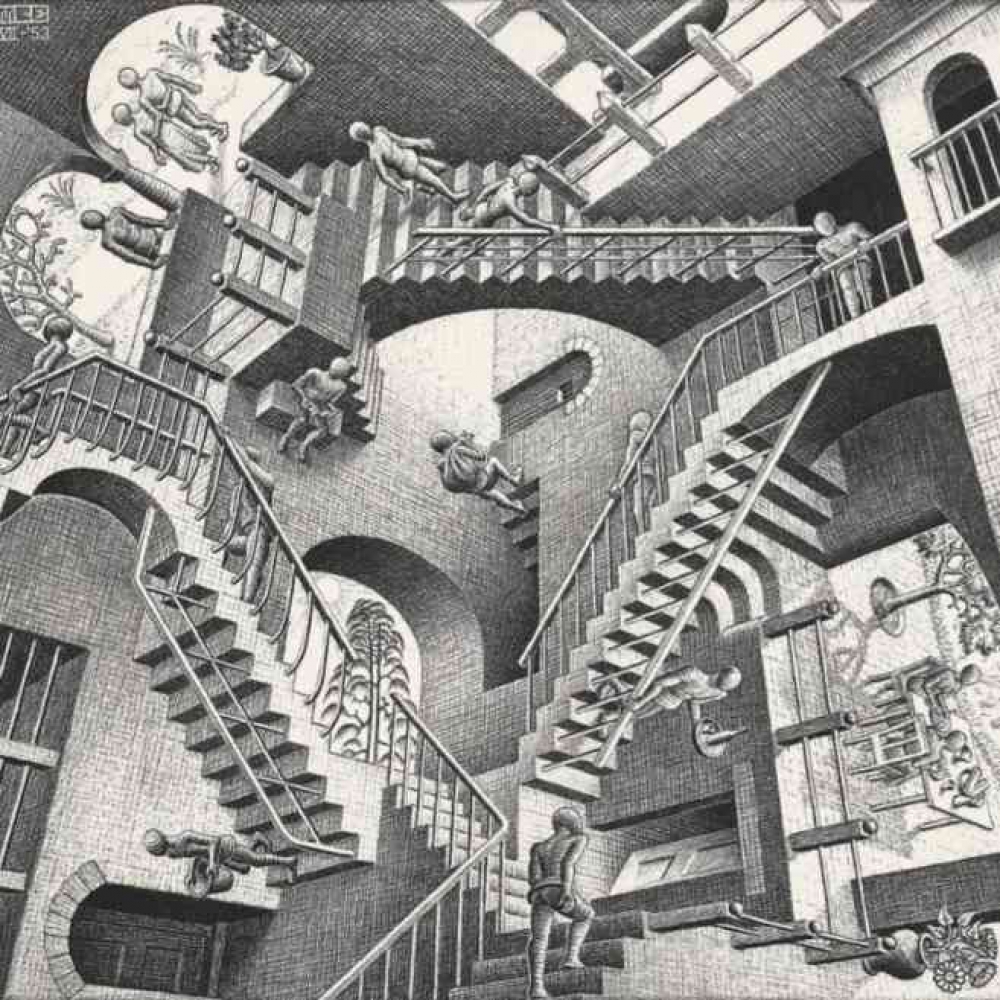
Si può avere dei pessimi gusti letterari ed essere delle brave persone. Si può pensare che l'impoesia sia poesia, che la poesia sia impoesia ed essere delle brave persone. Che tanto poi non esistono più da secoli dei criteri assoluti e oggettivi per stabilire che cosa sia poesia e che cosa non lo sia! Prima del Novecento i poeti dovevano essere aulici e rispettare i santi crismi della metrica. Ai tempi di Dante le terzine dovevano essere incatenate. Anche nell'Ottocento i versi sciolti di una poesia dovevano essere metricamente ineccepibili per sillabe e accenti tonici. Oggi tutto è permesso, tutto è lecito nel bene e nel male (sia inteso). Forse è anche la mancanza di regole a aver fatto perdere rispettabilità e credibilità alla poesia contemporanea (è un'ipotesi da non scartare, tant'è che qualche poetessa come la Valduga è ritornata all'ordine, all'ipermetrismo). Che poi la perfezione non è cosa umana e se c'è qualcosa che si avvicina alla perfezione é solo nel dettaglio, nel piccolo! Lo scrittore Sandro Veronesi, premio Strega, ha dichiarato che il romanzo perfetto non è mai esistito, nemmeno scritto da dei grandi geni, mentre invece esistono ogni tanto dei racconti che si avvicinano alla perfezione. Credetemi: si può avere ottimi amici illetterati e che nemmeno sono lettori forti. Magari si sta meglio in loro compagnia e non ci si avvelena il sangue. Scegliete le persone in base alla loro umanità, onestà, autenticità, lealtà, sincerità, non in base alla loro presunta intellettualità e non avrete mai delusioni cocenti. Di un amico non valutate le lacune culturali ma se manca o meno come persona con voi. Si può essere invece dei grandi letterati ed essere degli autentici farabutti. Che poi il sacrificio, l'abnegazione e la considerazione scarsissima delle persone, gli scarsi guadagni, molto spesso le poche risorse economiche, sommate tutte assieme, spesso rovinano il carattere di qualsiasi anima bella, di qualsiasi poeta. Perciò io li capisco, li comprendo pienamente certi letterati incompresi e fegatosi, come si suol dire a Roma. Spesso non solo non vengono capiti, ma vengono derisi, sbeffeggiati, irrisi o talvolta ancora peggio su di loro cala l'indifferenza. Certi preti per preservare le loro pecorelle dicono che la cultura umanistica allontana dalla fede (scordandosi che anche il cristianesimo è umanesimo antelitteram). Allo stesso modo direi che per non impermalosirsi, per non incattivirsi, per non rovinarsi il fegato è meglio stare ad esempio lontani dalla poesia e dalla scrittura in genere. Primo motivo: non girano i soldi. Secondo motivo: la fama è inconsistente. Terzo motivo: si spende e non si guadagna. Quarto motivo: il pubblico disinteressato non esiste, ma è fatto solo da aspiranti poeti in competizione tra loro. Quinto motivo, ovvero la risultante degli altri motivi: c'è il serio rischio di sviluppare una nevrosi o una psicosi, visto che il contesto poetico è nevrotico/psicotico. Ho la netta sensazione talvolta che il contesto poetico sia la sommatoria di tante psicopatologie, derivate dal disinteresse degli italiani nei confronti di questa materia. Alcuni o forse molti si ammalano o rischiano di ammalarsi e soffrire psicologicamente per quella che a tutti gli effetti dovrebbe essere una passione semplicemente. Molti cercano la riconoscibilità poetica. Non la trovano e da ciò scaturisce l'incomprensione perenne. Alcuni risultano provati dalle porte che la comunità poetica sbatte loro in faccia. In realtà anche in poesia bisogna rispecchiare certi canoni del conformismo culturale per affermarsi: essere integrati socialmente e lavorativamente, essere di buona cultura, essere sodale tra i sodali, essere solidali con i più deboli in forma vaga e indistinta, dimostrare di apparire sufficientemente contro il sistema, dimostrare di essere alternativi e anticonformisti, essere di sinistra (pur riservandosi di criticare la sinistra fino allo sfinimento e fino al disfattismo), presentarsi come anime belle e poi in realtà coalizzarsi con quelli che vengono considerati i nemici per le ragioni più banali e più inconsistenti. Spesso i poeti (veri o presunti) sono figli di buona donna con gli altri poeti perché si sentono in gara o sono amici di alcuni poeti per interesse, calcolo, quieto vivere. Spesso i poeti (veri o presunti) sono figli di buona donna con il resto dell'umanità non poetica perché se gli altri apprezzano le loro poesie i poeti (veri o presunti) li odiano dato che vorrebbero essere ripagati materialmente, sessualmente, socialmente, professionalmente e naturalmente ciò nella stragrande maggioranza dei casi non avviene. Molto spesso i poeti (veri o presunti) odiano il resto dell'umanità che non si cura di loro e delle loro poesie. Le loro parole, le loro moine, le loro formalità vuote non vi traggono in inganno: i poeti sono cattivi, profondamente cattivi e nemmeno amano più la poesia, ma i colpevoli di tutto ciò siamo tutti noi. Siamo noi che li abbiamo dimenticati. Siamo noi che non abbiamo voluto conoscere la loro poesia. Comunque tutti hanno le loro colpe: sia i poeti che i lettori che i non lettori hanno assassinato tutti la poesia. Poi diciamocelo chiaramente: un luogo comune vuole che i poeti siano tutti buoni e da ciò ne consegue che chiunque scriva poesia abbia il dovere di essere buono e comportarsi bene. Da ciò risulta che i poeti, veri o aspiranti, siano sempre sotto osservazione e sempre ricattabili dalle altre persone. Invece questo pregiudizio positivo che finisce per essere una trappola per i poeti crea aspettative troppo grandi e quasi sempre disattese. Un altro luogo comune è che il poeta sia una persona speciale verbalmente, concettualmente, per sensibilità, per cultura, per animo, per intelligenza. La realtà è che il poeta molto spesso è una persona come le altre. Non ha niente di speciale. Non ha niente di più. I poeti hanno assassinato la poesia con le loro parole. Tutto il resto dell'umanità ha assassinato la poesia con la mancanza di amore e di interesse nei confronti della poesia. Eppure, sembra tanto logico e scontato ma non lo è: ci vuole proprio la poesia di tutti per rendere il mondo più poetico, mentre invece l'assenza di poesia o una cattiva poesia lo rendono ancora più impoetico. L'equilibrio è instabile e precario. Talvolta ho la vaga impressione che ci sia meno poesia nelle poesie contemporanee e più poesia nelle piccole cose della vita quotidiana. Il terreno su cui tutti ci muoviamo è limaccioso, scivoloso. Come ha detto qualcuno molto più importante di me, ovvero Bobin, dovremmo tentare di abitare il mondo poeticamente. E lo stesso Bobin ha scritto che abitare il mondo poeticamente è l'identica cosa che abitare il mondo umanamente. La poesia è umanità. L'umanità è poesia. Naturalmente ci vuole pazienza e dedizione per riuscire a cogliere tutto ciò, per carpire la poesia nell'umanità e l'umanità nella poesia. Allora dobbiamo sopportare la vanagloria, l'opportunismo, l'arrivismo, il narcisismo, la smania di grandezza di alcuni o molti poeti (veri o presunti). La malignità dei poeti deriva dalla loro frustrazione, dal loro senso di sconfitta in una società che ha relegato ai margini la poesia. Naturalmente anche io un tempo scrivevo poesie (o presunte tali). Anche io un tempo facevo ridere. Ma come scriveva un tempo la grande poetessa Szymborska: "Preferisco il ridicolo di scrivere poesie, al ridicolo di non scriverne". Realisticamente parlando però, se non si è grandi poeti in grado di essere ricordati dai posteri, si trae molto giovamento quando si smette di scrivere poesie. Qualcuno che sa rinunciare ci vuole. Si dimostrerà avveduto. Ci guadagnerà in credibilità agli occhi del mondo. Ma questo non vuol dire che debba smettere di amare la poesia. Che tanto l'importante è che ci sia poesia. Non importa se la poesia sia propria o altrui!
set 082022

Ha un bel dire con tutti i suoi platani Firenze.
Non è uguale la musica, non può esserlo.
Ma uguale a che, la stessa di quando -
discetta perdutamente il senso
non trovando fondale a quel risucchio
di mancamento o rimorso.
Né so cosa m'intenerisce di lei,
se davvero la spina che le è infissa della mia vita
o quell'aria di congedo in lei da me, in me da lei. O il niente
di questo.
Mario Luzi è stato uno dei protagonisti della poesia italiana del Novecento. Attraversò quasi tutto il secolo breve. É stato anche senatore a vita. Fu candidato per anni al Nobel della letteratura. Consiglio a tutti di leggere le sue opere e magari anche di leggere "Saggio su Mario Luzi" di Anna Panicali. Luzi fu uno dei protagonisti al Caffè delle Giubbe Rosse. Fu professore universitario e saggista oltre che grande poeta. Apparentemente in questa lirica sembra che Luzi vada a capo quando vuole senza rispettare alcuna regola. In realtà si tratta di versi liberi che rispecchiano i canoni della metrica italiana, tutti con i giusti accenti tonici, anche se senza rime e con alcuni enjambements. Luzi utilizza alcune volte la sinalefe perché questa è la consuetudine tra poeti, mentre la dialefe è l'eccezione. La sinalefe infatti è più eufonica, mentre la dialefe è più disarmonica e più entropica. Ci sono anche degli endecasillabi canonici in questo testo. Non vi traggano in inganno alcuni versi più lunghi del componimento perché sono anch'essi metricamente ineccepibili. Mario Luzi nel corso di tutta la sua carriera poetica non è mai andato a capo a caso, come molti versoliberisti (forse a torto, più probabilmente a ragione). Il primo verso ad esempio è un doppio settenario con sinalefe. Il terzultimo verso è un doppio novenario, scandendo normalmente le sillabe. Il penultimo verso è un doppio ottonario con sinalefe. Certamente la sua prima produzione poetica era metricamente più rigorosa di quella in età matura e in vecchiaia, ma il poeta ha dimostrato sempre grande prolificità, capacità di rinnovarsi, una scrittura impeccabile. In questa poesia esprime sia un'idea che un sentimento. Non si perde nel dettaglio del dettaglio. È una lirica che va presa nella sua gestalt globale. È una poesia breve, ma solo apparentemente semplice.
"Ha un bel dire con tutti i suoi platani Firenze" è una personificazione. Firenze sembra parlare con i suoi platani. Luzi non cita la Firenze celebrata da cartolina, dei grandi capolavori artistici. Non rievoca neppure Firenze come grande città di marmo, come lui stesso ebbe modo di definirla. I platani appartengono al campo semantico della natura ma anche a quello associativo della familiarità (leggi anche della consuetudine).
Luzi è un grande poeta ermetico, che usa sapientemente le analogie e le metafore.
In questo senso è anche simbolista. Per lui fare poesia significa ricercare "corrispondenze", come nella celebre lirica di Baudelaire, e allora dopo aver trovato corrispondenze tra i propri stati d'animo e i paesaggi ogni città diventa un luogo dell'anima, un posto interiore, una "foresta di simboli", sempre per riprendere il poeta maledetto francese. Ma cosa significa "Non è uguale la musica, non può esserlo"? Significa che le corrispondenze cambiano continuamente, incessantemente perché cambia continuamente la città e cambiano sempre i moti dell'animo dell'autore. "Discetta" significa esamina. "Non trovando fondale a quel risucchio/ di mancamento o rimorso" significa che se la parola per Luzi deve volare verso il vertice della significazione (lo zenit) la memoria invece è un abisso, non ha fondo, eppure è un grande vortice, un grande gorgo. Ma di cosa? Di assenza (mancamento), perché mancano visi, volti, luoghi di un tempo, e di rimorso, ovvero di sensi di colpa per gli errori commessi. Si noti anche tutta l'umiltà e il basso profilo del grande poeta fiorentino che naturalmente non attribuisce niente di negativo a Firenze (non parla di nessun borgo selvaggio), ma paragona la propria vita a una spina infissa dentro la sua città. Ma cosa significa "quell'aria di congedo in lei da me, in me da lei"? Significa probabilmente che la Firenze di quei giorni non sarà più la stessa e forse non avrà più tutti i suoi bei platani, ma anche qui Luzi pensa alla sua dipartita. Oppure una terza opzione: Luzi chiude con "...o il niente di/ questo", con un versicolo ungarettiano di una sola parola, una clausola dal tono dimesso, che però significa che il poeta non è certo di niente, non sa davvero il senso della sua tenerezza, sa solo dell'affetto profondo che lo lega a quei luoghi senza saperne i motivi. Firenze per Luzi non è un posto come un altro. Leggendo questi versi sorgono in me alcuni interrogativi. Quanti anni bisogna vivere una città per conoscerla veramente? Quante strade bisogna conoscere? Quanti luoghi bisogna aver frequentato? Quante persone bisogna aver incontrato? Quante storie bisogna aver avuto? E se questo rapporto fosse una catena indissolubile? Cosa è che ci lega veramente a questo posto? Di cosa sentiremo la mancanza? Non ci sono risposte, ma solo impressioni e un vago sentore di essere abitudinari o recidivi. Approssimativamente posso solo dire che ogni paese ha il suo cielo e ogni cittadino ha un angolo di cielo, a cui spesso rimane fedele negli anni. Ma questa poesia mi dice altre cose, mi suggerisce altre cose. Quando descriviamo un paesaggio in realtà descriviamo il nostro punto di vista. Quando parliamo del mondo in realtà parliamo della nostra visione del mondo. L’umanità è una moltitudine incredibile di punti di vista, di visioni del mondo. Ognuno è una sintesi di interno ed esterno, di idee e cose, di soggettività e oggettività. Forse siamo fatti male, ma è così ad onor del vero. Questo è ciò che mi fa ricordare questa poesia. In definitiva Firenze sembra voler dire tante cose e sembra voler significare molte cose al grande poeta. Sempre Mario Luzi in una sua intervista dichiarava riguardo alla città: "La raffigurazione, naturalmente, è reale e simbolica nello stesso tempo e vuole denunciare che la città umana senza idea vitale si sfascia". Non a caso a conti fatti è difficile, anzi è quasi impossibile trovare il senso compiuto di una città, anche se è cara e familiare.
ago 022022

Sicuramente alcuni letterati giustamente hanno cercato di raccogliere o meglio hanno aspirato a raccogliere l'eredità letteraria e critica di Fortini, però mi chiedo io se ha più senso oggi la cosiddetta funzione Fortini, ovvero l'intento di politicizzare la letteratura italiana, in vista di una rivoluzione. Me lo chiedo ora che la rivoluzione a mio avviso non è più possibile, dato che le coscienze sono addomesticate dai mass media e che il capitalismo di sorveglianza ci ha tutti schedati, vivisezionati, controllati totalmente. Bisognerebbe forse cercare di distruggere mass media e capitalismo di sorveglianza? Bisognerebbe quantomeno boicottarlo? Non sarebbe forse un tentativo puerile, utopico, come del resto quello del luddismo? Forse la cosa migliore è aspettare tempi più propizi. Forse anche le multinazionali e le lobby faranno dei passi falsi. La speranza è che il mondo migliori. Di ingiustizie e disuguaglianze ce ne sono a bizzeffe. Come è possibile fare la rivoluzione quando questo sistema ha svuotato e distrutto la concezione sociale della comunità? Non esiste più il senso della comunità. Siamo in una società in cui è sempre più difficile dire "noi". Le classi sono scomparse e con esse anche la coscienza di classe e la lotta di classe. La rivoluzione pacifica non è più possibile e molto probabilmente neanche quella non pacifica: sarebbe solo un inutile e utopico bagno di sangue, in cui sarebbero i rivoluzionari prima di tutto a rimetterci. Il problema non è solo accettare una quota fisiologica di violenza per fare la rivoluzione, ma ormai la questione di fondo è rassegnarsi alla sconfitta, accettare le istanze della rivoluzione mancata, accettando razionalmente che quei tentativi non sono più ripetibili. La lotta è impari, realisticamente parlando. Allora non sarebbe meglio unirci tutti, indipendentemente dell'orientamento politico, in nome del buon caro umanesimo, un umanesimo più moderno, che comprenda anche le scienze umane, per una critica serrata e radicale alla società attuale? Che senso ha rimpiangere la rivoluzione? Non sarebbe un grande atto politico cercare di riunirsi in nome dell'umanesimo? Il treno della rivoluzione è stato perso e probabilmente non passa più. Che fare ora? Stare sempre rivolti al passato? È utile la nostalgia di un'epoca che non tornerà probabilmente? Certo di grandi insegnamenti da trarre da quegli anni ce ne sono. Quell'epoca e la quella cultura non devono essere passati invano. Non sarebbe però ritornare sempre a quei giorni ripetere il solito mantra, il solito continuo "vorrei ma non posso", nel vero senso della parola? Per fare una cosa molto umana, ovvero il comunismo ci vogliono dei metodi sanguinari e disumani. Chi tutela il sistema capitalistico tutela i propri interessi ed è mosso dal proprio egoismo. Cosa succederebbe poi se il sistema intero implodesse? Che ne sarebbe di noi? Inoltre al mondo d'oggi molti hanno qualcosa da perdere, anche poco, anzi pochissimo, ma se lo tengono stretto. Siamo sicuri che il comunismo sarebbe un sistema migliore? Siamo sicuri che il tracollo del capitalismo non ci porterebbe in condizioni umane ancora più disastrose? Comunque anche se non si può accettare le dinamiche e le trasformazioni socioeconomiche odierne vanno capite e criticate. In questo il pensiero di Fortini può aiutarci molto, può venirci in soccorso. Non si può nascondere la testa sotto la sabbia. Ci vogliono comunque anche nuovi strumenti intellettuali per capire nuove dinamiche. Bisogna stare al passo con i tempi. Fortini va sempre tenuto presente perché è un grande maestro e un lucidissimo intellettuale, anche se apparteneva a un'epoca lontana. Fortini, per quanto sant'uomo e autore geniale, non poteva prevedere tutto, anche se ha previsto molto. Il primo interrogativo è come fanno molti a definirsi fortiniani e perciò militanti quando hanno accettato di buon grado tutti i meccanismi dell'industria culturale e i compromessi delle carriere universitarie? Più che raccogliere l'eredità diciamo che ne hanno subito gli influssi, anzi degli echi lontani. Infine un ultimo dubbio: raccogliere interamente l'eredità fortiniana significa anche abbracciare la sua religiosità (i Salmi, i libri sapienziali del Vecchio Testamento, i profeti, etc etc), per quanto Fortini non fosse sionista (vedere "I cani del Sinai"), e non fraintendere, non equivocare la sua chiamata alla clandestinità, che non significava prendere le armi e che al mondo d'oggi molto probabilmente, questa clandestinità, non è più possibile perché qualsiasi lotta, qualsiasi forma di opposizione richiede una certa visibilità, anche a rischio di farsi fagocitare dai mass media: sono finiti i tempi dei fogli ciclostilati e delle riunioni piene di fumo. È vero che Fortini era anche un ideologo e oggi l'unica ideologia rimasta è quella del mercato, come cantava Gaber.

È vero che possono sembrare, anche se solo di primo acchito, un poco datate la politicità di Fortini e la politicizzazione del reale. Però non bisogna fermarsi alla superficie; bisogna sempre valutare la grande capacità critica e dialettica fortiniana, la sua costante ricerca di oggettività, le sue grandi intuizioni intellettuali. Non bisogna dimenticarsi neanche della grande capacità di accettare il dialogo e di mettersi sempre in discussione di Fortini: qualità o quantomeno cortesia che mancano a molti intellettuali oggi. Fortini va sempre tenuto in considerazione. Il suo saggio "Verifica dei poteri", più di ogni altro suo lavoro, va tenuto sul comodino, sempre a portata di mano, per dubbi, chiarimenti, delucidazioni, nuovi interrogativi. Ma bisogna anche chiedersi non qual è l'eredità di Fortini, piuttosto ciò che è vivo e ciò che è morto in noi del suo pensiero, parafrasando Croce. Insomma Fortini è importante e non deve essere dimenticato e lo scrivo anche se non sono fortiniano. L'eredità di Fortini sarebbe a ogni modo ingente, cospicua, ma molto probabilmente mancano gli eredi legittimi.
giu 242022
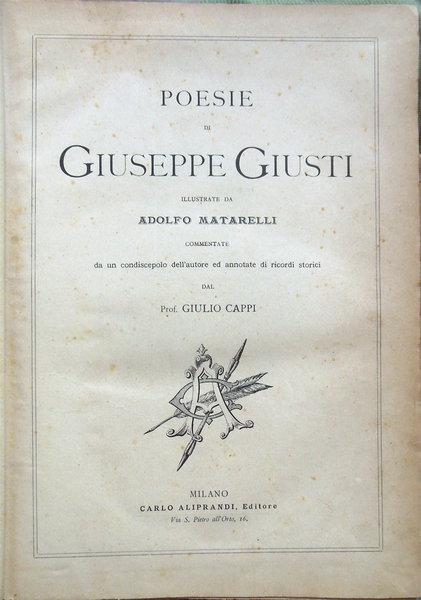
Giuseppe Giusti nacque a Monsummano nel 1809. Dopo aver frequentato diversi collegi toscani, si iscrisse a legge all’università di Pisa. Divenne avvocato, però non esercitò mai la professione. Visse la maggior parte della vita a Pescia. Affetto da tubercolosi polmonare si trasferì a Montecatini per curarsi. Morì di tisi a Firenze nel 1850 e fu sepolto a San Miniato. Nel corso della sua breve vita ebbe modo di conoscere Alessandro Manzoni. Fu anche accademico della Crusca e deputato al parlamento di Firenze. Il Giusti fu un liberale illuminato e uno dei migliori poeti satirici italiani della ’800. Anche Benedetto Croce si occupò della sua arte e lo definì "poeta prosastico". Il nostro avanzò critiche nei confronti delle istituzioni e delle ambizioni individuali. Le sue opere satiriche sono perfettamente aderenti alla realtà dell'epoca; presentano parodie e tratteggiano tipologie di persone senza alcun moralismo: i politici voltafaccia, i nobili esterofili, gli arricchiti, i falsi preti, i governanti indolenti. Il poeta comunque non si atteggia mai a censore di vizi e non è mai paternalista. Giunge sempre alla comicità, enfatizzando certi tratti ed esasperando certe caratteristiche di figure, che esistevano realmente ai suoi tempi. Il Giusti fu un artista colto, ferrato nella cultura classica e nella tradizione letteraria. Nelle sue poesie però fa la caricatura del potente, ma non offre una parola di conforto al povero. Certamente non fanno parte del suo retroterra poetico l'impegno civile e la partecipazione emotiva del Porta e del Belli, che riuscirono a dare risalto nei loro lavori a quel popolo, che fino ad allora non aveva mai avuto voce.

Il nostro poeta tratta spesso e volentieri di crapule e baldorie di persone, che non vivono in ristrettezze economiche. Resta da definire però se questo sia un difetto o un pregio. Infatti se da un lato può apparire distaccato, dall'altro non fa mai demagogia, non si abbandona a facili utopie e non ha la presunzione di dire qualcosa alla gente, che soffre e fatica. I poemetti satirici dei suoi "Scherzi" sono stati riconosciuti pregevoli all'unanimità, hanno avuto vasti consensi sia all'epoca (anche Gino Capponi era un grande estimatore del poeta), sia nel '900 (si pensi al Palazzeschi). Meno apprezzato dalla critica letteraria invece per le opere intime e di carattere sentimentale. Anche se in alcune liriche si può identificare il carattere risorgimentale, il Giusti non fu un mazziniano perché timoroso del popolo e di eventuali insurrezioni popolari. Comunque sono costanti nei suoi versi l'avversione per lo straniero conquistatore e il patriottismo. Difficile collocarlo politicamente. Fu davvero un liberale singolare in quel tempo: né un neoguelfo alla Gioberti, né un federalista come Cattaneo. Il Guerrazzi, suo avversario politico, disse di lui che scardinò lo stabile della società del periodo, avendo però paura dei calcinacci. Non mancano critici letterari che hanno una visione più giacobina dell'opera del Giusti. La sua produzione poetica è vasta e originale. Tocca gli argomenti più disparati. Spazia dall’ambito politico-sociale a quello storico. Notevole l’uso sapiente del poeta della metrica italiana. Prima dell’avvento nel ’900 del verso libero i poeti utilizzavano soprattutto l’endecasillabo (che non è necessariamente un verso di undici sillabe, ma l’importante è che abbia l’accento tonico sulla decima sillaba e un altro accento tonico sulla quarta o sulla sesta). Il Giusti invece varia prosodia continuamente. Spesso utilizza quinari e settenari. Più raramente usa le strofe saffiche (tre endecasillabi ed un quinario) e le ottave. Si può notare la sua autoironia in vari componimenti. Ad esempio in “Rassegnazione e proponimento di cambiar vita” scrive: “in quanto al resto, poi non mi confondo: / faccia chi può con meco il prepotente: / io me la rido e sono indifferente”. Il suo umorismo però talvolta è pervaso da un sentimento di nostalgia come nell’opera “Le memorie di Pisa”, in cui descrive la goliardia degli studenti universitari toscani.

La poesia satirica che mi ha divertito di più è l' "Apologia del lotto", che tra l'altro è ancora attuale. Il Giusti decanta i pregi del lotto, tra cui diventare signori con pochi soldi, far fare studi approfonditi sull'interpretazione dei sogni. Come se non bastasse scrive che il Lotto è l'unica fede rimasta al popolo e che giocando non si rischia la libertà, come invece accadde a Galileo che fu processato per aver professato la verità nell'ambito scientifico. Ma leggendo tra le righe, si capisce che lo Stato non perde mai e che chi è contento della sua condizione economica non gioca di certo al Lotto. La sua opera più famosa è senz’ombra di dubbio la raccolta di proverbi toscani. Popolari per i toscani e gli appassionati di letteratura anche poesie come “Lo stivale” e “Sant’Ambrogio”. Nella prima opera il Giusti adopra l’allegoria dello stivale per narrare le tribolazioni storiche dell’Italia: le dominazioni straniere, gli avvicendamenti di principi e regni dall’epoca dell’impero romano fino ai suoi tempi. Il poeta scrive: “Per un secolo e più rimasto vuoto,/ cinsi la gamba a un semplice mercante”. Questo verso sta a significare che solo durante il tempo dei Comuni l’Italia visse un periodo di relativa libertà, anche se la Sicilia era dominata dagli stranieri. Il capolavoro finisce con l’appello all’unità nazionale. Il Giusti scrive infatti: “E poi vedete un po’: qua son turchino, / là rosso e bianco, quassù giallo e nero;/ insomma a toppe come un Arlecchino: / se volete rimettermi davvero/ fatemi con prudenza e con amore, / tutto d’un pezzo e tutto d’un colore”. In Sant’Ambrogio invece il poeta tratta della dominazione austriaca. All'inizio della poesia l'artista dichiara che è stato considerato anti-tedesco solo perché in alcuni suoi versi ha parlato male degli sbirri. Ma nel finale il poeta ha una levata di umanità anche per i soldati austriaci, che sono lontani da casa e costretti a vivere in un paese straniero. Anche loro che in fondo sono gente comune "l'hanno in tasca". Solo i regnanti ci guadagnano sempre grazie all'antico "divide et impera". Anche la poesia dal titolo "Gingillino" gode di una certa fama. Il poeta descrive un tipo conformista e arrivista, che ingannando gli altri riuscirà a mettere le mani in pasta. Divenuto dottore in legge Gingillino va nella capitale per cercare un posto. Lì diventa "un birro", cioè un ufficiale della polizia e conosce l'ex-cuoca di un notabile, che gli dà tutti i consigli giusti per fare carriera: scansare i liberali e chi pensa con la propria testa, non parlare mai di libri e di giornali, arrufianarsi con il superiore, lodarlo a più non posso, riferirgli i pettegolezzi. Non ho voluto fare un saggio critico sul Giusti, anche perché non ne sarei in grado. Ho voluto invece dare un consiglio di lettura nel modo più semplice possibile. Leggete il Giusti. Le sue rime sono divertenti e mai scontate. Personalmente lo ritengo geniale per il suo estro e la sua arguzia. A mio modesto avviso è uno dei pochi poeti italiani di tutti i secoli che sappia sorridere e accantonare la tragicità.
giu 172022

Ungaretti dovrebbe essere un modello per i poeti contemporanei spesso illeggibili perché incomprensibili. Ognuno, dopo aver finito di scrivere una raccolta poetica, dovrebbe rileggere "Allegria", che si caratterizza per i versicoli immediati. Dovrebbe essere la prova del nove per tutti i poeti. Allo stesso modo ogni romanziere dovrebbe, dopo ogni sua fatica letteraria, rileggere "Se questo è un uomo" e "Una giornata di Ivan Denisovič" perché questi due capolavori riescono a coniugare anche essi sostanzialità e testimonianza. Poi magari ogni scrittore potrebbe decidere se pubblicare o rivedere di nuovo il lavoro. Ma ritorniamo a Ungaretti. Sono talmente dirette e spontanee le sue liriche, che riescono a spiazzare e a colpire favorevolmente anche i lettori più snob, abituati alla poesia del Novecento che si distingue per essere così intellettuale! Ungaretti è agli antipodi di poeti così ricercati come Eliot e Pound. Riesce a semplificare il linguaggio e a essere scarno ed essenziale. Nei suoi versi troviamo tutta la sua vita di esule che si forma culturalmente a Parigi (conoscendo Apollinaire e Picasso) e che combatte sul Carso. Queste sue poesie sono testimonianza ineguagliabile della guerra. Sono prive delle descrizioni e dell'eloquenza della lirica di quegli anni. Non vi sono leziosismi. Sono frutto di un'ispirazione, che trascende la metrica, la retorica e l'estetica. Non vi venga in mente che le sue poesie scaturissero solo da intuizioni, seppure formidabili. C'era del lavoro alle spalle. Erano state molte le varianti e le revisioni prima delle versioni definitive. A onor del vero bisogna anche ricordare che il poeta distrusse le tradizionali forme poetiche nelle prime liriche, ma successivamente dimostrò di saper utilizzare anche versi canonici come novenari ed endecasillabi. Forse oseremmo troppo a scrivere che fu una sorta di cubista della poesia nella sua prima fase. Come ebbe a scrivere Ungaretti per essere poeti è necessaria non solo la pazienza, la conoscenza della tradizione, l'intelletto. Bisogna anche saper fare i conti con il mistero che alberga in ogni animo: soltanto così una poesia può diventare unica come la sua. Ungaretti, quando scrisse i suoi primi innovativi versicoli, aveva appreso la lezione dei simbolisti francesi. Ma Ungaretti era completamente originale. Aveva subito saputo distinguersi dai suoi illustri predecessori. Era un predestinato della poesia. Lo stesso Thomas Merton scrisse che Ungaretti era sconvolgente e che la sua intensità annientava. Alcuni suoi versi rimarranno per sempre nella memoria di molti: "m'illumino d'immenso", "è il mio cuore il paese più straziato", "si sta/come d'autunno/ sugli alberi/ le foglie", "Di che reggimento siete/ fratelli?", "Non sono mai stato/ tanto/ attaccato alla vita", "tra un fiore colto e l'altro donato/ l'inesprimibile nulla". Queste illuminazioni esprimono in modo impareggiabile la precarietà e la fragilità proprie di chi combatte in una guerra assurda. Ungaretti aveva combattuto la grande guerra e per capire quanto fu devastante la prima guerra mondiale non bisogna andare molto lontano: basta andare a visitare Asiago, che fu completamente rasa al suolo in quegli anni. Ungaretti viaggiò molto. Visse molto. Soffrì molto. Non soltanto per l'esperienza della guerra ma anche per la morte del figlioletto di nove anni a cui dedicò la raccolta "Giorno per giorno". Il poeta si chiedeva come era possibile continuare a vivere e a fare le cose di ogni giorno quando non poteva più vedere il suo bambino, la cui voce non avrebbe udito più. Scrisse Ungaretti: "E t'amo, t'amo, ed è continuo schianto!...". Nella sua vita il poeta sperimentò i dolori più terribili: gli orrori della guerra e la scomparsa del figlioletto. Ma Ungaretti riuscì a non lasciarsi mai sopraffare dalle avversità e dai tristi eventi. Riuscì sempre a superare questi periodi di crisi, testimoniando con i suoi versi le tragedie vissute. La follia della guerra riuscì a vincerla confidando nell'uomo: credendo nella fraternità. Il dolore atroce per la perdita del figlio lo sconfisse non solo con la terapia della scrittura ma anche con la religiosità. Non auguro a nessuno di provare i dolori di Ungaretti. Dovrebbe però essere preso di esempio per la sua semplicità, che è mai scontata e non scade mai in banalità. Il Nostro scrisse in modo apparentemente semplice ed è comprensibile a tutti. Ma non lasciatevi ingannare. Ungaretti era anche un profondo conoscitore della lingua e della poesia. C'è chi potrebbe pensare che molti sarebbero in grado di scrivere come Ungaretti ma è un giudizio affrettato dovuto a pura superficialità e faciloneria: pensarla così è pura ingratitudine nei confronti di uno dei più grandi poeti del Novecento. Comunque Ungaretti fu il primo a scrivere in quel modo così breve e coinciso. Nel peggiore dei casi gli vanno riconosciute in tutta onestà sia la bravura che la grande originalità.
giu 172022

Quasimodo, nonostante le sue sperimentazioni e le sue revisioni stilistiche, fu sempre legato alla tradizione, grazie alla musicalità dei suoi versi e al suo classicismo (non a caso tradusse i lirici greci). Inizialmente il poeta cantò il mito della Sicilia, la nostalgia e lo sradicamento dalla sua terra; nelle sue prime raccolte rievocò l'infanzia e i paesaggi che lo avevano visto nascere e crescere. In quegli anni fu ermetico. Alcuni lo hanno considerato un caposcuola, mentre altri solo un fiancheggiatore di questa corrente letteraria. Coloro che lo criticano negativamente per questa sua adesione dovrebbero però ricordarsi che erano gli anni della formazione del suo immaginario e del suo apprendistato poetico: non era ancora nella fase della maturità.
L'ermetismo aveva il grande pregio di proporre "la letteratura come vita" e di opporsi all'autoesaltazione, all'enfasi, alla megalomania di D'Annunzio. Alcuni critici però hanno sempre accusato gli ermetici di essere oscuri e di utilizzare un linguaggio allusivo. Ma Quasimodo anche in questo suo periodo non fece mai un utilizzo eccessivo dell'analogia. Poteva sembrare di primo acchito non totalmente originale, eppure successivamente si dimostrò unico sia dal punto di vista espressivo che per quel che riguarda la visione del mondo.
Il poeta seppe distaccarsi dalla retorica di Carducci, dall'estetismo e dall'irrazionalismo di D'Annunzio, dall'intimismo e dalla stanchezza di vivere dei crepuscolari, dall'esaltazione del progresso dei futuristi, dal nazionalismo di altri artisti; il poeta siciliano non scavò mai nella parola e non distrusse il verso come fece Ungaretti; non distrusse mai le strutture logiche e sintattiche; non si abbandonò all'estetismo; non si lasciò corrodere dall'autodistruzione e dalla nevrosi; non fu mai preda dell'intellettualismo e ricordo che per esempio per Croce l'autentica poesia era priva di sovrastrutture ideologiche, di allegorie, di tematiche filosofiche e teologiche. Quindi secondo i canoni estetici crociani i suoi componimenti erano poesia. Il grande critico letterario Oreste Macrì scrisse un saggio sulla "poetica della parola" di Quasimodo. Come poeta sono pochissimi coloro che lo giudicano in modo negativo. Come uomo all'epoca alcuni lo criticarono per non aver partecipato alla Resistenza. Ma come scrisse lo stesso Quasimodo "il poeta modifica il mondo" e non è detto che lo possa fare soltanto con l'impegno politico-sociale, ma lo può fare anche con i suoi versi. Dopo la fase ermetica non scrisse più dell'Eden perduto ma trattò della sofferenza dell'uomo in guerra. Quasimodo dimostrò di saper compiere un'evoluzione dal punto di vista umano, affrontando nuove tematiche. Aveva sempre nostalgia di casa, ma non era più il paesaggio siciliano a avere la meglio: era piuttosto la coscienza civile ad essere presente in ogni lirica. Il poeta non poteva stare nella sua torre eburnea, ma doveva esprimere sentimenti come solidarietà, partecipazione emotiva, fraternità. Evitò così di descrivere l'incomunicabilità e divenne forse il più comunicativo dei poeti del Novecento, addirittura forse più di Ungaretti: sicuramente uno dei più semplici e più comprensibili a leggersi, il più efficace a descrivere la crisi esistenziale dell'uomo moderno conseguente alla tragedia e all'orrore della guerra. I suoi messaggi erano chiari ed espliciti.
Come non ricordare la lirica "Uomo del mio tempo", in cui scrive che l'uomo è sempre lo stesso di quando usava la pietra e la fionda e che ora utilizza le sue scienze esatte per sterminare i suoi simili? Oppure come scordarsi "Alle fronde dei salici" che necessita di una parafrasi solo se letta da un bambino delle elementari o al massimo delle scuole medie inferiori? Oppure come non ricordarsi la lirica "Quasi un epigramma" in cui definisce la società moderna come "la civiltà dell'atomo"? Non era forse questa poesia civile? Non era questo un lirismo fatto da parole semplici che potevano arrivare a tutti? Ancora memorabili i versi di "Lamento per il Sud" in cui descrive un Sud dove si moriva di stenti e nonostante ciò ancora bello e incontaminato, a differenza di un Nord industrializzato e già inquinato. La lirica più celebre di tutte è senza ombra di dubbio "Ed è subito sera" perché in pochissimi versi sono rappresentate sia la solitudine dell'uomo contemporaneo che la brevità della vita e lo scorrere inesorabile del tempo. A mio modesto avviso il poeta cercò sempre di descrivere l'enigmaticità e il non senso di un mondo sfuggente e colmo di brutture: una società di massa desacralizzata ("senza Cristo") in preda alla barbarie. Da ricordare anche che dopo la fine del conflitto mondiale si avvicinò al neorealismo e si mostrò critico nei confronti del boom economico e del consumismo. Con queste poche righe non voglio assolutamente spiegare Quasimodo. Posso solo interpretare i suoi versi e voglio farlo da dilettante senza seguire le regole, i criteri e i metodi dei critici di professione. Comunque per avere più chiara la sua poetica ricordo che fu proprio Quasimodo nel suo saggio "Discorso sulla poesia" a scrivere che "la poesia si trasforma in etica, proprio per la sua resa di bellezza".
giu 172022

Montale nacque nel 1896 a Genova e morì a Milano nel 1981. Nell'adolescenza e nella giovinezza trascorse le estati a Monterosso, dove faceva bagni e gite con Anna degli Uberti, che forse si può identificare con Annetta, la prima presenza femminile della sua poesia.
È proprio a Monterosso (alle Cinque Terre) che si formò come poeta autodidatta e fu proprio questo paese a essere fondamentale nel suo immaginario. La critica ormai ha sistemato Montale assieme a Ungaretti (la poesia pura) e Saba (la poesia onesta). Oppure talvolta ha proposto una nuova triade: Montale, Ungaretti, Quasimodo (caposcuola dell'ermetismo).
A mio modesto avviso, queste collocazioni lasciano il tempo che trovano. Gli stessi critici un tempo proponevano la triade Carducci, Pascoli, D'Annunzio. Comunque Montale non fu mai legato a alcuna scuola o ad alcun ismo letterario. Possiamo solo affermare con certezza che in gioventù i suoi modelli di riferimento furono Foscolo, Leopardi, Manzoni. Gli Ossi di seppia furono pubblicati da Gobetti nel 1925 e dimostrano una grande originalità perché si distanziano dall'opera dannunziana Alcyone.
Lo stesso Montale definì la poesia degli Ossi controeloquente e per nulla aulica. Il premio Nobel non a caso predilige i limoni ai bossi ligustri dei poeti laureati. La poesia degli Ossi permette di dire soltanto "ciò che non siamo, ciò che non vogliamo". Nella sua prima raccolta poetica troviamo come protagonista l'aridità del paesaggio ligure: non troviamo neanche sullo sfondo i grandi eventi storici o le ideologie, anche se Montale firmò in seguito il manifesto degli intellettuali antifascisti e si oppose quindi alle "stalle di Augia". Gli stessi Ossi di seppia, che sono detriti in balia della corrente e che poi restano inermi sulla spiaggia, non simboleggiano altro che la condizione umana. L'agave abbarbicata allo scoglio in fondo non rappresenta altro che l'isolamento del poeta. La natura soffre; lo stesso essere umano soffre e non può far altro che testimoniare la propria sofferenza ("il male di vivere").
La poesia montaliana si contraddistingue per il descrittivismo, la capacità di creare oggetti-emblemi e di mitizzare i luoghi della sua giovinezza. Ma è allo stesso tempo anche una poesia che rappresenta la crisi esistenziale di Montale, le sue disarmonie, il suo disagio, la precarietà della vita, l'inautenticità dell'esistenza: in definitiva il suo rapporto problematico con la realtà. La sua poetica non consiste quindi in una pura nominazione e i suoi componimenti non sono semplici esercizi di stile, nonostante la sua giovane età. Montale inoltre non ha e non offre mai speranze, illusioni e neanche metafisiche consolatorie (i morti per Montale perdurano soltanto nella memoria dei vivi. Non c'è alcun aldilà): "è della razza di chi rimane a terra", anche se è alla ricerca di un varco (alcuni critici hanno considerato per tale ragione il poeta comunque pervaso da un'ansia metafisica). Forse anche per questo è stato accusato di immobilismo esistenziale (è lui stesso Arsenio) nel corso della sua carriera poetica, oltre al fatto che è sempre stato etichettato come il poeta borghese per antonomasia. Per alcuni critici era non credente e borghese: perciò incapace di evolversi e destinato a ripetere le stesse tematiche.
Comunque gli Ossi di seppia forse restano il vertice della poesia montaliana: l'esito più alto.
Non voglio trattare delle innovazioni metriche ed espressive della poesia di Montale. Sono state scritte molte pagine di critica letteraria riguardanti la metafisica montaliana dell’ “anello che non tiene” e del “male di vivere”. Sono stati versati fiumi di inchiostro sul fatto che non ebbe certezza della realtà né dell’esistenza e che non riuscì mai a conciliarsi con sé stesso. Forse per queste ragioni la sua poesia è un’interrogazione delle cose ed è costituita da oggetti che divengono simboli. Ma non è mai puro esercizio di nominazione né vano tentativo di giungere alla soglia del dicibile. Il poeta è teso verso l’essenziale, evita inutili orpelli. Non a caso il poeta degli “Ossi di seppia” nel 1946 aveva sostenuto in “Intervista immaginaria” che la poesia era apporto di conoscenza e non più mera rappresentazione. Questa sua affermazione si può considerare una dichiarazione di intenti a cui seppe rimanere fedele e coerente negli anni successivi. Montale aveva intuito che gli oggetti potevano inviare dei segnali da decifrare e che in essi ci fossero dei significati profondi da cogliere, evitando di cacciarsi in zone inesplorate ai più e di dare forma alla materia informe e indifferenziata dell’inconscio. Ecco allora che Montale cerca la verità nel dettaglio. La cerca nella traccia di lumaca, nello smeriglio di vetro. Non esclude dalla sua indagine nemmeno lo stuzzicadenti e la briciola, perché anche queste “possono dirci qualcosa”. La verità è sotto ai nostri occhi, nelle nostre mani. E’ come una cosa che non riusciamo a trovare, l’abbiamo cercata in tutti gli angoli tranne che nelle nostre mani. Ma allo stesso tempo Montale ci dice che “è inafferrabile e sguscia come un’anguilla”. Esistono però delle persone che sono in grado di aiutarci nella ricerca della verità. E’ il caso di Esterina, che salva dal “delirio di immobilità” Arsenio e tutti coloro che appartengono alla “razza di chi rimane a terra”. Nel lessico poetico di Montale compare in più occasioni il termine “agnizione”, che significa riconoscimento. Grazie ad Esterina il poeta giunge all’agnizione, alla rivelazione esistenziale, all'illuminazione interiore. Tramite quelle che Holderlin definiva “divinità terrestri” Montale giunge alle sue formule poetiche, alle sue celebri sentenze. Queste “divinità terrestri” sono state naturalmente persone in carne ed ossa, ma hanno incontrato un grande poeta che è riuscito a vagheggiarle e trasfigurarle. Forse idealizzandole. Alcune di queste celebri epifanie montaliane furono vissute a Monterosso. Recentemente, naturalmente prima della pandemia, sono stato a visitare le Cinque Terre, che dal 1997 sono diventate patrimonio dell'umanità. Sono rimasto deluso perché i borghi erano sovraffollati. Era pieno di turisti stranieri, che erano in gran parte arrivati con il traghetto da La Spezia. I parcheggi erano tutti a pagamento e nonostante questo non si trovava un posto. I ristoranti erano affollati. I negozi alimentari, i bar, le pizzerie a taglio erano prese d'assalto. Il turismo di massa arricchisce i liguri ma salvaguarda forse il territorio? Un tempo forse era un'ingiustizia che tale natura incontaminata fosse privilegio di pochi (quando non c'erano ancora le autostrade, i traghetti, le ferrovie). Quando ci sono andato era una calca, un caos. Non esiste una via di mezzo? Il consumismo e il turismo mordi e fuggi forse finiranno per deturpare anche le Cinque Terre. Per la tutela di quei borghi dovrebbe essere preferito un turismo di qualità a un turismo di quantità. Il rischio è che i vandali oppure più probabilmente i maleducati rovinino tutto.
giu 142022

Reno Bromuro (Paduli, 2 luglio 1932 – Roma, 12 giugno 2009) è stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale italiano. Nel 1957 ha fondato a Napoli il "Centro Sperimentale di Ricerca per un Teatro Neorealista". Nel 1970, ha fondato a Roma la Compagnia di Prosa "I Corinti". Ha lavorato in teatro con i giovanissimi della Scuola Media Statale San Giorgio di Fregene. È stato anche giornalista e critico letterario. Ha pubblicato numerose raccolte poetiche. Ha vinto numerosi primi premi per la Poesia, per la Narrativa, la Saggistica e il Giornalismo. Non l'ho mai conosciuto personalmente. Non ho mai interagito con lui. Leggevo però nel 2001, 2002, 2003 le sue riflessioni e il suo almanacco del giorno su una mailing list che ora non esiste più, ovvero Nonsolopoesia. Bromuro spiccava per la sua cultura, il suo talento, ma anche per il fatto di essere un operatore culturale instancabile, sia nella vita reale che su Internet. Il web allora era agli albori. La maggioranza dei siti che trattavano di poesia erano amatoriali, gestiti dagli studenti o da semplici appassionati. Molte case editrici, molti scrittori, molti intellettuali snobbavano Internet. Allora io avevo un sito di poesia su Geocities, ma c'era anche chi lo faceva su Digiland, su Lycos, su Blogspot, insomma sui vari portali che offrivano hosting gratis. Bastava conoscere i rudimenti di Html e smanettare un poco. Mi colpì la competenza di Bromuro. Lessi attentamente il suo saggio intitolato "Il racket nell'arte e il valore umano della poesia". Leggendolo, avevo la conferma di una cosa, che avevo solo grossolanamente e vagamente intuito. Esisteva la cosiddetta mafia nel mondo della poesia. Era una mafia che non uccideva le persone ma ignorava il talento, lo mortificava giorno dopo giorno, infine lo uccideva e con esso assassinava la poesia. Non bastava la mancanza di talento degli aspiranti poeti (aspirazione legittima quella di essere poeti) che erano soprattutto poeti della domenica che infestavano il web. No. Erano anche i letterati e gli addetti ai lavori a giocare sporco. Qualcuno poteva giustificare tutto ciò col fatto che dovesse compiersi una selezione artistica, che la poesia non era per tutti, che l'arte non era esclusiva o inclusiva ma solo meritocratica. Eppure bastava leggere Bukowski per capire che la tendenza a fare cricca era un fenomeno non dico universale ma tipicamente occidentale. A cosa era dovuto tutto ciò? Forse a quella che Bromuro definiva "mercificazione dell'inutile"? Nel frattempo leggevo le poesie e gli scritti di Bromuro. Era un artista a tutto tondo oltre che un intellettuale senza fronzoli, che parlava chiaro e non si perdeva in intellettualismi. Aveva incorporato, interiorizzato la lezione di Popper sulla chiarezza espositiva non come qualità rara ma come dovere di tutti gli scriventi. Nei suoi saggi, nelle sue prefazioni, nelle sue recensioni riusciva a essere concettuale senza mai semplificare e ridurre alla banalità, ma anche senza essere troppo concettoso e difficile. Bromuro era un letterato che sapeva rivolgersi a tutti e farsi comprendere da tutti o perlomeno dai più. Eppure a distanza di 13 anni dalla morte ci restano testimonianza del suo ottimo ingegno alcuni siti a cui collaborava (compreso Letteratour) e alcuni suoi libri. Per il resto il mondo letterario ha ripagato con l'indifferenza e l'oblio questo artista, forse perché troppo scomodo e capace di denunciare cose che non si potevano dire né scrivere. Qualche potente delle patrie lettere avrà tirato un sospiro di sollievo alla sua dipartita ("A pensare male si fa peccato ma ci si indovina sempre" sosteneva Andreotti). Ma non è prettamente una questione artistica o totalmente artistica oppure riguardante la politica culturale. È prima di tutto una questione di coscienza e Bromuro era in pace con la sua. A volte mi sembra che i poeti contemporanei siano come dei polli che si azzuffano per poco becchime che elargisce loro il potere. Di poesia non si campa e allora molti si impiegano in professioni intellettuali, talvolta scendendo a dei compromessi. Contano le pubbliche relazioni anche nel mondo poetico. I poeti cercano sodalizi, appoggi da critici, cardinali, giornalisti. Bromuro non cercava conoscenze altolocate, ma si sapeva mettere a disposizione di tutti, ritenendo irrinunciabili l'onestà intellettuale e la sua dignità umana. Alle moine, gli arrufianamenti, i favoritismi lui opponeva le sue argomentazioni lucide. Una cosa che mi ha colpito è che in lui non c'era traccia di pressapochismo o di sfoggio di cultura. Sapeva ciò che scriveva. Non faceva l'erudito. Ma era colto e su questo personalmente non avevo dubbi. La sua cultura era pervasa al contempo da rigore e umanità. So che incoraggiava anche tutti gli artisti. Si prendeva a cuore della poesia degli altri, non solo della sua. Non vedeva come alcuni la poesia come una gara, una competizione a chi pubblica più libri o a chi vince più premi, anche se poi la poesia italiana era ed è soprattutto una PREMIOPOLI! Come mi disse lo scrittore lucchese Vittorio Baccelli in diversi casi i giurati dei premi con le tasse di iscrizione al concorso pagavano le cene al ristorante con la "ganza", ovvero con l'amante. Insomma nel migliore dei casi per quanto riguarda i premi c'era un poco di malafede, un piccolo abuso di credulità popolare oltre che un modo ignobile di speculare su chi vuole sentirsi artista. Nel peggiore dei casi può essere come per il premio Grinzane Cavour e lo scandalo che ne è conseguito. Fu la guardia di finanza, nel corso dell’inchiesta sulle vessazioni al domestico del patron Soria, a interessarsi dei conti del premio letterario e a certificare malversazioni dei contributi che gli enti pubblici fornivano al premio letterario: denaro che Soria usava anche per sé. Poi ci sono altri importanti premi che scompaiono per la morte della fondatrice o per delle incomprensioni, come nel caso del premio Montale, presieduto dalla poetessa Maria Luisa Spaziani. Ma veniamo a cose più importanti.

(Nella foto Vittorio Baccelli)
Occupiamoci di un altro artista. Vittorio Baccelli (Lucca, 12 ottobre 1941 – Lucca, 23 ottobre 2011) è stato uno scrittore italiano di letteratura fantastica. Anche lui è un artista ormai dimenticato. Ma perché un poeta viene dimenticato? In vita un poeta può essere stato oggetto di ostracismo artistico. Può essere soggetto da morto di damnatio memoriae. Ma spesso molti poeti finiscono nella dimenticanza per disinteresse generale. I poeti viventi spesso non guardano indietro, non sono riconoscenti a chi li ha preceduti. Si tratta talvolta di mancanza di sensibilità culturale e di ingratitudine. Ma tutto ciò ritorna al mittente perché siamo tutti mortali Oppure forse i letterari viventi non sono malvagi. Semplicemente sono in tutte altre faccende affaccendati. Sono occupati nella stragrande maggioranza del tempo a promuovere sé stessi e non hanno spazio né tempo per gli altri. Forse c'è questo alla base del racket dell'arte. Forse alla base di tutto c'è una mancata predisposizione all'ascolto delle voci altrui. Qualcuno sostiene che quando un poeta muore aumenta la sua quotazione o che addirittura un poeta morto è una iattura infinita perché ruba la scena a quelli ancora in vita. Ma sono prese di posizione e polemiche forse un poco ingenerose se non talvolta pretestuose. A ogni modo come scrisse la poetessa Vivian Lamarque, tanto per tagliare la testa al toro: "PS.: Siamo poeti/ vogliateci bene da vivi di più/ da morti di meno/ che tanto non lo sapremo". Vi consiglio, come per Reno Bromuro, di fare ricerche su Google anche su Vittorio Baccelli. Troverete anche il suo sito su Interfree. Ebbi modo di intervistarlo nel 2005. Rimasi anche in questo caso favorevolmente colpito. Era un vulcano di idee. Anche in questo caso, come per Bromuro, Baccelli era entusiasta del web. Aveva fiducia in questo nuovo mondo virtuale. Lo vedeva come una grande opportunità, un nuovo modo di farsi conoscere. Accettò di buon grado di farsi intervistare da me. Pubblicai l'intervista sul mio sito, ma nel 2009 Geocities chiuse, il mio PC fu attaccato da un virus. Insomma per farla breve persi integralmente tutti i contenuti di quel dialogo fitto. La cosa mi dispiacere perché Baccelli non era stato laconico, non mi aveva snobbato. Piuttosto aveva risposto a tutte le domande in modo molto esauriente. Baccelli era un artista e intellettuale di talento, ma forse è stato dimenticato anche perché non allineato politicamente: da giovane era stato di destra, nella maturità era un radicale. Inoltre era uno che non le mandava a dire. Aveva il coraggio delle sue idee. Come ebbe modo di scrivere Bartolomeo Di Monaco non aveva peli sulla lingua. Consiglio a tutti di leggere i suoi racconti brevi. Sono scritti in modo magistrale. Essenziali, mai sciatti; una prosa ideata e orchestrata da una mano sapiente. Baccelli aveva conseguito una laurea in lettere a Pisa e una in scienze umane a Urbino. Giocava con i riferimenti letterari. C'erano dei cenni autobiografici nei suoi racconti, ma oltre alla testimonianza di vita la sua scrittura si caratterizzava per uno sperimentalismo di alto livello, in cui la speculazione intellettuale non era mai fine a sé stessa. Era un maestro impareggiabile della narrativa. Non ebbe mai la tentazione di scrivere un romanzo, ma raccolte di racconti come "Storie di fine millennio" sono la prova inconfutabile della sua bravura. Scrisse inoltre un libro sul grande scienziato Nicola Tesla. Baccelli era stato anche un protagonista della Mail Art o arte postale. Riporto fedelmente la definizione della Treccani a figuardo: "Movimento artistico che si realizza nell'invio per posta di materiali come francobolli, cartoline, buste, lettere, pacchi e simili rielaborati artisticamente e indirizzati a uno o più destinatari. ♦ Due lettere identiche, una datata Parigi e una Torino, firmate dalla stessa Gina Pane e contenenti un identico messaggio: «Qui tutto somiglia a lì». Un terzo telegramma, con cui Bernard Auriard invita: «Immaginate neon rosa pallido preoccupazione temporanea». Sono tutte opere d'arte, e rappresentano l'ultimissima scemenza: la «mail art» o arte postale. Convinti che l'arte sia ormai antiarte, e l'opera assenza d'opera, certi artisti giocosi ne avevano già fatte di tutti i colori: Vittor Pisani aveva esposto in galleria soltanto se stesso; Kounellìs aveva esposto alcuni cavalli (molto indisciplinati e sudicioni) , esibito in una mostra unicamente il proprio pappagallo (più mite, ma sboccatissimo) e alla fine radunato dieci ragazzini suonatori di flauto incaricandoli di eseguire, ad una certa ora, un concerto di una sola nota. Al confronto, assicura il critico francese Jean Clair, l'arte postale è molto più impegnativa: «Ormai nessuno si dedica alla corrispondenza, la lettera è divenuta lettera morta», spiega. «Nel momento in cui la gente abbandona il mezzo postale, gli artisti se ne impadroniscono. (Lietta Tornabuoni, Stampa sera, 29 marzo 1972, p. 3, Aggiornatissimo)". Baccelli fu anche la risposta encomiabile ai molti che sottovalutavano la fantascienza italiana. Come ebbe a riportare in un suo libro lo stesso Baccelli: "A Lucca Comics (allora si chiamava “Salone dei comics”), alla fine degli anni ’70 nel corso di un’intervista nella quale gli si chiedeva perché non pubblicasse mai autori italiani e perché le storie di fantascienza non erano mai ambientate in Italia, Carlo Fruttero che all’epoca assieme a Lucentini era curatore di Urania, per esprimere efficacemente il concetto che la fantascienza italiana mai avrebbe avuto la possibilità di competere con quella americana e, per proclamare una sorta d’incapacità congenita da parte degli scrittori italiani ad essere buoni autori di fantascienza, dichiarò pubblicamente che un disco volante avrebbe plausibilmente potuto atterrare a New York, a Londra, a Pechino, a Mosca, ma a Lucca mai!". E Baccelli nel corso della sua vita fece il possibile per smentire questo luogo comune, che era anche una concezione limitata e limitante di un intero genere letterario. In questo caso Baccelli si dimostrò un pioniere lungimirante. Non aveva paura ad andare contro gli stilemi letterari imposti dall'alto. Baccelli come Bromuro erano perfettamente consapevoli dei canoni e delle mode letterarie imperanti, ma incuranti di tutto scrivevano come si sentivano, erano alieni da ogni conformismo. Entrambi inoltre cercavano con la loro arte di aderire alla vita. Anche Baccelli come Bromuro cercava di divulgare il sapere, di diffondere le idee, tant'è che negli anni Settanta aveva collaborato a diverse riviste cartacee e nei primi anni Duemila era diventato una presenza assidua di molti siti letterari. Mi chiedo talvolta perché mi sono imbattuto in questi due autori, degni di ogni rispetto e stima. Forse tutto ha un senso. Forse il mio piccolo compito era constatare il loro valore e scriverne qui in questa sede. Tra tanti presunti o sedicenti poeti che avanzavano pretese Baccelli e Bromuro volevano che fossero riconosciuti legittimamente i loro meriti e le loro capacità. Nel magazzino della memoria di chi si occupa di poesia italiana di questi ultimi anni ci dovrebbe essere un posto per tutti e due. Non è assolutamente giusto che cali definitivamente il sipario, che venga premuto il tasto delete su questi due artisti. Che si sappia almeno che sono esistiti! Che di sappia qualcosa di loro! Che il loro lavoro non sia stato inutile! E se è vero che non c'è memoria senza oblio è anche vero che ricordarli entrambi sarebbe almeno utile per chi non ne sa niente di loro. Ci sono ancora diversi angoli del web in cui trovare i loro scritti gratuitamente. Che almeno le loro vite non siano state vane! Concludendo, Paduli e Lucca dovrebbero avere la sensibilità di onorare la memoria di Bromuro e Baccelli. Almeno questi sarebbero due atti dovuti, anche se tardivi.