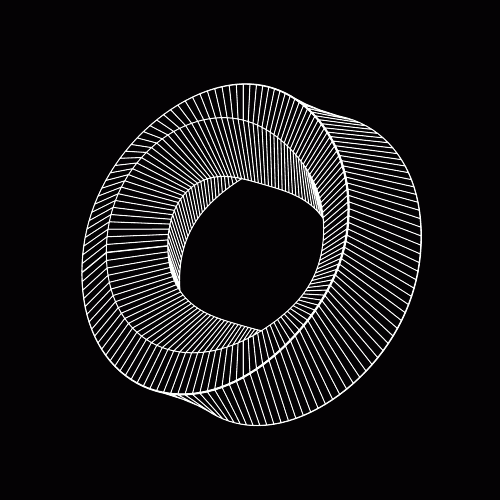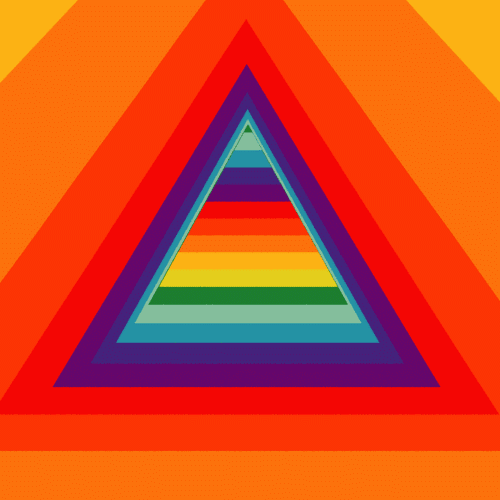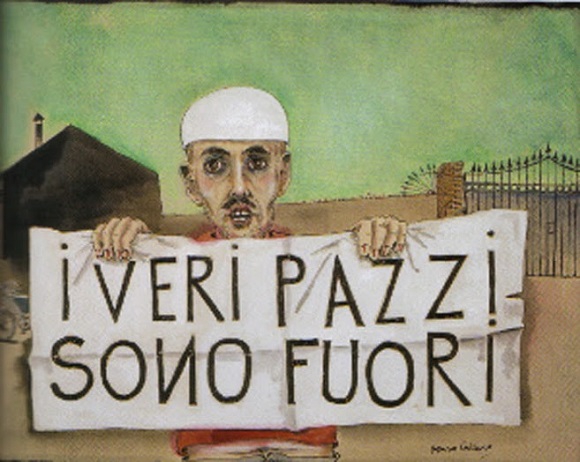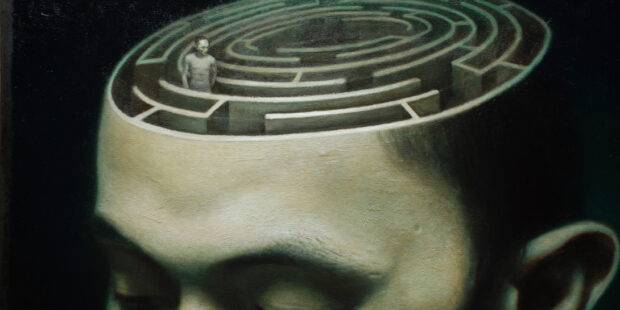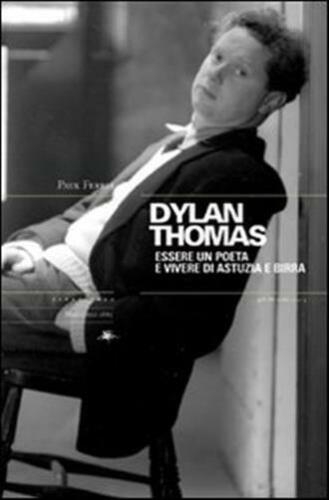ott 012022
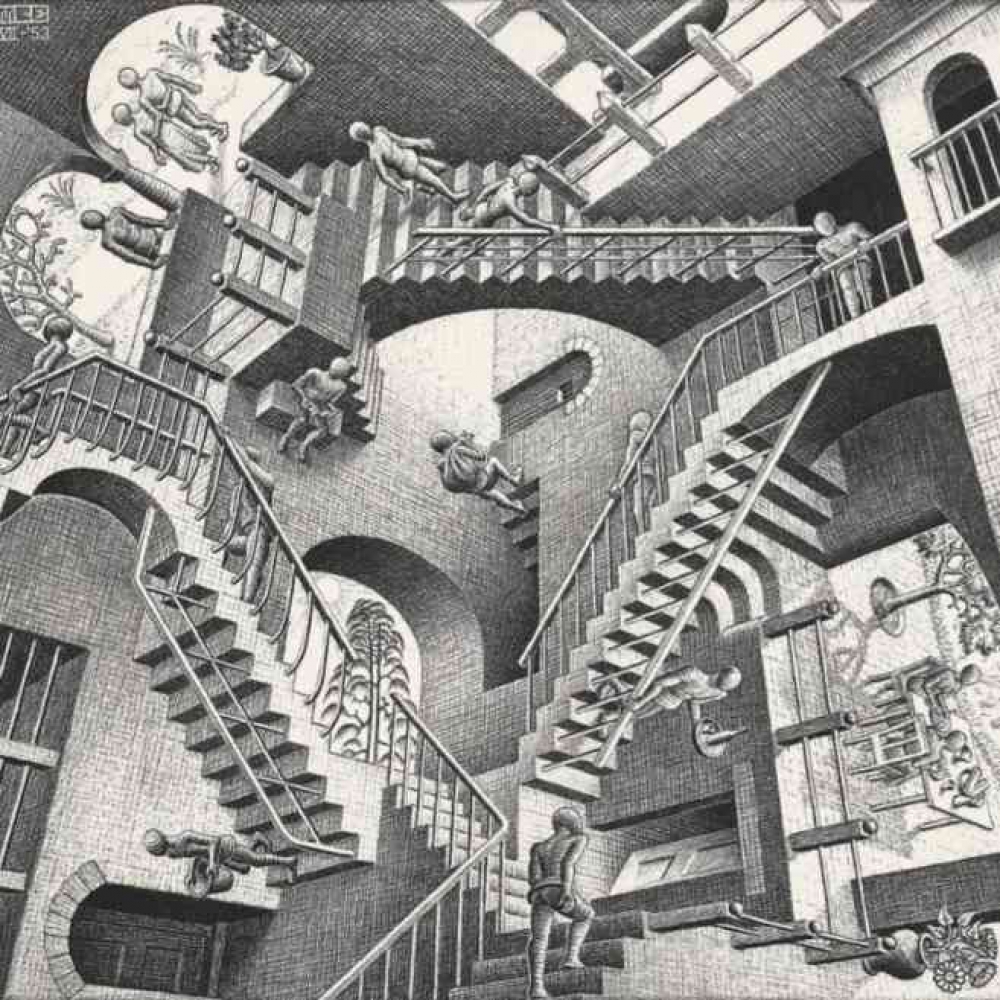
Si può avere dei pessimi gusti letterari ed essere delle brave persone. Si può pensare che l'impoesia sia poesia, che la poesia sia impoesia ed essere delle brave persone. Che tanto poi non esistono più da secoli dei criteri assoluti e oggettivi per stabilire che cosa sia poesia e che cosa non lo sia! Prima del Novecento i poeti dovevano essere aulici e rispettare i santi crismi della metrica. Ai tempi di Dante le terzine dovevano essere incatenate. Anche nell'Ottocento i versi sciolti di una poesia dovevano essere metricamente ineccepibili per sillabe e accenti tonici. Oggi tutto è permesso, tutto è lecito nel bene e nel male (sia inteso). Forse è anche la mancanza di regole a aver fatto perdere rispettabilità e credibilità alla poesia contemporanea (è un'ipotesi da non scartare, tant'è che qualche poetessa come la Valduga è ritornata all'ordine, all'ipermetrismo). Che poi la perfezione non è cosa umana e se c'è qualcosa che si avvicina alla perfezione é solo nel dettaglio, nel piccolo! Lo scrittore Sandro Veronesi, premio Strega, ha dichiarato che il romanzo perfetto non è mai esistito, nemmeno scritto da dei grandi geni, mentre invece esistono ogni tanto dei racconti che si avvicinano alla perfezione. Credetemi: si può avere ottimi amici illetterati e che nemmeno sono lettori forti. Magari si sta meglio in loro compagnia e non ci si avvelena il sangue. Scegliete le persone in base alla loro umanità, onestà, autenticità, lealtà, sincerità, non in base alla loro presunta intellettualità e non avrete mai delusioni cocenti. Di un amico non valutate le lacune culturali ma se manca o meno come persona con voi. Si può essere invece dei grandi letterati ed essere degli autentici farabutti. Che poi il sacrificio, l'abnegazione e la considerazione scarsissima delle persone, gli scarsi guadagni, molto spesso le poche risorse economiche, sommate tutte assieme, spesso rovinano il carattere di qualsiasi anima bella, di qualsiasi poeta. Perciò io li capisco, li comprendo pienamente certi letterati incompresi e fegatosi, come si suol dire a Roma. Spesso non solo non vengono capiti, ma vengono derisi, sbeffeggiati, irrisi o talvolta ancora peggio su di loro cala l'indifferenza. Certi preti per preservare le loro pecorelle dicono che la cultura umanistica allontana dalla fede (scordandosi che anche il cristianesimo è umanesimo antelitteram). Allo stesso modo direi che per non impermalosirsi, per non incattivirsi, per non rovinarsi il fegato è meglio stare ad esempio lontani dalla poesia e dalla scrittura in genere. Primo motivo: non girano i soldi. Secondo motivo: la fama è inconsistente. Terzo motivo: si spende e non si guadagna. Quarto motivo: il pubblico disinteressato non esiste, ma è fatto solo da aspiranti poeti in competizione tra loro. Quinto motivo, ovvero la risultante degli altri motivi: c'è il serio rischio di sviluppare una nevrosi o una psicosi, visto che il contesto poetico è nevrotico/psicotico. Ho la netta sensazione talvolta che il contesto poetico sia la sommatoria di tante psicopatologie, derivate dal disinteresse degli italiani nei confronti di questa materia. Alcuni o forse molti si ammalano o rischiano di ammalarsi e soffrire psicologicamente per quella che a tutti gli effetti dovrebbe essere una passione semplicemente. Molti cercano la riconoscibilità poetica. Non la trovano e da ciò scaturisce l'incomprensione perenne. Alcuni risultano provati dalle porte che la comunità poetica sbatte loro in faccia. In realtà anche in poesia bisogna rispecchiare certi canoni del conformismo culturale per affermarsi: essere integrati socialmente e lavorativamente, essere di buona cultura, essere sodale tra i sodali, essere solidali con i più deboli in forma vaga e indistinta, dimostrare di apparire sufficientemente contro il sistema, dimostrare di essere alternativi e anticonformisti, essere di sinistra (pur riservandosi di criticare la sinistra fino allo sfinimento e fino al disfattismo), presentarsi come anime belle e poi in realtà coalizzarsi con quelli che vengono considerati i nemici per le ragioni più banali e più inconsistenti. Spesso i poeti (veri o presunti) sono figli di buona donna con gli altri poeti perché si sentono in gara o sono amici di alcuni poeti per interesse, calcolo, quieto vivere. Spesso i poeti (veri o presunti) sono figli di buona donna con il resto dell'umanità non poetica perché se gli altri apprezzano le loro poesie i poeti (veri o presunti) li odiano dato che vorrebbero essere ripagati materialmente, sessualmente, socialmente, professionalmente e naturalmente ciò nella stragrande maggioranza dei casi non avviene. Molto spesso i poeti (veri o presunti) odiano il resto dell'umanità che non si cura di loro e delle loro poesie. Le loro parole, le loro moine, le loro formalità vuote non vi traggono in inganno: i poeti sono cattivi, profondamente cattivi e nemmeno amano più la poesia, ma i colpevoli di tutto ciò siamo tutti noi. Siamo noi che li abbiamo dimenticati. Siamo noi che non abbiamo voluto conoscere la loro poesia. Comunque tutti hanno le loro colpe: sia i poeti che i lettori che i non lettori hanno assassinato tutti la poesia. Poi diciamocelo chiaramente: un luogo comune vuole che i poeti siano tutti buoni e da ciò ne consegue che chiunque scriva poesia abbia il dovere di essere buono e comportarsi bene. Da ciò risulta che i poeti, veri o aspiranti, siano sempre sotto osservazione e sempre ricattabili dalle altre persone. Invece questo pregiudizio positivo che finisce per essere una trappola per i poeti crea aspettative troppo grandi e quasi sempre disattese. Un altro luogo comune è che il poeta sia una persona speciale verbalmente, concettualmente, per sensibilità, per cultura, per animo, per intelligenza. La realtà è che il poeta molto spesso è una persona come le altre. Non ha niente di speciale. Non ha niente di più. I poeti hanno assassinato la poesia con le loro parole. Tutto il resto dell'umanità ha assassinato la poesia con la mancanza di amore e di interesse nei confronti della poesia. Eppure, sembra tanto logico e scontato ma non lo è: ci vuole proprio la poesia di tutti per rendere il mondo più poetico, mentre invece l'assenza di poesia o una cattiva poesia lo rendono ancora più impoetico. L'equilibrio è instabile e precario. Talvolta ho la vaga impressione che ci sia meno poesia nelle poesie contemporanee e più poesia nelle piccole cose della vita quotidiana. Il terreno su cui tutti ci muoviamo è limaccioso, scivoloso. Come ha detto qualcuno molto più importante di me, ovvero Bobin, dovremmo tentare di abitare il mondo poeticamente. E lo stesso Bobin ha scritto che abitare il mondo poeticamente è l'identica cosa che abitare il mondo umanamente. La poesia è umanità. L'umanità è poesia. Naturalmente ci vuole pazienza e dedizione per riuscire a cogliere tutto ciò, per carpire la poesia nell'umanità e l'umanità nella poesia. Allora dobbiamo sopportare la vanagloria, l'opportunismo, l'arrivismo, il narcisismo, la smania di grandezza di alcuni o molti poeti (veri o presunti). La malignità dei poeti deriva dalla loro frustrazione, dal loro senso di sconfitta in una società che ha relegato ai margini la poesia. Naturalmente anche io un tempo scrivevo poesie (o presunte tali). Anche io un tempo facevo ridere. Ma come scriveva un tempo la grande poetessa Szymborska: "Preferisco il ridicolo di scrivere poesie, al ridicolo di non scriverne". Realisticamente parlando però, se non si è grandi poeti in grado di essere ricordati dai posteri, si trae molto giovamento quando si smette di scrivere poesie. Qualcuno che sa rinunciare ci vuole. Si dimostrerà avveduto. Ci guadagnerà in credibilità agli occhi del mondo. Ma questo non vuol dire che debba smettere di amare la poesia. Che tanto l'importante è che ci sia poesia. Non importa se la poesia sia propria o altrui!
set 252022

Forse tutto è già stato scritto e quello che non è stato scritto forse non meritava di essere scritto, non era degno di nota, era puro nonsense.
Forse -dicevo- tutto è già stato scritto.
La Neoavanguardia già nel dopoguerra sembrava aver divorato tutte le poetiche. È impresa ardua, quasi improponibile cercare di riformulare dei codici espressivi. Il ‘900 letterario è stato artefice di grandi stravolgimenti. Il panorama nell’ambito della poesia è mutato completamente. Per secoli ha predominato una tradizione aulica, intessuta di preziosismi, latinismi, grecismi. Per secoli il linguaggio poetico è stato vago, raffinato e circoscritto. Le sperimentazioni tutt’al più erano metriche.
Tutto a un tratto nel 1900 ecco una miriade strabiliante di innovazioni sintattiche, morfologiche e lessicali. Ecco affacciarsi l’antilirica, se si paragona la poesia moderna a quella dei secoli addietro. Un’antilirica, che sempre più si disinteressa della metrica e pone tutto il suo interesse nelle poetiche e nell’ampliamento del lessico. Non esiste più la poesia come entità autonoma di conoscenza e produzione, di corrispondenza prelogica e preconscia tra l’essenza delle cose e l’essenza dell’animo umano. Avviene il dominio del contenuto sulla forma, della poesia del fare poesia sulla poesia, dell’arte dell’arte sull’arte.
Alcuni critici riprendono il concetto hegeliano di “morte dell’arte”, ma piuttosto si tratta di serie di radicali trasformazioni, della dissoluzione di canoni preesistenti ormai sclerotizzati. Non esiste una “morte dell’arte”, ma il prevalere della poetica sulla poesia e ciò comporta una maggiore consapevolezza del proprio fare artistico e talvolta un eccessivo smontaggio analitico delle opere creative. Ogni aspetto del reale può ispirare, anche ciò che un tempo poteva essere considerato impoetico per eccellenza. Ogni termine di qualsiasi campo semantico può diventare poetico. Si pensi ai tecnicismi di Zanzotto recentemente, ma a dire il vero avevano iniziato Pascoli e Montale, profondi conoscitori della botanica. Ecco comparire all’improvviso l’inconscio con il surrealismo e il paroliberismo dei futuristi: i sintagmi sono in libertà, non c’è alcuna struttura interna.
Nella poesia sembra essere ammesso quello che ordinariamente non è ammesso altrove. Per seguire i flussi di coscienza l’artista spesso procede per associazioni, frammenti, immagini-frase.
Nel’900 è vietato ogni presupposto assolutistico. I poeti sono politeisti dell’arte. Ci si può perdere di primo acchito in questo caleidoscopio, in questa confusione di linguaggi che ha come comune denominatore il relativismo e il prospettivismo (la realtà viene indagata da più angolazioni).
Niente sembra più stabile e il cultore di poesia non sa più di chi e cosa fidarsi in questo apparente disordine, in questa molteplicità stilistica. Dopo lo schizoformismo di Giuliani, la prosa poetica di Nanni Balestrini, l’asintattismo di Elio Pagliarani, la Palus Putredinis di Sanguineti, il ritmo di Amelia Rosselli, il tono colloquiale e privato di Dario Bellezza, “Il disperso” di Maurizio Cucchi, le folgorazioni di Milo De Angelis è difficile non essere banali. È fuori luogo poi essere loro manieristi. Altra era la temperie culturale vissuta da questi grandi autori, altro era il contesto sociale del ‘900 e le problematiche annesse e connesse (boom economico, unificazione linguistica, comparsa della televisione, scomparsa della civiltà contadina, migrazioni interne dal Sud al Nord, contestazione studentesca, anni di piombo, il ruolo e lo status del letterato nell’era industriale, netta divisione tra cultura di massa e cultura alta).
Molte poi sono le scuole (l’idealismo, il crocianesimo, lo storicismo gramsciano, la critica formalista, lo strutturalismo, la semiologia), gli ismi letterari (il simbolismo, il crepuscolarismo, il surrealismo, l’ermetismo, il futurismo, il neorealismo, il neosperimentalismo, la neoavanguardia, il neo-orfismo), i maestri di pensiero (i più recenti ad esempio: Lacan e l’inconscio come linguaggio, Wittgenstein e i suoi giochi linguistici, Lyotard e il postmoderno, Heidegger e la sua ontologia della poesia, Gadamer e la sua ermeneutica, Foucalt ed il suo concetto di potere, Derrida ed il suo decostruzionismo e ancora… R. Barthes, Levi-Strauss, Chomsky, Marcuse, etc, etc) a cui un autore può fare riferimento. Molte sono le strade percorribili. Svariate sono le problematiche stilistiche: scegliere tra suggerire e nominare, tra prosaico e lirico, tra tradizione e innovazione, tra metafora e analogia, tra un linguaggio puro e astorico e uno ricco di contaminazioni.
Difficile oggi poi fare una mappatura esaustiva della poesia italiana, difficile definire attualmente che cosa sia in quest’epoca di “tradizione del nuovo”, di autori neo e post la vera poesia.
Simposi, convegni, corsi di creative writing, articoli, saggi hanno cercato e cercano di pontificare a riguardo.
set 142022

Analisi e commento di "Così siamo" di Andrea Zanzotto:
Dicevano, a Padova, “anch’io”
gli amici “l’ho conosciuto”.
E c’era il romorio d’un’acqua sporca
prossima, e d’una sporca fabbrica:
stupende nel silenzio.
Perché era notte. “Anch’io
l’ho conosciuto”.
Vitalmente ho pensato
a te che ora
non sei né soggetto né oggetto
né lingua usuale né gergo
né quiete né movimento
neppure il né che negava
e che per quanto s’affondino
gli occhi miei dentro la sua cruna
mai ti nega abbastanza.
E così sia: ma io
credo con altrettanta
forza in tutto il mio nulla,
perciò non ti ho perduto
o, più ti perdo e più ti perdi,
più mi sei simile, più m'avvicini.
Sarò possibilista dal punto di vista metrico. Il primo verso potrebbe essere un endecasillabo, se usiamo la dialefe. Il secondo verso è un decasillabo. Il terzo verso è un doppio settenario, sempre se consideriamo la dialefe. Il quarto verso è un endecasillabo, sempre con dialefe. Il quinto verso è un settenario. Nei primi cinque versi di Zanzotto, in questi due primi periodi, mi sembra che le parole debbano essere soppesate, ponderate. Nessuna parola è di troppo in questa lirica e ogni parola è al posto giusto: ciò denota una precisione chirurgica nella nominazione. Se non utilizziamo la dialefe invece gli endecasillabi sono solo due (uno è l’ultimo verso della poesia). Inizialmente si noti l’iperbato. Il romorio è un termine desueto per indicare un rumore persistente, incessante. Solo l’acqua sporca e la fabbrica scalfiscono il silenzio. Nelle prime due frasi il grande poeta si rifà metricamente alla tradizione, alternando due endecasillabi (uno solo se non contiamo con la dialefe) a un doppio settenario e a due settenari. Successivamente ci sono diversi ottonari, diversi novenari, diversi settenari e svariati enjambements. I versi sono liberi, ma c’è il rispetto delle regole metriche. In questa lirica non abbiamo ancora lo Zanzotto de “Il galateo in bosco”, che con il suo ipersonetto rinnova la tradizione del sonetto “classico”. Qui Zanzotto non tratta del petèl (della lingua dei lattanti) né della “psicanalessi” né utilizza il suo plurilinguismo. Qui Zanzotto non gioca con il linguaggio, non è in bilico tra balbettio e sproloquio, né tra afasia e amnesia. Qui non c’è ancora lo Zanzotto che tratta degli ossari del Montello. Qui ancora non c’è l’io “male sbozzolato” e neanche “Io – in tremiti continui, – io – disperso e presente”. Il poeta mette da parte psicologismi e nevrosi, insomma “l’esistere psichicamente”. Zanzotto qui doveva ancora diventare il poeta sperimentale, quello che si riferiva al significante (a Saussure, a Lacan), assolutamente non legato alla neoavanguardia, ma che però aveva fatto la sua gita a Chiasso (come voleva Arbasino) e aveva cultura non provinciale ma europea. Il poeta doveva ancora utilizzare il dialetto. Zanzotto doveva ancora diventare il poeta che voleva salvaguardare a tutti i costi il suo amato Veneto dall’industrializzazione selvaggia, dallo scempio edilizio, dall’inquinamento. C’è un fatto personale da un certo punto di vista che mi lega alla grande poesia di Zanzotto: avevo amici in giovinezza a Pieve di Soligo, Conegliano, Vittorio Veneto. Sono stato in quei posti. I miei amici mi raccontavano di questo loro grande poeta, di questo loro grande concittadino, schivo e riservato. Ho conosciuto anche io quei luoghi. Sia ben inteso che il Veneto che ho visto io è più quello cantato da Zanzotto che quello narrato a tinte fosche da Carlotto (con tutto il rispetto e la stima per quest’ultimo). A ogni modo questo componimento è tratto da “IX ecloghe”, raccolta scritta tra il 1957 e il 1960. Zanzotto doveva far ancora sua la frase di Hölderlin “siamo segni senza significato”, anche se leggendo attentamente questi versi memorabili c’erano già tutte le premesse, ma è altrettanto vero che qui il poeta è alla spasmodica ricerca di un’autentica significazione, che però naturalmente non trova, dato che di fronte alla morte ogni parola di conforto, di consolazione è vana. In questa lirica c’è un lutto e il suo tentativo di rielaborare il lutto. Ora anche il poeta è morto da anni, ma questo capolavoro è ancora attuale, ci parla ancora a noi e di noi perché la grande poesia è eterna. In fondo suo padre è morto, ma è stato eternato, immortalato. Zanzotto è morto, ma ha avuto gloria postuma e noi ancora lo leggiamo. La grande poesia quindi rende immortali. Qui c’è solo un brevissimo cenno descrittivo al contesto, all’ambiente nel terzo, quarto, quinto verso. Non c’è nessun bozzetto paesaggistico e non c’è nessuna descrizione minuziosa, ma vengono riportate alcune frasi degli amici del padre (a cui questa poesia è dedicata). Il verso più terribile è questo: “neppure il né che negava”. Il padre ormai se pensiamo al mondo dei viventi e al mondo del visibile non è più nulla. Però anche il poeta è allo stesso tempo nulla perché vive nella precarietà esistenziale e come tutti è prossimo alla fine. Il poeta cerca uno spiraglio, una fessura (la cruna), ma invano. Non è con la percezione usuale e nemmeno con la ragione che si trova un pertugio di speranza, ma come vedremo più tardi solo con un atto di fede nella propria umanità e nella propria interiorità (ricordando cosa diceva Sant’Agostino sul rapporto tra interiorità e verità). È impossibile per la ragione umana pensare a qualcuno che esiste ma che è non è più niente né nessuno, né oggetto né soggetto.
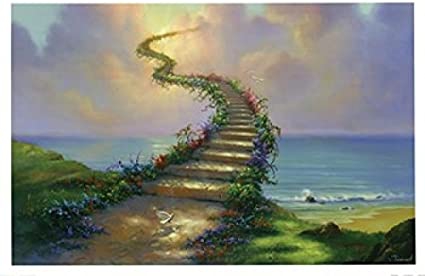
Mentre nella parte centrale era il “né”, ripetuto più volte (queste iterazioni determinano il ritmo di questi versi) a condizionare ogni periodo e a negare la presenza del padre su questa Terra, è decisiva negli ultimi sei versi la particella avversaria “ma”, che determina tutto. Nella parte centrale c’era quell’avverbio “vitalmente” poi seguito da “ho pensato” che era una sorta di eufemismo, un modo elegante e meno brusco per non usare le parole “morte”, “morto”: Zanzotto infatti non utilizza concetti banali come “passato a miglior vita”, eppure non utilizza nemmeno termini mortuari né necrofili. Se nei primi versi sembrerebbe che di un morto resti soltanto l’averlo conosciuto di persona, nell’ultima parte c’è l’affermazione della memoria, della vita, di una nuova vita, anche se mai esplicitata pienamente. Lo testimonia l’espressione “E così sia”, ripresa dalle formule liturgiche, che dimostra il fatto che questa splendida poesia è una preghiera laica. Zanzotto credeva nel divino. Non fu casuale a mio modesto avviso se criticò positivamente e promosse la poesia di David Maria Turoldo. Ritornando a questo componimento, a onor del vero, sono importanti tre parole che condizionano il discorso: “ma io credo”. Zanzotto fa un atto di fede, quello di credere con tutta la sua forza in tutto il suo nulla (dato che ogni uomo è poca cosa, essendo carnale e mortale). Altrettanto importante è la convinzione che ne consegue: “perciò non ti ho perduto” perché le parole, i gesti dei morti restano nella memoria dei vivi e prepotentemente ritornano quando meno uno se lo aspetta. A mio avviso in questo modo anche non essere più il né che nega significa ancora una volta che la doppia negazione afferma. Eppure la morte è terribile perché è fortissimo il contrasto tra assenza e presenza. L’autore ebbe a dichiarare che la poesia è “un elogio della vita”, però -aggiungo io- la morte nullifica non solo ogni poter essere ma ogni nostra dicibilità. La morte è l’evento clou, il trauma finale. Se esiste il trauma della nascita, quello della separazione dalla madre, esiste anche il trauma della morte, quello della separazione dai propri cari dal morente e del morente dai propri cari. Comunque è da notare è che il grande poeta quando tratta della morte lo fa con chiarezza memorabile, evitando citazioni, astrazioni, raffinatezze. Zanzotto di fronte alla morte non è mai troppo sentimentale né distaccato, ma sempre coinvolto e partecipe. Non è mai troppo semplice né troppo complesso. Sa trovare la giusta distanza e la giusta dimensione. Sa trovare le parole esatte. Si veda ad esempio “Idioma”, raccolta scritta tra il 1975 e il 1986, in cui compaiono una poesia dedicata a Maria Fresu, vittima della strage di Bologna (di cui non restò più niente, morta insieme alla figlia), e il Tato padovano. In quest’ultimo componimento l’autore scrive dell’anima immortale. In fondo questa concezione religiosa, ma prima di tutto metafisica, era già presente in questo componimento. Non è un caso che in ogni civiltà per fondare un’etica o anche solo una nuova cultura ci sono sempre stati due punti insostituibili: l’immortalità dell’anima e l’esistenza di Dio o delle divinità. È stato così per gli antichi greci. È stato così per gli illuministi, che credevano nella ragione in modo quasi totalizzante, ma erano anche deisti (credevano cioè in una sorta di panteismo). In fondo non è necessario e non l’ho fatta apposta una parafrasi di questo testo. Basta ricordarsi del titolo: “Così siamo”. Per ognuno, indistintamente, suona la campana, citando Hemingway.
set 082022
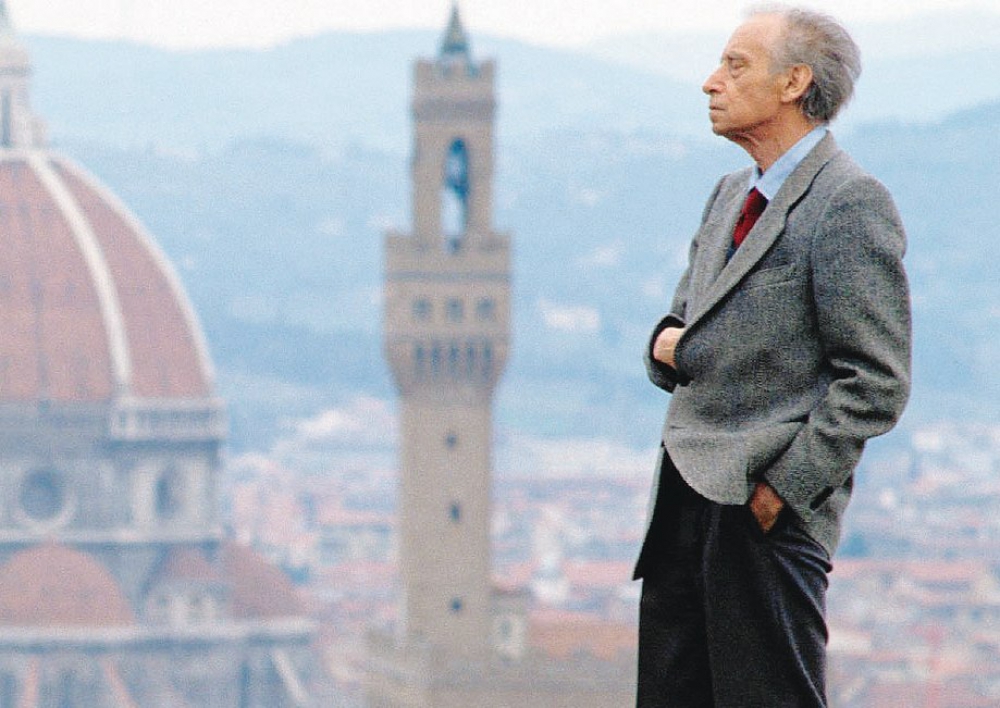
Ha un bel dire con tutti i suoi platani Firenze.
Non è uguale la musica, non può esserlo.
Ma uguale a che, la stessa di quando -
discetta perdutamente il senso
non trovando fondale a quel risucchio
di mancamento o rimorso.
Né so cosa m'intenerisce di lei,
se davvero la spina che le è infissa della mia vita
o quell'aria di congedo in lei da me, in me da lei. O il niente
di questo.
Mario Luzi è stato uno dei protagonisti della poesia italiana del Novecento. Attraversò quasi tutto il secolo breve. É stato anche senatore a vita. Fu candidato per anni al Nobel della letteratura. Consiglio a tutti di leggere le sue opere e magari anche di leggere "Saggio su Mario Luzi" di Anna Panicali. Luzi fu uno dei protagonisti al Caffè delle Giubbe Rosse. Fu professore universitario e saggista oltre che grande poeta. Apparentemente in questa lirica sembra che Luzi vada a capo quando vuole senza rispettare alcuna regola. In realtà si tratta di versi liberi che rispecchiano i canoni della metrica italiana, tutti con i giusti accenti tonici, anche se senza rime e con alcuni enjambements. Luzi utilizza alcune volte la sinalefe perché questa è la consuetudine tra poeti, mentre la dialefe è l'eccezione. La sinalefe infatti è più eufonica, mentre la dialefe è più disarmonica e più entropica. Ci sono anche degli endecasillabi canonici in questo testo. Non vi traggano in inganno alcuni versi più lunghi del componimento perché sono anch'essi metricamente ineccepibili. Mario Luzi nel corso di tutta la sua carriera poetica non è mai andato a capo a caso, come molti versoliberisti (forse a torto, più probabilmente a ragione). Il primo verso ad esempio è un doppio settenario con sinalefe. Il terzultimo verso è un doppio novenario, scandendo normalmente le sillabe. Il penultimo verso è un doppio ottonario con sinalefe. Certamente la sua prima produzione poetica era metricamente più rigorosa di quella in età matura e in vecchiaia, ma il poeta ha dimostrato sempre grande prolificità, capacità di rinnovarsi, una scrittura impeccabile. In questa poesia esprime sia un'idea che un sentimento. Non si perde nel dettaglio del dettaglio. È una lirica che va presa nella sua gestalt globale. È una poesia breve, ma solo apparentemente semplice.
"Ha un bel dire con tutti i suoi platani Firenze" è una personificazione. Firenze sembra parlare con i suoi platani. Luzi non cita la Firenze celebrata da cartolina, dei grandi capolavori artistici. Non rievoca neppure Firenze come grande città di marmo, come lui stesso ebbe modo di definirla. I platani appartengono al campo semantico della natura ma anche a quello associativo della familiarità (leggi anche della consuetudine).
Luzi è un grande poeta ermetico, che usa sapientemente le analogie e le metafore.
In questo senso è anche simbolista. Per lui fare poesia significa ricercare "corrispondenze", come nella celebre lirica di Baudelaire, e allora dopo aver trovato corrispondenze tra i propri stati d'animo e i paesaggi ogni città diventa un luogo dell'anima, un posto interiore, una "foresta di simboli", sempre per riprendere il poeta maledetto francese. Ma cosa significa "Non è uguale la musica, non può esserlo"? Significa che le corrispondenze cambiano continuamente, incessantemente perché cambia continuamente la città e cambiano sempre i moti dell'animo dell'autore. "Discetta" significa esamina. "Non trovando fondale a quel risucchio/ di mancamento o rimorso" significa che se la parola per Luzi deve volare verso il vertice della significazione (lo zenit) la memoria invece è un abisso, non ha fondo, eppure è un grande vortice, un grande gorgo. Ma di cosa? Di assenza (mancamento), perché mancano visi, volti, luoghi di un tempo, e di rimorso, ovvero di sensi di colpa per gli errori commessi. Si noti anche tutta l'umiltà e il basso profilo del grande poeta fiorentino che naturalmente non attribuisce niente di negativo a Firenze (non parla di nessun borgo selvaggio), ma paragona la propria vita a una spina infissa dentro la sua città. Ma cosa significa "quell'aria di congedo in lei da me, in me da lei"? Significa probabilmente che la Firenze di quei giorni non sarà più la stessa e forse non avrà più tutti i suoi bei platani, ma anche qui Luzi pensa alla sua dipartita. Oppure una terza opzione: Luzi chiude con "...o il niente di/ questo", con un versicolo ungarettiano di una sola parola, una clausola dal tono dimesso, che però significa che il poeta non è certo di niente, non sa davvero il senso della sua tenerezza, sa solo dell'affetto profondo che lo lega a quei luoghi senza saperne i motivi. Firenze per Luzi non è un posto come un altro. Leggendo questi versi sorgono in me alcuni interrogativi. Quanti anni bisogna vivere una città per conoscerla veramente? Quante strade bisogna conoscere? Quanti luoghi bisogna aver frequentato? Quante persone bisogna aver incontrato? Quante storie bisogna aver avuto? E se questo rapporto fosse una catena indissolubile? Cosa è che ci lega veramente a questo posto? Di cosa sentiremo la mancanza? Non ci sono risposte, ma solo impressioni e un vago sentore di essere abitudinari o recidivi. Approssimativamente posso solo dire che ogni paese ha il suo cielo e ogni cittadino ha un angolo di cielo, a cui spesso rimane fedele negli anni. Ma questa poesia mi dice altre cose, mi suggerisce altre cose. Quando descriviamo un paesaggio in realtà descriviamo il nostro punto di vista. Quando parliamo del mondo in realtà parliamo della nostra visione del mondo. L’umanità è una moltitudine incredibile di punti di vista, di visioni del mondo. Ognuno è una sintesi di interno ed esterno, di idee e cose, di soggettività e oggettività. Forse siamo fatti male, ma è così ad onor del vero. Questo è ciò che mi fa ricordare questa poesia. In definitiva Firenze sembra voler dire tante cose e sembra voler significare molte cose al grande poeta. Sempre Mario Luzi in una sua intervista dichiarava riguardo alla città: "La raffigurazione, naturalmente, è reale e simbolica nello stesso tempo e vuole denunciare che la città umana senza idea vitale si sfascia". Non a caso a conti fatti è difficile, anzi è quasi impossibile trovare il senso compiuto di una città, anche se è cara e familiare.
set 062022

Ho un modo di recensire particolare, nel senso che trasgredisco la regola d’oro del recensore, formulata sia da Giovanni Raboni in “La poesia che si fa” che da Massimo Onofri in “Recensire. Istruzioni per l’uso”.
Tengo a sottolineare che sono due libri molto importanti per iniziare a recensire, ma secondo questi due grandi letterati ad artista non di deve aggiungere artista (secondo un adagio degli antichi latini), ovvero un recensore deve essere sottotono, deve mantenere un profilo basso e nel testo deve vigere l’understatement.
Io ritengo piuttosto che una recensione debba spiegare tutto, essere esaustiva o quantomeno cercare di essere esauriente.
Forse così si rischia di strabordare. Nel primo caso invece si rischia di fare un compitino striminzito.
E poi a mio modesto avviso per capire cosa voleva dire un poeta bisogna un poco immedesimarsi nel poeta in questione ed essere di volta in volta un poco artisti anche noi miseri recensori. Ma è solo questione di opinioni. So benissimo che Onofri e Raboni sono delle autorità in materia e io sono un bastian contrario. Ma passiamo ad altro. Alcune volte mi arrivano dei documenti pdf da recensire via mail oppure dei libri a casa.
Sgombro il campo da ogni equivoco: non esiste assolutamente l’obbligo di recensire nessuno. Alcuni ritengono che tutto sia loro dovuto. Anche se mi arriva un ottimo libro non è mio dovere recensirlo: sia ben chiaro. Io non sono pagato a cottimo. È una bella pretesa! Alcuni sono anche molto sbrigativi e si scordano le belle maniere, ma questo fa parte della personalità egoriferita di alcuni autori.
Personalmente io non cerco lo scambio di favori. Non scrivo più poesie o presunte tali dal 2018. Quindi nessun do ut des! Non cerco recensioni incrociate. Tutto questo mi consente una maggiore obiettività e indipendenza, non scrivendo più poesie.
Alcuni potrebbero criticarmi per il fatto che scrivo recensioni in cui esprimo un giudizio positivo sul libro. Ma è solo una parte della verità. Diciamo piuttosto che io non voglio stroncare nessuno e quindi non pubblico mai stroncature.

Perché non stronco? Semplicemente perché onestamente non mi va. Inoltre ritengo che si debba avere una certa autorità per farla e io ne sono sprovvisto. Non solo ma esiste una regola non scritta secondo cui si stronca solo i big. So bene anche che ogni autore si sente padre della sua opera. Penso che una stroncatura sia più che un atto di lesa maestà (di cui mi importa poco) un vero colpo al cuore, una piccola ferita. Diciamocelo francamente: non voglio far rimanere male nessuno. Di conseguenza alcuni pensano che io sia facile di gusti o che tratti tutti i libri con bonaria indulgenza. Nella maggioranza dei casi io recensisco invece libri di qualità, ma questa è solo la parte emersa dell’iceberg: nessuno sa i libri e i documenti via mail che mi hanno inviato e che non ho recensito. Al momento mi sono anche imposto di recensire solo libri pubblicati e non autopubblicati, libri cartacei e non ebook (altrimenti non ce la farei a recensire tutto). Preferisco quindi non recensire che recensire negativamente. Non solo ma Giovanna Rosadini, direttrice di Atelier poesia, fa una scrematura di opere prima di inviarmi le cose da recensire.
È comunque vero che preferisco evidenziare i punti di forza di un’opera invece che i punti deboli. Ritengo in questo modo di spronare, di incoraggiare l’autore. Ma recensire è un diritto e non un dovere. Inoltre rivendico l’orgoglio di recensire. Tutti vogliono diventare scrittori o poeti, vogliono la fama, la gloria postuma. Il recensore invece è relegato ai margini della vita letteraria, eppure i libri vanno obbligatoriamente recensiti, altrimenti li leggerebbero in molti meno e non ci sarebbe alcun passaparola tra i lettori. Anzi forse è il caso di dire che al mondo d’oggi ci sono troppi poeti effettivi, aspiranti, sedicenti e davvero pochi recensori. Sempre a mio modesto avviso un recensore non deve essere obbligatoriamente un critico letterario e aver letto migliaia di libri come vorrebbe Valerio Magrelli. Un recensore deve solo avere un minimo di sensibilità, un minimo di comprensione del testo e sapere un minimo la lingua italiana. Questi sono i prerequisiti fondamentali. Aggiungo anche che se ogni lettore diventasse un recensore nel suo blog personale o sui profili social ne guadagnerebbe il lettore suddetto che eserciterebbe il suo senso critico e ne guadagnerebbe la letteratura che diventerebbe un grande oggetto di attenzione, un argomento di tendenza, di dibattito e non più un fenomeno marginale. Se ci fossero più lettori-recensori certo ci sarebbe qualcuno di essi che rientrerebbe nella categoria degli odiatori, ma la letteratura sarebbe più rizomatica, meno stagnante, insomma più viva. Infine va detto che anche se a nessun recensore spetta la gloria postuma a differenza dei poeti qualcosa possono guadagnare se lo vogliono. Qualche agenzia letteraria i recensori li può pagare; ci sono autori disposti a pagare recensori. Infine recensire libri può essere un primo passo per fare il saggista, il giornalista culturale o il web content editor (coloro che a pagamento riempiono di contenuti i siti web). Non solo ma c’è anche chi si inventa un’attività redditizia recensendo libri su Instagram, anche se ci riescono solo i giovani e non i letterati attempati. Nel peggiore dei casi arrivano gratis dei libri a casa, anche se le ore passate a leggere il libro e a recensire non vengono pagate.
set 012022
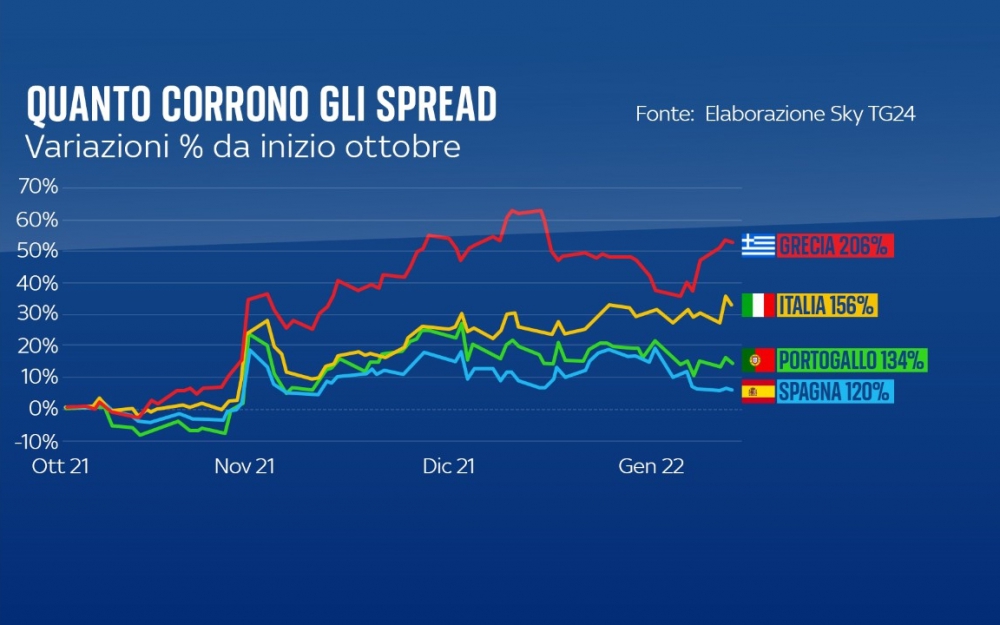
In questo articolo non tratterò di letteratura, ben sapendo che la letteratura può essere maestra di vita, ma è vero anche il contrario. Perciò ora parlerò della vita di ieri e quella di oggi.
Succede che talvolta mi volgo indietro e penso agli anni '90 quando ero ventenne. Cerco di individuare analogie e differenze con i tempi d'oggi. A volte mi sembra di essere stato catapultato nel 2022 direttamente dagli anni '90, però so bene che è solo un'impressione fugace, transitoria. Ritengo comunque che più di una svolta epocale, di una rottura improvvisa si possa parlare di continuazione di alcuni fenomeni agli albori, appena in atto negli anni '90. Allora erano di moda le discoteche. C'erano anche dei giovani che assumevano ecstasy e poi andavano fuori strada, ammazzandosi. Era l'inizio delle stragi del sabato sera. Oggi le discoteche sono in crisi, sono meno frequentate, ma la cultura dello sballo esiste tuttora nel mondo giovanile. Allora le prospettive erano più rosee per i giovani. Il lavoro si trovava, anche se la mia generazione X avrebbe dovuto fare i conti in seguito con la crisi economica del 2001 dopo l'11 settembre e con la crisi del 2008 dei mutui subprime americani. Ma oggi la situazione è molto peggiorata. C'è stata la pandemia, c'è la guerra in Ucraina. La vita è molto rincarata. C'è il problema delle bollette. Cosa fare? Mettere una tassa sugli extraprofitti? Fare ancora debito pubblico? Mettere un tetto al prezzo del gas? Investire in altre forme di energia? Nel frattempo migliaia e migliaia di posti di lavoro sono a rischio. Molte aziende e attività commerciali sono con l'acqua alla gola. La cosiddetta generazione Z è stata definita anche generazione 280 euro: chi non è disoccupato tra i giovani è spesso sottopagato o comunque sottoccupato. Tra generazioni covano rancori e incomprensioni. Per i più anziani i giovani non hanno voglia di lavorare e sono schizzinosi. Per i giovani gli anziani sono boomer, persone privilegiate che hanno sfruttato il boom economico e hanno votato politici, che hanno a loro volta creato un grande debito pubblico. Intanto le coscienze degli italiani vengono obnubilate e assopite con le armi di distrazioni di massa della televisione generalista e del gossip sempre più futile. Nel frattempo gli italiani si sono disaffezionati alla politica. Molto probabilmente alle prossime elezioni sceglieranno le false promesse irrealizzabili del centrodestra alla litigiosità e alla frammentazione del centrosinistra, che ha come maggior colpa la sua mancanza di capacità comunicativa. Ma forse è meglio non angustiarsi troppo. Probabilmente la politica nazionale non è più decisiva per le sorti del Paese. Probabilmente tutto si decide altrove (in ambito internazionale). Per quanto mi riguarda ho paura dell'aumento dello spread, di speculazioni economiche contro l'Italia. A mio modesto avviso non bisogna scegliere alle elezioni i migliori ma i meno peggio, cioè coloro che tutto sommato sembrano un poco più coscienziosi, responsabili, affidabili. Bisogna andare alle urne, procedendo per esclusione. E chi non è di sinistra si ricordi di votarla "turandosi il naso", come ebbe a dire a suo tempo Indro Montanelli. Mi fa paura che la potenziale futura premier, ovvero Giorgia Meloni, pubblichi online il filmato di uno stupro, non considerando la privacy della vittima, che poi tra l'altro è stata riconosciuta. Mi sembra, ma non so se sbaglio che tutto venga considerato lecito in nome della propaganda. Il problema del centrodestra non è tutto quello che promette, ma se malauguratamente quelle promesse le realizzerà, dimostrandosi a quel punto una coalizione sciagurata. Però gli italiani molto probabilmente voteranno di pancia. Il loro sarà un voto emotivo, dimenticandosi anche chi realmente ha fatto cadere il governo Draghi per personalismi e/o per andare alle elezioni anticipate, infischiandosene delle sorti del Paese. Gli italiani cercano di non pensarci, anzi distolgono completamente il pensiero e intanto hanno il culto dell'apparire. L'imperativo è quello di essere presentabili, in perfetta forma fisica, piacenti e appariscenti. È un obbligo (im)morale imposto dalla società di massa, dalla civiltà dell'immagine.

Tutti in palestra quindi. Già negli anni '90 c'era chi ne faceva un'ossessione e magari prendeva dei betabloccanti. Tutti dal dentista poi, a spendere soldi per i denti di porcellana, proprio come quella conduttrice di una trasmissione pomeridiana o come quell'opinionista di un reality show. Tutti dal chirurgo plastico, anche se poi ne risente l'espressività del viso e naturalmente a costo di apparire tutti uguali. Tutti o quasi, rifatti o ritoccati, con l'eterno dilemma della scelta tra botulino e lifting. Oggi per accettarsi bisogna essere accettati socialmente. L'io corporeo ha una parte preponderante. Se gli altri non ti apprezzano esteticamente non puoi essere felice. C'è bisogno dell'approvazione degli altri, c'è bisogno del consenso riguardo al tuo aspetto fisico. Questi sono i (falsi) problemi degli italiani. Le grane quotidiane, come il fatto che spesso i soldi finiscono alla terza settimana del mese, diventano più accettabili se si è piacenti esteticamente, se si è considerati dei begli omuncoli o delle belle donnine. C'è una grande pressione mediatica e sociale, che impone certi canoni estetici e la messa al bando di certi difetti fisici. Non è forse un campanello d'allarme oppure la cartina di tornasole il fatto che la Meloni abbia inserito tra le devianze l'obesità e l'anoressia, salvo poi fare un passo indietro (forse perché aveva paura di un danno d'immagine, di una crisi reputazionale più di altro?)? Già negli anni '90 si iniziava a parlare di anoressia e bulimia. C'era chi dava la colpa all'eccesso d'importanza dell'aspetto fisico in questa società. Dopo si sarebbe scoperto che le cause di questi disturbi alimentari erano multifattoriali, talvolta familiari, talvolta associati ai tratti di personalità dei soggetti. Ma il dibattito a riguardo è tuttora aperto. Aveva forse ragione il filosofo Emanuele Severino quando negli anni '90 sosteneva che era iniziata l'epoca dei Sileni "rovesciati", in cui tutti erano belli fuori e vuoti dentro? Già negli anni '90 era iniziata l'epoca del "vivere sano" e soprattutto del culto dell'immagine. Oggi l'aspetto fisico è fondamentale per trovarsi il o la partner. Più che l'anima gemella molti cercano un bel corpo. L'importante è l'involucro più di quello che ci sta dentro. I contenuti mi sembrano talvolta secondari. A ogni modo la prima scrematura la fanno in base all'estetica. Se non superi quello scoglio iniziale sei out. Le donne sono più emancipate ma anche molto più esigenti. Anni fa sognavano il principe azzurro, ma si accontentavano anche di un rospo gentile e premuroso, simpatico e alla mano. Oggi l'uomo lo pretendono palestrato, alto, bello, superdotato sessualmente, con una bella casa, con una bella macchina, con un bel lavoro, a costo di rimanere sole. Così gli uomini si imbottiscono di Viagra e Cialis, acquistano a rate macchine costose che poi non sanno come pagare, fanno mutui per acquistare belle case, vanno tutti i giorni in palestra, acquistano scarpe coi tacchi, raccontano bugie sul loro lavoro e i loro guadagni, etc etc. Anche gli uomini hanno aspettative sempre più alte. Gli uomini non sono da meno. Importante è apparire, anche magari bluffare. Tanto poi cosa importa dell'esame di realtà? La società occidentale tramite la moda e i mass media propone certi modelli estetici quotidianamente, ma ritengo che a tutto ciò si siano aggiunti trent'anni di berlusconismo, che hanno peggiorato l'andazzo generale. Lo so che è una caratteristica attribuita agli anziani dire "mala tempora currunt" ed essere lodatori del tempo passato. Lo so che ogni generazione crede ciecamente nei suoi miti, nelle sue mode, nelle sue icone. Certo a livello di diritti civili in questi anni sono stati fatti dei passi avanti. Prima c'era molta più omofobia e negli anni '90 non si poteva parlare di fluidità di genere; nessuno poteva mettere in dubbio l'identità di genere: lo dimostrano tutti i rifiuti editoriali al capolavoro "L'arte della gioia" di Goliarda Sapienza. Lo so che c'è il rischio di passare per persone retrograde, datate, antiquate (per quanto io non sia affatto moralista né bigotto) a ricordare con nostalgia quei tempi (forse enfatizzandoli e migliorandoli nella memoria), ma negli anni '90 comunque mi ricordo che c'erano allora amori che nascevano sugli scalini di una chiesa, complici una chitarra scordata e senza plettro, e alcuni conquistarono le ragazze solo perché conoscevano a memoria le canzoni dei cantautori. Negli anni '90 mi ricordo di amori nati dopo che taluni declamavano nell'alcova della loro stanza in affitto di studenti fuori sede con una luce soffusa le loro poesie acerbe o quelle di poeti già famosi. Negli anni '90 mi ricordo di amori nati in discoteca, facendo quattro salti in pista, che erano stati studiati allo specchio della propria camera per tutta la settimana. Era più facile allora ed è più difficile oggi oppure viceversa? Oggi se non sei piacente esteticamente sei out! Dipende dai punti di vista. Negli anni '90 conoscevo personalmente allora giovani che credevano nei contenuti, nella profondità d'animo, nella poesia. E oggi tra la gioventù si trovano isole (in)felici (dato che è tutto da dimostrare e da accertare che la poesia renda felici)? Sicuramente esistono; io spero e credo in quei giovani che amano la poesia, anche perché ognuno è libero di credere e sperare in coloro che lo rappresentano meglio e in coloro che pensa siano un futuro migliore, ammesso e non concesso che esista un futuro tra debito pubblico alle stelle, ingovernabilità del Paese, instabilità politica in Italia e poi nel mondo tra inquinamento e sovrappopolazione.
ago 262022

Gli italiani leggono poco. Le cause possono essere svariate. Alcuni dicono che siamo un Paese arretrato culturalmente. Alcuni sostengono sia colpa della grave crisi economica. Altri danno la colpa ad Internet. La giustificazione è che nessuno ha mai tempo libero per leggere. La verità è che gli italiani nel loro tempo libero fanno tutto tranne che leggere. I giovanissimi non leggono. Le donne leggono più degli uomini. Eppure le statistiche ci insegnano che sono troppi i laureati usciti dalle facoltà umanistiche e che solo il 30% dei laureati esce fuori da discipline scientifiche. Quindi ci dovrebbe essere uno zoccolo duro di lettori forti, determinato da un umanesimo diffuso, ma non è così. Le statistiche ci dicono anche che sono pochi i laureati in percentuale rispetto alla popolazione. Da questo si deduce che molti dottori, finiti gli studi, abbandonano completamente la lettura. È vero che con la pandemia le vendite sono aumentate, ma non siate ottimisti: nessun cambiamento di rotta; era solo perché eravamo in una situazione di emergenza e gli italiani non sapevano cosa fare. Tullio De Mauro a suo tempo aveva messo in guardia dall'analfabetismo di ritorno. Insomma sono davvero pochi i divoratori di libri: coloro che fanno shopping compulsivo molto probabilmente non sono affatto lettori accaniti. Sono rarissimi anche i cleptomani nelle librerie italiche. Non esistono affatto ladri di opere di poesia. Ma quali libri leggono gli italiani? Nella maggioranza dei casi leggono volumi di personaggi televisivi, cantanti, Youtuber, comici, cuochi, sportivi. È stato stimato che soltanto un quinto dei libri venduti è pubblicato da scrittori veri e propri. Il libro delle barzellette su Totti ha avuto un grande successo. Vengono venduti anche molti romanzi d'amore. I romanzieri autentici hanno problemi a vendere. Sono relativamente pochi i lettori, che cercano libri di qualità. Non voglio riportare tutte le cifre perché non sono il mio pane e perché questi dati vanno presi con il beneficio di inventario. Le case editrici e gli autori si vergognano a confessare le scarse vendite di libri "impegnati". È difficile trovare testimonianze a riguardo. Questa situazione infelice dovrebbe indurre autori e addetti ai lavori a fare autocritica, ma i più non fanno altro che chiudersi a riccio e a mantenere un atteggiamento snob. Sono pochi coloro che possono permettersi o che si potevano permettere di vivere di scrittura: Camilleri (più di 10 milioni di copie vendute) Susanna Tamaro (con il suo bestseller ha venduto circa 15 milioni di copie), Federico Moccia, Elena Ferrante, Niccolò Ammaniti, Isabella Santacroce, Saviano (con Gomorra ha venduto più di 2 milioni di copie), Sandro Veronesi, Andrea De Carlo, Erri De Luca, Dacia Maraini, Sveva Casati Modignani, Alessandro Baricco. Enrico Brizzi può vivere di sola scrittura grazie soprattutto alle ristampe del suo primo romanzo. Forse dimentico qualche nome? Perdonatemi. Molti altri arrotondano con il giornalismo, l'insegnamento, i corsi di scrittura, le consulenze editoriali, le traduzioni, facendo radio oppure facendo gli autori televisivi, gli editor, i redattori, gli sceneggiatori. In Italia gli autori fanno un doppio lavoro o addirittura sono costretti a considerare la scrittura un dopolavoro. D'altronde anche in passato Kafka lavorava in una assicurazione, Svevo lavorava nell'azienda del suocero, Gadda faceva l'ingegnere alla Rai, Bianciardi era un traduttore, S.King faceva il bidello, Salinger era un intrattenitore su una nave da crociera, Joyce faceva il musicista. Ai giorni nostri Vincenzo Pardini fa la guardia giurata, Carofiglio faceva il magistrato e Marco Buticchi gestiva uno stabilimento balneare. Andrea Vitali ha lasciato la professione di medico soltanto nel 2014 per dedicarsi esclusivamente alla scrittura. Sono lontani i tempi di Calvino e Pavese. Non c'e più neanche una azienda come la Olivetti in cui trovarono occupazione molti talenti. Questa condizione così precaria degli scrittori al mondo di oggi ha un unico grande vantaggio: non essendo considerati vip nella maggioranza dei casi non sono oggetto di gossip e neanche di critica biografica o psicoanalitica. Ma ritorniamo agli svantaggi. Si consideri che molto spesso le presentazioni dei volumi non vengono pagate. Addirittura spesso i costi delle presentazionidei libri e dei premi ricevuti (viaggio, pasti, pernottamento) ricadono tutti sugli scrittori. Le royalties sono scarse. Sono mosche bianche coloro che non pubblicano a proprie spese. Sono una rarità coloro che prendono un anticipo. La tiratura per la maggioranza dei libri è scarsa. La distribuzione lascia a desiderare se uno non pubblica con una grande casa editrice. Per un esordiente le difficoltà sono insormontabili. Per uno scrittore italiano vendere 5000 copie è già un successo. Ma con 5000 copie in un anno non si campa di certo. Per il momento abbiamo parlato di romanzieri ma per altri generi va molto peggio. L'eBook può essere una opportunità. Prendiamo ad esempio un genere come la poesia. Sono pochissimi coloro che non pubblicano a proprie spese: solo i poeti che pubblicano con Mondadori, Crocetti, Einaudi, Garzanti. I ricavi sono davvero scarsi.

Ma c'è sempre l'opportunità dell'autopubblicazione di eBook. L'unico inconveniente è l'impegno profuso, ma la scrittura va considerata sempre una passione. Pubblicare un eBook quindi può essere una fonte di reddito e un modo per farsi conoscere da una ristretta cerchia di persone (almeno per ora). Alcuni scrittori hanno avuto anche un grande successo, iniziando con l'eBook, come ad esempio Anna Premoli (premio Bancarella) e Roberto Emanuelli. Basta ricordarsi che la signora James (pseudonimo) ha venduto circa dieci milioni di copie tramite Internet, prima di approdare all'editoria tradizionale. Ora la trilogia delle Cinquanta sfumature è famosa in tutto il mondo. Che sia questo il futuro? L'editoria tradizionale dovrebbe stare in guardia e dovrebbe stare soprattutto al passo con i tempi. Dovrebbe fare molto più scouting per scrittori emergenti. Per il resto che dire? Ai nativi digitali l'ardua sentenza.
ago 162022
"È chiaro che il pensiero dà fastidio
anche se chi pensa è muto come un pesce,
anzi un pesce
e come pesce è difficile da bloccare
perché lo protegge il mare;
com'è profondo il mare.
Certo, chi comanda
non è disposto a fare distinzioni poetiche.
Il pensiero come l'oceano
non lo puoi bloccare,
non lo puoi recintare.
Così stanno bruciando il mare.
Così stanno uccidendo il mare.
Così stanno umiliando il mare.
Così stanno piegando il mare"
("Com'è profondo il mare" di Lucio Dalla)
"Se negli anni Sessanta l’obiettivo era andare sulla Luna – afferma Steve A. Garan, scienziato leader nel campo della ricerca sull’invecchiamento – oggi la sfida è riuscire a vivere il più a lungo possibile. Ci riusciremo, perché cinque milioni di persone qui nella Silicon Valley, in un raggio di dieci miglia, stanno lavorando per questo".
Alla Silicon Valley ci vogliono immortali (noi tutti o forse più probabilmente soltanto un'esigua minoranza che avrà i soldi necessari?). Ma ci vogliono anche tranquilli, sereni, pacifici e pacificati. Gli psicofarmaci non bastano più perché nessun psicofarmaco può ridurre o eliminare il desiderio o la libertà/il coraggio di pensare. Ci sono però le droghe sintetiche, le droghe pesanti che aiutano il potere a ridurre l'elaborazione del pensiero, ma non a ucciderlo. È sempre più diffusa la cultura dello sballo, dell'autodistruzione. Che dire poi del fatto accertato che finite le scuole sono pochissimi i lettori forti, che leggono più di dieci libri in un anno? C'è tempo per tante cose, ma per leggere mai. Perfino la giovane filosofa Ilaria Gaspari ha combattuto per anni contro l'idea che la filosofia fosse inutile, fosse "aria fritta". Lo ha ammesso lei stessa pubblicamente, candidamente. Il group thinking può arrivare a influenzare anche le persone più autonome. Si vedano a proposito i celebri esperimenti dello psicologo Salomon Asch. Musk vuole impiantare i microchip nel cervello. La scusa ufficiale è quella di combattere le malattie neurologiche, il pretesto ufficioso è quello di avere una migliore interfaccia tra fisico e digitale, tra reale e virtuale. Potremmo ordinare una pizza col solo pensiero. Io mi chiedo se ci sia davvero bisogno di questa comodità apparente che finirebbe in concreto per essere invasiva, anzi totalmente pervasiva perché finiranno per essere controllati tutti i nostri pensieri. Il capitalismo di sorveglianza attuale è solo una fase di transizione. Per ora siamo tutti schedati, videosorvegliati, identificati e controllati. Un tempo la psichiatria era una modalità di controllo psicosociale. La repressione finì in Italia nel 1978 con la legge Basaglia grazie a un movimento come Psichiatria democratica. Ci furono a ogni modo illustri personalità che levarono la loro voce contro la chiusura dei manicomi, come lo scrittore Mario Tobino. Basta leggere "Gli ultimi giorni di Magliano" per capire il dibattito acceso e le polemiche di quell'epoca.
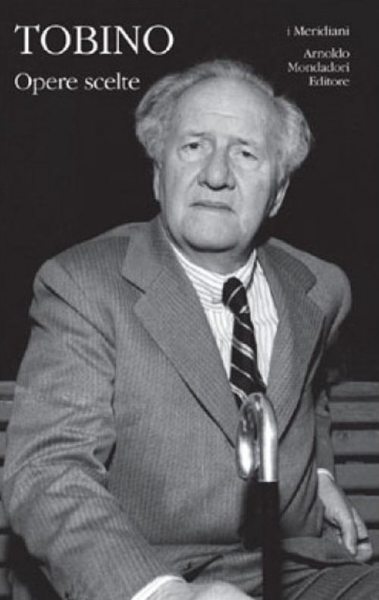
Oggi le nostre camicie di forza sono informatiche, virtuali. Per ora stanno controllando solo il nostro comportamento. Non hanno ancora inibito totalmente la nostra libertà e capacità di pensiero. Per ora le macchine stanno sostituendo gli uomini sul lavoro e sempre più persone lavorano da casa. Gli algoritmi governano la nostra vita online: algoritmi di cui non conosciamo niente o ben poco perché le multinazionali ci tengono all'oscuro della loro logica. Oggi addirittura vogliono scoprire tutti gli "algoritmi" del cervello umano per poi riprodurli con le reti neurali. Siamo sempre più asociali e questo al potere fa molto comodo: è esattamente così che ci vogliono. Se andiamo in una metropoli i grandi assembramenti di persone non fanno socializzare nessuno; il fatto è che siamo sempre più disgregati psichicamente, interiormente. Però siamo ancora agli albori. Forse se prendessimo realmente provvedimenti saremmo ancora in tempo a fermare tutto. Comunque bisognerebbe essere in tanti ed essere organizzati: quindi realisticamente parlando ciò non è assolutamente fattibile. Qualcuno dovrebbe avere una visione, vivere per essa e riuscire a coinvolgere molte altre persone: è possibile in teoria, in pratica è quasi irrealizzabile. Ma forse il processo è irreversibile. E poi chi ha la forza di ribellarsi? Chi è che si prende la responsabilità di opporsi? Chi è che non ha paura di ribellarsi? E poi ribellarsi sarebbe illegale e porterebbe a degli spargimenti di sangue. Prima di tutto però gradualmente ci hanno tolto la capacita di sognare, di essere intraprendenti. Nessuno vuole perdere la propria comfort zone. Anche chi ha poco non vuole perdere quel poco, che rispetto ai cittadini del secondo e del terzo mondo è molto. Quindi siamo punto e a capo. Lasciamo perciò che facciano ogni tipo di esperimento psicosociale sulla nostra pelle e nella nostra mente. I potenti vivono con discrezione e al contempo sfrontatezza. Sanno che nessuno li può fermare concretamente. Prestiamo perciò il fianco al potere. In fondo qualche anno fa Fukuyama teorizzava la fine della storia e questo non è avvenuto. Quindi non disperiamo. Ricordiamoci che lo scrittore e ingegnere Roberto Vacca pubblicò "Il medioevo prossimo venturo" e fu un bestseller del 1971. Vacca era catastrofico, apocalittico. Invece questo grande uomo di scienza non ci indovinò. Era stato fortunatamente per noi troppo pessimista. La regressione umana tanto temuta da lui non si è verificata. Non sempre gli studi dei futurologi, le distopie e le ucronie sono attendibili.
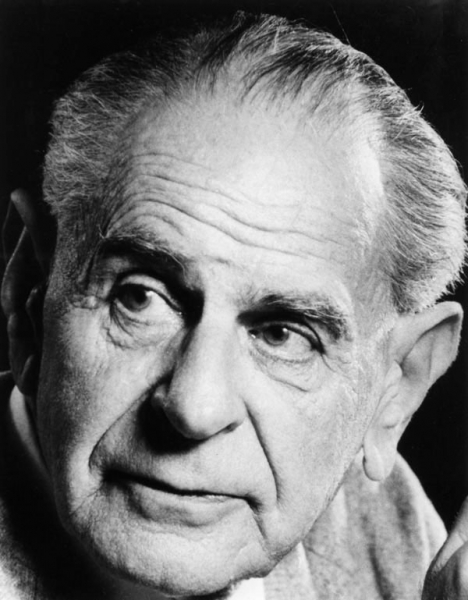
"Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno e faranno, oggi, domani e dopodomani. E quello che noi facciamo e faremo dipende a sua volta dal nostro pensiero e dai nostri desideri, dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da come vediamo il mondo e da come valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte."
(Karl Popper)
Gli scrittori di fantascienza hanno aguzzino le loro menti per proiettarsi nel futuro. Gli epistemologi hanno indagato la natura della conoscenza umana e i limiti di ogni metodologia scientifica. Alcuni scienziati si sono avventurati nell'ambito della teologia come de Chardin e Polkinghorne. A conti fatti però l'innovazione tecnologica più determinante nelle nostre vite per ora è la rivoluzione digitale; comunque siamo solo agli inizi. Ma è breve il passo tra telecomandare ed essere telecomandati. Saremo liberi di vivere nel metaverso, un universo parallelo virtuale. Ma saremo veramente liberi? Siamo ancora sicuri che il transumano, il postumano abbiano veramente qualcosa di umano? Non è che la tecnologia ci porterà all'antiumano? Per ora abbiamo solo un antiumanesimo diffuso. Sappiamo che è difficile rintracciare, definire, identificare l'essenza umana, ma mi chiedo io quale filosofia dell'uomo c'è dietro a tutto questo progetto? Più siamo pacifici, rincoglioniti, teledipendenti, internettiani più quelli della Silicon Valley sono felici, aumentano a dismisura ricchezza, potere, controllo. Vogliono diventare padroni dell'umanità intera. Quante persone sono dipendenti da televisione e Internet? Non c'è una stima precisa e gli esperti se ne guardano bene. Già oggi è molto difficile, impegnativo, quasi improponibile essere esseri pensanti. Ci sono troppe limitazioni e troppe inibizioni. Molte cose attaccano il libero pensiero. E se domani il pensiero non fosse più libero che razza di pensiero sarebbe? Sarebbe un pensiero eterodiretto. Ogni pensiero sarebbe vivisezionato e censurato. Cantava Gaber in tempi non sospetti: e pensare che c'era il pensiero! Hanno iniziato col controllare la nostra libertà d'azione, hanno proseguito impedendo di fatto la nostra libertà di cambiare il sistema, in futuro vogliono dominare il pensiero umano. Ma in futuro sarà un élite umana a controllare il pensiero della massa oppure tutto sarà delegato alle macchine? Ancora non lo sappiamo. Non c'è un angolo del mondo che non abbiano invaso, ma prima di tutto loro occupano la nostra mente, progettano con le loro tecnologia nuovi modi di essere e ci rendono sempre più dipendenti dalle loro invenzioni. In futuro solo una casta di scienziati e tecnologi dominerà il resto dell'umanità. Resta una speranza esile, incerta: sperare che il cervello umano non sia totalmente conoscibile, che la mente umana riservi sorprese e riesca a preservare zone inesplorate e auspichiamo inaccessibili agli scienziati. Forse come sostiene il filosofo della scienza Matthias Eckoldt non si può capire totalmente il cervello con il cervello. Trovare un equilibrio per noi poveri anonimi cittadini è difficile. In definitiva i condizionamenti dei mass media già oggi finiscono per essere un'efficace tecnica di controllo mentale, addirittura di manipolazione mentale, anche se apparentemente blanda ma persistente, martellante, ripetitiva e sempre presente. Una volta il poeta Lorenzo Mullon mi ha chiesto: "Davide, a quale Matrix giochiamo?".
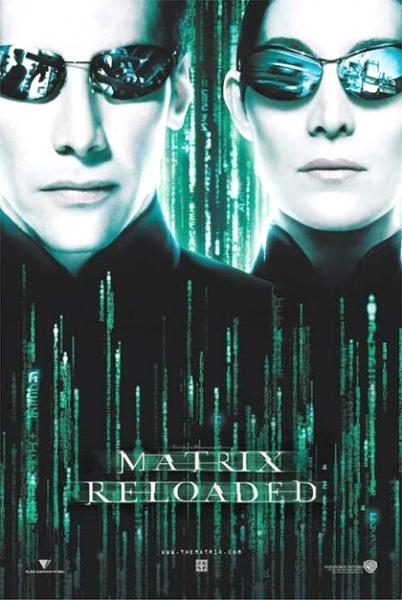
Siamo veramente sicuri che questa sia la realtà effettiva? Disintossicarsi totalmente significa rinunciare totalmente al mondo, autoescludersi, essere fuori dal mondo. Per essere liberi per ora bisogna perciò essere anche connessi, ma bisogna utilizzare con prudenza e saggezza le nuove forme di comunicazione, le nuove tecnologie. Bisogna essere dentro e fuori allo stesso tempo per salvare l'indipendenza, il pensiero e questo atteggiamento ondivago fa male alla nostra salute mentale. Così viene da chiedersi: dobbiamo sacrificare il nostro benessere interiore per la libertà o viceversa? È quasi impossibile avere entrambe le cose. Inoltre se gli uomini diverranno immortali dovranno colonizzare altri pianeti. La sola Terra non potrà contenere tutti, a meno che non si controllino le nascite. E se saremo tutti telecomandati allora chi potrà fare ulteriormente progredire l'umanità? Solo i figli e i nipoti degli attuali esperti di tecnologia potranno migliorare l'umanità? Sarà quindi una nuova casta? Gli altri saranno tutti assoggettati e schiavizzati? Gibson era stato troppo ottimista col suo Neuromante. In futuro anche la giustizia e la medicina saranno predittive. Nessuno potrà delinquere probabilmente, come nel film Minority report.
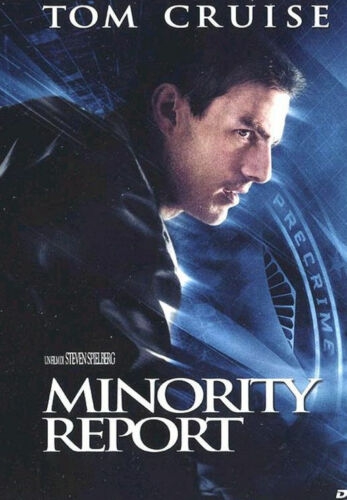
Forse arriveremo a quei livelli. Forse gli uomini saranno esseri totalmente prevedibili per il potere. Raggiunto l'obiettivo dell'immortalità la ricerca scientifica riguarderà solo quisquilie, solo minuscole migliorie. Il futuro è il presente, si usa dire. Non sappiamo ciò che è futuristico, ancora più precisamente futuribile, Tutti i grandi progetti a lungo termine però saranno inutili se non avverrà nel futuro immediato la decarbonizzazione energetica e industriale, se non inquineremo molto meno, se non salvaguarderemo il pianeta. Mi chiedo io se qualche potente non abbia mai dei dubbi a riguardo. Lo psichiatra Paolo Crepet ha sostenuto che una parte importante dell'intelligenza umana è costituita dalla capacità di coltivare dei dubbi. La cosa che mi stupisce di questi potenti è che non hanno dubbi o almeno non li manifestano pubblicamente. Speriamo che il futuro non sia già deciso dai signori di Cupertino in California. Di sicuro più andiamo avanti e più ci accorgiamo che non esistono le cosiddette frontiere della scienza, che la scienza è senza frontiere e che è un illuso chi cerca di porre a essa dei limiti etici.
ago 142022
(Nella foto Freak Antoni)
"Sono contro" degli Skiantos:
"Non ci credo,
alla carriera
alla pensione, soldi come soluzione
alla prigione
Non ci credo,
al panettone
ai finti artisti, parrocchiani, percussionisti napoletani
ai registi americani
E non mi fido,
dei paninari,
dei ragazzotti e Ramazzotti del decoro
che han le marlboro
Sinceralisti, moralisti, anticristi
albanisti, qualunquisti
Sono contro, io sono contro
si sono contro e fino in fondo
e sono pronto a stare contro
sono contro
Io sono contro
Non ci credo,
al nucleare
alla potenza militare, al radicale da salotto al buonsenso del bigotto
ai nuovi fan, ai Duran Duran
Non mi fido
Non mi fido
Non mi fido dei razzisti
dei cantautori ecologisti
della finta tolleranza dei barbuti
occhialuti intellettuali prevenuti tossicomani venduti
Sono contro, io sono contro
e fino in fondo
e sono pronto a stare contro
io sono contro
Si, sono contro
io sono contro
si sono contro
e sono pronto
a stare contro
e fino in fondo
Sono contro
io sono contro
e fino in fondo
io sono contro, si sono contro
e fino in fondo
Io sono contro
e sono pronto a stare contro fino in fondo
Io sono contro"

Achille Bonito Oliva (nella foto) ha scritto su Robinson: "Oggi il sistema riesce a inglobare qualsiasi tentativo di rottura e di novità, sia che si tratti di gesti diretti come la politica che di gesti indiretti come la cultura".
Achille Bonito Oliva sostiene che il sistema attuale inglobi tutto, anche le maggiori forme di dissenso e di contrasto al sistema stesso. Non c'è più niente che faccia scandalo. Non c'è più niente che cambi davvero qualcosa. Chiunque si metta contro il potere è innocuo e/o la paga cara con gli interessi. Se tutto va bene la sua iniziativa viene considerata una ragazzata o un volo pindarico e l'ideatore un fanciullo, un mattacchione o un matto. Un tempo uno era un poeta maledetto, era bohémien, era uno scapigliato. Bastava allora andare a vivere con una prostituta, sposarla oppure vivere una relazione omosessuale per fare scandalo, per far parlare i benpensanti. Oggi niente fa scandalo. Oggi per esempio qualsiasi rapporto sessuale tra maggiorenni, consenzienti, capaci di intendere e di volere è stato fortunatamente considerato normale. Certo già ai tempi di Rimbaud la buona borghesia sosteneva che gli artisti erano tipi strani e tollerava queste trasgressioni, bollandole come stravaganze, come eccentricità. Insomma gli artisti erano tipi matti, bislacchi. Li si tollerava, ma a quei tempi facevano la distinzione tra borghesi e artisti. I veri borghesi non potevano trasgredire e gli artisti avevano libertà, ma venivano etichettati, non venivano più considerati rispettabili e potevano morire poveri. Poi ci furono gli hippies, i sessantottini. Fare l'amore e non la guerra era uno slogan rivoluzionario. Adesso niente e nessuno può essere così innovativo. Ogni cosa, ogni persona, ogni idea, ogni movimento ha perso qualsiasi carica eversiva. Niente sorprende né entusiasma più a questo mondo. Flaiano aveva già ironizzato su questo, aveva già previsto tutto, scrivendo "Un marziano a Roma", dove il marziano appena sbarcato è un fenomeno da baraccone e tutti lo vogliono conoscere, ma dopo poco tempo nessuno più lo considera. Tutto viene fagocitato, metabolizzato in fretta. Anche tutto ciò che è contro è apparentemente contro, diventa una moda, diventa "in". Chi è davvero al di fuori dalla logica del dominio, del sistema finisce per essere incomprensibile o finisce per diventare invisibile. Non fidatevi di quelli che rivendicano in tutti i modi e in tutte le salse la loro diversità, la loro unicità e in fin dei conti il loro essere contro: in realtà sono sempre a favore di qualcuno, molto spesso a favore del potere. Anche se vuoi essere alternativo non puoi essere solo, devi essere con qualcuno o per qualcosa, devi mettere la testa a partito devi accettare dei compromessi: altrimenti vieni tacciato di finto ribellismo vuoto, astratto, improduttivo, inconcludente. La prima difficoltà insormontabile è che il potere corrompe tutto e tutti. Ci aveva già avvertito Pareto, un pensatore conservatore, che la controélite diventava élite, avveniva una cooptazione dei rivoluzionari più validi da parte del potere. Detto in parole povere a volte quando qualche allievo capace ma indisciplinato disturba troppo le lezioni lo si fa diventare capoclasse o rappresentante di classe, in modo da responsabilizzarlo e renderlo tranquillo, pacifico. Così avviene anche nelle logiche del potere. Ma il problema principale è che il potere corrompe prima di tutto nell'animo e nella mente perché deforma, inibisce la crescita interiore, la creatività, l'autonomia di pensiero, tarpa le ali sul nascere. Inibire la crescita come individui significa che il potere della società attuale ci lascia solo la libertà negativa, ovvero la scelta di vivere secondo gusti e preferenze, ma non ci consente la libertà positiva, ovvero di scegliere in modo razionale e con la possibilità di dire no al mainstream, al conformismo di massa (riprendendo i due concetti di libertà di Berlin). I veri falliti, i veri puri sono soli, sono costretti alla solitudine dal potere. Al limite possono creare una piccola comitiva di disperati, ma la comunità dei perdenti non esiste. I barboni si litigano la notte sotto stazione per un pezzo di cartone da adibire a giaciglio. La rivolta dei barboni è destinata a essere e rimanere solo un bellissimo racconto di fantasia di Bukowski. Non esiste alcun collante, alcun legame. Ognuno è chiuso nella sua storia, perso nei suoi problemi. Chi non è omologato è solo, chi agisce e pensa in modo difforme dalla massa è solo. Tutto ciò è dovuto anche alla solitudine dell'uomo contemporaneo. Si parla tanto di individualismo sfrenato, ma a conti fatti è in crisi la soggettività. Esiste la libertà di associarsi spontaneamente almeno a livello teorico, ma poi in definitiva non ci aggreghiamo più, non fraternizziamo più, non facciamo più comunità perché esiste solo una massa anonima con la conseguente legge del branco. Ma per essere contro veramente bisognerebbe anche essere contro una parte di noi stessi: quella che deriva, che è più legata alla logica del sistema e da qui nascerebbe una contraddizione insanabile, una grande lotta contro sé stessi. Noi abbiamo interiorizzato il sistema, il potere. Noi facciamo parte del sistema e il sistema è dentro noi, nella nostra mente, nelle nostre viscere. Qualche reazionario ci ricorda il celebre detto napoletano che "Nun sputà ‘ncielo ca ‘nfaccia te torna”, altri possono invitarci a non sputare nel piatto in cui mangiamo. Tutte le critiche sono ammesse teoricamente, nessuna critica è legittima. Essere contro nel migliore dei casi significa essere contro la propria famiglia spesso, contro il partner o la partner, contro le proprie amicizie. Ricordiamoci della scelta drastica che fu chiamato a fare San Francesco d'Assisi. Essere contro oggi significherebbe gettare la televisione, non leggere giornali, essere consumatori critici, essere attivisti. Insomma sono richiesti troppi sacrifici. E andare veramente contro potrebbe significare in forma estrema anche pagare con la stessa vita perché certi argomenti non si possono affrontare e certe verità non si possono dire né scrivere.

Allo stesso tempo non esiste più soltanto l'ineguaglianza dovuta alla distinzione marxiana tra cittadino e borghese, ma come ha sottolineato il professore Salvatore Veca a questa si è aggiunta la problematica della cittadinanza come frammentazione delle proprie identità socioeconomiche, sessuali, ideologiche, etniche, culturali, etc etc. Siamo troppe cose per accettarle, comprenderle pienamente in noi e gli altri hanno anch'essi troppe identità, troppe sfaccettature, troppe sfumature per riconoscerci pienamente negli altri, per rispecchiarci, per identificarci. Finiamo così per non fare neanche un pezzo di strada con gli altri. Al potere sempre più invasivo non si oppone più alcun contropotere. E poi il contropotere in questo mondo in cui siamo tutti sorvegliati, controllati, schedati non può essere più clandestino, viene subito istituzionalizzato, irregimentato, incanalato nei "giusti binari". Il contropotere deve essere presentabile, deve rientrare nell'ottica del sistema, nell'ordine del discorso. Nessuno può sgarrare. Niente e nessuno può deragliare. A ogni mossa originale e scaltra del contropotere si verifica puntualmente tutta una serie di contromosse opportune e neutralizzanti del potere, che rendono ogni tentativo goffo, inopportuno, velleitario, utopico, inutile. Inoltre per essere contropotere efficace ci vogliono soldi e chi ha davvero soldi difficilmente diventa contropotere o lo finanzia perché ha molto da perdere. Un rivoluzionario come Giangiacomo Feltrinelli oggi non esisterebbe più. Non solo ma viene da chiedersi come prendere alla sprovvista questo potere così pervasivo e onnipresente? Esistono dei cavalli di Troia per scardinare il potere? Infine questo potere, almeno in Occidente, non ha più forme dittatoriali e cruente, perciò moltissimi cittadini sottovalutano le dinamiche del dominio, così come le ingiustizie. Questo potere apparentemente democratico sa nascondere le proprie schifezze agli occhi dei cittadini. All'epoca di Feltrinelli c'era il pericolo imminente di un colpo di Stato, di una grande deriva autoritaria. E oggi? Non esistono così grandi paure o almeno non vengono avvertite dai cittadini italiani. Infine i cittadini hanno sempre paura di finire dalla padella nella brace, pensano che ogni cambiamento peggiori le cose.

E allora cosa ci resta? Forse la poesia? Forse l'arte? Scriveva Baudelaire che ogni poesia diceva un mondo. A patto che il mondo detto dalle vostre poesie non sia livellato, appiattito, omologato, già codificato troppe volte. E dire il vostro mondo con delle poesie a cosa può servire? A niente, non cambia niente, come scriveva Fortini. Però è terapeutico per voi e forse, anche se meno comunemente, per qualcuno che legge.
ago 132022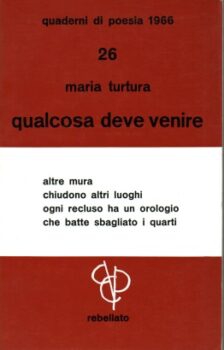
Maria Turtura (1930-1972) fu un medico bolognese, sorella della sindacalista Donatella, prima donna nel 1980 a far parte della segreteria generale della Cgil. La poetessa si suicidò dopo essere stata lasciata dal marito. Pubblicò "Qualcosa deve venire" (Rebellato, 1966) e "I cancelli della mattina" (Argalia, 1970). Unico critico letterario ad averla considerata è stato il grande Franco Fortini in "Poeti del Novecento", che ha definito la sua poesia "significativa" e di lei ha scritto che era una voce "severa e profonda". È stata una mia cugina di secondo grado, ma è morta l'anno che sono nato. Ecco alcune sue poesie:
Caro dottore che mi curi i nervi
voglio dirti in questi giorni com'è andata
affinché tu ti possa regolare
per quello che mi serve in questi giorni:
ho dei sintomi al cuore
nella parte che nessuno vede:
sapessi che disastro, dottore!
Il mattino lavoro
il pomeriggio lavoro
e di sera ho la netta sensazione
di essere un guscio vuoto in un cartoccio.
Ho altri mali che non dico
perché la lista è molto piena
e non posso far tardi soprattutto
ho quel mal di cuore
nella parte che nessuno vede:
ti consiglio di ascoltarmi, dottore.
Questi occhi che hai
non dimenticati
con dentro un'ombra
di mare del Nord tempestoso
che cosa guardano stasera
nel tuo freddo paese, amico,
mentre io mi ricordo
di una luce sul lago e di una
esile speranza, così esile
come solo può essere
un amore al principio.
Alberi di neve che non vedi
respiro corto della terra e voci
da luoghi ignorati
mentre suonano passi sul tuo capo
e la notte si prepara anche per gli altri.
Io non trovo più Dio, bambino cieco,
nel celeste sospeso dei tuoi occhi
nelle cose che indovini con parole ardite:
"Questo luogo è chiuso da mura".
Io so che fuori non sono centauri
né terre di lunga corsa.
Altre mura
chiudono altri luoghi.
Ogni recluso ha un orologio
che batte sbagliato i quarti.
Questo è tutto, e qualcosa
deve venire
a distruggere i muri
e all'ora giusta confondere i luoghi,
a cancellare gli ordini di Dio
perché valga la pena di vedere.
(Di lei che ama un mio amico sposato
e ha una malattia difficile da guarire,
di lei in ogni caso
padrona di sé stessa):
cara amica, io ti ho visto
su un ponte di primavera
tu eri là guardando in avanti
con uno sguardo che pareva azzurro,
dicendo parole di quieta meraviglia
e muovendo le tue esili mani.
La sua bontà capovolta
il rifiuto delle cose assolute
per un mondo di treni
e di letti da rifare,
il suo vestito, ai piedi
di uno da non confondere con altri.
Sempre lei, che di mattina
si prepara con cura
a un altro giorno di silenzio.
Si oscura l'aria sul tuo prato, Anna,
e con lenti giri
cala il falco.
Una notte di pioggia è in cammino
per accordare il tuo respiro al calmo
frusciare dell'acqua.
Stasera un cielo di inchiostro veleggiava sulle case
e la città muta guardava dalle finestre di maggio.
Un caldo vento mi spingeva innanzi
traendo il suono sospeso di un telaio.
Io venni alla tua casa
per un discorso che mi urgeva
nato da quelle immagini.
Tu sorridevi alla porta.
Alle undici Gesù è risorto.
Sulla Certosa il sole era alto.
Poiché non ho pregato: - Prendi per mano mio padre
e portalo con te a fare un giro nel cielo -
il babbo è rimasto dietro la sua pietra
e Gesù se n'è andato per conto suo.
Prima che scomparisse gli ho gridato:
- Fai morire quelli che uccidono i Viet! -
La luce è calata di una luce
e ora pare sera
ma l'uomo dai capelli bianchi
alto sullo sfondo dei vetri
deve avere in sua mano
il segreto finire del giorno.
L'ora di notte mi porta
alla piazza delle Sette Chiese
dai silenziosi cipressi.
Un inverno di piccoli passi
si irraggia verso il punto che tardi
chiamai la casa, luogo che nulla
dice agli altri, breve
inverno stellare, dove l'anima
tende a riavvolgersi.
Per aver visto il suo nome
su tre cose che gli altri
dicono belle, io vorrei
bere pazzamente e battermi
con la mia sfortuna fino a perdere,
fino a far sangue,
tanto mi sottrasse la donna
che si mise nella sua ombra
ed era in niente
migliore di me.
Si sono accese insieme nell'acqua
due luci; il giardino ha rumori;
con veste bianca e chino il capo
due donne dall'infermeria
mentre geme un autunno
di muri e di alberi
inseguiti dal vento.
Se avessi avuto un cappotto
con un colletto di pelliccia
forse non mi avresti lasciato.
Se un fischio arguto
avesse accompagnato i miei discorsi
ti saresti così confuso
da ritenermi importante.
Invece non sapevo fischiare
e avendo mal di gola
parlavo piano, per via di quel colletto
di pelliccia che non possedevo.
Quando il bambino
avrà finito di battere sul suo tamburo
comincerà la danza
delle zanzare,
suonerà qualcuno alla porta
o mi sentirò così triste
di qualcosa che ora non conosco.
Nel silenzio della campagna
a un tratto
chiamava una voce.
Veniva da una siepe oscura
presso gli alberi di confine,
mi gridava di ritornare.
Io cammino così
sotto le nuvole bianche
per raggiungere un sogno
di mezzogiorno.
Non disturbate questa
bellezza degli amanti giovani
che guardano solo dentro i loro occhi
e vivono come i rami degli alberi
strettamente confusi
alteri e senza presagi
della terra che tiene le loro radici.
Come le lettere bianche
sulla tenda azzurra del macellaio
come quest'aria di paese
così confidenziale e nuova
i miei pensieri.
Noi ci amammo poveramente.
Solo una luce di fanali
una tiepida pioggia
nella città di notte, e poco altro
ci diedero per amarci. Ma noi fummo
per il distacco e il ricordo
per la gioia di ritrovarci
sempre grati a noi stessi
di non esserci persi
nelle strade e nei porti
che mai vedemmo.
ago 042022
Nietzsche e il relativismo dei fatti:
E’ facile fraintendere la dottrina di Nietzsche perché la sua filosofia non è sistematica; è una filosofia delle contraddizioni e delle illuminazioni grazie all’utilizzo dell’aforisma.
Lukacs ha sempre considerato Nietzsche un distruttore della ragione, ma forse il filosofo tedesco dovrebbe essere considerato soprattutto un potenziale distruttore della metafisica platonico-cristiana. Per il filosofo tedesco nel cristianesimo è insito il nichilismo passivo; il cristianesimo è mortificazione del corpo, religione e morale dei vinti e dei deboli, risentimento dello schiavo nei confronti del signore, proiezione verso un altrove che riscatta la miserie del mondo terreno. Questo naturalmente è il suo punto di vista.
Nietzsche sceglie l’eterno ritorno per non cadere in un regresso all’infinito. Altrimenti dietro un velo ci sarebbe sempre un altro velo, dietro un fondo un altro fondo, dietro una maschera un’altra maschera.
Per il filosofo tedesco il tempo è circolare. Il divenire non è una linea retta, che prosegue all’infinito. I quanta d’energia per quanto illimitati per la mente umana, non sono infiniti. Di conseguenza ogni evento è destinato a ripetersi, a ripresentarsi. Ecco l’eterno ritorno.
La sua filosofia oltrepassa ciò che comunemente viene considerato nichilismo con l’amor fati e la volontà di potenza.
Il superuomo è colui che ha capito e accettato la dottrina dell’eterno ritorno. La genealogia della morale non è altro che la scoperta del meccanismo colpa-pena-punizione, meccanismo con cui la morale controlla totalmente le coscienze umane.
Nietzsche è un nichilista attivo, distrugge perché qualcuno in futuro ricrei. Nietzsche inizia dall’analisi e dal pessimismo di Schopenhauer, ma laddove quest’ultimo sceglie come rimedio l’ascetismo, Nietzsche opta invece per la volontà di potenza.
Le considerazioni di Nietzsche sono inattuali perché si volgono alla Grecia antica e denunciano la superficialità e il vuoto dei disvalori della sua epoca. La Grecia antica riusciva a trasfigurare la realtà con l’arte, che comprendeva la catarsi, l’elemento dionisiaco e l’elemento apollineo.
Il filosofo nella sua dottrina riesce a dire sì alla vita, pur essendo cosciente delle avversità, delle contrarietà e del dolore.
Nietzsche va letto più di una volta, facendo uso della parte più razionale di noi stessi, perchè di primo acchito e a una lettura superficiale la sua filosofia può condurre all’autoesaltazione fine a se stessa e all’odio nei confronti della religione e delle persone religiose. Ma veniamo ora al relativismo propugnato dal filosofo tedesco.
Nietzsche scrive nei Frammenti postumi che non esistono fatti ma solo interpretazioni. Per fatto si intende un avvenimento, un evento, un dato oggettivo, una prova. Ma nessuno dovrebbe più dire che esistono dati di fatto incontestabili e incontrovertibili a riguardo di una cosa. Non si dovrebbe più dire che qualcuno nega l’evidenza dei fatti. Nessuno dovrebbe usare espressioni come “constatazione di fatto”, “attenersi ai fatti” o “alla prova dei fatti”. Qualsiasi fatto e qualsiasi riscontro sono insostenibili. Non si può più neanche dire che esiste una interpretazione univoca per un certo fatto secondo la logica. Non ci può essere corrispondenza univoca tra un fatto e una interpretazione. Il filosofo scrive che i fatti non esistono e che possono esistere infinite interpretazioni. Questo relativismo ermeneutico è totale e sconfina nel nichilismo. Diventa nichilismo, ovvero totale perdita dei valori, perché quel che consideravamo fatti sono diventati nulla. Naturalmente agli uomini resta ancora la condivisione apparente delle percezioni. Ma anche le sensazioni sono soggettive. Variano da individuo a individuo. Nietzsche sempre nei Frammenti postumi scrive che ogni costruzione del mondo è un antropomorfismo. La conoscenza è illusione. Il relativismo di Nietzsche è prima di tutto gnoseologico. Il filosofo tedesco si pone contro la fiducia smisurata dei fenomeni e della scienza da parte dei positivisti, che vedevano nell’ascesa della borghesia e nel dominio della tecnica un enorme progresso. Nel Novecento il relativismo conoscitivo si estenderà ancora grazie al paradosso di Kripkenstein sul linguaggio privato e sul seguire le regole in ambito cognitivo. Questo paradosso scaturisce da una riflessione di Wittgenstein in “Lezioni e conversazioni”. Ma ritorniamo al filosofo della volontà di potenza. C’è chi come il filosofo Maurizio Ferraris ha ironizzato sulla questione, affermando “Non esistono gatti, ma solo interpretazioni”. Però il problema rimane. Per Nietzsche inoltre non vale più nessuna metafisica e nessuna religione. Possiamo perciò affermare che anticipa Lyotard secondo cui sono finite le metanarrazioni. Ogni ismo quindi è morto. Ogni grande racconto non ha più modo di esistere. È sempre più difficile distinguere il bene dal male e il vero dal falso. Nietzsche si conferma uno dei peggiori nemici del cristianesimo non tanto perché secondo lui era la morale dei vinti e dei deboli quanto per il relativismo di cui il grande pensatore è portatore. Non a caso i suoi libri vennero messi all’indice dalla Chiesa. Non a caso molti lo considerarono il filosofo del nazismo e non considerarono invece lo stravolgimento assoluto e la mistificazione della sua opera da parte della sua folle sorella. Allo stesso modo a ben vedere si può dire addio anche a ogni senso comune, che viene polverizzato dal filosofo tedesco. Ormai la maschera è stata tolta: dietro ogni verità c’è una convenzione, un compromesso, una realtà condivisa. Niente altro che questo. Qualsiasi interpretazione del mondo equivale a un’altra interpretazione. Una visione del mondo vale come infinite altre visioni. Sempre secondo Nietzsche sono i nostri bisogni che creano una interpretazione e non certo la nostra logica. Dietro ad ogni interpretazione ci sono così i nostri istinti e non la nostra razionalità. Dietro ogni interpretazione c’è un soggetto: un interprete, che ha un suo particolare punto di vista e una sua prospettiva. Il fatto in sé dei positivisti non esiste. Tutto è soggettivo. Ognuno si fida delle sue idee. Non resta altro che questo. Ognuno si tiene i suoi convincimenti più o meno radicati. Ognuno è creatore di senso. Il neopositivismo o positivismo logico potrà fare ben poco nel Novecento: solo proporre il criterio di verificazione e cercare di rendere inutile la metafisica. Popper successivamente rivaluterà la metafisica perché la considererà una risorsa di idee e di ipotesi plausibili per la scienza. Ma il neopositivismo e Popper non condizioneranno la filosofia e neanche la mentalità della popolazione quanto Nietzsche. Il relativismo etico finisce quindi per essere l’unico dogma, l’unica certezza, l’unica verità. Nessuno ora può scagliarsi contro il relativismo senza essere tacciato di essere antidemocratico, retrogrado o moralista. Il relativismo viene sempre più ritenuto una filosofia di vita, un modo di intendere e di approcciare la realtà. Chi è contro di esso viene considerato sostanzialmente un passatista. Questo ismo non nasce certo nell’Ottocento. Era già il perno della filosofia dei sofisti e degli scettici. Ma attualmente come ha dichiarato il Papa Ratzinger è avvenuta la dittatura del relativismo, che può assumere diverse forme e può essere etico, culturale, gnoseologico, antropologico. Eppure a rigor di logica si potrebbe criticare sostenendo che se tutto è illusorio anche lo stesso relativismo è illusorio e vano. Viene però da chiedersi alla fine chi vince in questa realtà occidentale dominata dal relativo? Vince l’interpretazione del più potente e/o del più ricco, che ha più forza e più mezzi per affermarla. Il logocentrismo non esiste più. Il Logos non esiste più nella parola. L’irrazionalità e l’assurdità regnano sovrane. Questa è la civiltà dell’immagine e dei messaggi subliminali. L’interpretazione dei più potenti diventa verità perché ripetuta all’infinito dai mass media. Il relativismo quindi si è diffuso a macchia d’olio e è al servizio completo del potere; ma era forse meglio il moralismo di un tempo? Oppure è più tollerabile questo nuovo tipo di edonismo scaturito dalla mancanza di morale? Di certo una filosofia di vita in cui tutto è relativo può indurre al consumismo e può essere facilmente al servizio di multinazionali e lobby. Il relativo è il più importante credo laico odierno e avrà molti limiti intrinseci, ma come ha affermato Giulio Giorello bisogna stare attenti perché il contrario del relativismo è l’assolutismo. Infine questo atteggiamento è una premessa indispensabile per il pluralismo di una società aperta. I filosofi oggi discutono perciò su come arrivare ad un relativismo ragionevole e non totalmente pervasivo.

Parole e fatti:
Le parole talvolta anzi spesso sono ambigue. Ma anche i fatti raramente sono chiari e inequivocabili. I fatti raramente sono incontestabili e incontrovertibili. I fatti raramente sono a interpretazione univoca. I fatti difficilmente sono fatti in sé. C’è anche chi dice che il fatto in sé non esiste. Ci vogliono parole per interpretare fatti. Ci vogliono parole per fare l’amore e poi raccontarlo. Ci vogliono parole per lavorare e per fare affari, per fare da mangiare e salvare vite umane. Ci vogliono parole per viaggiare. Ci vogliono parole per soddisfare bisogni primari. Ci vogliono parole per fare la guerra, ma altre parole ci vogliono per fare la pace. C’è chi dice che i fatti sono molto più eloquenti di molte parole e per affermare ciò usa parole e per giunta perentorie, si comporta come se con le sue parole fosse depositario della verità. Non si può far godere una donna con le parole. Però alcuni per fare fatti continuamente usano le parole con negligenza, trascuratezza, estrema disinvoltura, inconsapevolezza. E se fanno male con le parole che importa? Sono gli altri che sono permalosi, troppo sensibili e loro non l’hanno fatto apposta. Per alcuni le parole sono inutili, ma quando pensano ai fatti loro lo fanno con categorie verbali. Non si può negare l’evidenza dei fatti, ma neanche quella delle parole. Anche le parole sono fatti ed è per questo chei sto lontano da alcuni, che significa stare lontano dalla loro metafisica dei fatti e dalle intenzioni cattive delle loro parole. Voi pretendete di giudicare una vita dai fatti ma quali fatti selezionare e giudicare? Come giudicare in modo equanime i fatti di una vita? Le parole esattamente come i fatti fanno soffrire ma anche godere. La vita si vive con i fatti e con le parole. Alle parole devono seguire i fatti, a cui seguono altre parole e così via fino alla fine di ogni vita. Fatti si susseguono a parole che si susseguono ai fatti in un circolo infinito. Senza parole non ci sarebbero fatti. Abbiamo bisogno di fatti ma anche di parole. Fatti e parole continuamente si richiamano e intrecciano tra loro. Ai bambini si insegna prima a parlare per capire e dire i fatti. Le parole perciò vengono prima dei fatti. Quando uno muore vanno al capezzale a raccogliere le ultime volontà, le ultime parole. Le parole, neanche quelle di cordoglio o conforto, possono niente di fronte alla morte.

Sulla poesia:
La poesia non vende principalmente perché gli italiani non comprano libri, perché i libri di poesia costano 15 euro e si leggono in fretta, perché c’è insufficiente considerazione dei mass media per la poesia, perché le stesse case editrici non investono nella poesia, perché anche le grandi casi editrici guardano più ai follower di un aspirante autore che alla qualità, perché molti scrivono e pochi leggono, perché alcuni intellettuali vogliono che la poesia resti una nicchia, perché la comunità poetica è suddivisa in cricche, perchè altre cose contano oggi e non la poesia, perché l’editoria a pagamento pubblica tutti, perché a scuola la poesia viene insegnata in modo soporifero, perché nel mondo dominano il consumismo e la razionalità tecnologica, perché la cultura è in declino, perché la società è allo sbando, perché regna incontrastato il nichilismo, perché la lettura di un libro di poesia richiede impegno, perché la neoavanguardia ha intrapreso una strada difficile e impopolare, perché le persone credono che solo i cantautori facciano poesia, perché la gente non vuole pensare e ha altri problemi per la testa. Ma talvolta anche i poeti hanno le loro colpe perché non trattano dei problemi del mondo e della gente, trattano di sé soltanto in modo oscuro, difficile. I poeti non vanno incontro alle persone. Le persone non vanno incontro ai poeti. Io non so se la poesia è veramente distante dalle persone o se sono le persone a essere distanti dalla poesia. Forse entrambe le cose. Ma sta di fatto che la poesia in Italia non vende.

Su poesia, fatti, posteri:
Per Austin le parole sono atti linguistici, ovvero azioni, fatti. Le frasi hanno anche degli effetti. Agiscono. Sono anche atti perlocutori. Inoltre l’interlocutore come il lettore molto spesso, al di là dell’effetto, sa capire anche le intenzioni, gli atti illocutori; sa capire il retropensiero. Cosa è un fatto? Un fatto è ciò che accade nel nostro mondo, parafrasando e modificando un poco Wittgenstein. Anche le parole accadono; anche le conversazioni che restano nell’aria calda di quest’estate per qualche secondo. Le parole inoltre producono effetti. Fanno bene o male. Hai scritto un libro e pensi che sia un fatto? È un fatto di sole parole. I giudizi critici lo stesso. Ma alcuni vanno fieri di ciò e li chiamano fatti, li considerano fatti inoppugnabili. Sono totalmente sicuri di aver fatto una cosa importante. Invece è quasi impossibile distinguere tra fatti e parole in poesia. Invece spesso sono solo parole. Il problema è se la poesia incide nella realtà qui in Italia oppure no. La risposta è approssimativamente no, quasi per niente, in modo infinitesimale. Nella maggioranza dei casi la poesia non cambia la realtà, è impotente di fronte a essa. La poesia in buona parte dei casi fa più bene a chi la scrive che a chi la legge. Ormai è qualcosa di inessenziale. Un tempo ognuno sarebbe diventato famoso per quindici minuti secondo Warhol. Oggi secondo Roberto D’Agostino si può diventare tutti famosi nella stragrande maggioranza dei casi solo per pochi amici, ammesso e non concesso che si abbia degli amici. Molti sono famosi nella loro bolla. E tutt’al più sono conosciuti marginalmente anche in qualche altra bolla. Ma è molto difficile assurgere alla vera notorietà, uscire fuori bolla. Si tratta perlopiù sempre di bolle, ovvero di minuscole porzioni della realtà. Inutile bearsi del niente. E poi si è davvero sicuri del gradimento effettivo? In fondo si può mettere un like a un post perché l’autore fa pena e non metterlo perché sta antipatico, indipendentemente dalla valutazione della qualità di quel post. Ci sono autori con alcuni ammiratori ma anche con alcuni hater e constato che è meglio non avere ammiratori né hater perché gli odiatori lasciano in fondo parecchia negatività e strascichi nell’animo di ognuno. Ci sono stati casi di personaggi pubblici che hanno momentaneamente chiuso i profili social per critiche al vetriolo e insulti di pochi odiatori, pur avendo un grande seguito. Alcuni in poesia si convincono di aver raggiunto la fama con quella pubblicazione a pagamento, con quel premio di un paesino sperduto, con quella pubblicazione in un’antologia che compreranno solo gli antologizzati. La realtà è un’altra. La realtà è che nel 99,9% dei casi molti finiranno nell’anonimato, nel dimenticatoio. Di me non resterà niente e mi piace anche questa prospettiva di cadere nell’oblio. In fondo ci sono sempre stato nell’oblio, nel dimenticatoio. Non avrò alcun peso, alcuna responsabilità, alcun onere della fama. Ci sono abituato ormai e mi va bene così. Ma di chi avrà la cosiddetta posterità cosa resterà? Resteranno forse dei guadagni per gli eredi? Nel 99,9% dei casi assolutamente no. Resterà una via di periferia e nessuno saprà a chi era dedicata? Una pagina alla fine di un manuale di letteratura che nessuno consulterà e che nessun professore farà studiare agli allievi? Una conferenza in cui pochissimi amici faranno in sua memoria per un pubblico di pochissime persone? Una cena tra parenti che ricorderanno che grande poeta fosse il loro defunto? Oppure resterà una pagina Wikipedia scritta da un sodale, che quasi nessuno leggerà in un anno? Oppure un sito Internet con pochissimi visitatori, più intenti a curiosare che ad apprezzare o ad ammirare? La poesia contemporanea italiana non è di moda, non fa tendenza, non è popolare. La poesia è moribonda e perciò viva la poesia! Sono altre le persone incisive. Sono le persone pratiche, pragmatiche. È loro la realtà. Loro hanno compiti e funzioni precise. Loro hanno lavori e guadagni importanti. La gente li considera, li rispetta, li stima, li ammira. Loro fanno qualcosa agli altri per gli altri. La poesia di fatto non riesce a sortire alcun effetto. Tanti scrivono poesie ed è come se non le scrivesse nessuno. Bisognerebbe ricordarsi come sostiene Federico Fiumani che si può anche vivere poeticamente senza obbligatoriamente scrivere versi. Inoltre non si può essere elitari e rifugiarsi in una torre eburnea in nome di un’aristocrazia di pensiero, che non c’è più. Un tempo ci voleva kunstwollen, ovvero volontà d’arte per scrivere poesie. Oggi sono necessarie molta convinzione di sentirsi artisti e un minimo di consenso, poco importa se in grandissima parte amicale e autoreferenziale. Beckett tratta del fallimento umano, di riprovare ancora e di fallire di nuovo. Ebbene la condizione umana dell’uomo contemporaneo è la stessa di molti poeti, che però vivono di illusioni e non sanno riconoscere il proprio fallimento umano e artistico. La poesia oggi perlopiù è amorfa, cade nell’indistinto, non produce effetti benefici né malefici. Non è benedizione né maledizione. Non fa niente. Nella gran parte la poesia non è perlocutoria, è semplicemente inoffensiva, improduttiva, sciatta. A meno che non si tratti di voci inconfondibili, di ottimi poeti e poetesse. Ma io non sto parlando delle eccellenze che ci sono. Sto parlando soprattutto del gran marasma generale, del grande caos, che tutto appiattisce, tutto livella, quasi tutto annulla. È quasi come se non ci fosse la poesia oggi. Le altre parole hanno un uso comune. Le parole poetiche sembrano perdere di senso. La colpa non è dei poeti ma di questa cultura, di questa società allo sbando. Le poesie sono atti linguistici quasi inutili, per pochissimi eletti. Ma non si può nasconderci purtroppo dietro alla retorica del “meglio pochi ma buoni”. Bisogna ambire a molto di più. Certi poeti però hanno un minimo di responsabilità: la società occidentale dà loro già addosso e loro tanto per gradire finiscono per fare gratuiti atti autolesionistici, allontanando sempre di più le persone, il pubblico già sospettoso e lontano. Certi poeti infatti fanno terribilmente sul serio. Si prendono terribilmente sul serio. E questo va a loro discapito. Si rinchiudono nella loro cricca. Non cercano di andare incontro alle persone. Le cose sono due almeno: dovrebbero riversare la loro ironia nella pagina o sulla loro persona, nel loro atteggiamento esistenziale, nel modo di relazionarsi agli altri, se non addirittura a fare tutte queste cose insieme. Invece la postura è sempre la solita. Alcuni non scendono dal piedistallo e hanno come modelli dei monumenti. Come se non bastasse alcuni sono rimasti a una condizione della poesia tipica del Pascoli. Se poi la poesia non ha pubblico non lamentiamoci. Forse chiedo troppo chiedendo autoironia, ma certi poeti dovrebbero abbracciare la semplicità, l’umiltà. La strada è tutta in salita. Montarsi la testa per piccoli insignificanti traguardi oltre a essere così poca cosa è controproducente alla causa della poesia. Infine i poeti dovrebbero sapersi gestire. No ai falsi miti, all’autodistruzione, al trascurare disturbi psichici e non curarli in nome di un presunto genio creativo, tutto da dimostrare. Un’altra cosa utile alla poesia sarebbe parlare chiaro, dire pane al pane e vino al vino, non perdersi in inutili intellettualismi. Questa è l’amara realtà di cui bisogna prendere coscienza: questi sono i fatti inoppugnabili.
ago 022022
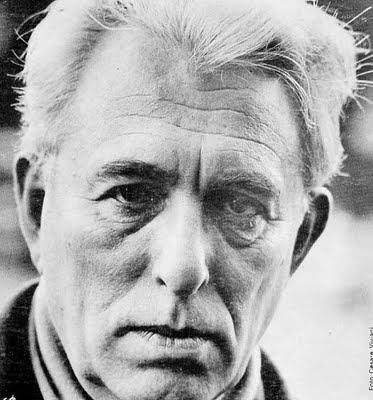
Sicuramente alcuni letterati giustamente hanno cercato di raccogliere o meglio hanno aspirato a raccogliere l'eredità letteraria e critica di Fortini, però mi chiedo io se ha più senso oggi la cosiddetta funzione Fortini, ovvero l'intento di politicizzare la letteratura italiana, in vista di una rivoluzione. Me lo chiedo ora che la rivoluzione a mio avviso non è più possibile, dato che le coscienze sono addomesticate dai mass media e che il capitalismo di sorveglianza ci ha tutti schedati, vivisezionati, controllati totalmente. Bisognerebbe forse cercare di distruggere mass media e capitalismo di sorveglianza? Bisognerebbe quantomeno boicottarlo? Non sarebbe forse un tentativo puerile, utopico, come del resto quello del luddismo? Forse la cosa migliore è aspettare tempi più propizi. Forse anche le multinazionali e le lobby faranno dei passi falsi. La speranza è che il mondo migliori. Di ingiustizie e disuguaglianze ce ne sono a bizzeffe. Come è possibile fare la rivoluzione quando questo sistema ha svuotato e distrutto la concezione sociale della comunità? Non esiste più il senso della comunità. Siamo in una società in cui è sempre più difficile dire "noi". Le classi sono scomparse e con esse anche la coscienza di classe e la lotta di classe. La rivoluzione pacifica non è più possibile e molto probabilmente neanche quella non pacifica: sarebbe solo un inutile e utopico bagno di sangue, in cui sarebbero i rivoluzionari prima di tutto a rimetterci. Il problema non è solo accettare una quota fisiologica di violenza per fare la rivoluzione, ma ormai la questione di fondo è rassegnarsi alla sconfitta, accettare le istanze della rivoluzione mancata, accettando razionalmente che quei tentativi non sono più ripetibili. La lotta è impari, realisticamente parlando. Allora non sarebbe meglio unirci tutti, indipendentemente dell'orientamento politico, in nome del buon caro umanesimo, un umanesimo più moderno, che comprenda anche le scienze umane, per una critica serrata e radicale alla società attuale? Che senso ha rimpiangere la rivoluzione? Non sarebbe un grande atto politico cercare di riunirsi in nome dell'umanesimo? Il treno della rivoluzione è stato perso e probabilmente non passa più. Che fare ora? Stare sempre rivolti al passato? È utile la nostalgia di un'epoca che non tornerà probabilmente? Certo di grandi insegnamenti da trarre da quegli anni ce ne sono. Quell'epoca e la quella cultura non devono essere passati invano. Non sarebbe però ritornare sempre a quei giorni ripetere il solito mantra, il solito continuo "vorrei ma non posso", nel vero senso della parola? Per fare una cosa molto umana, ovvero il comunismo ci vogliono dei metodi sanguinari e disumani. Chi tutela il sistema capitalistico tutela i propri interessi ed è mosso dal proprio egoismo. Cosa succederebbe poi se il sistema intero implodesse? Che ne sarebbe di noi? Inoltre al mondo d'oggi molti hanno qualcosa da perdere, anche poco, anzi pochissimo, ma se lo tengono stretto. Siamo sicuri che il comunismo sarebbe un sistema migliore? Siamo sicuri che il tracollo del capitalismo non ci porterebbe in condizioni umane ancora più disastrose? Comunque anche se non si può accettare le dinamiche e le trasformazioni socioeconomiche odierne vanno capite e criticate. In questo il pensiero di Fortini può aiutarci molto, può venirci in soccorso. Non si può nascondere la testa sotto la sabbia. Ci vogliono comunque anche nuovi strumenti intellettuali per capire nuove dinamiche. Bisogna stare al passo con i tempi. Fortini va sempre tenuto presente perché è un grande maestro e un lucidissimo intellettuale, anche se apparteneva a un'epoca lontana. Fortini, per quanto sant'uomo e autore geniale, non poteva prevedere tutto, anche se ha previsto molto. Il primo interrogativo è come fanno molti a definirsi fortiniani e perciò militanti quando hanno accettato di buon grado tutti i meccanismi dell'industria culturale e i compromessi delle carriere universitarie? Più che raccogliere l'eredità diciamo che ne hanno subito gli influssi, anzi degli echi lontani. Infine un ultimo dubbio: raccogliere interamente l'eredità fortiniana significa anche abbracciare la sua religiosità (i Salmi, i libri sapienziali del Vecchio Testamento, i profeti, etc etc), per quanto Fortini non fosse sionista (vedere "I cani del Sinai"), e non fraintendere, non equivocare la sua chiamata alla clandestinità, che non significava prendere le armi e che al mondo d'oggi molto probabilmente, questa clandestinità, non è più possibile perché qualsiasi lotta, qualsiasi forma di opposizione richiede una certa visibilità, anche a rischio di farsi fagocitare dai mass media: sono finiti i tempi dei fogli ciclostilati e delle riunioni piene di fumo. È vero che Fortini era anche un ideologo e oggi l'unica ideologia rimasta è quella del mercato, come cantava Gaber.
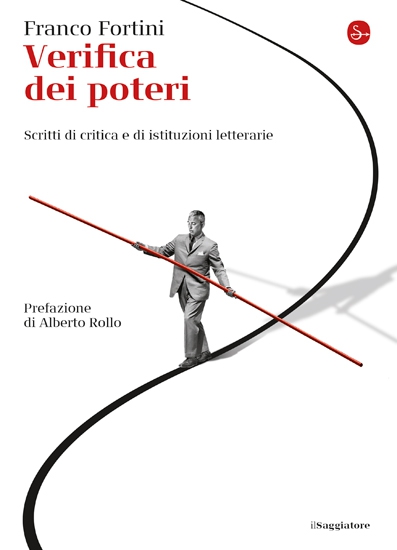
È vero che possono sembrare, anche se solo di primo acchito, un poco datate la politicità di Fortini e la politicizzazione del reale. Però non bisogna fermarsi alla superficie; bisogna sempre valutare la grande capacità critica e dialettica fortiniana, la sua costante ricerca di oggettività, le sue grandi intuizioni intellettuali. Non bisogna dimenticarsi neanche della grande capacità di accettare il dialogo e di mettersi sempre in discussione di Fortini: qualità o quantomeno cortesia che mancano a molti intellettuali oggi. Fortini va sempre tenuto in considerazione. Il suo saggio "Verifica dei poteri", più di ogni altro suo lavoro, va tenuto sul comodino, sempre a portata di mano, per dubbi, chiarimenti, delucidazioni, nuovi interrogativi. Ma bisogna anche chiedersi non qual è l'eredità di Fortini, piuttosto ciò che è vivo e ciò che è morto in noi del suo pensiero, parafrasando Croce. Insomma Fortini è importante e non deve essere dimenticato e lo scrivo anche se non sono fortiniano. L'eredità di Fortini sarebbe a ogni modo ingente, cospicua, ma molto probabilmente mancano gli eredi legittimi.
lug 272022
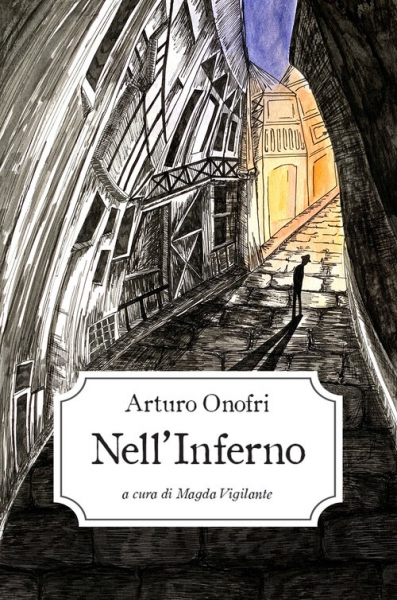
Questi tre racconti, editi in un volume dalla Pandilettere, di Arturo Onofri, poeta metafisico e scrittore (1885-1928) rappresentano a mio modesto avviso delle autentiche rivelazioni. Non lo scrivo per essere celebrativo perché Onofri è un letterato memorabile, che ha in modo inequivocabile segnato il '900 per l'originalità e la qualità della sua scrittura. Dell'importanza di Onofri ne è la controprova che una esperta italianista come Magda Vigilante ha dedicato una prefazione di quaranta pagine, facendo una disamina accurata dei racconti. Cercherò quindi di fare una breve rassegna di questo libro, spoilerando il meno possibile per non togliere istinto di acquisizione e gusto della lettura. Farò delle considerazioni di carattere personale, senza parlare della sua vita, del suo apprendistato, delle sue frequentazioni e delle sue collaborazioni con le riviste letterarie. Il primo racconto si intitola "Il pollice esercitato" (che sta a significare il talento coltivato) e tratta il tema della creazione artistica e della ispirazione con tutte le difficoltà del caso (la creta non è mai molle, indipendentemente dal fatto che si cerchi la mimesi, la trasfigurazione, la creazione ex novo). Come ci ricorda la Vigilante le idee in questione non sono quelle dell'Iperuranio, ma sono spiritelli maligni. Forse il poeta vuole suggerirci che la vera creatività spetta alle donne oppure solo a madre natura: forse solo loro hanno la vera capacità di generare. Le stesse idee sono signore algide e scostanti. Ho letto recentemente che le idee veramente innovative e originali scaturirebbero in modo casuale secondo i neuroscienziati e che addirittura la loro frequenza potrebbe essere descritta dalla distribuzione statistica di Poisson: semplificando ogni idea sarebbe un evento raro e fortuito nelle menti più creative. Ecco quindi la fatica di Sisifo della creazione artistica. Insomma Onofri aveva anticipato i tempi. Il secondo intitolato "I due" mette in scena sia il tema del doppio che quello psicologico del falso Sé (più che dell'Ombra junghiana a mio modesto avviso). Alla fine viene da chiedersi chi sia il personaggio autentico, se la figura in carne e ossa oppure il sembiante. Uno è il Sé autentico e l'altro è la maschera sociale, colui che rispetta codici e convenzioni borghesi. Il terzo intitolato "Inferno" esamina il perturbante in senso freudiano. Il protagonista prova allo stesso tempo repulsione e attrazione verso la donna, descritta inizialmente come orrida. Il lettore viene spiazzato più volte con alcuni straniamenti, con alcuni colpi di scena. Perché una scena sia effettivamente perturbante per Freud deve essere ambivalente emotivamente, deve essere familiare ed estranea al contempo. Onofri si dimostra un artista enigmatico, simbolista, decadente, esoterico (non a caso studiò l'antroposofia steineriana) in questi tre racconti, a cui lasciamo libera interpretazione agli acquirenti del volume; in questa sede ho voluto solo dare delle indicazioni di massima. D'altronde l'arte si caratterizza per la sua polisemia e ambiguità. Ognuno quindi può dargli il suo significato. Posso solo affermare che Onofri nei suoi racconti accosta elevazione spirituale e spavento, grazia e solitudine, levità ed angoscia, orfismo e scissione, purezza e terribilità. Sulla scena si affaccia prepotente il mistero, l'irrazionale sotto la forma di ossessione, di paura. Senza mai cadere nell'intimismo c'è una propensione innata alla penetrazione psicologica. Sono ineludibili lo sgomento e la sorpresa dei protagonisti, che sono tra la veglia e il sonno, quasi in uno stato di reverie e hanno delle apparizioni sconvolgenti. Onofri dà forma al materiale informe dell'onirico. Getta un ponte tra conscio e inconscio, trovando archetipi senza scandagliare oscenamente i segreti recessi dell'anima. Lavora di cesello e l'oscuro non è mai incoerente né incongruo. La sua prosa -per quanto subisce echi, risonanze, influssi- è suggestiva e mai suggestionata da nessun altro autore. Centrali sono le visioni e le analogie di Onofri. Non imita né prende a prestito alcunché. Piuttosto si rifà sporadicamente ed episodicamente alla tradizione. Per dirla alla Peirce il poeta era mosso da autentico amore per la conoscenza, era all'instancabile ricerca della verità. Non è forse un caso che amò diverse dottrine, ma non divenne mai dottrinario? E ora veniamo all'inghippo: quella di Onofri è una prosa poetica? E ancora si può cercare un discrimine tra poesia e prosa poetica?

Voglio sgomberare il campo da ogni possibile fraintendimento: è impossibile a mio avviso fare una distinzione oggettiva tra poesie in versi e prose poetiche. Di distinzioni se ne possono fare ma sono solo soggettive e a mio avviso stucchevoli. Mi auguro che non lo si faccia per faziosità o per partito preso. È sempre arduo stabilire una relazione tra prosa e poesia oppure una linea di confine. C'è chi sostiene che non vi sia più una grande differenza tra i due generi e che per vendere più copie molti poeti farebbero meglio a non andare a capo. Ricordo a tutti che condannare la prosa poetica può voler dire giudicare negativamente i capolavori di Pagliarani e Bertolucci. Perché condannare un certo ibridismo? Per quale motivo? Inoltre ricordatevi che per i puristi del verso scrivere in versi liberi significa andare a capo arbitrariamente ed è considerato alla stessa stregua dello scrivere in prosa. Il verso libero è il lasciapassare e allo stesso tempo la diretta conseguenza della prosa poetica. È meglio non mettere steccati e paletti. Nel secondo Novecento non l'hanno fatto. A mio avviso è lecito scrivere in ogni modo. È sempre meglio non fare restrizioni di nessuna sorta e permettere ogni tipo di libertà. Preferisco per quel che mi riguarda essere onnicomprensivo e inclusivo ai massimi livelli. Un poeta può dimostrare la propria versatilità e scrivere in ogni modo: Onofri ne è stato l'esempio lampante e ha dimostrato tutta la sua versatilità. Un poeta deve avere sempre la massima libertà espressiva. Di conseguenza può utilizzare qualsiasi registro espressivo, che deve essere considerato comunque espressione artistica. Può anche adottare il pluristilismo. La poesia in versi liberi può essere a mio avviso poesia come, anche la prosa poetica può essere allo stesso tempo poesia. Tutto il resto è polemica sterile fatta per amor della polemica. Personalmente non cerco ossessivamente come fanno taluni una linea di demarcazione tra poesia e non poesia. Cerco solo di distinguere solo ciò che mi emoziona da ciò che non lo fa, ciò che mi fa pensare da ciò che non lo fa. I tre racconti di Onofri mi hanno colpito favorevolmente, mi hanno emozionato. Una cosa che contraddistingue la sua scrittura è il fatto che, nonostante le innumerevoli variazioni della lingua italiana dagli anni di stesura a oggi, essa sia ancora comprensibile e chiara senza l'ausilio di alcuna nota: ciò dimostra la capacità comunicativa dell'Onofri. Quella del poeta romano è a ogni modo una prosa lirica, è quella che un tempo veniva chiamata prosa d'arte. Per tutte queste ragioni il volume meriterebbe di essere letto.
lug 232022
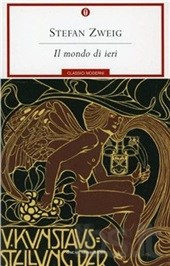
"Il mondo di ieri" di Stefan Zweig, scrittore austriaco ebreo di successo negli anni '20 del Novecento, è un'autobiografia illuminante, che fa piena luce sia sulla sua vita che sulla sua epoca. Il libro è caratterizzato da riflessioni e ricordi, intesi in senso guicciardiniano. Il libro fu scritto tra il 1939 ed il 1941 in Brasile, dove l'autore si era rifugiato. Si possono rintracciare aforismi, massime, avvertimenti, però a differenza del segretario fiorentino, Zweig non si impegna nella scrittura breve, non è discontinuo né frammentario, anzi è un accumulatore seriale di aneddoti e ricordi, pur tuttavia sempre racchiusi in una forma organica, lineare e razionale. L'opera si legge tutta di un fiato. Lo scrittore riesce sempre a ravvivare e ridestare l'interesse nel lettore, non perdendosi mai in intellettualismi e senza scadere mai in digressioni prolisse. Zweig fa un affresco memorabile dell'impero austro-ungarico e della sua caduta; lo fa a pieno diritto, visto e considerato che è stato un rappresentante di alta levatura della cultura mitteleuropea. In Europa fu un autore molto letto. Zweig inizia col descrivere la sua infanzia a Vienna. Definisce la scuola una galera, a causa della disciplina ferrea vittoriana che determinava molti "complessi di inferiorità". In quella Vienna la massima aspirazione delle famiglie borghesi non era che i loro figli si arricchissero ulteriormente ma che diventassero dottori. Molti bambini e adolescenti volevano diventare artisti. Allo stesso modo l'educazione era molto rigida e impostata. I doveri avevano la priorità assoluta sui diritti. I ragazzi avevano come modelli dei maestri di pensiero, prima di tutto rispettabili. La sessualità era un tabù. Era un'attività da non mettere in mostra e un argomento di cui non parlare. L'erotismo in quella società sessuofobica era tutto nascosto e adulterato o almeno mistificato. Ma allo stesso tempo per un meccanismo di compensazione quella era in Austria anche l'epoca della sicurezza. Era la Felix Austria. Era la Belle Époque. Era la società del liberalismo e del progresso, delle "magnifiche sorti e progressive". Zweig proveniva da famiglia agiata ed ebbe la fortuna sia di poter andare all'università che di scegliere la facoltà, cose non affatto scontate a quei tempi. Scelse filosofia, ebbe modo anche di pubblicare le prime poesie e di conoscere Herzl, fondatore del sionismo. Poi il 28 giugno 1914 Princip, uno studente serbo, assassinò l'erede al trono asburgico. Come scrive Zweig erano stati 40 anni di pace e poi era sopraggiunta all'improvviso la guerra. Molto fuoco covava sotto la cenere. L'equilibrio in Europa era precario. C'erano molte tensioni di varia natura (economica, politica, sociale, ideologica). Iniziarono gli sconvolgimenti, gli eccidi, gli orrori. Come ci racconta Zweig i soldati al fronte morivano, mentre gli altoborghesi imboscati se la spassavano in patria. I superpatrioti ce l'avevano con lui che era pacifista. Ma lo scrittore era impegnato lo stesso perché aveva la coscienza e l'esatta percezione di quanto fosse importante il parere e la presa di posizione di un letterato o di un artista a quei tempi, mentre come sottolinea molto lucidamente nella seconda guerra mondiale gli intellettuali erano ormai fuorigioco e ininfluenti. Finita l'università si trasferisce a Parigi. Zweig descrive con nostalgia la capitale francese, una città cosmopolita per eccellenza, e scrive che sulla Senna ognuno si sentiva a casa propria. Racconta anche i suoi viaggi, che lui definisce "pellegrinaggi". Un artista, per essere tale, deve avere frequentazioni con giganti intellettuali e lui ebbe molti incontri con geni come Rilke, Harden, Richard Strauss, Herzl, Romain Rolland, Pirandello, Freud, Dalì. Riconobbe nella Svizzera un modello per tutti per la civiltà e l'accoglienza, dato che in terra elvetica trovavano rifugio tutti i perseguitati. Allo stesso modo ci descrive gli Stati Uniti come il paese in cui ci sono più libertà ma anche più opportunità, visto che in pochi giorni gli offrono ben cinque impieghi. Inoltre descrive il periodo londinese, che va dal 1934 al 1940.
altmann-zweigandrothinostendin1936(cropped)1_0_o.jpg)
Zweig dagli anni '20 era uno scrittore noto al grande pubblico. I suoi libri vendevano molto. Aveva ottime entrature nell'alta società, anche se tutto ciò non lo interessava granché. Conosceva tutti gli scrittori, gli editori, i direttori di riviste che contavano in Europa. Eppure fece naufragio perché si suicidò in Brasile insieme alla moglie. Nonostante il suo successo personale aveva vissuto anche troppo orrore per la guerra, la crisi dell'Austria, che non aveva più fabbriche, era povera e la cui banca nazionale era senza più oro, tutti segni di una miseria inenarrabile e della fine di un'epoca felice. Ma non c'è solo questo: Zweig aveva assistito anche all'ascesa di quel folle di Hitler. Gliene avevano parlato già all'epoca in cui istitgava all'odio i bavaresi nelle birrerie. Aveva avuto modo di constatare la follia di Hitler, che aveva saputo approfittarsi della difficile situazione in cui versava la Germania in quegli anni, obbligata a pagare una indennità di guerra incredibile. Hitler si approfittò di una Germania umiliata e colse la palla al balzo, coniugando necrofilia, imitazione del fascismo, antisemitismo, anticomunismo, sadismo e crudeltà infinita. Zweig era un intellettuale così lucido che si era accorto del pericolo. Cosí come probabilmente forse si era accorto della "banalità del male" del popolo tedesco. Date queste premesse la fine di Zweig era quasi scontata.
lug 172022
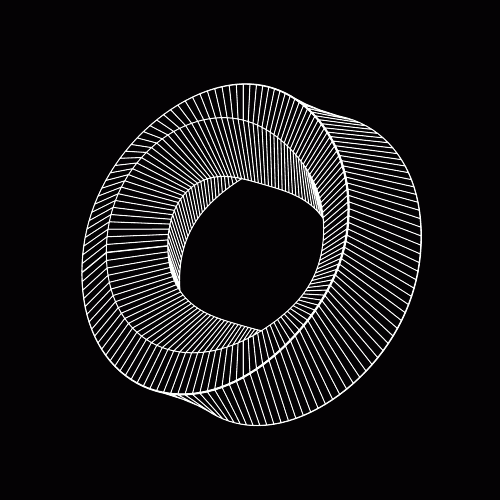
“Quando avremo quarant’anni altri uomini e più validi di noi ci gettino pure nel cestino come manoscritti inutili” (Filippo Tommaso Marinetti)
Molto probabilmente Marinetti, fondatore del futurismo, quando scrisse questa frase voleva solo provocare. Oppure forse ci credeva davvero. Oppure era un modo per opporsi al passatismo e alla tradizione. Cosa è che ha dettato queste parole? Il calcolo oppure l'incoscienza giovanile? O forse entrambi in una miscela esplosiva? Per rendere più popolare il suo movimento d’avanguardia scrisse molti manifesti dissacranti. Per far parlare di sé e del proprio movimento non disdegnò polemiche al vetriolo e vere e proprie risse. Propose il culto della macchina e della velocità, la teoria delle parole in libertà, “l’immaginazione senza fili”. Si scagliò contro i professori passatisti e la tradizione, invitò ad “uccidere il chiaro di luna”. I futuristi come scrisse Boccioni inseguirono “l’estasi del moderno e il delirio innovatore della loro epoca”. Ecco il motivo per cui volevano distruggere i musei e le biblioteche e odiavano chi imitava e ammirava il passato. In letteratura furono veramente degli innovatori tramite la distruzione della sintassi, l’abolizione degli avverbi e degli aggettivi, la distruzione dell’io. Politicamente - nonostante il loro antiparlamentarismo - lo furono un po’ meno, dato che furono nazionalisti e considerarono la guerra “sola igiene del mondo”: furono fascisti della prima ora. Per la maggioranza dei letterati della loro epoca furono visti come esaltati, ignoranti, militaristi e violenti, creatori di stramberie e goliardismi. A distanza di decenni dalla loro comparsa va senz’altro riconosciuto che il futurismo - nonostante mille difetti - ebbe il merito di essere il primo vero movimento di avanguardia. Marinetti scrisse forse questa frase per scagliarsi contro l’immobilismo sociale e culturale, in cui versava l’Italia di allora. Però nella nostra epoca sembra che molti imprenditori e dirigenti di azienda abbiano messo in pratica la provocazione di Marinetti. Il giovanilismo imperante induce al prepensionamento e al licenziamento di chi abbia superato gli anta. Non solo, ma una volta licenziato da un’azienda un cinquantenne ha molte più difficoltà di reinserirsi a livello lavorativo perché le aziende gli preferiscono persone più giovani. Un tempo si considerava la vecchiaia come possibile fonte di saggezza. Oggi perfino la maturità è vista come un periodo di declino inarrestabile. Erroneamente molti selezionatori del personale ritengono che chi ha superato gli anta non è provvisto di capacità di apprendimento. Molto probabilmente quando prendono sbrigativamente le loro decisioni non tengono conto della ponderatezza di chi ha più di quaranta anni. Eppure la stessa vecchiaia non è una stagione della vita, in cui si debba per forza consegnarci al silenzio. Per quel che mi riguarda penso di sfruttare al meglio le mie facoltà intellettuali oggi rispetto a quando avevo 20 anni. Mi ritengo anche più equilibrato interiormente.
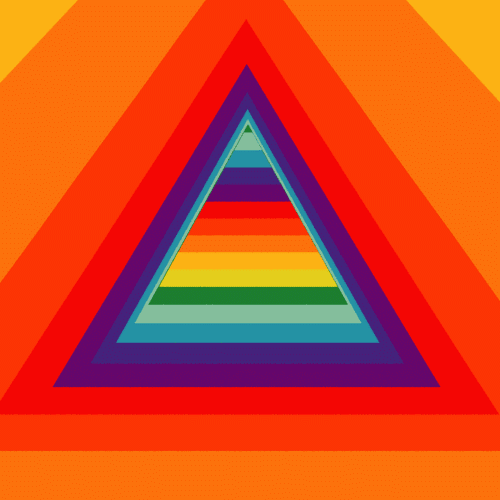
A 20 anni volevo tutto e mi accontentavo solo con molto. Oggi voglio poco e mi accontento di pochissimo. A 20 anni si può vivere delle crisi interiori spaventose. A 50 ormai sono un'esistenzialista positivo: nell'antichità c'era chi vedeva Dio come "pensiero di pensiero", io oggi vedo il trascendente come il filosofo Abbagnano, ovvero come "possibilità di possibilità", come scelta di scelta; la sola possibilità di poter scegliere, anche senza fare niente di speciale, nella vita, mi infonde speranza e ottimismo. Andare al bar piuttosto che rimanere a casa mi inebria di libertà. Oggi ho una consapevolezza esistenziale che prima non avevo. Forse non so niente di più o di nuovo, ma quello che sapevo un tempo viene confermato, rafforzato, corroborato da letture e riflessioni odierne. Mi basta stare bene di salute e tirare a campare. Non chiedo l'impossibile. Questo già mi basta. Per quanto riguarda la sessualità con il Cialis e il Viagra le persone anziane hanno risolto molti problemi. Non vivono più i drammi descritti da Brancati ne "Il bell'Antonio" e non esiste più il gallismo e la concezione dell'onore di un tempo. Inoltre sono molti gli anziani attivi intellettualmente, che leggono libri e periodici. Non dimentichiamoci che la morte colse Moliere mentre stava recitando. Più recentemente non dimentichiamoci dell’attività intellettuale di Norberto Bobbio, Carlo Bo, Karl Popper, Mario Luzi, quando erano ormai ottuagenari. Solo la malattia mentale e la morte prematura annichiliscono la mente e l’intelletto. Non dimentichiamoci infine che l'invecchiamento cerebrale inizia da ventenni, ma che abbiamo a disposizione miliardi di neuroni ed esiste anche la neuroplasticità.
lug 132022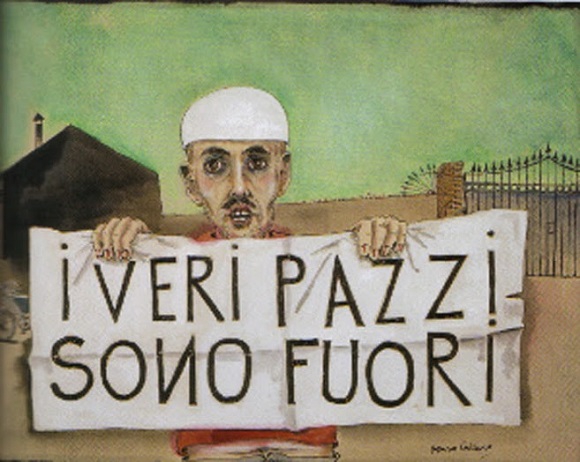
In molti credono nel mito dell’artista maledetto e nel binomio genio e sregolatezza. Di studi ne sono stati fatti parecchi negli ultimi duecento anni sul rapporto tra psicopatologia e creatività.
È dall’antichità che si suppone che gli artisti siano saturnini. Secoli fa si pensava che la creatività fosse un dono per pochi che avevano una dote innata. Erasmo da Rotterdam elogiò la follia (“la sola capace di rallegrare uomini e dei”), mentre lo stesso Cesare Lombroso associò il genio alla follia in quanto fu colpito dall’ingegno dei pazienti nei manicomi.
Alcuni si chiederanno cosa significhi esattamente il termine “follia”. Per i saggi è follia anche il possibile suicidio collettivo della specie a causa dell’inquinamento e della distruzione delle risorse naturali. Ma torniamo al rapporto tra disturbi psichici e creatività.
Secondo le ricerche più recenti in linea di massima sarebbero creative alcune persone depresse, alcuni ciclotimici, alcuni maniaco-depressivi, ma anche alcuni che soffrono di schizofrenia. Secondo la psichiatria la schizofrenia sarebbe contrassegnata oltre che da deliri e dalle allucinazioni anche da ritiro sociale e scarsa capacità di comunicazione. Ciò sembrerebbe in netto contrasto con la smodata voglia di esprimersi e dalla grande capacità comunicativa degli artisti. Gli schizofrenici in genere dovrebbero avere povertà ideativa e soffrire di anaffettività.
Eppure nel corso della storia ci sono stati anche casi di artisti schizofrenici. Secondo gli studiosi Van Gogh, Holderlin, Tasso, Gogol, Dino Campana, Strindberg, Artaud erano schizofrenici (tanto per citare i più celebri). Si veda a tale riguardo lo studio di Eugenio Borgna su Artaud.
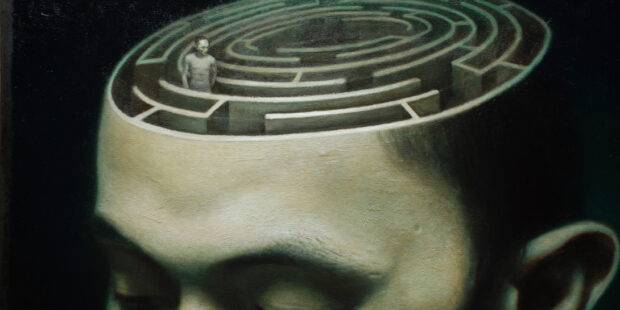
Non è assolutamente detto però che se uno è schizofrenico debba per forza diventare artista o che al contrario essere artista comporta il rischio di diventare schizofrenico. Le persone schizofreniche in Italia sono circa l’1% della popolazione e solo una esigua minoranza di essi è veramente creativa. Bisogna però considerare che non a tutti gli schizofrenici viene diagnosticata la schizofrenia. Esiste comunque un legame tra schizofrenia e creatività artistica. Lo possono testimoniare gli psicoterapeuti e gli psicologi che curano pazienti psicotici con l’arteterapia.
Nessuno però è riuscito a spiegare scientificamente questo legame tra creatività e follia, anche se di ipotesi ne sono state fatte molte. L’espressione artistica sarebbe una valvola di sfogo e la creazione produrrebbe uno stato euforico. Le persone cosiddette equilibrate e normali non avrebbero alcun bisogno di provare queste emozioni. Starebbero già bene senza bisogno di creare.
Per gli psicoanalisti la creatività sarebbe una risposta all’angoscia. Per gli psicologi cognitivi le persone creative starebbero buona parte del tempo in uno stato di rêverie prima di giungere all’illuminazione. La psicopatologia inoltre potrebbe causare originali associazioni di idee, che potrebbero rendere pregevole la creazione di uno psicotico. Come definire però la creatività?

Secondo il matematico Henri Poincarè: “Creatività è unire elementi esistenti con connessioni nuove, che siano utili”. A mio avviso questa è la definizione più sensata, ma molti hanno provato a stabilire in cosa consistesse il pensiero creativo. Gli psicologi ad esempio hanno studiato la creatività tramite vari approcci (psicometrico, psicodinamico, cognitivo, comportamentale) e sono giunti a conclusioni differenti.
Spesso per essere creativi gli intellettuali devono essere fuori dagli schemi e originali. Avere disturbi dell’umore, disturbi di personalità o turbe psichiche può talvolta aiutare a vedere il mondo in modo inusuale e ad accorgersi di cose che gli altri non vedono. Ritornando alla schizofrenia, bisogna ricordare che sono diversi i miti da sfatare e che non sempre una persona affetta da schizofrenia ha un deterioramento cognitivo e una disorganizzazione del pensiero tale da non poter comunicare con gli altri.
Ogni caso clinico è una storia a sé e deve essere valutato singolarmente. Ci sono diverse forme di schizofrenia: quella di tipo paranoide, quella di tipo disorganizzato, quella di tipo catatonico, etc etc. Ci sono anche diverse fasi. Ci possono essere storie di persone caratterizzate da miglioramenti e ricadute.
È sempre difficile generalizzare. La creatività è un mistero; la cosiddetta follia è un mistero e anche il legame tra queste due realtà è un enigma insolubile su cui molti studiosi hanno cercato di indagare senza approdare a niente di certo. Viene poi da chiedersi se il disturbo psichico tolga o aggiunga all’artista. I pareri sono discordanti.
C’è chi sostiene che un artista sia tale a causa del disturbo psichico e chi invece ritiene che lo sia malgrado questo. Una cosa è sicura: l’arte non fa impazzire ma nella stragrande maggioranza dei casi è terapeutica.
lug 082022
Riporto testualmente dal sito www.platon.it: “Paradosso di Goodman (o degli “smeraldi blerdi”): data una certa proprietà contraddistinta da una variazione dopo una certa data (l’essere blerde, ossia verde fino a una certa data, quindi blu), per quante osservazioni io faccia relative a oggetti che sembrano godere della stessa proprietà senza variazione (p.e. smeraldi verdi), non posso mai escludere che questi stessi oggetti godano della proprietà con variazione (siano smeraldi blerdi); in particolare, aumentando i casi confermativi, aumenterebbero sempre nello stesso modo sia la probabilità di registrare la proprietà senza variazione (smeraldi verdi), sia la probabilità di registrare la proprietà con variazione (smeraldi blerdi)”.
N. B: la stessa cosa si può dire del vlu.
E ora ecco le mie considerazioni:
Secondo il paradosso di Goodman dobbiamo considerare un nuovo predicato: il vlu. Mettiamo di applicare questo predicato a uno smeraldo. Uno smeraldo vlu è uno smeraldo, che fino al tempo t è verde e dopo il tempo t diviene blu. Mettiamo che alcuni individui credano che gli smeraldi dopo il 2030 diventeranno blu. Mettiamo che io non creda a questa loro affermazione. Allora io posso formulare due ipotesi opposte per ciò che accadrà dopo il 2030: “tutti gli smeraldi restano verdi” oppure “tutti gli smeraldi sono vlu”. Tutte e due le ipotesi sono possibili, quindi nessuna è meglio dell’altra. Da un certo punto di vista potremmo affermare che si equivalgano. Il problema che ne consegue è che se le due ipotesi si equivalgono anche il verde e il vlu si equivalgono. Quindi io potrei adoprare il vlu ogni volta che voglio. Il linguaggio finirebbe per diventare vlu. Voi vi chiederete: perché mai gli smeraldi, che sono tutti verdi e che sono sempre stati verdi, dovrebbero cambiare colore? Mettiamo per assurdo che dopo il 2030 cambi la struttura del mondo fisico, oppure cambi il nostro sistema nervoso (e quindi anche le nostre percezioni e i nostri stati mentali) oppure che lo smeraldo per qualsiasi motivo emetta un’altra lunghezza d’onda. Comunque sia…. noi - secondo il filosofo Goodman - possiamo fare due previsioni. Come mai noi consideriamo più probabile (più “proiettabile”) l’ipotesi che tutti gli smeraldi siano verdi piuttosto che l’ipotesi che tutti gli smeraldi siano vlu? Ora io farò delle semplici osservazioni da uomo comune e non da filosofo (perché naturalmente non sono filosofo). Io so che per gli smeraldi l’essere verde è una proprietà, che considero permanente di quell’oggetto. Se uno smeraldo cambia colore - potrei anche affermare - che non posso più considerarlo uno smeraldo, piuttosto un nuovo oggetto. Un nuovo oggetto, che avrà bisogno di un altro nome. In modo molto semplice: Goodman dà un nuovo nome al colore in base ai cambiamenti nel tempo, mentre si dovrebbe dare solo un nuovo nome all’oggetto. Poniamo il seguente principio: quando la proprietà (ritenuta prima permanente e inalterabile) di un oggetto viene modificata non bisogna etichettare in modo nuovo il predicato che descrive la proprietà di quell’oggetto in base ai possibili cambiamenti nel tempo, ma bisogna considerare che quell’oggetto sia un nuovo oggetto e necessiti di un nuovo nome. Il paradosso di Goodman, se seguissimo questo principio, esisterebbe ancora? Resterebbe comunque una domanda: perché dobbiamo utilizzare per forza questo principio? Ma veniamo di restare nella realtà e di non fare astrazioni campate per aria. L’acqua a 0 gradi oppure al di sotto diventa ghiaccio, mentre invece in condizioni normali (alla pressione di 1 atmosfera) vaporizza alla temperatura di 100 gradi. Sappiamo che ciò dipende dallo stato fisico della materia. Sappiamo quindi che lo stato fisico della materia (e quindi anche dell’acqua) può cambiare. Nella realtà io non utilizzo predicati come acqua-ghiaccio o come acqua-vapore per indicare l’acqua che è diventata ghiaccio o per indicare l’acqua che è diventata vapore. Non utilizzo aggettivi- definiamoli- “deciduali”. Altrimenti sarei costretto ogni volta per l’acqua ad utilizzare un aggettivo (predicato) come acqua-ghiaccio-vapore perché c’è la possibilità che l’acqua a certe condizioni possa diventare ghiaccio e ad altre condizioni possa diventare vapore. Noi invece sappiamo che lo stato fisico dell’acqua cambia, ma non utilizziamo un linguaggio “deciduale” (come le foglie. Mi riferisco all’esempio di Piattelli Palmarini) per definire lo stato fisico dell’acqua. Semplicemente cambiamo nome all’oggetto quando la proprietà di quell’oggetto non è permanente, costante. Facciamo un altro esempio. Consideriamo l’animale dal colore più mutevole (e diciamo più “deciduale”) del mondo: il camaleonte. Che cosa caratterizza il camaleonte? Potremmo dire: gli occhi grandi, la lingua che si può ritirare in qualsiasi momento, il fatto di cambiare colore in base all’ambiente. Queste sono le caratteristiche ritenute costanti di quest’animale. Per le nostre menti le proprietà permanenti di un oggetto o di un soggetto sono le proprietà, che caratterizzano quell’oggetto. Qualcuno potrebbe chiedere il perché. Non lo so. Io so solo che quelle proprietà ritenute costanti lo distinguono dagli altri oggetti. Ma il problema è che se io mi imbattessi in un animale, che ha tutte le caratteristiche fisiche di un camaleonte e non cambia più il colore in base al colore dell’ambiente, non potrei più considerarlo un camaleonte. Semplicemente: sarebbe un altro animale. Se la proprietà ritenuta permanente di un oggetto cambia allora cambia anche l’oggetto (o il soggetto) e perciò cambia anche la definizione di quell’oggetto. Se quell’oggetto è diventato un altro oggetto è chiaro che ha bisogno di un nuovo nome, di nuovi predicati, di una nuova definizione. Se facciamo in questo modo (e nella realtà facciamo in questo modo) il paradosso di Goodman diventa più semplice. Ci sono sempre due ipotesi: 1) quell’oggetto (lo smeraldo) subirà una trasformazione (oppure la realtà oppure il soggetto conoscente) e diventerà (oppure verrà considerato dal soggetto) un altro oggetto. 2) quell’oggetto (lo smeraldo) non subirà trasformazioni e resterà lo stesso. E’ un problema di semplice convenzionalismo linguistico? Quello che Goodman chiama “trinceramento” è soprattutto un fatto derivante dalle convenzioni linguistiche? Il problema che si pone è: perché non possiamo utilizzare predicati “deciduali” e un linguaggio “deciduale”? Perché il verde va sempre preferito al vlu? Se io ammetto il vlu, cioè ammetto un aggettivo “deciduale” allora ammetto che qualsiasi predicato possa essere “deciduale”. Permetto quindi che tutto il linguaggio possa essere “deciduale”. Ma un linguaggio “deciduale” non è una semplice foglia, che cade per terra. E’ l’intera conoscenza umana, che cade nel nulla. Alcuni sostengono che il paradosso di Goodman sia una riformulazione più elaborata del vecchio problema di Hume sull’induzione. Secondo Hume gli uomini facevano delle inferenze in virtù di “uso e abitudine”. Potremmo oggi parlare di innatismo e di intersoggettività. Ma è lo stesso. Detto in parole povere: data una mole di osservazioni io ho bisogno di individuare delle proprietà costanti dagli oggetti per poi successivamente classificarli e definirli. I problemi sembrerebbero quindi due: come io giungo all’inferenza e come passo dall’inferenza alla classificazione. In questo senso in filosofia dal “tacchino induttivista” di Russell oggi sono passati al “tacchino anti-induttivista” di Goodman. Ma non c’è solo questo. Il tacchino di Goodman è anche un tacchino anti-classificatorio. Io ragiono come l’uomo della strada, anzi sono l’uomo della strada. Allora mi chiedo molto semplicemente una cosa. Se io ammetto il vlu posso anche dare un nome a ogni singolo oggetto? Se io ammetto il vlu tutto è possibile nel linguaggio. Il linguaggio diventa eracliteo. Ogni elemento del linguaggio potrà variare in base al fattore tempo o in base a qualsiasi altro fattore. Alcuni studiosi hanno pensato che il paradosso di Goodman dipendesse esclusivamente dal tempo, ma a mio avviso non è così. Il fattore tempo è solo un pretesto. Comunque se accettassimo tutti universalmente il concetto di vlu non ci sarebbero più limiti. Finiremo quindi per dare un nome anche ad ogni singola sedia o ogni nostro stato mentale. Sorge spontanea una domanda: perché io ogni sedia la chiamo sedia e non scelgo un nome specifico per ogni singola sedia? Ora mi posso chiedere: perché classifico gli oggetti? Probabilmente ho bisogno di classificare gli oggetti per i limiti della memoria umana, per economia di tempo e di risorse cognitive, per non avere rappresentazioni mentali offuscate, per vivere la vita e non per passare tutta la vita a nominare oggetti. Se io ammettessi che qualsiasi proprietà di un oggetto ( o soggetto) possa essere definita in base ai cambiamenti passati, attuali futuri (o possibili) francamente passerei tutta la vita immobile nel letto soltanto a definire sempre tutti i miei umori e i miei stati mentali. Non ci può essere una corrispondenza totale tra linguaggio e realtà. Per motivi di tempo e di risparmio di energia abbiamo sempre bisogno di etichettare, catalogare, generalizzare. Ma perché ho parlato di tacchino anti-classificatorio di Goodman? Prendiamo ad esempio il noto paradosso del mentitore. Epimenide di Creta sostiene che “tutti i cretesi sono bugiardi”. Essendo cretese Epimenide è bugiardo e sta dicendo il falso. Oppure Epimenide sta dicendo il vero, ma essendo anch’egli cretese l’affermazione è falsa perché allora non tutti i cretesi sono bugiardi. Nel celebre paradosso del mentitore il soggetto contraddice se stesso o il predicato. Ma perché? Perché in fondo predica se stesso. Nel paradosso di Goodman non è il soggetto a “mentire” (diciamo così). E’ piuttosto il predicato a mentire. Ci sono infatti due alternative: 1) se una proprietà costante degli smeraldi è di essere verde non potranno mai essere blu. Quindi in questo caso è il concetto di vlu che si autocontraddice. 2) se lo smeraldo, che viene definito come tale in base alla proprietà costante dell’essere verde, diventa blu non è uno smeraldo. Quindi in questo caso il predicato sembra contraddire il soggetto della proposizione. Il predicato quindi annulla la proprietà interna del soggetto.
Fino ad oggi il colore dello smeraldo ha sempre denotato lo smeraldo e lo smeraldo è sempre stato definito anche in base al colore. Ma cosa posso fare se gli smeraldi diventano blu dopo il 2030? Posso ridefinire il soggetto della proposizione successivamente e dare un nuovo nome al nuovo tipo di smeraldo. La domanda allora è: posso considerare un nuovo tipo di smeraldo (che non è più verde) e considerarlo un altro oggetto e dargli un altro nome. Sì. Io posso. L’umanità può. Può incessantemente costruire logicamente e verbalmente in modo nuovo la realtà. Perché quindi devo preferire il “vlu” (che porta all’anarchia linguistica) quando posso costruire in modo logico e verbale nuovi oggetti mentali? E poi posso considerare sempre in modo probabilistico le proprietà ritenute costanti degli oggetti o dei soggetti. Se l’umanità accettasse (e quindi estendesse) il vlu a tutte le proprietà e a tutti gli oggetti non ci sarebbe più alcuna classe. Non ci sarebbero nemmeno più gli insiemi in matematica. Russell definiva gli stessi numeri delle “proprietà di classi”. Alcuni studiosi sostengono che ci sia una certa parentela tra il paradosso di Goodman e il paradosso del corvo di Hempel. Secondo quest’ultimo paradosso le cose non nere confermano il fatto che tutti i corvi siano neri. E’ esclusivamente un problema di induzione. In fin dei conti questo paradosso filosofico ci insegna a chiederci: perché facciamo inferenze soltanto sui corvi e non sulle cose che non sono corvi? Alcuni filosofi hanno ragionevolmente pensato che sia dovuto al fatto che l’insieme dei corvi è molto inferiore rispetto all’insieme dei non-corvi. Inoltre mi chiedo molto semplicemente a proposito di questo paradosso: perché le cose non nere devono per forza confermare il fatto che tutti i corvi sono neri? Quello che voglio dire è che alla fin fine non dovremmo chiederci solo perché facciamo inferenze nel dominio di quell’oggetto di indagine, ma anche perché ogni volta che facciamo un’inferenza non cambiamo oggetto di indagine. E’ una domanda scontata. Ma a mio avviso è una domanda scontata anche chiederci perché osserviamo solo corvi quando vogliamo confermare l’ipotesi “tutti i corvi sono neri”. Vlu in fin dei conti significa semplicemente “prima verde e dopo un periodo stabilito blu”. Potrei sostenere semplicemente che il paradosso di Goodman porta a una situazione indecidibile perché gli aggettivi in qualsiasi lingua umana non sono caratterizzati da un istante t (che determina il cambiamento di questo o quello oggetto). Si può però dire che un oggetto è mutevole. L’aggettivo “mutevole” indica genericamente che quell’oggetto può subire dei cambiamenti o delle trasformazioni nel tempo. Mutevole però indica una qualità dell’oggetto. Ci dice che genericamente quell’oggetto cambia sempre. Il vlu invece ci dice che quell’oggetto dopo un certo istante t da verde diventerà blu. Ci dà due informazioni precise. Nessuna lingua umana contempla un aggettivo, che sia predittivo ed esatto. Inoltre un unico aggettivo ci dà due informazioni: quell’oggetto fino ad un certo istante t sarà verde e poi diventerà blu. Pensiamo per un attimo a quanti concetti e a quante relazioni ci vogliono per definire il vlu. Ci vuole il concetto di cambiamento, il concetto di colore, la definizione di verde, la definizione di blu, il concetto di tempo, l’avverbio di tempo “prima”, l’avverbio di tempo “dopo”, la conoscenza dell’istante t, la relazione tra il colore verde e l’avverbio di tempo “prima”, la relazione tra il colore blu e l’avverbio di tempo “dopo”. L’aggettivo “mutevole” invece richiede solo due concetti: il cambiamento e la forma. Potremmo quindi ritenere che nell’aggettivo vlu ci sia un eccesso di senso, un surplus di informazioni. Gli aggettivi qualificativi di solito sono più vaghi. Almeno nella lingua italiana ci forniscono la qualità di un oggetto o di un soggetto. Niente altro. Se si vuole fare una frase di senso compiuto comprendendo anche il tempo - è banale dirlo - utilizziamo gli avverbi di tempo e non gli aggettivi. Il vlu è un concentrato di concetti. Nasce da un paradosso linguistico perché almeno nella lingua italiana è un aggettivo (il vlu), che comprende anche due avverbi di tempo e altre cose. Allora bisogna chiedersi perché utilizziamo gli avverbi di tempo e non il vlu? Facciamo così, parliamo così. Probabilmente per economizzare le nostre risorse cognitive. Probabilmente se dovessimo estendere il vlu a ogni qualità e a ogni colore e a ogni trasformazione la nostra memoria a breve termine andrebbe a fottersi. E’ così in italiano, ma è così anche in tutte le altre lingue. Non solo ma se io ammetto il vlu ammetto anche il ble. Infatti dopo che quell’istante t l’oggetto che prima era verde ora è blu, ma io devo anche presupporre che in futuro possa ridiventare verde e quindi devo ammettere anche il ble (il blu che dopo un istante t diventerà verde). Se io accetto il ble accetto anche il giasso (il giallo che prima era giallo e dopo un certo istante è diventato rosso). E così all’infinito. Ma per economia delle risorse cognitive umane nessuno si sogna di utilizzare aggettivi, che tengano conto di tutti i cambiamenti della realtà e di tutti gli istanti esatti in cui avvengono questi mutamenti. Il problema di Goodman è quindi solo di natura semantica? Assolutamente no. Se io accetto il vlu accetto non solo le proposizioni scaturite dal paradosso del mentitore (del tipo: “questa frase non è vera”), ma sono costretto ad accettare anche proposizioni come “questa proposizione è vera-falsa” oppure proposizioni come “questa proposizione è vera-falsa-priva di significato” oppure come “questa proposizione è bella-brutta”. Perché restino in piedi le classi e le classi delle classi bisogna estromettere dalle classi delle proposizioni quelle derivanti da concetti come quello di vlu. Alcuni studiosi potrebbero parlare di gerarchie linguistiche tra predicato e soggetto, altri di metalinguaggio. Russell sosteneva che paradossi come la sua antinomia e il paradosso del mentitore fossero determinati da quella che definiva una circolarità viziosa. Può darsi che anche il paradosso di Goodman dipenda da una circolarità viziosa. Non lo so con certezza. Per i filosofi medievali non esistevano questi paradossi e non esistevano quindi tutte le implicazioni annesse e connesse. Loro le consideravano senza significato. Comunque sia nel paradosso di Goodman è presente il fattore tempo (quell’istante t in cui avviene il mutamento della qualità dell’oggetto). Ma potremmo anche cambiare e considerare il fattore spazio: ad esempio un oggetto che in casa mia è verde e fuori dalla mia casa è blu. Anche in questo caso abbiamo il famigerato vlu. Anche in questo caso compaiono due ipotesi: il verde e il vlu. Ecco perché sostengo che il fattore tempo è solo un pretesto. Nell’induzione le osservazioni possono dipendere dal tempo, ma anche dallo spazio. Visto che possiamo ipotizzare e fare qualsiasi cosa nel mondo filosofico di Goodman allora possiamo pensare che le osservazioni (e l’induzione) possono dipendere da infiniti elementi. L’importante è che ci sia il cambiamento della proprietà dell’oggetto di indagine. Ci vuole questo per fare il paradosso di Goodman e per farne altre varianti. Il paradosso di Goodman si basa sull’ipotesi riguardo alla proprietà (ritenuta costante) di un oggetto. E non riguarda solo il fatto in sé (l’osservazione), ma riguarda anche come siamo fatti noi esseri umani (come percepiamo, interpretiamo e nominiamo il mondo là fuori). Il paradosso di Goodman ci dice che prima della formulazione di quell’ipotesi abbiamo osservato la realtà, abbiamo fatto delle inferenze, abbiamo individuato delle proprietà costanti di un oggetto, abbiamo fatto una classificazione successiva, abbiamo nominato e definito l’oggetto. Dopo aver fatto queste cose ora possiamo fare un’ipotesi. Dopo l’istante t se gli smeraldi saranno vlu noi faremo le nostre osservazioni, faremmo delle nuove inferenza (osserveremo mille smeraldi vlu e concluderemo che tutti gli smeraldi sono vlu), individueremo delle proprietà costanti di un oggetto, faremo una nuova classificazione (in cui per forza di cosa gli smeraldi saranno tali se sono blu). Comunque da che cosa è composto dal punto di vista epistemologico il paradosso di Goodman? Da due ipotesi. Da un lato abbiamo un’ipotesi (quella del verde), che è dovuta all’induzione e alla verificazione (e anche alla convenzione linguistica, alla credenza, alla probabilità, alla rappresentazione mentale, alla classificazione, al concetto di tipo). Dall’altro abbiamo l’ipotesi del vlu che a primo acchito sembrerebbe dipendere dalla falsificazione. Dal punto di vista epistemologico la falsificazione va preferita alla verificazione, perché sappiamo che esiste quella che viene chiamata un’asimmetria logica tra verificazione e falsificazione. Il problema però è che il vlu del paradosso di Goodman non rischia di falsificare solo il verde e il blu, ma anche le nostre invarianze linguistiche. Uno scienziato potrebbe formulare qualsiasi tipo di ipotesi, anche quelle più improbabili e addirittura quelle ritenute impossibili. Potrebbe ipotizzare che nel 2030 il verde diventerà blu, nel 2040 il blu diventerà rosso, nel 2050 il giallo diventerà viola, nel 2060 il bianco diventerà nero. Potrebbe anche ipotizzare che il verde tra due minuti diventerà blu e dopo due minuti diventerà grigio e dopo ancora due minuti diventerà rosso e dopo due minuti ancora sarà nero. La stessa cosa non vale solo per le ipotesi formulate in base al fattore tempo, ma in base ad altri fattori (ad esempio il fattore spazio). Per dirla in modo generico - se noi non accettiamo delle invarianze nell’induzione, delle invarianze nella categorizzazione e delle invarianze linguistiche - finiamo per essere sommersi da infiniti vlu e da infiniti ble (il blu che dopo un istante t diventerà verde. E se accettiamo il vlu dobbiamo accettare il suo complementare ble). Nella realtà noi cerchiamo di fare economia anche nel campo delle ipotesi. Consideriamo solo le ipotesi ritenute più probabili e non tutte quelle possibili (altrimenti ci sarebbe un proliferare di ipotesi). Ma riflettiamo sulla frase “tutti gli smeraldi sono verdi”. Dire che “uno smeraldo è verde” almeno in questo mondo fino a oggi è una tautologia in fin dei conti. Si può considerare come tale. Prima chiamo l’oggetto A (lo smeraldo) quell’oggetto che ha come proprietà B (l’essere verde) e poi dico che quell’oggetto A ha come proprietà B. Quando dico uno smeraldo è verde dico questo. Qual è il problema? Il problema è che l’ipotesi del vlu può falsificare quella tautologia. Dopo quell’istante t se l’ipotesi che si verificherà sarà quella del vlu allora potremmo dire che uno smeraldo non è più uno smeraldo. Ora io posso fare tre cose per risolvere questo problema: posso ridefinire tutti gli smeraldi in base al fatto che siano tutti blu, posso dare un nuovo nome agli smeraldi (e considerarli dei nuovi oggetti) oppure posso definire gli smeraldi in base ad altre proprietà (ritenute) costanti, non considerando più quindi il colore degli smeraldi. Posso quindi chiamarli ancora smeraldi e non nominare più il loro colore perché potrebbe cambiare da un momento all’altro. Posso chiamarli ancora smeraldi e dire che un tempo erano verdi e ora sono blu senza utilizzare il vlu. Sono possibili tutte le soluzioni. Sono le soluzioni più efficaci e più economiche. Perché dovrei utilizzare il vlu? Visto e considerato che sono a conoscenza che questi cambiamenti non avvengono che raramente (lo so dall’esperienza) posso anche cambiare il nome allo smeraldo e chiamarlo in altro modo. Posso fare in diversi modi senza utilizzare il vlu. Inoltre prima ho scritto che il vlu sembrerebbe falsificare il verde. Ma se analizziamo bene la questione dal punto di vista linguistico potrebbe essere così, ma non dal punto di vista metodologico. Dopo il 2030 gli smeraldi potrebbero diventare verdi o vlu. Io però dopo il 2030 ho bisogno dell’induzione (come prima del 2030) per constatare se gli smeraldi siano verdi o vlu. Posso trovare che molti smeraldi siano vlu, ma mi basta un solo smeraldo verde per constatare che nessuna delle due ipotesi è valida (smeraldi tutti verdi e smeraldi tutti vlu). Posso anche trovare che molti smeraldi siano verdi, ma mi basta un solo smeraldo vlu per constatare che nessuna delle due ipotesi è valida. Ho bisogno dell’induzione quindi anche dopo il 2030. Inoltre il principio di falsificazione di Popper può smentire tutte e due le ipotesi. Tutti gli smeraldi potrebbero essere vlu tranne uno che è rimasto verde oppure tranne uno che è diventato verde (tranne uno che è ble). Tutti gli smeraldi potrebbero restare verdi tranne uno che è sempre stato blu (e non ce ne siamo accorti) oppure tranne uno che è diventato blu e che prima era anch’esso verde (quindi vlu). Io non sarò mai certo che tutti gli smeraldi siano verdi o vlu dopo il 2030. Il vlu quindi dal punto di vista epistemologico non è migliore del verde. Visto e considerato che gli esseri umani hanno delle convinzioni radicate e hanno anche una certa resistenza al cambiamento perché adottare il vlu anche a livello linguistico e logico (se il vlu a livello metodologico non è migliore di come noi nominiamo i colori in questo mondo fino ad oggi?). Possiamo anche cambiare regole, ma le nuove regole non migliorano assolutamente niente.
Piattelli Palmarini ci ricorda che il filosofo Donald Davinson ha complicato ulteriormente le cose, immaginandosi degli smerazi. Gli smerazi vengono definiti come degli smeraldi che dopo un certo istante t diventeranno topazi. Piattelli Palmarini scrive di immaginarsi le implicazioni di affermazioni come “tutti gli smerazi sono vlu”. Il fatto qui si complica anche perché i topazi possono avere molte colorazioni. In questo caso può cambiare sia il soggetto che il predicato della proposizione. Ci sono molte ipotesi concorrenti dell’ipotesi “tutti gli smerazi sono vlu”. Tutte ugualmente valide dal punto di vista logico. C’è l’ipotesi “tutti gli smeraldi sono verdi”, “tutti gli smeraldi sono vlu”, etc etc. Ci sono anche le ipotesi che gli smerazi saranno di molte altre colorazioni, ma non vlu. La stessa frase “tutti gli smerazi sono vlu” a sua volta è composta dall’ipotesi (o informazione) “tutti gli smeraldi dopo l’anno 2030 diventeranno topazi” e “tutti i topazi dopo il 2030 diventeranno vlu”. Prima del 2030 potremmo considerare gli smeraldi dei semplici smeraldi oppure degli smerazi. “Tutti gli smerazi sono blu” significa che queste gemme prima erano smeraldi verdi e dopo il 2030 sono diventati topazi blu. Potremmo anche affermare che “tutti gli “smerazianti sono vlugi”. Per smerazianti posso intendere gli smeraldi che dopo il 2030 diventano topazi e dopo il 2040 diventano diamanti. Per vlugi posso intendere che il verde dopo il 2030 diventerà blu e dopo il 2040 diventerà grigio. E potrei continuare all’infinito. Ma la memoria a breve termine degli individui ha dei limiti ben noti. Apparentemente queste sono frasi semplici, ma rischiano di racchiudere troppe informazioni e/o troppe ipotesi per la nostra mente. Perché quindi non utilizzare il vlu invece del verde? Semplicemente per i limiti della mente umana. Continuando a complicare le cose potrei anche formare un unico predicato che contiene tutte le trasformazioni da un oggetto all’altro e potrei anche formare un aggettivo che contiene tutte i cambiamenti possibili e impossibili di una proprietà del predicato. La frase sarebbe assolutamente semplice dal punto di vista sintattico, ma il soggetto sarebbe costituito da migliaia di mezze parole e così anche il predicato. La domanda che si pone è: perché non utilizziamo una frase con un soggetto lunghissimo e un predicato lunghissimo per fare delle ipotesi o per trasmetterci delle informazioni? Perché invece quando facciamo ipotesi utilizziamo un linguaggio fatto di parole corte? La nostra mente procede in questo modo, perché la nostra memoria ha dei limiti. Ho fatto una ricerca singolare. Ho guardato quale era la parola più lunga del vocabolario italiano. E’ una parola impronunciabile e ha 29 lettere. Per me non è pronunciabile e penso anche per molti altri. Più dell’80% delle parole italiane sono formate da un minimo di tre lettere a un massimo di venti lettere. Qualcuno potrebbe farmi l’esempio dell’inui (la lingua parlata dagli eschimesi). Ma anche in questa lingua ci sono parole molto lunghe rispetto all’italiano, ma non sono composte da centinaia di sillabe. E invece se accettivamo il vlu non esisterebbero più limiti di lunghezza delle parole. Immaginiamoci ora parole formate da migliaia di lettere composte da sillabe di altre parole. Diventerebbe insostenibile la situazione. Non solo perché dovremmo ricordarci parole lunghissime, ma perché dovremmo utilizzare due vocabolari. In fondo noi (esseri umani del 2021) per definire il vlu abbiamo bisogno sia della parola verde che della parole blu. Avremmo quindi bisogno di una lingua madre con cui creare successivamente il vlu, il ble, etc etc. La domanda che mi chiedo è: il vlu presuppone sempre l’esistenza di una lingua preesistente? Se così fosse perché io devo utilizzare una seconda lingua che mi dà più problemi quando posso utilizzare una lingua da me ritenuta più semplice o più adeguata? Il vlu, lo smerazio, lo smeranziante sono parole composte, che mi ricordano di tutti i cambiamenti e di tutte le trasformazioni del soggetto e del predicato. Noi esseri umani abbiamo bisogno di queste parole composte se vogliamo utilizzare il vlu, lo smerazio, lo smeraziante. Un uomo che parla il vluese non esiste. Nella sua vita ha trovato oggetti che erano verdi e lui gli ha dato un nome a quel colore. Nella sua vita ha trovato oggetti che erano blu e gli ha dato un nome. Può forse definire un colore in base ai cambiamenti che questo colore ha nel tempo? Dare un nome a un colore significa porre un’invarianza linguistica. Nessuno può esimersi da questo. Il vlu quindi presuppone due invarianze linguistiche (il blu e il verde). Il colore vlu può esistere solo se esiste un linguaggio con il blu e il verde. Qualcuno potrebbe sostenere che gli uomini che parlano la lingua del vlu non hanno bisogno di parole composte. Ma non è così. Chiamiamo X la proprietà di un oggetto, che subisce dei cambiamenti. Chiamiamo Y un soggetto, che subisce delle trasformazioni. Potrei formulare l’ipotesi “tutti gli X sono Y” e tutto ciò sembrerebbe molto semplice a livello linguistico. Ma dovrei ricordarmi mentalmente tutti i cambiamenti di X e tutti i cambiamenti di Y. La memoria sarebbe sempre sovraccarica e ingolfata. In ogni caso non si va da nessuna parte con parole composte da migliaia di mezze parole e non si va da nessuna parte con una proposizione sintatticamente semplice, che contiene implicitamente centinaia di informazioni o ipotesi. In ogni caso dobbiamo ricordarci che la nostra memoria a breve termine ha dei limiti. Perché dovremmo preferire il verde al vlu? Anche per il semplice motivo che dovremmo cercare di stabilire sempre una corrispondenza tra percezione e linguaggio. Alcuni esperimenti in psicologia hanno dimostrato che alcune tinte di colori sono innominabili per qualsiasi essere umano. Quindi una corrispondenza totale non può esserci. Ma una certa corrispondenza c’è. Per la psicologia la percezione è il modo con cui organizziamo le sensazioni, gli stimoli esterni del mondo. Quando noi cerchiamo di individuare a livello percettivo la forma degli oggetti per esempio lo facciamo anche tramite delle inferenze inconsce. La percezione è data da questa interazione continua tra organismo ed ambiente. La nostra mente alcune volte convalida, altre corregge. Secondo la psicologia l’uomo ha bisogno delle costanze percettive, anche perché sono necessarie per adattarsi in qualsiasi ambiente. Faccio un esempio banale. Una tribù di indigeni sa che nei campi ci sono due tipi di serpenti perfettamente uguali nella forma, ma che hanno colore diverso. I serpenti verdi sono velenosissimi. I serpenti marroni sono innocui. Salvarsi o non salvarsi la vita dipende quindi dalla percezione del colore ed è scontato dirlo (ma è bene dirlo) dalla costanza percettiva del colore. Il verde è una invarianza linguistica, determinata da una costanza percettiva. Possiamo dire che il verde è in corrispondenza con il nostro modo di percepire i colori. Per adattarsi all’ambiente l’essere umano ha bisogno di costanze percettive e di conseguenza anche di costanze linguistiche. Che senso avrebbe avere il linguaggio sfasato rispetto alla percezione? Mettiamo che un indigeno ipotizzi che un serpente velenosissimo possa essere vlu invece che verde. A questo punto ammette qualsiasi possibilità. Ammette anche che possa essere vlugio (cioè essere verde fino all’istante X, quindi diventare blu e dopo l’istante Y diventare grigio). E così via. Diventerebbe una sorta di serpente-camaleonte nella sua testa e ciò genererebbe un eccesso di ansia e di apprensione, che lo condurrebbe all’immobilismo. Mettiamo che gli indigeni per sopravvivere debbano andare a caccia e ci rendiamo conto che questo modo di concepire la realtà sarebbe inconcepibile!!! Goodman sostenne che non si poteva risolvere il suo paradosso utilizzando la nozione di adattamento. Da un certo punto di vista è vero: quali sono le cose che mi permettono di creare queste costanze percettive se non la pratica e l’esperienza? Però bisogna anche ammettere che queste costanze percettive a loro volta ci permettono di adattarci al mondo a differenza del modo di percepire-nominare la realtà in vlu o in vlugio. Goodman ci insegna che esistono l’io e il mondo e che non sapremo mai dove finisca l’io ed inizi il mondo e dove finisca il mondo e inizi l’io. Il paradosso di Goodman ci insegna che c’è una base di partenza di noi esseri umani e che noi agiamo partendo sempre da lì. Non possiamo fare altrimenti. Ma la nozione di adattamento ci aiuta a capire come le nostre basi di partenza si accordano o meno al mondo. Se al posto degli smeraldi utilizziamo i serpenti velenosi ci accorgiamo che non solo noi preferiamo il verde piuttosto che il vlu in base alle nostre basi di partenza innate, ma anche in base alla nostra interazione continua con il mondo. Ma non c’è solo questo. Se io ammetto il vlu - serpenti o non serpenti, smeraldi o non smerald i- ammetto anche qualsiasi tipo di ipotesi possibile e impossibile. Noi scegliamo quindi le ipotesi più probabili? Se le intendiamo come ipotesi più probabili dal punto di vista soggettivo, allora senza ombra di dubbio. Sappiamo però che se accettiamo il vlu rischiamo di passare tutta la vita a formulare ipotesi. Una selezione delle ipotesi quindi ci vuole. Buona o cattiva che sia. Se tutta l’umanità fosse in preda all’immobilismo si estinguerebbe la razza umana. Che cosa ci permette di creare costanze percettive? Hanno ragione gli innatisti o gli empiristi? In questo caso non ci interessa. Molto probabilmente individuare delle costanze percettive dipende prima di tutto dalla nostra struttura cerebrale. Ma la cosa più importante è che le costanze percettive abbiano una funzione adattiva dell’essere umano all’ambiente. Di solito esiste una “discreta” corrispondenza tra percezione e linguaggio. Non deve esserci una corrispondenza totale tra percezione e linguaggio, ma non deve esserci nemmeno nessuna corrispondenza. Perché? Perché siamo fatti così. Tra percezione e linguaggio c’è una corrispondenza non totale e non può essere altrimenti per noi esseri umani. Allora perché adoprare il vlu quando non risponderebbe a queste esigenze primarie di sopravvivenza? Perché dovremmo avere un linguaggio sfasato rispetto alla percezione? Il paradosso di Goodman sembrerebbe farci capire che fare in un modo o fare in un altro è uguale. Ma se cerchiamo di estendere il concetto di vlu a ogni possibile ipotesi (trasformazione o cambiamento) ci accorgiamo che la mente umana preferisce il verde al vlu a causa dei limiti della propria memoria a breve termine. Per noi esseri umani il verde e il vlu possono essere ipotesi ugualmente valide dal punto di vista logico, ma non possiamo considerarle ugualmente valide da un punto di vista linguistico. Abbiamo i nostri limiti. Questo naturalmente non vuol dire che l’evoluzione della specie umana non continui e non ci siano in futuro altri uomini che preferiranno il vlu. Questo naturalmente non vuol dire che nell’universo non ci siano extraterrestri più evoluti rispetto a noi, che utilizzino il linguaggio del vlu. Con queste mie osservazioni non penso assolutamente di aver risolto il paradosso di Goodman. Sono abbastanza fesso, ma non fino a questo punto. Con queste mie osservazioni ho voluto solo precisare alcune cose. Per esempio alcuni formulano il paradosso di Goodman prendendo come esempio una tribù di indigeni, che parla il vluese. A mio avviso nessun essere umano fino ad oggi ha parlato e può parlare il vluese a causa di certi limiti mentali di noi esseri umani. Dovrebbero piuttosto parlare di esseri superiori alieni, che parlano il vluese. E ora vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale. L’epistemologia in Inghilterra e in America viene intesa come lo studio della conoscenza umana, mentre in Italia viene considerata come metodologia della ricerca scientifica. Il paradosso di Goodman ci dimostra che per una seria analisi della metodologia della ricerca scientifica gli scienziati e i filosofi della scienza devono occuparsi seriamente anche dell’analisi del linguaggio. E’ questo che il paradosso di Goodman ci invita a fare. Su questo paradosso, che riguarda la scienza e anche il linguaggio, sono stati versati fiumi di inchiostro. Nessuno lo ha risolto e non è detto che qualcuno in futuro possa risolverlo (e sono passati decine di anni). Con questo suo paradosso Goodman sferrò un attacco decisivo al neopositivismo logico del circolo di Vienna. La metodologia scientifica sembrava basarsi fino ad allora sul principio di causalità, sull’induzione, sul principio di verificazione. A distruggere il determinismo e il causalismo filosofico (secondo cui ogni cosa era allo stesso tempo causa ed effetto di qualche altra cosa) ci pensò Heisenberg. Quello che ci interessa sapere a riguardo è che con il suo principio di indeterminazione dimostrò che non si poteva stabilire contemporaneamente la posizione e la quantità di moto di una particella. Ma non c’era solo questo. Le scoperte di Heisenberg avevano anche altre implicazioni. Per esempio si poteva dedurre che un osservatore (uno strumento scientifico oppure uno studioso di scienze umane) interagiva con l’oggetto di indagine e quindi in un certo qual modo interferiva. Dopo il principio di indeterminazione di Heisenberg crollò la certezza di stabilire con esattezza delle relazioni lineari di dipendenza tra due eventi. I filosofi invece che criticarono in modo serrato l’induzione e il principio di verificazione furono soprattutto Popper e Goodman. Quest’ultimo molto probabilmente ideò questo celebre paradosso per attaccare l’induzione ed invece finì per mettere in crisi l’intera epistemologia. Il paradosso di Goodman è una sorta di violazione del principio di non contraddizione della proposizione. Se io ritengo che possa esistere una cosa che allo stesso tempo è e non è allora violo il principio di non contraddizione. Goodman scatena un putiferio con un solo aggettivo: il vlu. Il vlu è ciò che è verde e dopo un certo periodo di tempo potrebbe diventare blu. Ecco allora che gli smeraldi fino ad allora considerati da noi tutti verdi finiscono per essere e non essere. Il verde è una qualità costante dello smeraldo. Ma se il verde diventa vlu gli smeraldi per il linguaggio umano sono e non sono allo stesso tempo, almeno fino a quando non ci decidiamo di cambiare nome agli smeraldi oppure fino a quando non decidiamo di definirli in base ad altre qualità. Visto e considerato che trattare questo paradosso è molto complesso fino ad ora ho cercato di essere più chiaro possibile. Potremmo essere più filosofici e affermare che il vlu è un elemento metalinguistico della proposizione “tutti gli smeraldi sono vlu”. E se ci pensiamo questo potrebbe anche essere un modo per approcciare il problema. “Tutti gli smeraldi sono vlu” significa che “tutti gli smeraldi sono verdi fino al 2030, ma dopo il 2030 saranno tutti verdi”. E poi avete notato una cosa? Il verbo. Quando utilizziamo il vlu condensiamo due ipotesi e mettiamo il verbo “sono”. In realtà gli smeraldi sono blu e dopo il 2030 saranno verdi se è vera questa ipotesi. In realtà gli smeraldi vlu sono e saranno allo stesso tempo. Il vlu implica che gli smeraldi “sono e saranno”. Potrei quindi sostenere che in ogni lingua umana esiste almeno un passato, un presente e un futuro. Noi esseri umani abbiamo bisogno in ambito linguistico di distinguere tra passato, presente e futuro. Siamo fatti così. Se io ammetto il vlu ammetto anche la confusione temporale. Noi esseri umani non possiamo permettercelo. Potremmo anche pensare che quel vlu non sia che metalinguaggio condensato.
E ora una riflessione di carattere più generale. Kuhn aveva parlato già di “sfondo fornito dai paradigmi” quando descriveva la “scienza normale”, che cercava di risolvere i rompicapi. Popper aveva controbattuto sostenendo che si doveva disfarsi del “mito dello sfondo” e che lo sfondo poteva venire superato di volta in volta. Goodman con il suo celebre paradosso è riuscito a mettere in crisi non solo lo sfondo determinato dai paradigmi. E’ riuscito a mettere in crisi anche lo sfondo fornito dal linguaggio comune (qualsiasi tipo di linguaggio), dagli schemi mentali umani, dalle credenze e dalle costanze umane: lo sfondo fornito dal nostro modo di esperire e concepire la realtà. Molto probabilmente ci vorrebbe un essere di un altro pianeta per superare questo paradosso: un altro essere con un altro sfondo che riesca a vincere questo nichilismo degli sfondi. Il paradosso di Goodman non mette in crisi una “nicchia” culturale o scientifica. Mette in crisi tutto lo sfondo della conoscenza umana. Ci fa capire che gli esseri umani non possono uscire dai limiti e dalle possibilità del loro linguaggio. Forse l’unico tentativo per arrestare provvisoriamente questo paradosso è attaccarsi al caro vecchio nominalismo. Prendere per buono il fatto che possiamo individuare delle proprietà degli oggetti e ritenerle costanti. Qualcuno potrebbe chiedermi: come fanno gli esseri umani a rilevare queste proprietà? Oppure potrebbe chiedermi: ma per una tribù di indigeni il vlu non potrebbe essere considerato una proprietà costante di un oggetto? Allora io risponderei: non mi importa come gli esseri umani rilevano le proprietà e se una proprietà è più o meno semplice da rilevare di un’altra. E aggiungerei: mi importa il fatto che gli uomini individuino delle proprietà, che ritengono costanti. A questo punto sorge una domanda: su quali basi gli uomini ritengono costanti delle proprietà? E’ questo che in fondo ci domanda il paradosso di Goodman. Molto probabilmente lo fanno tramite l’induzione. Ma per tentare di arrestare provvisoriamente il paradosso di Goodman mi può bastare anche dimostrare che tutti gli esseri umani hanno bisogno dell’induzione, delle costanze linguistiche, di classificare oggetti in base a delle proprietà ritenute costanti. A mio avviso nessun uomo può parlare il vluese per tutta la vita e instaurare una corrispondenza tra linguaggio e realtà parlando il vluese. Non può farlo perché il vlu non definisce la proprietà (ritenuta) costante di un oggetto. Almeno per gli uomini di quest’epoca. Tra migliaia di anni non lo so. E ora concludo…..perché quindi non dobbiamo accettare il vlu? Perché sarebbe il nichilismo del linguaggio (è quello che più mi interessa) almeno per noi esseri umani del 2021. Ma è possibile combattere il nichilismo del linguaggio soltanto tramite il linguaggio? Molto probabilmente è impossibile. Goodman che era uno dei più grandi filosofi del ‘900 creò questo paradosso, ma è morto senza risolverlo. Fino ad oggi nessuno lo ha risolto.
lug 042022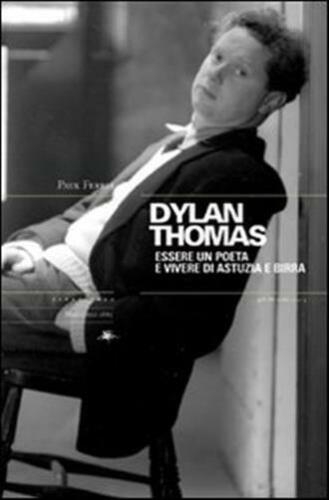
Quest’opera è una biografia del grande poeta Dylan Thomas, che nacque nel 1914 nel Galles e morì in America nel 1953. L’ultimo capitolo del libro sembra far chiarezza in modo definitivo sulle cause della morte del poeta gallese. L’ipotesi più accreditata è che non fu il delirium tremens scaturito dai 18 whisky ingurgitati a causarne il decesso, ma un’eccessiva dose di morfina somministrata dal medico. Il biografo cerca innanzitutto di distinguere gli episodi realmente accaduti da tutta una serie di leggende, aneddoti e dicerie riguardo all’eccentrico Dylan Thomas. D’altronde accade spesso nel caso di grandi poeti, che hanno fama postuma e imperitura. Se poi aggiungiamo che Thomas non è solo ricordato per le sue poesie immortali, ma anche per il fatto che il cantautore Robert Zimmerman ha utilizzato il nome d’arte Bob Dylan per rendergli omaggio, si capisce perché le leggende siano fiorite ad iosa. Nel libro non viene presa in esame la poetica di Thomas. Nessun cenno alle liriche visionarie, agli schemi metrici, alle analogie che gli procurarono la gloria. Nessuna analisi accurata sulla poesia che cercava di “penetrare la chiara nudità della luce”. Piuttosto possiamo leggere alcuni inediti, tra cui le sue prime incerte liriche. Da questi scritti si può arguire che Thomas fu un poeta molto precoce. Inizialmente i pareri della critica letteraria riguardo alle sue poesie furono discordanti. Vengono anche riportate le testimonianze degli amici e i brani più significativi delle lettere scritte alla moglie. Da questa biografia scopriamo quindi alcuni lati della personalità del poeta. In fondo la sua poesia traeva linfa proprio dalla sua personalità. Un amico del poeta dichiarò che Thomas non faceva altro che costruire e riassemblare la sua personalità incessantemente. Infatti Dylan Thomas dichiarò: “Dentro di me albergano una bestia, un angelo e un pazzo, la mia indagine riguarda le loro opere, il mio problema è soggiogarli vittorioso, scaraventarli a terra e risollevarli, la mia fatica è la loro espressione”.

Dylan Thomas morì a soli 39 anni. Ebbe una vita breve, ma intensa. Visse spesso di espedienti. Fu un clown per gli amici e un assiduo frequentatore di pub e di bordelli. Quando era in comitiva amava sempre essere al centro dell’attenzione. Fu un accanito fumatore e probabilmente soffrì di asma. Per alcuni fu solo un compagno di sbronze, uno che beveva come una spugna. Certamente amava la “compagna bottiglia”, ma il biografo non riesce a stabilire esattamente, dopo aver raccolto molte testimonianze in proposito, se fosse un forte bevitore o un vero alcolizzato. Fu un clown per molti amici. Essendo spesso squattrinato approfittò spesso di loro, chiedendo ospitalità e dormendo spesso sui loro divani. Fu un pessimo studente, nonostante suo padre fosse un insegnante della scuola in cui studiava. Fu cronista locale, ma venne licenziato. Per un periodo visse a Londra, frequentando pseudoartisti e pseudorivoluzionari. Fu sregolato e a tratti si ha la netta impressione che fosse indifferente a tutto (anche alla guerra), tranne che alla propria arte. Si sposò con Caitlin: una ragazza disinibita, piacente, infedele, amante del ballo, inquieta, litigiosa, spesso ubriaca. Alcune incomprensioni nacquero anche perché lei proveniva da una famiglia aristocratica e si disinteressava totalmente di ciò che dicevano vicini e conoscenti, mentre invece il grande poeta gallese - essendo di estrazione borghese - cercava di non dare adito ai pettegolezzi, pur vivendo anche lui di eccessi. Sua moglie odiava i piccoli paesi perché a suo dire nelle piccole comunità vigeva una mentalità ristretta e retrograda, mentre Thomas - pur essendo cosciente di ciò - riteneva che in un borgo poteva fare vita più sana e essere più concentrato per scrivere. Caitlin inoltre era un’aspirante artista e non voleva accontentarsi di essere solo e semplicemente la moglie del poeta. Un’estate andarono in vacanza all’isola d’Elba, ospitati dall’intellettuale Luigi Berti. Passarono anche qualche giorno nei pressi di Firenze, ma da ciò che Thomas scrisse nelle lettere si deduce che non si trovò affatto a suo agio. Molti intellettuali americani e italiani volevano incontrarlo e ciò lo infastidiva. Si guadagnò da vivere per alcuni anni scrivendo le sceneggiature di documentari per il cinema. Per un periodo lavorò anche alla BBC. Infine si recò in America in quanto il direttore del Poetry Center dell’associazione giovani ebrei di New York era disposto a pagarlo perché tenesse conferenze e readings. Questa opera è quindi una biografia rigorosa, accurata e per niente romanzata di uno dei più grandi poeti inglesi e del secolo scorso.
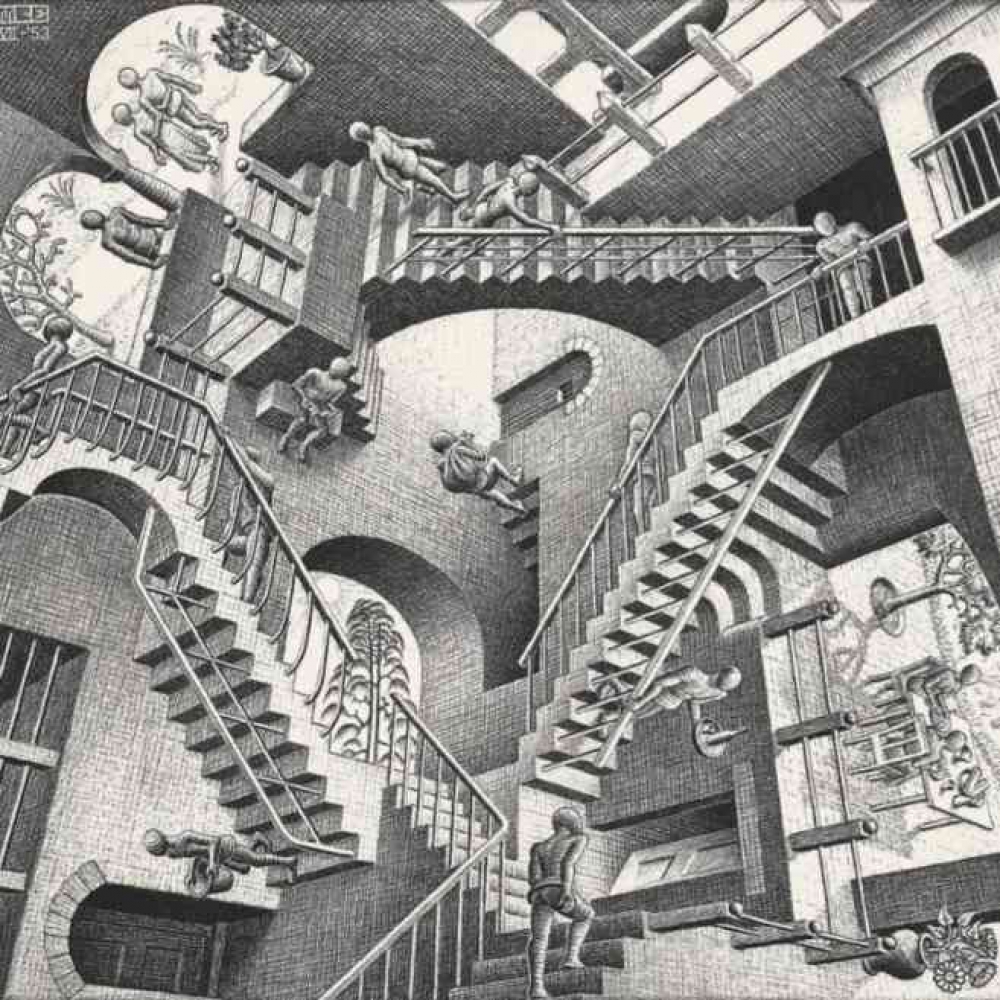




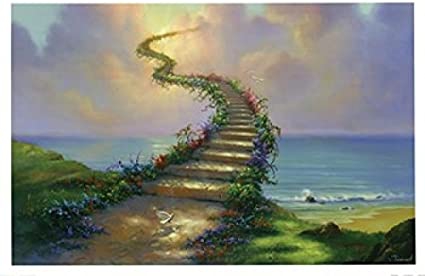
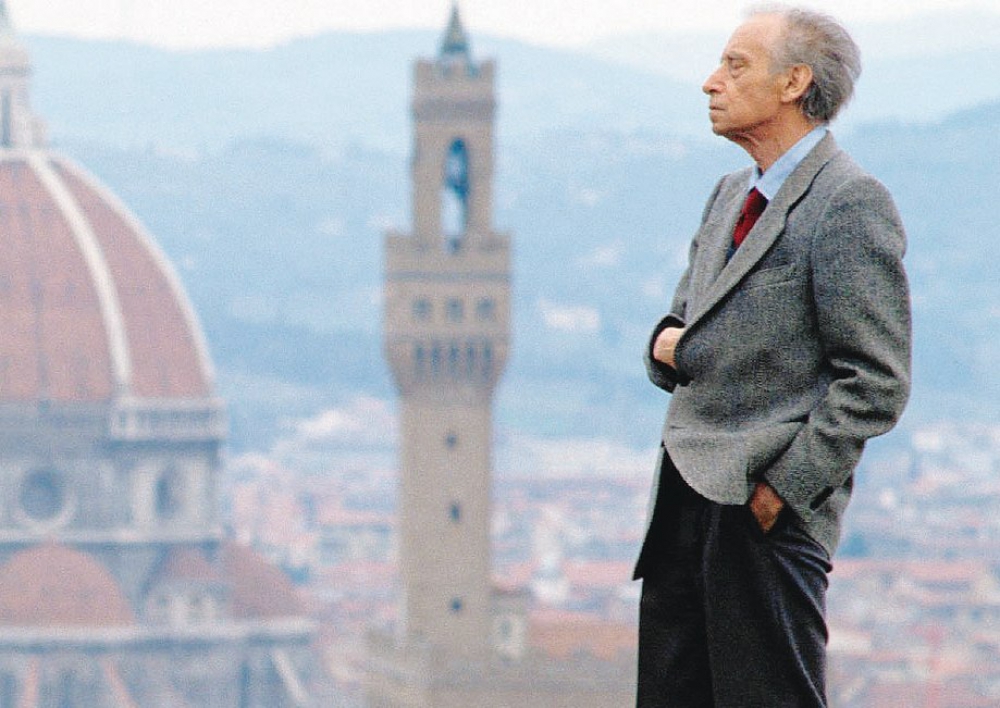


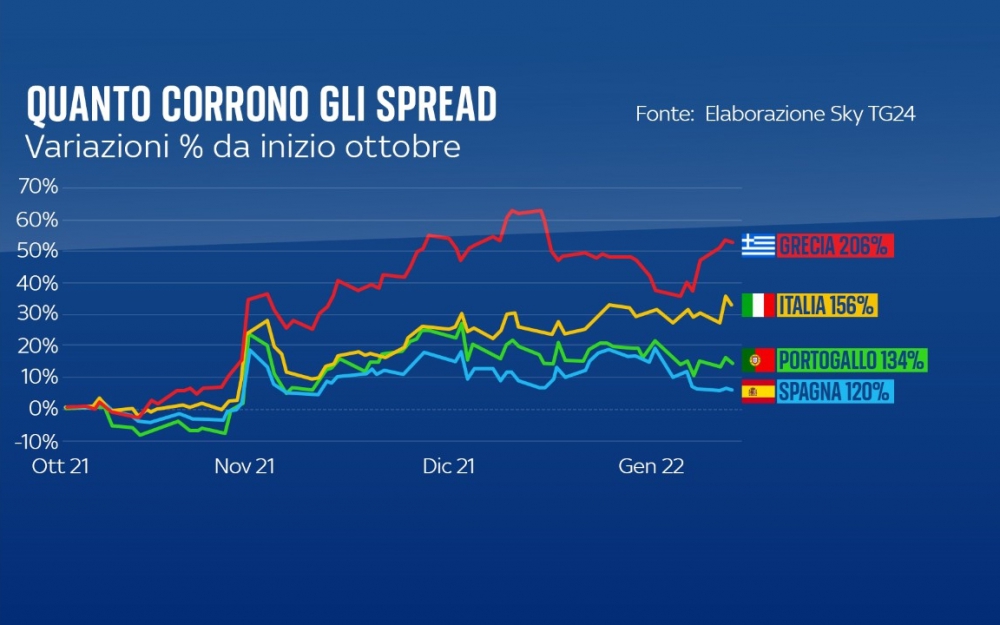




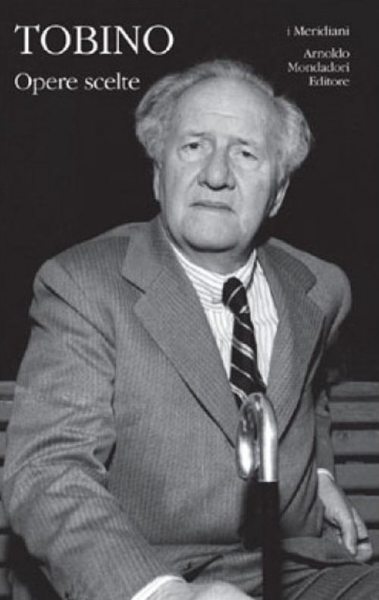
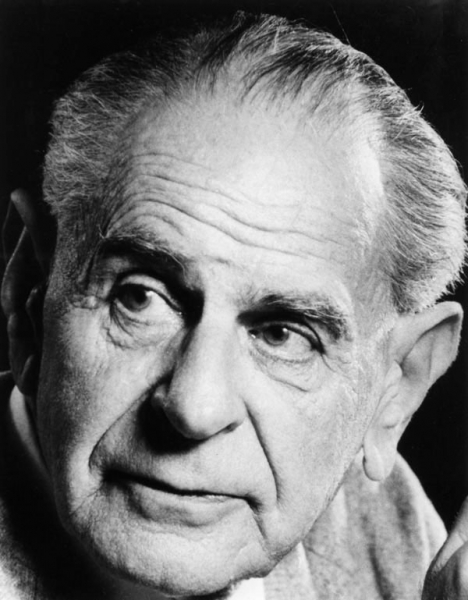
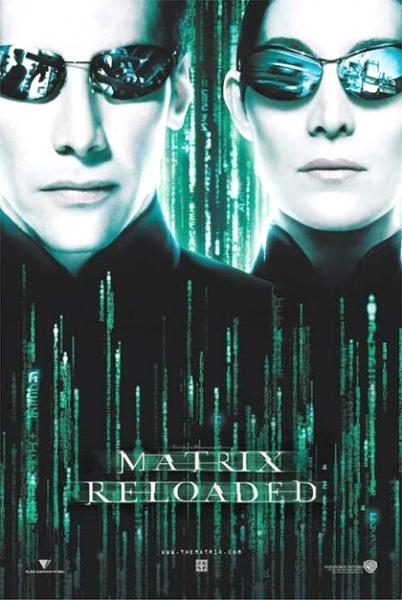
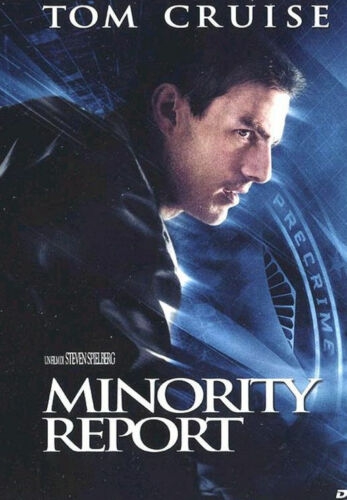




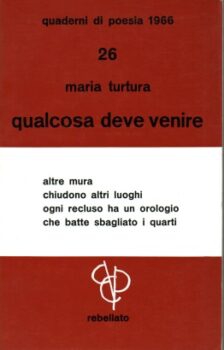




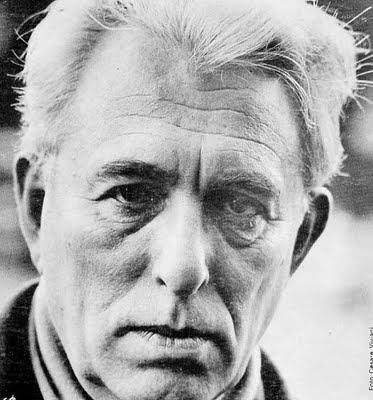
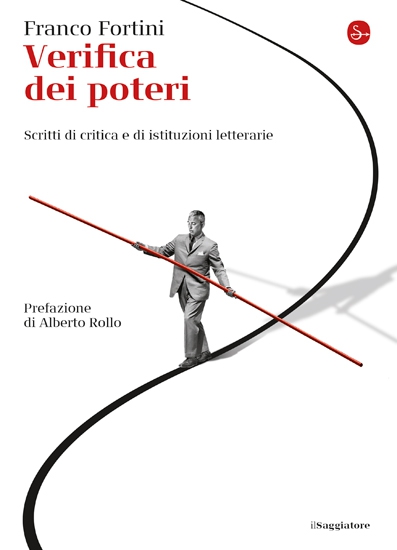
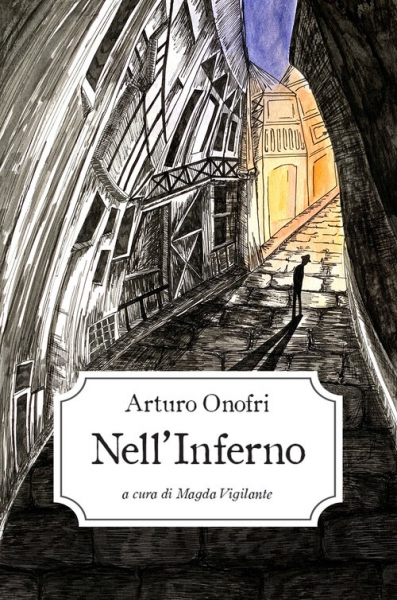

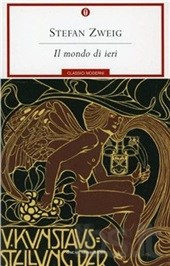
altmann-zweigandrothinostendin1936(cropped)1_0_o.jpg)