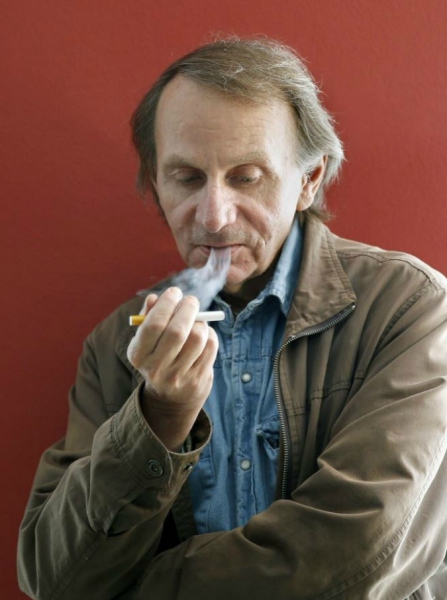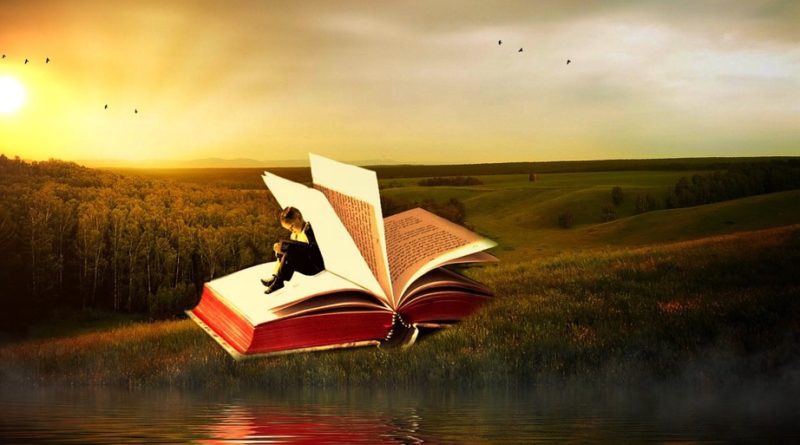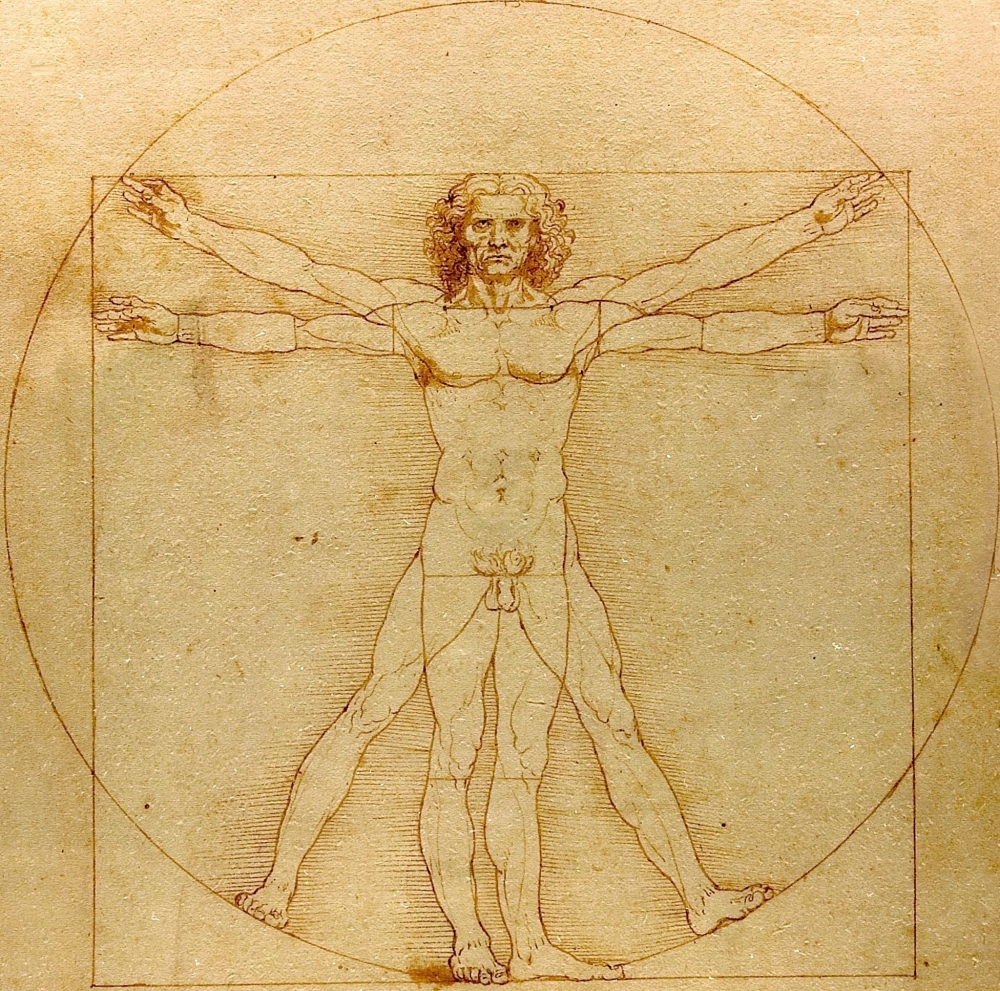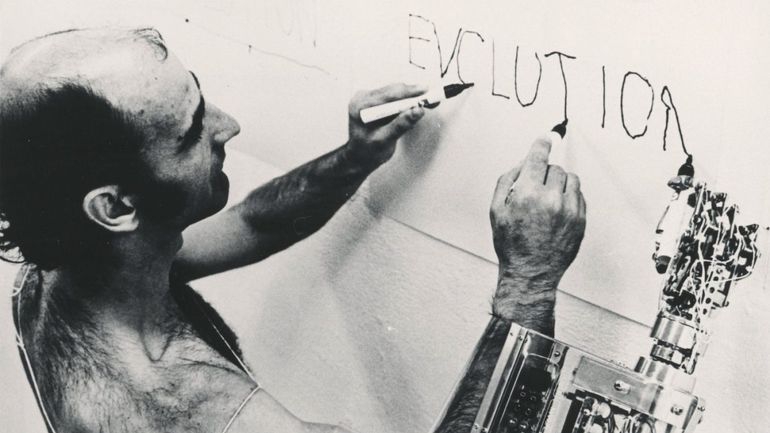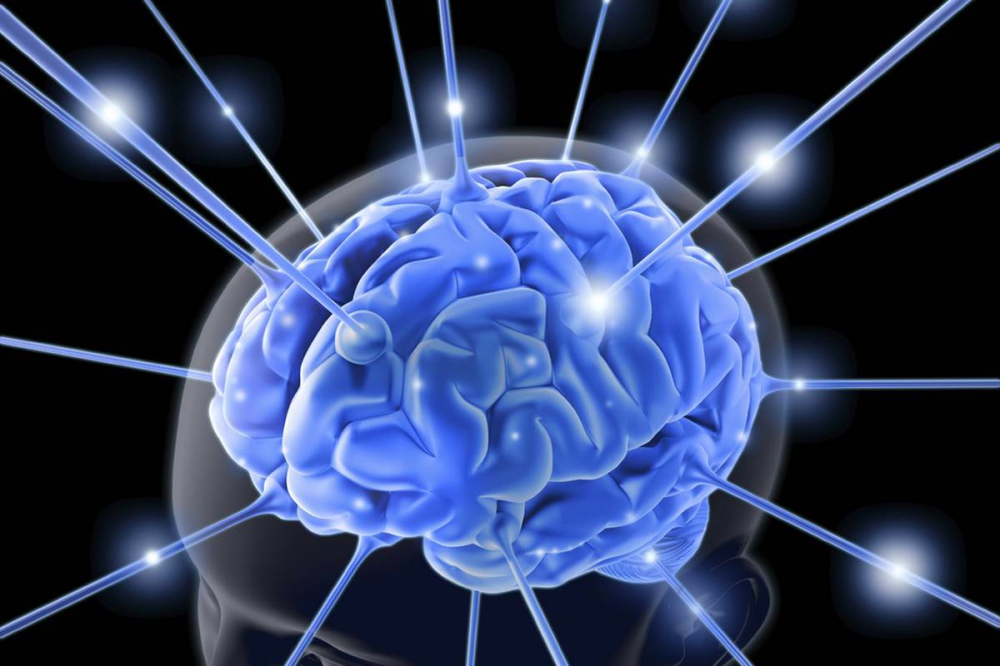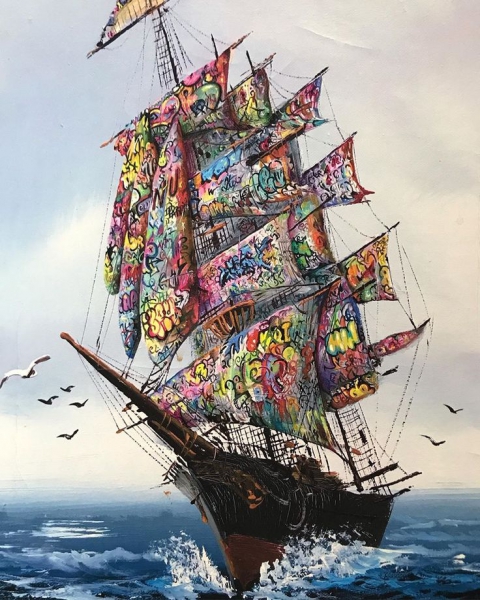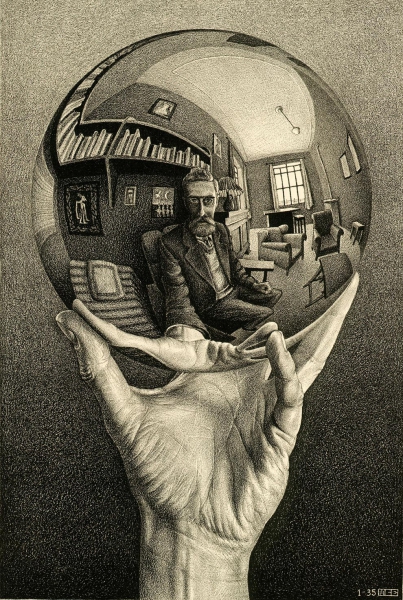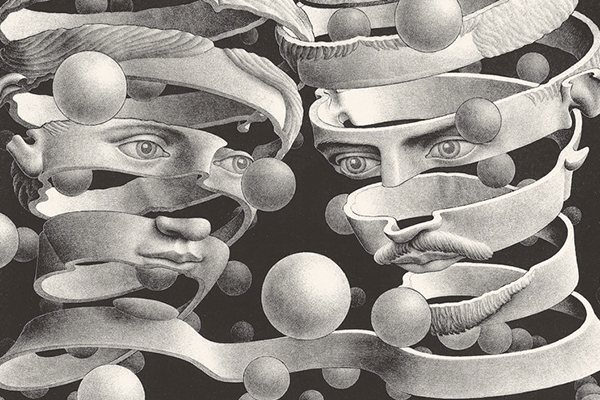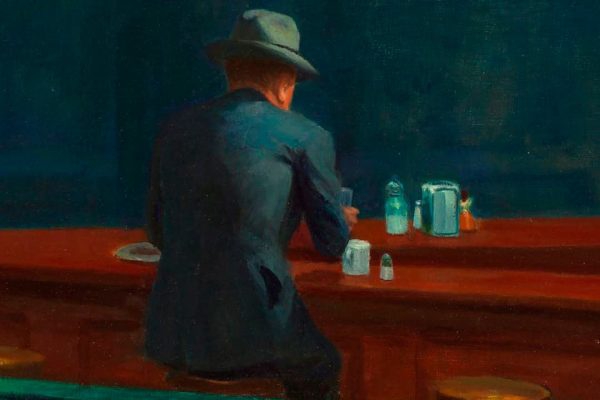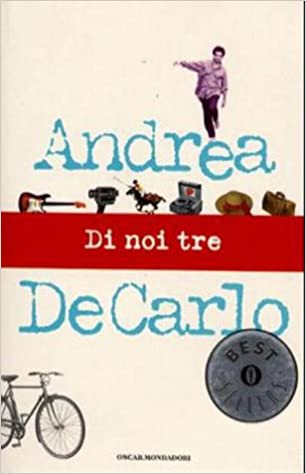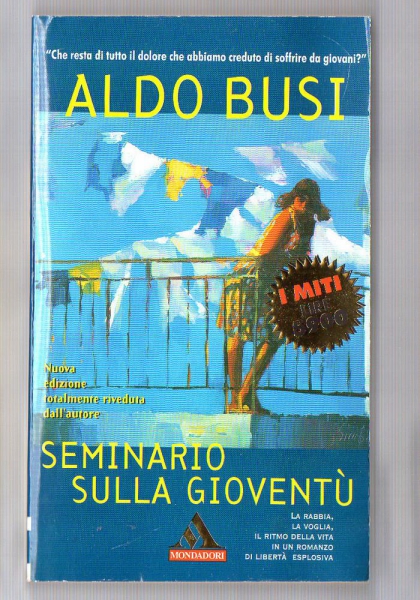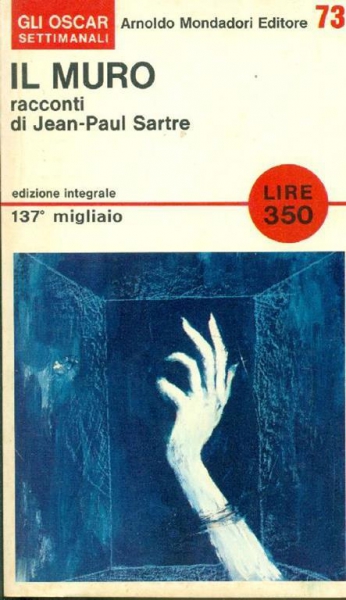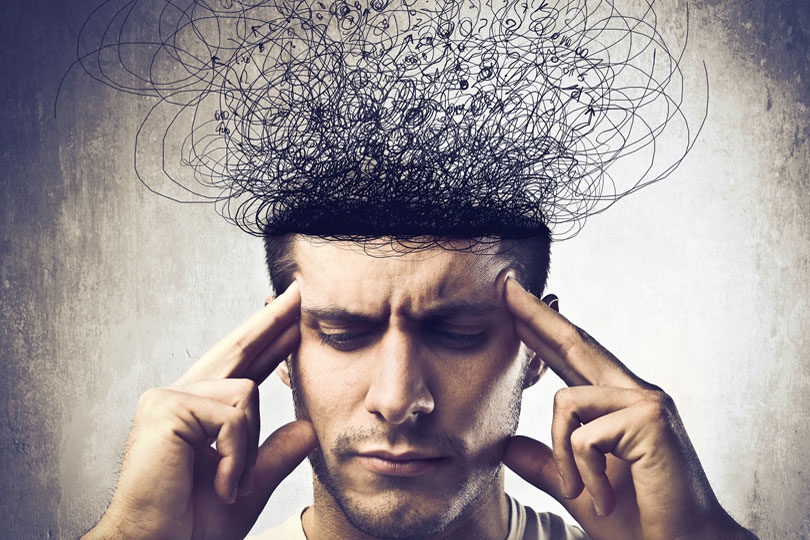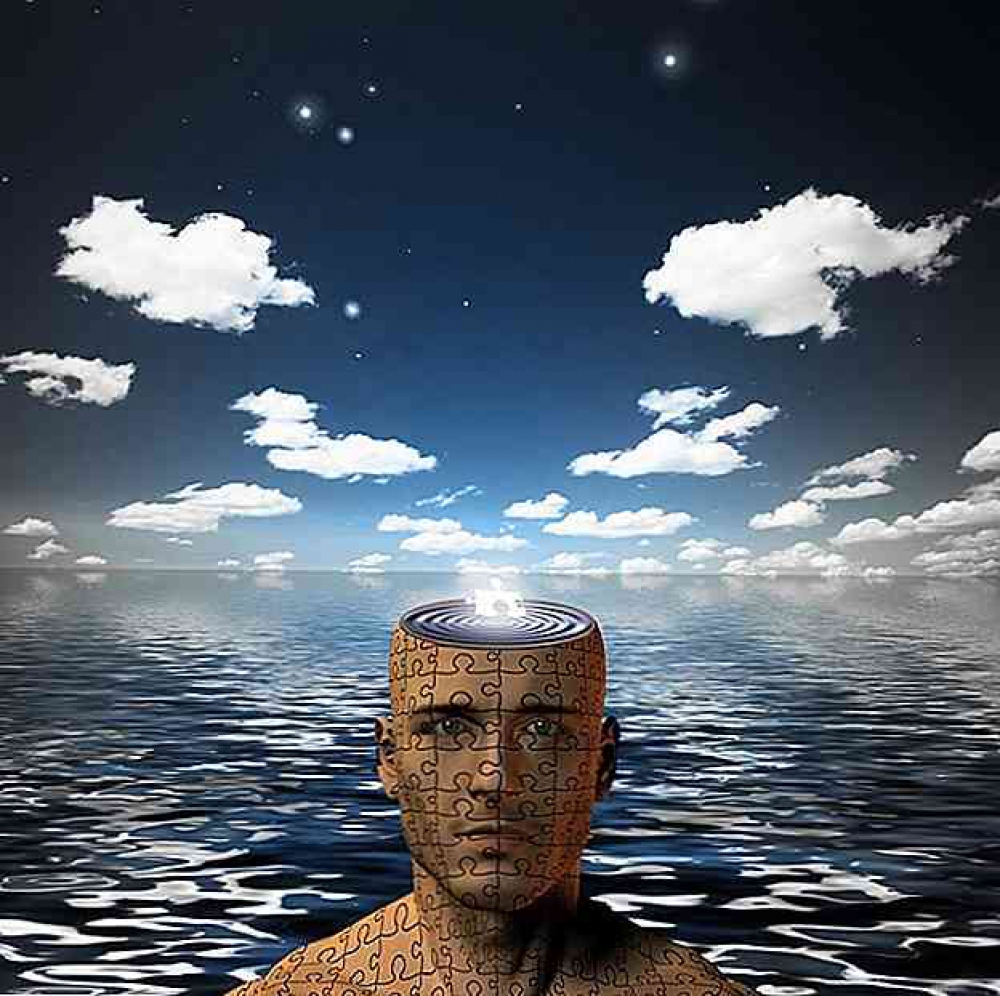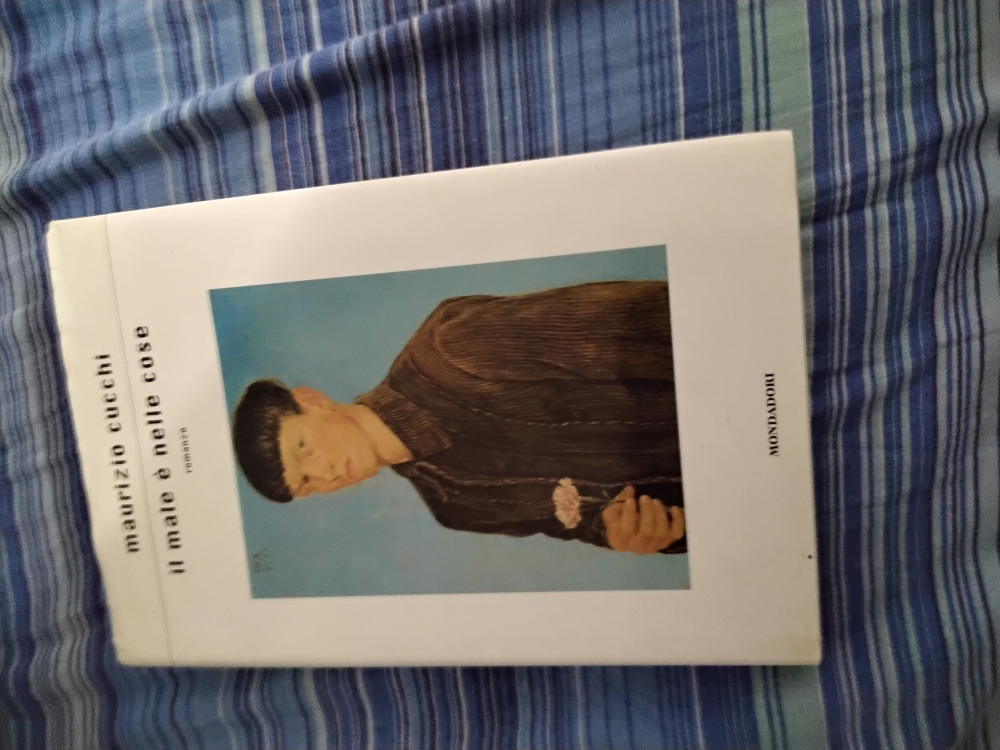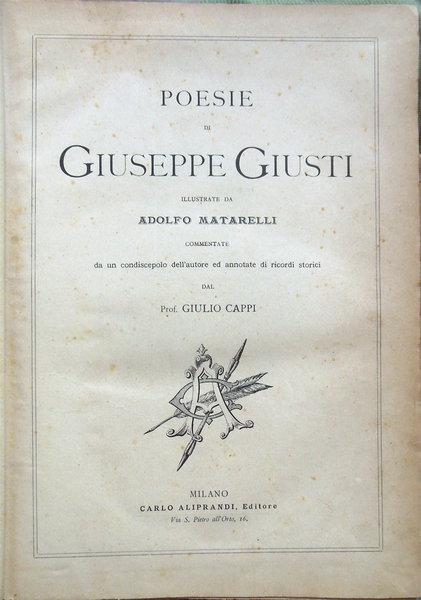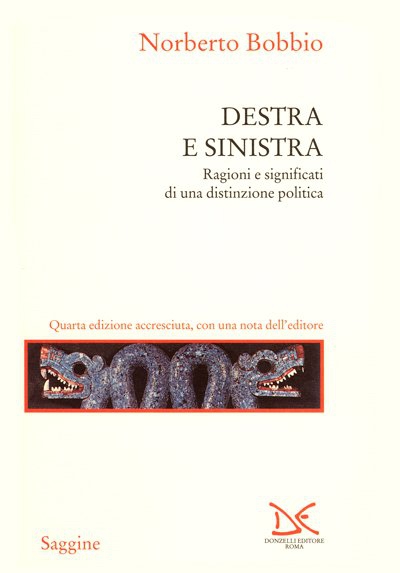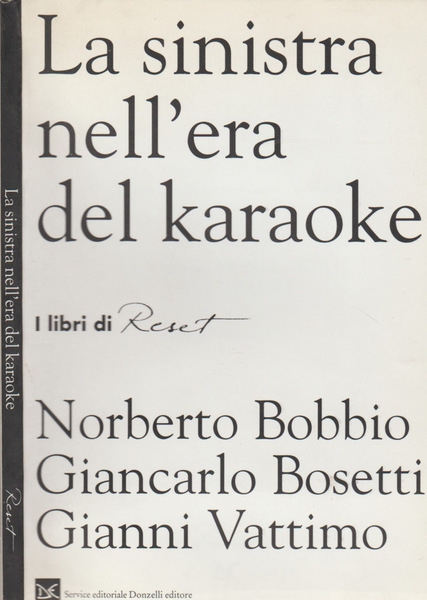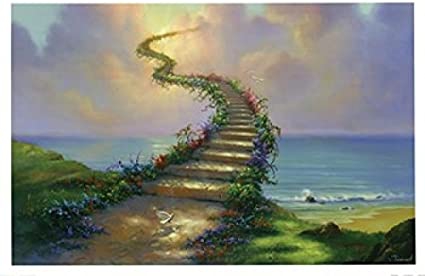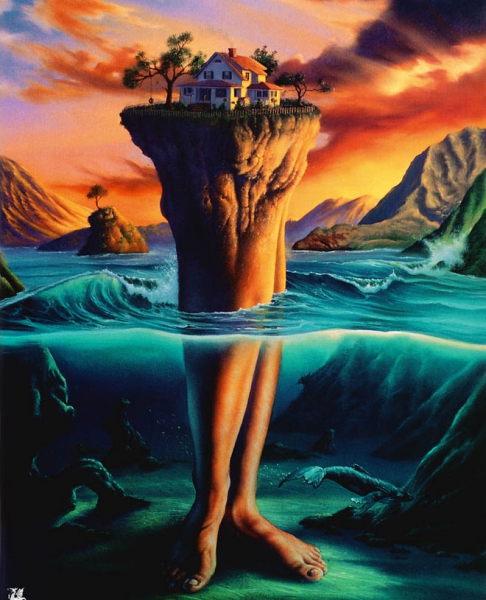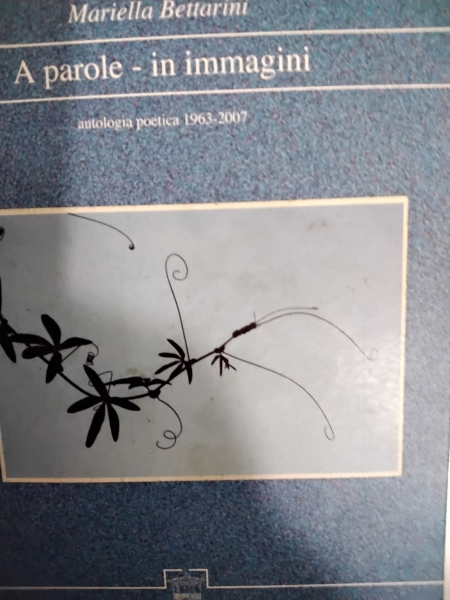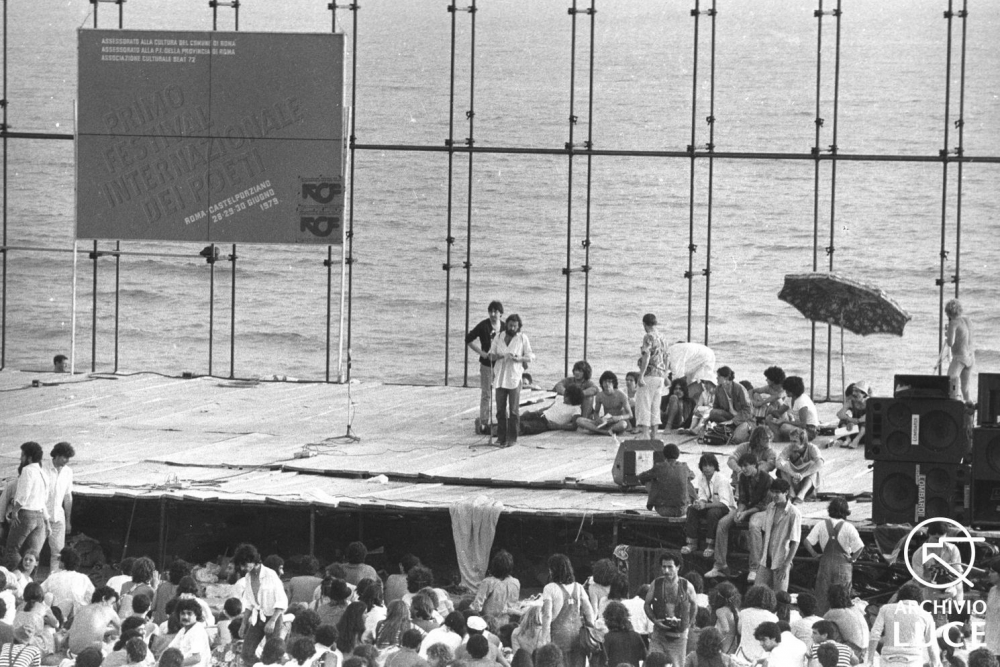giu 302022

La letteratura è minacciata dalla comunicazione di massa, al punto che Montale nel suo discorso per il Nobel nel 1975 si domanda se in una società di massa possa sopravvivere la poesia e conclude così: "Si potrebbero moltiplicare le domande con l’unico risultato che non solo la poesia, ma tutto il mondo dell’espressione artistica o sedicente tale è entrato in una crisi che è strettamente legata alla condizione umana, al nostro esistere di esseri umani, alla nostra certezza o illusione di crederci esseri privilegiati, i soli che si credono padroni della loro sorte e depositari di un destino che nessun’altra creatura vivente può vantare. Inutile dunque chiedersi quale sarà il destino delle arti. E’ come chiedersi se l’uomo di domani, di un domani magari lontanissimo, potrà risolvere le tragiche contraddizioni in cui si dibatte fin dal primo giorno della Creazione (e se di un tale giorno, che può essere un’epoca sterminata, possa ancora parlarsi)".
La letteratura è amplificata, potenziata, ma in parte deformata e resa un poco asettica dal web. Siamo sicuri che la critica non diventerà giornalismo? Il significato non prevarrà sul suono, il segno sul simbolo, l'algoritmo sul mito?
La letteratura italiana è inoltre diventata poca cosa, relegata ai margini con il dominio dell'inglese. Siamo una provincia dell'impero anglofono. Non siamo neanche più una riserva. La lingua italiana arricchita o divorata dagli inglesismi? Avrà ancora modo di esistere la letteratura italiana?
La poesia che relazione può avere con la tradizione (a chi deve rifarsi uno scrittore? Con chi deve essere uno scrittore stilisticamente e letterariamente? Oppure deve pensare: "toglietemi la storia, sennò da dove ricomincio?" come negli anni '70 scrisse Milo De Angelis)? Bisogna guardare "Conversazioni su Tiresia", monologo di Andrea Camilleri e poi magari decidere, anche se per Eliot la tradizione e il talento individuale dovrebbero sempre interagire.
Ha più senso scrivere? Cosa può comunicare oggi uno scrittore? Essere per esempio irregolari e di nicchia può servire a qualcuno? Probabilmente né agli altri né a sé stessi. Comunicare la propria incomunicabilità spesso significa parlare da soli contro un muro e sentire l'eco delle proprie parole. Niente altro che questo. E se uno invece vuole arrivare alle masse finisce di solito per non fare letteratura. In ogni caso spesso non vengono salvaguardati né lo scrittore né la letteratura.

"Duchamp diceva: se un oggetto a tre
dimensioni proietta un'ombra a due,
dovremmo immaginare quell'ignoto
oggetto a quattro dimensioni di cui noi
siamo l'ombra. Da parte mia, mi affascina la
ricerca dell'oggetto a una dimensione che
non getta ombra".
Octavio Paz da "Corrente alterna"
Forse l'oggetto a quattro dimensioni di cui teorizzava Duchamp è ciò che ci trascende, ovvero Dio. Meglio rasentare terra col nostro volo, direbbe Bob Dylan. Quindi è del tutto legittima la ricerca di Paz dell'oggetto a una dimensione che non getta ombra. Ma noi esseri umani percepiamo il mondo in modo tridimensionale grazie alla superficie bidimensionale della nostra retina. La quarta dimensione ci sfugge, ma anche una sola dimensione ci sfugge. Una sola dimensione è al di sotto della nostra soglia di coscienza. Noi non possiamo percepirla come gli ultrasuoni, che invece sentono i cani. Noi non abbiamo neanche gli occhi mirifici della mosca. Certe cose sono precluse alla nostra percezione. Lo scrittore deve perciò fare riferimento a un'altra dimensione inaccessibile? Non è chiedere troppo? Forse è troppo. È un dato di fatto. Dobbiamo accettarlo. Non possiamo farci niente, a meno che l'oggetto a una dimensione che non getta ombra non debba intendersi come l'inconscio (non totalmente attingibile) o il nostro Sé (sfuggente). La vera letteratura potenzialmente si dovrebbe confrontare con tutto ciò? E se scrivere significasse gettare un ponte sull'assurdo?
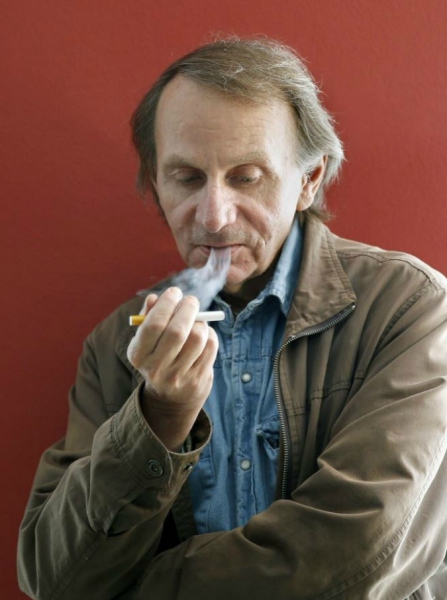
Houellebecq scrive che l'uomo contemporaneo legge perché "ha bisogno di altre vite, diverse dalla sua, semplicemente perché la sua non gli basta". Leggere significa quindi avere un arricchimento esperienziale. Di solito ci arricchiamo con le parole, i pensieri, la fantasia degli scrittori morti, difficilmente degli autori contemporanei. Ma come affrontare il mondo? Con la crudezza anche se con la penetrazione psicologica di Houellebecq, che talvolta finisce nella provocazione fuori luogo e nelle forzature estremistiche? Oppure con il rigore morale di Dante, che addirittura si erge a giudice delle azioni altrui, ma anche con la sua grazia e la sua leggiadria, come per esempio in queste terzine del primo canto del Purgatorio, in cui descrive come si lascia alle spalle l'inferno. In queste terzine è Virgilio che pulisce il viso di Dante con la rugiada:
Quando noi fummo là ‘ve la rugiada
pugna col sole, per essere in parte
dove, ad orezza, poco si dirada, 123
ambo le mani in su l’erbetta sparte
soavemente ‘l mio maestro pose:
ond’io, che fui accorto di sua arte, 126
porsi ver’ lui le guance lagrimose:
ivi mi fece tutto discoverto
quel color che l’inferno mi nascose.

La prima cosa che il potere vuole è interferire su quelli che Lewin chiamava “campi di forza”. Anche questo è un modo per imbrigliare le carte, per confonderci interiormente. È sempre più difficile trovare il modo, lo spazio e per molti il tempo di concentrarsi, di riflettere. Anche molte persone che svolgono professioni intellettuali non ci riescono e delegano perciò a intellettuali riconosciuti il compito arduo di pensare. Però a molti cittadini oltre alla possibilità di riflettere sul mondo manca la possibilità di riflettere, di meditare sulla propria psiche, sulla propria vita; per questo chiedono aiuto a un/a analista. In poesia spesso è il testo che ci fa da analista. Oppure paziente e analista coesistono in noi stessi all’interno della scrittura, della valutazione, della censura, della revisione. In poesia uno può dar libero sfogo al suo materiale spurio psichico, così come può controllare l’inconscio. Ma l’inconscio non si può rimuovere totalmente: qualcosa sfugge sempre. Esprimere il proprio inconscio oltre che una rispettabile scelta artistica è anche un atto di libertà interiore, per alcuni addirittura una necessità interiore.
Un’altra cosa che il potere vuole fare è imporre un immaginario e un inconscio collettivo che sovrasti totalmente sull’inconscio individuale. Ho già espresso a più riprese questo concetto: l’inconscio collettivo attuale non ha più archetipi decenti perché mass media, moda, cinema, televisione non sono più mitopietici come un tempo lo era la letteratura. Oggi gli archetipi propinati sono tutti negativi. È anche questo un modo per renderci senza principi, per farci mancare punti fermi e terreno sotto i piedi. Ma non c’è solo questo. Andiamo oltre.
“Se la funzione alfa non agisce sulle percezioni, ad esempio emozioni dolorose, allora l’esperienza viene espulsa, mediante un’attività pilotata dall’angoscia. Una paziente diceva: “non mi sono dovuta alzare per andare in bagno, nel bel mezzo della notte, perché ho fatto un sogno”. Intuitivamente riconosceva che il sogno trattiene qualcosa in modo che non si debba evacuare precipitosamente. Bion chiama questi elementi che non possono essere trattenuti nella mente elementi beta. […] Sono non-digeriti e danno la sensazione di essere cose-in-sé. Come corpi estranei all’interno della mente. Sono solo adatti ad essere evacuati perché non li si può pensare. Sono persecutori: pezzi di scarto dei quali la mente vuole sbarazzarsi; secondo il principio di piacere quel che provoca disagio viene espulso.” (Symington J e N. (1996), Il pensiero clinico di Bion, Raffaello Cortina, Milano, 1998. [p. 68]). Il potere tramite mass media, moda, pornografia non vuole che metabolizziamo gli oggetti del nostro desiderio. Non vuole che li comprendiamo, che li interiorizzamo globalmente, che li rielaboriamo criticamente e consapevolmente. Per Kernberg in questo modo non siamo più in grado come un tempo di “integrare le parti buone con quelle cattive”. Il potere vuole da noi la scarica, l’acting out senza naturalmente che mai avvenga l’abreazione. Così facendo il potere cerca di ridurre la funzione alfa e di aumentare gli elementi beta. La funzione alfa digerisce tutto ciò che è psichicamente negativo. Bion usa proprio la metafora della digestione. Il desiderio non è che una delle tante cose umane su cui agisce la funzione alfa. La poesia è funzione alfa allo stato puro. Ecco perché la poesia dà noia al potere e i mass media rivolgono un’attenzione insufficiente nei confronti della poesia. La poesia è conoscenza e comunicazione dal nostro profondo al profondo altrui ed è per questo che dà noia al potere, che ci vorrebbe conformisti, frivoli, superficiali, consumistici.
A ogni modo lo scrittore non può autoesaltarsi. Dovrebbe essere contro il potere. Dovrebbe denunciare il disastro ecologico, le ingiustizie economiche. Dovrebbe fare denunce sociali e/o esprimere disagio esistenziale. Ci si potrebbe accontentare quando non tratta delle grandi assurdità della vita e del mondo se riesce a mostrare quelle piccole, come un turista, che da dieci anni non va in ferie e quando va in vacanza è costretto a stare tutto il tempo in albergo a causa del maltempo, oppure come una donna che porta con sé il suo bambino, gli mette anche il casco, e poi attraversa con il rosso.
Ma non scordiamoci che l'uomo sarà sempre un "animale simbolico" come lo definì Cassirer e inoltre anche Goethe nel Faust scrisse: "Tutto ciò che passa è solo un simbolo; l'inattingibile, qui si fa evento; l'indescrivibile, qui ha compimento; l'Eterno Femminile ci fa salire".

La scrittura, anche quella di infimo livello (come la mia) è memoria o suo tentativo goffo, maldestro. Quando scrivo mi ricordo, cerco di ricordarmi. Ma cosa? Per quel che mi riguarda è ricordarmi all’improvviso di pomeriggi afosi ed estivi in una stanza d’albergo in una località imprecisata del lago di Garda oppure di una delle tante sere sulla soglia dell’ingresso a guardare la vita della piazza in attesa di chiudere la cassa e il negozio. È ricordarmi all’improvviso di tutto il tempo perso a rigirarsi nel letto, rimuginando in un mix quasi letale fantasie erotiche e frustrazioni sessuali. Ricordarmi scene di vacanze da bambino o da adolescente sotto l’ombrellone a Cecina oppure al bagno Trieste a Rosignano. Ricordarmi da giovane delle mie notti brave e poi il tempo passato in sala di attesa ad aspettare il treno del mattino, che mi riportava a casa. Ricordarmi tutte le notti insonni e i giorni sonnambuli da giovane. Ricordarmi i viaggi di due/tre giorni fatti con mio padre, a giro per l’Italia e pensare che forse non andremo mai a visitare Matera o che non ritornerò più nelle Marche o all’Aquila. Ricordarmi le cene con gli amici in varie località d’Italia, amici persi, mai più rivisti. Ricordarmi i pochissimi amori e i tanti rifiuti, le delusioni cocenti. Ricordarmi le ore distratte a leggere libri da studiare e le lezioni frequentate svogliatamente. Ricordarmi il vocio indistinto di una strada principale del centro o il brusio in una osteria. Ricordare i viaggi in treno, le impressioni guardando fuori dal finestrino, le viaggiatrici nello stesso scompartimento, i giochi di sguardi, le conversazioni, i silenzi. Ricordare tutte le passanti che abbiamo guardato e che non ci consideravano minimamente. Ricordare le passeggiate col mio cane, con mia madre al parco dei Salici o alla Sozzifanti. Ricordare tutti i sogni, le aspirazioni, i voli pindarici, le albagie, le illusioni, alcuni dichiarati, altri mai minimamente confessati, tutti abbattuti dalla realtà, dalla ragione, dall’età. Ricordare tutti i viaggi, tutte le città che ho visto. Ricordare tutte le nostre metamorfosi, le nostre idee, i nostri sentimenti, la nostra rabbia, le nostre malinconie, i miti creduti. Ricordare tutti gli omicidi, le scene di violenza reali o fittizie a cui abbiamo assistito alla televisione o su Internet. Ricordare tutti i libri letti e accorgersi che è rimasto solo un senso implicito, una conoscenza implicita. Ricordare le astrazioni, gli intellettualismi che non servono a proteggersi dai colpi bassi della vita né a fare da schermo per non mettersi a nudo. Ricordare che nessuna opera d’arte rende la vita fedelmente così come è. Ricordare della maturità acquisita, della pochissima arte, della insipida e scontata saggezza. Ricordare della teoria che si fa esperienza di vita e dell’esperienza di vita che si fa teoria. Ricordarmi di tutte le nozioni apprese, interiorizzate e poi lasciate andare, perdute per sempre. Ricordarmi tutte le nostre conversazioni, le frasi dette agli amici, ai familiari, frasi di circostanza, spesso di convenienza e chiedersi quanto fosse di vero, di autentico in tutte le parole dette e scritte (ma solo io, nessun altro cretino, posso stabilire se siano autentiche o meno le mie parole e forse nel momento in cui le ho scritte o proferite erano autentiche). Ricordare tutte le persone sfiorate, intraviste e tutte le persone conosciute, apparentemente in modo profondo, ma che non abbiamo mai afferrato, mai colto totalmente. Ricordare e dopo aver fatto notevoli sforzi di memoria capire che probabilmente tutto ciò che era più importante ci è sfuggito, è passato dalle maglie della memoria, si è involato chissà dove. Quale archivio disordinato e immenso di cianfrusaglie, di cose squallide è la memoria di ognuno! Fatico a trovare un senso a tutto questo, anzi sarò più sincero: non lo trovo assolutamente. Lo smemorato di Collegno e il Funes di Borges sono due facce della stessa medaglia. L’ippocampo serve per l’apprendimento, ma poi ci vuole la reiterazione per conservare tutto a lungo termine. La memoria talvolta degenera fino alla malattia degenerativa, ma non improvvisatevi neurologi! Si può vivere senza ricordare? Ogni sera prima di addormentarci facciamo il riepilogo spesso del giorno trascorso. Si può ricordare senza vivere? Non ci si può limitare a ricordare senza più vivere perché ricordare non è vivere ma tutt'al più rivivere. Memoria e vita sono legate a doppio filo, ma forse il loro impasto è sadico, crudele, eppure così raffinato. Alcuni perdono memoria e altri si perdono nella memoria. Ci vorrebbe un uso saggio della memoria per vivere! Ma non ci sono leggi certe perché ogni vita, ogni memoria hanno le loro regole. Aveva ragione Proust: la selezione, l’archiviazione, il richiamo della memoria è grosso modo involontario. Do ragione a Proust senza erigere una cattedrale della memoria come fece lui perché non ne avrei il genio né ne scorgerei la benché minima utilità: non frequentai la crema della crema della società come fece lui. Ho in mente solo piccoli ricordi, minuscoli pensieri, pronti a ogni evenienza, spesso adibiti a scacciare la noia. Francamente ammettiamolo pure: ognuno di noi nel profondo conserva una certa ossessività, ritornano nella sua mente, anche quando essa è libera di scorrazzare liberamente, sempre le solite immagini ricorrenti.
giu 302022
Riguardo al mito di Teuth: "O ingegnosissimo Theuth, c'è chi è capace di creare le arti e chi è invece capace di giudicare quale danno o quale vantaggio ne ricaveranno coloro che le adopereranno. Ora tu, essendo padre della scrittura, per affetto hai detto proprio il contrario di quello che essa vale. Infatti, la scoperta della scrittura avrà per effetto di produrre la dimenticanza nelle anime di coloro che la impareranno, perché fidandosi della scrittura si abitueranno a ricordare dal di fuori mediante segni estranei, e non dal di dentro e da se medesimi: dunque, tu hai trovato non il farmaco della memoria, del richiamare alla memoria. Della sapienza, poi, tu procuri ai tuoi discepoli l'apparenza e non la verità: infatti essi, divenendo per mezzo tuo uditori di molte cose senza insegnamento, crederanno di essere conoscitori di molte cose, mentre come accade per lo più, in realtà, non le sapranno; e sarà ben difficile discorrere con essi, perché sono diventati portatori di opinioni invece che sapienti.»
(Platone, Fedro)
Sant’Agostino si stupì quando vide Sant’Ambrogio che leggeva non a voce alta ma silenziosamente. Il dialogo permette una maggiore interattività e una maggiore reattività. Le lezioni degli insegnanti servono anche a questo. Si può ricorrere maggiormente alla metacomunicazione; si possono avere chiarimenti, delucidazioni in modo più semplice e in tempo reale. Poi c’è naturalmente il mito di Teuth tutto a vantaggio dell’oralità, ma c’è da dire che lo stesso Platone a differenza di Socrate lasciò tutto per iscritto. La scrittura permette maggiore complessità, talvolta porta alla complicazione delle cose semplici. Però per quel che mi riguarda permette di argomentare, di approfondire, di elaborare, di rielaborare le idee, di formularle compiutamente, di ristrutturare il pensiero. Richiede più tempo e più ponderatezza. L’oralità richiede più sintesi e semplificazione. Il talk show indicato da molti come l’apice dell’intelligenza verbale sfocia invece a mio avviso nella tracotanza e nella rissa verbale. I dialoghi tra persone comuni spesso mi sembrano ricalcare i talk show, le interviste, le conduzioni televisive più che essere davvero frutto di autenticità.

La scrittura porta a maggiore riflessività, a maggiore accuratezza. L’oralità richiede più sangue freddo. Con la scrittura si possono raffreddare gli animi, si può ragionare più a mente lucida. Ma questo non significa che l’oralità sia facile e la scrittura più difficile. Entrambe hanno pro e contro, punti di forza e punti deboli. C’è un modo per cercare la verità nel dialogo come nella corrispondenza epistolare, nella scrittura. Ci sono ostacoli, inganni che si frappongono alla ricerca della verità in entrambe queste forme comunicative. La scrittura, soprattutto quella artistica e filosofica, è frutto di meditazione estenuante. I dialoghi sono spesso più approssimativi e improvvisati, specialmente quelli quotidiani. Ci sono scrittori che non sanno parlare bene perché sono introversi e/o ansiosi. Tra scrittura e oralità vinse una mistura raffazzonata come i commenti nei blog, sui social, i messaggini, etc etc. Chi sa cosa ci riserva il futuro in questo senso? Ci sarà la creazione di nuove forme di comunicazione? Oggi sembra avere la meglio l’oralità sulla scrittura: fondamentale è bucare lo schermo; un Leopardi senza oratoria, senza un eloquio veloce non sarebbe minimamente considerato. Leggere permette di entrare in contatto intellettuale con i pensieri di grandi uomini vissuti in tutti i tempi e in tutti i luoghi (come in una celebre canzone). Borges annovera tra i giusti del mondo “Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto”.
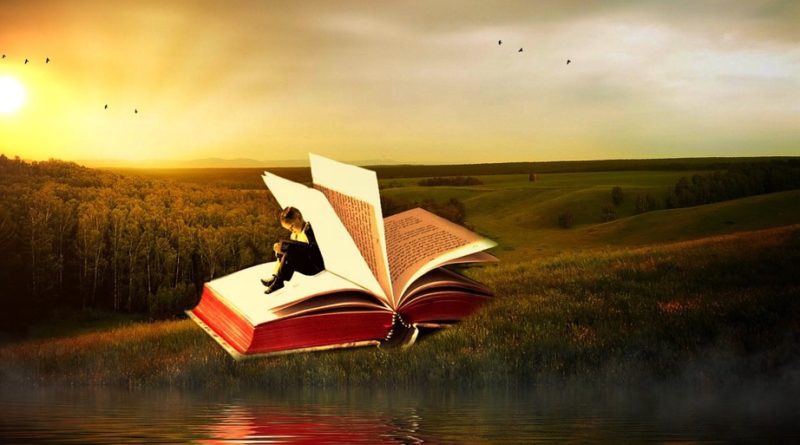
Che poi, scrittura o oralità, alla fine è importante questo, come ha scritto Gianni Rodari: “Tutti gli usi della parola a tutti: mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico. Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo”. Un poco classista invece Valentino Bompiani che scriveva: ““Un uomo che legge ne vale due”. Non sempre questo corrisponde a verità. Don Chisciotte a leggere pessimi libri impazzisce per esempio. Comunque sul furgoncino della biblioteca comunale hanno verniciato proprio questa frase. Alla frase di Bompiani fa da controcanto Rino Gaetano, il cui “fratello è figlio unico” perché “è convinto che anche chi non legge Freud può vivere cent’anni”. Io ritengo che Freud vada letto, ma poi subito dopo dimenticato per vivere meglio. Per quel che mi riguarda leggere non cambia la vita, almeno non ha cambiato la mia vita, forse l’ha addirittura peggiorata, ha contribuito a isolarmi, a peggiorare i rapporti umani. Ma forse dipende da me soltanto, mentre per altri la lettura è un mezzo di promozione sociale. Come ho scritto in un mio aforisma tempo fa (scusate l’autocitazione) la lettura fortifica l’intelligenza. Umberto Eco a favore della scrittura sostenne: “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è un’immortalità all’indietro”.

C’è una cosa però che lo scritto non darà mai ed è il calore umano, per quanto anche le parole scritte possono testimoniare vicinanza umana. Ci sono conversazioni banali quotidiane tra familiari che sono molto più importanti anche per persone ad alto coefficiente intellettuale del libro di un grande scrittore o di un filosofo memorabile, ma ci sono anche persone per cui le voci dei grandi artisti sono un bisogno insopprimibile, come un mio lontano parente di Bologna, che, pur essendo consapevole della fine, il giorno stesso della morte finì di leggere un libro. La lettura non avrebbe certo contribuito a salvargli l’anima, ma d’altronde in tutta onestà agiamo sempre per salvarci l’anima? Eppure leggeva perché ne traeva beneficio il suo animo e la sua mente. E poi chi può sapere con certezza, anche se è prossimo alla fine, che quel giorno morirà? A un colloquio di lavoro possono chiedere a un candidato quale è il suo ultimo libro letto (domanda molto sciocca), ma nessuno saprà mai quale sarà il nostro ultimo libro, l'ultimo libro della nostra vita.
giu 292022
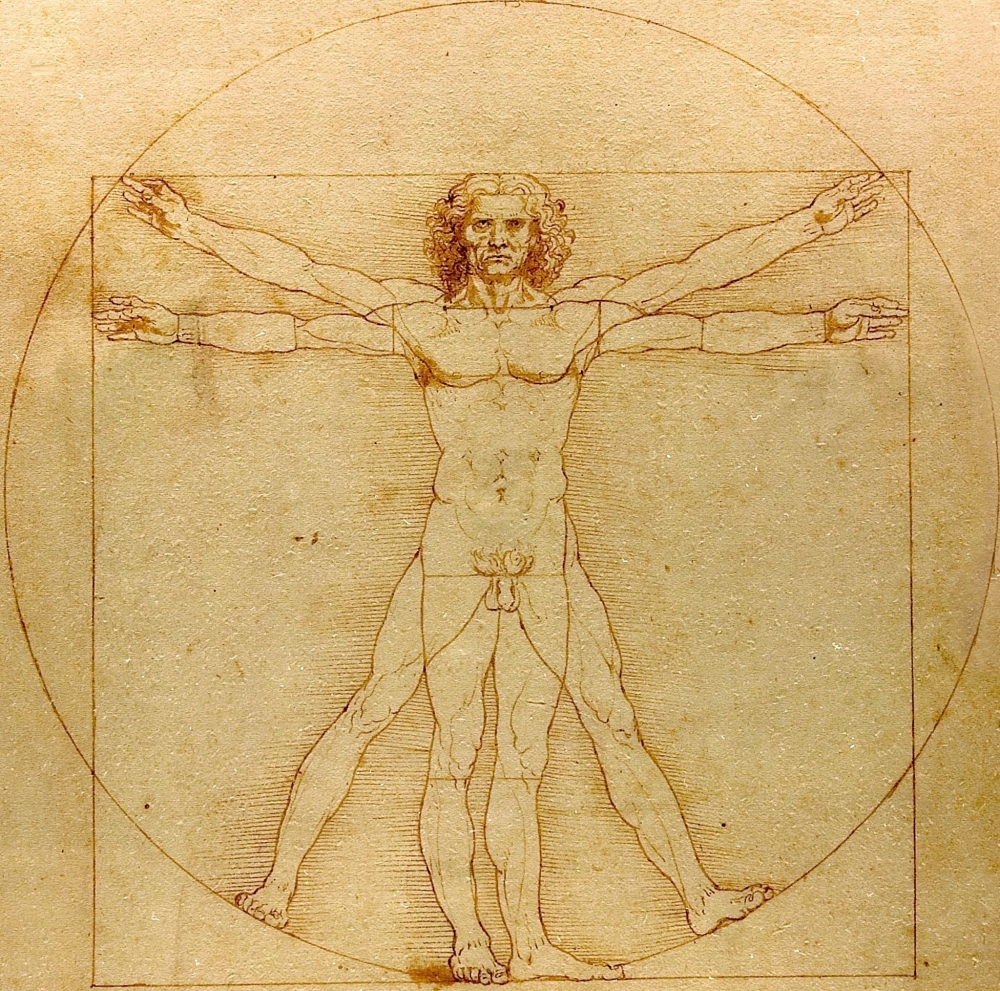
Cercherò di essere semplice e breve perché essere sintetici significa fare meno errori e inoltre come scrivevano ne "I quaderni piacentini": "poche parole=poche mistificazioni". Ma veniamo subito al nocciolo. La cultura umanistica è in crisi in Italia. È chiaro che l'umanesimo è in crisi in quasi tutto il mondo perché la razionalità scientifica ha avuto la meglio, come sostengono Husserl, Heidegger, Spengler, Junger, Emanuele Severino e molti altri ancora. Secondo queste filosofie il trionfo della tecnica è dovuto al diffondersi a macchia d'olio del nichilismo nella società occidentale. Certo anche gli umanisti possono avere le loro colpe. Possono essere stati snob, elitari, incomprensibili, oscuri, criptici, noiosi, impopolari, troppo ideologici, mentalmente disturbati, addirittura guerrafondai. Si potrebbe stare a criticare per ore l'umanesimo classico, gli umanisti e non la finiremo più! Ortega y Gasset a proposito delle avanguardie scrisse anche della "disumanizzazione dell'arte", ovvero neanche il nuovo che avanzava si salvava perché anche le avanguardie tracciavano in nome di una presunta oggettività ancora un solco tra letterati e popolo. Ma nessuno era ed è esente da colpe. Però l'Italia un tempo era Magna Grecia, antica Roma, Rinascimento. Era la culla della civiltà e dell'umanesimo. E allora perché si è per così dire imbarbarita? Una parvenza di umanesimo, comunque ancora oggi rimane. Rimane come zoccolo duro nelle scuole elementari, nelle scuole medie inferiori e superiori. Si fa leggere Leopardi già alle elementari. Alle medie si fa già "I promessi sposi". Ai miei tempi nei licei scientifici le ore delle materie umanistiche superavano di gran lunga le ore di quelle scientifiche. Oggi le cose non sono sostanzialmente cambiate. Ma era un umanesimo datato, un poco retrogrado, comunque non aggiornato (se si considera che anche la psicologia, la sociologia, la pedagogia sono umanesimo oltre che scienze appunto umane). Oggi in Italia siamo ancora alle "due culture" di Snow, ovvero scienza e umanesimo sono nettamente separati, difficilmente vengono fatti dei collegamenti, ancora più raramente vengono integrati. Non dimentichiamoci invece che la relazione tra i due saperi può essere proficua. Calvino vedeva in Galileo Galilei il più grande scrittore italiano. Ma anche la fantascienza ha fornito ipotesi e idee agli scienziati.

Un tempo c'era il boom delle iscrizioni nelle università. Anni fa anche le facoltà di lettere e filosofia erano sovraffollate. È vero che allora molto genitori "parcheggiavano" i figli all'università, sognando che conseguissero il famigerato pezzo di carta. Oggi per trovare subito lavoro bisogna essere medici, ingegneri, informatici. Dopo la pandemia c'è stato un grande calo delle iscrizioni. Un tempo anche alcuni datori di lavoro pensavano che gli "umanisti" avessero la mente più aperta, potessero impostare meglio i problemi, riuscissero a mettere meglio le cose in prospettiva, potessero avere un'opinione su tutto, fossero anch'essi in grado di apprendere il nuovo e affrontare la complessità crescenti, riuscissero a mettere in relazione le cose più disparate, avessero insomma quella che Mills definiva come "immaginazione sociologica". Oggi questa visione del mondo viene considerata superata. In un mondo tecnologico i laureati nelle facoltà scientifiche sono visti e presi, sono considerati più preparati perché hanno studiato discipline necessarie e hanno superato una selezione scolastica più dura. Gli umanisti hanno meno opportunità non solo perché ci sono meno posti di lavoro per loro ma anche perché un datore di lavoro preferisce assumere come operaio o impiegato un perito o un ragioniere a un laureato in lettere e filosofia con maturità scientifica o classica. Esiste così la cosiddetta disoccupazione "intellettuale" e anche la sottoccupazione "intellettuale". Esistono anche i casi di alcune persone che dopo aver conseguito il diploma di ragioneria con il massimo dei voti hanno rifiutato il posto in banca, a loro subito offerto, si sono laureate in una facoltà umanistica e al momento dell'ingresso del lavoro hanno trovato serie difficoltà, ovvero hanno trovato tante porte chiuse in faccia. Un laureato "umanista" può dire al datore di lavoro: "mi dia un'opportunità. Imparo in fretta". Altrettanto prontamente quest'ultimo può rispondere: "Cerco persone con esperienza e competenze. Non ho tempo di insegnare e non posso aspettare che tu impari il mestiere". Per gli economisti è questione di mismatch, ovvero domanda e offerta non si incontrano. Dicono che le università non formano le figure professionali e non danno le competenze che servirebbero nel mercato del lavoro. È anche vero però che l'istruzione, anche quella universitaria, dovrebbe formare per imparare a imparare, visto che non si può spesso prevedere ciò che sarà richiesto nel mercato del lavoro in futuro. È anche vero che molte aziende italiane investono poco per la formazione del personale così come investono poco per il settore ricerca e sviluppo. D'altronde il mondo economico italiano è fatto di piccole imprese e queste nella stragrande maggioranza dei casi non hanno le risorse e qualche volta, pur avendole, non hanno la lungimiranza di investire. Ma sul laureato "umanista" oltre a un certo discredito c'è anche il sospetto che sia uno non pratico, uno troppo teorico. Esistono diversi pregiudizi nei confronti degli "umanisti" tra cui quelli di essere troppo critici del sistema. In fondo per dirla alla Said l'umanesimo è anche critica del sistema, della sua scientificità, della sua industrializzazione, della sua managerialità. L'umanista è visto quindi oltre a uno che non è abituato a faticare anche come un sovversivo potenziale. Non solo ma a tutto ciò si aggiunga il fatto che molti piccoli imprenditori si sentono dei self made men, nutrono una sorta di complesso di superiorità nei confronti del laureato umanista, salvo poi commuoversi se il loro figlio si laurea in una disciplina anch'essa umanistica e andarne fieri per tutta la vita. Ma nessuno naturalmente è esente da contraddizioni.
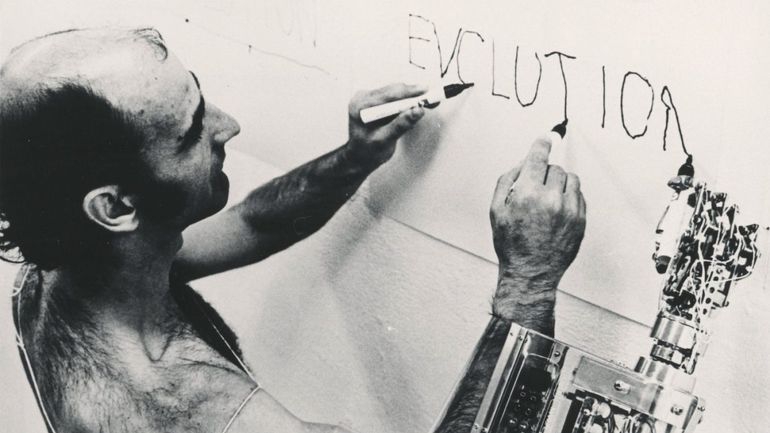
La crisi dell'umanesimo in Italia è data anche dal fatto che molte librerie di paese o di periferia nella città stanno chiudendo. Quelle rimaste lavorano soprattutto con i libri scolastici. Probabilmente a rendere critica la situazione sono stati gli ebook, gli acquisti online di libri, il fatto che oggi si legge di meno. Sembrava una commedia al di fuori della realtà "C'è posta per te" nel 1998, ambientata a New York, dove un grande imprenditore di una catena di librerie metteva in crisi una piccola libreria. Il web ha condannato oggi le piccole librerie italiane. Le anime belle sostengono che quelle librerie dovevano sopravvivere grazie a dei finanziamenti statali perché erano l'anima del quartiere, il cuore di una piccola comunità, però magari loro stesse hanno fatto sempre pochissimi acquisti prima, decretandone l'insuccesso. È indubbio che ci siano dei vantaggi ad acquistare online: è più comodo, si può fare tutte le ricerche online e trovare tutti i libri da soli senza l'aiuto di nessuno. Trent'anni fa uno andava in libreria anche per vedere quello che passava il convento, i libri che erano lì in bella mostra, sempre se non ordinava dei libri e doveva aspettare di solito due settimane per ritirarli.

Alle presentazioni dei libri ci vanno sempre poche persone, a meno che non siano influencer o personaggi televisivi che pubblicano un libro.
C'è chi dice che il teatro non è in crisi, che bisogna intendere cosa significa crisi, insomma spacca il capello in quattro, fa sottili distinguo per negare l'evidenza dei fatti. In realtà la stragrande maggioranza degli italiani non va a teatro e non ha mai assistito a uno spettacolo teatrale. Secondo le statistiche ISTAT nel 2018 7 italiani su 10 non andavano nei musei. Poi le cose si sono aggravate col Covid.
I caffè letterari sono in crisi, poco frequentati come sono, e spesso i giovani ci vanno per bere, rifocillarsi, incontrarsi ma non per fare letteratura. Dove si fa letteratura oggi? Soprattutto online, anche su blog, siti letterari, social. La piazza non esiste più. Sono tutti più social e anche più asociali rispetto a un tempo. A riprova di questo fatto il nel 2018 il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della società che gestisce il caffè Le giubbe rosse. Eppure questo storico locale aveva fatto la storia della letteratura del '900. Era un luogo di ritrovo abituale per Montale, Luzi, Alfonso Gatto, Parronchi, Bigongiari, etc etc. Cosa sarebbe stato l'ermetismo senza questo locale? Eppure ha chiuso i battenti prima della pandemia. Naturalmente riaprirà prossimamente, ma la chiusura temporanea ha rivelato il segno dei tempi. A cosa è dovuta questa crisi delle librerie e dei caffè letterari? Potremmo affermare che il globale sembra aver preso il sopravvento sul locale. Non sembra esserci competizione. Le multinazionali come Amazon mangiano sempre le piccole realtà periferiche. Eppure l'Italia potrebbe vivere di rendita, pardon, di turismo culturale, se valorizzasse il proprio patrimonio e formasse culturalmente i giovani. Hanno un bel dire ad affermare che in Italia c'è accoglienza se non ci sono strutture e persone idonee ad accogliere i turisti che vogliono apprendere, sapere, vedere l'arte e la cultura. Secondo report statistico fornito dalla World Tour Organization (UNTWO) l'Italia è terzo per turismo in Europa, superato da Spagna e Francia. Bisognerebbe incominciare a capire, noi italiani, di sfruttare al meglio il nostro patrimonio culturale perché siamo molto di più di pizza, mandolino spaghetti, Capri (che vanno già bene). Non dimentichiamoci che il turismo culturale è sottovalutato oggi. Ma ha una grande tradizione alle spalle. Si ricordi i viaggi in Italia di Goethe e Stendhal. Si pensi che la cosiddetta sindrome di Stendhal prende il nome dal fatto che lo scrittore ebbe un malessere visitando la basilica di Santa Croce a Firenze.
giu 282022

Non è così tanto alla luce del sole, ma chi scrive versi non deve farsi nessuna illusione. Nel migliore dei casi la strada è impervia e in salita. Uno pensa bonariamente che il mondo della poesia sia senza macchia e alieno da ogni forma di mercificazione, di compromesso commerciale. Pensa che sia un'isola felice, un'eccezione in questo mondo consumista. È vero che il business poetico è poca cosa e che c'è poco giro di denaro. Ai tempi degli antichi romani dicevano che carmina non dant panem (lo sosteneva Orazio per l'esattezza). Oggi scrivere versi e venire un minimo riconosciuti non è un atto gratuito ma addirittura una spesa. Non è così ovvio e scontato, ma comunque per fare carriera poetica ci vogliono soprattutto i soldi. Sono un requisito indispensabile, una conditio sine qua non. Oltre a un minimo di talento ci vogliono gli schei detto alla veneta, i danee detto alla milanese. Non è richiesta una grande quantità di capitale, ma bisogna avere uno stipendio oppure una famiglia alle spalle disposta a investire/spendere per arricchire la nota biografica/il curriculum artistico del figlio o della figlia. La carriera poetica può dipendere dalle opportunità economiche o quantomeno da quanto una persona è disposta a spendere per la sua passione. Non è un atto di accusa, un'invettiva o chissà che. È un dato di fatto assodato ormai. Sono rarissimi i casi in cui ciò non avviene come ora vi esporrò. Non succede se un poeta pubblica con Einaudi, Mondadori, Garzanti, Crocetti o Feltrinelli e poi si ritira dalle scene. Nei restanti casi, anche i poeti affermati sono costretti a spendere qualcosa e difficilmente fanno pari o guadagnano. Non c'è niente di male: la mia è solo la presa di coscienza dello stato in cui versa la poesia italiana attuale. I poeti affermati non campano come poeti ma lavorano come giornalisti, impiegati, editor, insegnanti, non parlando di quelli non integrati come erano la Merini o Zeichen.
"Io non ho bisogno di denaro.
Ho bisogno di sentimenti.
Di parole, di parole scelte sapientemente,
di fiori, detti pensieri,
di rose, dette presenze,
di sogni, che abitino gli alberi,
di canzoni che faccian danzar le statue,
di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti...
Ho bisogno di poesia,
questa magia che brucia le pesantezza delle parole,
che risveglia le emozioni e dà colori nuovi."
Alda Merini, Terra d'Amore (Bari, Acquaviva 2003).
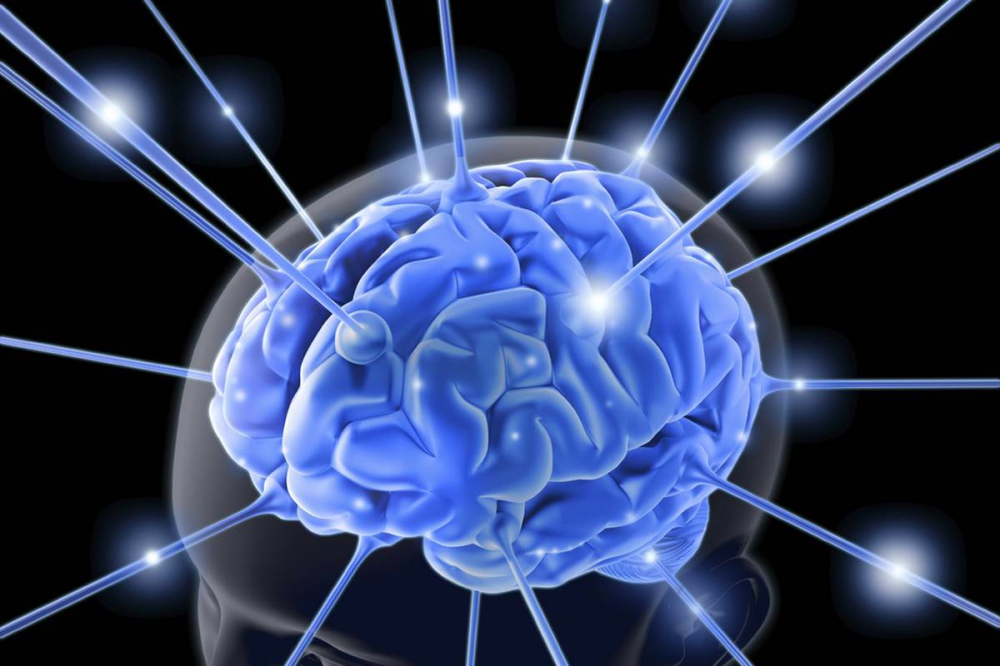
Una parte delle proprie entrate economiche, una voce in bilancio per le spese poetiche va messa in conto. Innanzitutto un poeta nella stragrande maggioranza dei casi deve pubblicare a pagamento. Spesso come costo ulteriore c'è l'editing che viene fatto. Autopubblicarsi non è visto di buon occhio dalla critica. Gli ebook, anche se pubblicati gratis su riviste online pregevoli, non vengono presi in considerazione. Inoltre il poeta deve spendere per la prefazione, per organizzare un aperitivo per la presentazione del suo libro. Non solo ma deve spedire decine e decine di copie a critici, direttori di riviste online e blog letterari perché questi poi recensiscano la sua opera: spedire un semplice pdf significa non essere presi in considerazione; non è comunque una grande spesa, se si invia tramite posta ordinaria e non per raccomandata. Un poeta deve partecipare a dei premi letterari, nella maggioranza dei casi deve pagare la tassa di iscrizione e poi se vince il premio o concorso deve viaggiare, pernottare nella località della premiazione, deve bere e mangiare, quindi presenziare alla cerimonia. I rimborsi spese non esistono per poeti effettivi, aspiranti e sedicenti. Per non farsi mancare niente qualche poeta si rivolge a un'agenzia letteraria, che lo promuove, lo istrada, lo avvantaggia, lo fa entrare nel giro giusto. Ma tutto ciò ha anch'esso un costo. Quindi ci sono le antologie di poesia. Molto spesso si tratta di antologie non scolastiche e dopo essere stati inseriti i poeti devono acquistare almeno una o due copie: spese irrisorie, ma pur sempre delle spese. Ci sono anche i libri di poesia e di critica letteraria comprati per acculturarsi ulteriormente, per approfondire o estendere le conoscenze culturali. Non sempre le biblioteche comunali, anche quando esiste una rete efficiente di prestito interbibliotecario nella provincia come a Pisa, si trovano i libri attuali. Quindi ci sono le riviste letterarie a cui abbonarsi per informarsi ulteriormente e per aggiornarsi. Ma la comunità poetica non è solo online. Bisogna anche frequentarsi, andare alla presentazione dei libri, frequentare i festival poetici, incontrarsi con poeti affermati e critici, partecipare alle conferenze universitarie o a quelle delle associazioni culturali. Non solo ma un poeta o una poetessa che si rispetti ha un suo sito personale con un suo dominio registrato, con la sua brava informativa della privacy, con la sua grafica accattivante creata da un webmaster professionista: insomma altri soldi da spendere. Quindi ci sono poeti che pagano per appartenere a un'associazione culturale o un'accademia poetica. Poi ci sono alcuni siti di poesia che mettono in vetrina online i propri iscritti, ma bisogna versare una quota annua. Come se non bastasse ci sono anche delle scuole di scrittura e alcuni sia per migliorare a scrivere che per entrare in contatto con critici o scrittori importanti spendono centinaia di euro per frequentare. Infine ci sono i poetry slam e uno spende per recarvisi. Inoltre per combattere l'ansia beve qualche birra oppure spende bevendo qualche birra per avere maggiore comprensione empatica nei confronti dei partecipanti: in ogni caso dopo un certo tasso etilico anche i mediocri sembrano Montale nella notte in cui tutte le vacche sono nere e le poesie sono capolavori. Però anche viaggi, panini, piadine, birre costano.

Inoltre bisogna offrire qualcosa al bar o al pub al cronista, che molto spesso non si intende assolutamente di poesia contemporanea, perché scriva un trafiletto su un quotidiano in modo da certificare alla comunità locale che uno esiste come poeta. Non solo ma va considerato tutto il tempo speso a occuparsi di poesia e che poteva essere occupato in attività più remunerative, Molte di queste cose non l'ho mai fatte (qualcuna sì, ma pochissime e le più economiche), però per fare carriera poetica è questo ciò che legittima culturalmente. Non dico che tutto ciò sia giusto o sbagliato. La mia è una pura e semplice constatazione di fatto. I soldi sono una grande facilitazione, aprono molte porte, anche nel mondo apparentemente puro e incontaminato della poesia. Nel mondo della poesia un poco di soldi da spendere sono una premessa indispensabile. Ci sono poeti che mettono al primo posto nei loro valori e come priorità nella loro vita la carriera poetica. Così si ritrovano con la casa piena di libri pubblicati a proprie spese e di premi e targhe di scarsa importanza, ma in ristrettezze economiche e con pochissimi soldi per fare la spesa. Pur con tutta la solidarietà dell'intera comunità poetica forse potrebbero gestire in modo più avveduto e oculato i loro soldi. Ma molto spesso dopo tutti questi sforzi economici e dell'impegno profuso la maggioranza dei poeti ha successo oppure diventa memorabile? Assolutamente no. Ogni sforzo spesso è vano. Tutto è destinato a finire nel dimenticatoio. Poi i soldi non vanno considerati lo sterco del diavolo. Di solito si assiste a questo doppio sacrificio: 1) i genitori hanno speso soldi per mandare all'università i poeti con scarso o addirittura nessun ritorno economico 2) i poeti sacrificano tempo e denaro per la loro passione, vivendo un'esistenza precaria.
Mi è stato riferito da alcuni che conoscono a menadito la comunità poetica che la maggioranza dei poeti proviene da famiglia benestante, ma nel corso della vita sono destinati di solito a impoverirsi tra mancati guadagni di una educazione umanistica che non dà frutti economici e le spese per partecipare all'agone lirica.

Di solito però quando un poeta recita le sue liriche alla maggioranza della gente questa gli dice che le sue poesie sono belle, come contentino. In realtà la poesia contemporanea è vista dai più come oziosa, inutile, noiosa, incomprensibile. Alla cosiddetta gente non importa nulla della poesia e dei poeti contemporanei. Come scrive il critico e poeta Davide Brullo fino a quando non ci saranno soldi statali per finanziare i poeti e fino a quando non verrà istituito un centro di ricerca per la poesia statale ci sarà un grande bailamme di poeti, alcuni veri ma anche molti presunti, pronti a fare un baccano inenarrabile. La poesia, anche la migliore, viene considerata solo un hobby. I poeti quindi dovrebbero rimanere con i piedi per terra. Spesso ai poeti manca il senso pratico e un poco di sano realismo. Non c'è niente di male in questo. Ognuno ha le sue pecche. Nessuno è perfetto, come la celebre battuta di Casablanca. Basta esserne consapevoli. Non sempre il talento viene riconosciuto. Lo pensavo proprio stamani che ero seduto al bar e solo dopo che se ne è andata ho riconosciuto una bella donna come la sorella di una ragazza che trent'anni fa mi aveva rifiutato. Allo stesso modo non sempre si riconosce la poesia come tale, anche se è bella. Comunque la poesia può essere considerata per alcuni un atto di pace, per altri un atto di insubordinazione nei confronti della società attuale (scrivere in questo senso è un piccolo atto "rivoluzionario" anche da parte di chi non è rivoluzionario politicamente), per altri ancora un atto d'amore che poche persone, forse nessuno raccoglierà. Questo bisogna tenerlo presente, pur tra molte difficoltà per i poeti e tra tanta ilarità delle persone pragmatiche. Se è vero che i poeti in Italia suscitano ilarità, la libertà di scrivere è concessa. Qui non accade come a Brodskij che nel regime russo decenni fa fu accusato perfino di parassitismo. A ogni modo i poeti non possono fare a meno di scrivere. Quindi si sobbarcano, più o meno incoscientemente, costi e crisi reputazionali.
giu 282022

Il verso libero:
Nel corso del '900 si è diffuso il verso libero. Questo è avvenuto non solo tra quelli che vengono definiti dai cattedratici poeti dilettanti ma anche da grandi poeti stranieri e italiani. Laforgue fu il primo grande poeta ad adoprare il verso libero e a tal proposito scrisse: "mi dimentico di rimare, mi dimentico il numero delle sillabe, mi dimentico la distribuzione delle strofe". Anche Pound fece un uso moderato nelle proprie liriche del verso libero. I poeti dell'imagismo scrivevano tutti in versi liberi. E. Lee Masters nella celeberrima Antologia di Spoon River adoprò spesso nei suoi epitaffi versi liberi e non prestò molta attenzione al rispetto della metrica. Per quel che riguarda il nostro paese i crepuscolari Corazzini, Gozzano, Govoni, pur utilizzando anche forme metriche tradizionali, introdussero il verso libero nella poesia italiana. Anche il poeta simbolista Gian Pietro Lucini scriveva soprattutto versi liberi e dichiarò che al momento della creazione non cercava "misure prestabilite (versi), né sequenze numerate di misure (strofe)", né il posizionamento di accenti tonici. Inoltre bisogna ricordare che i poeti vociani Jahier e Boine scrissero solo prose poetiche. Infine i futuristi utilizzarono solo ed esclusivamente il verso libero. Se in poesia e in letteratura devono essere messe delle regole forse devono riguardare il rapporto tra l'arte e il tentativo di ideologizzazione dell'arte stessa. Ritornando al verso libero alcuni intellettuali ritengono che la vera libertà si acquisisca nell'ambito delle regole imposte e degli schemi precostituiti o almeno questa è la loro giustificazione alla loro concezione di una poesia, che per essere tale deve adoprare le forme metriche classiche. Altri intellettuali ritengono invece che nell'arte la libertà non esista, per cui devono essere accettate le regole imposte dalla tradizione. Per il poeta Robert Frost "scrivere versi liberi è come giocare a tennis senza rete».
Ma non è detto che chi scriva versi liberi e non rispetti la metrica tradizionale non si imponga altre regole riguardanti altri ambiti. Un tempo erano presenti dei canoni estetici. Oggi forse è più problematico valutare un poeta. Sono rari i casi di coloro che scrivono endecasillabi canonici. I più scrivono in versi liberi.

La crisi della poesia:
Comprendere le poesie non sempre è facile. Un testo può essere analizzato per il suo significato psicoanalitico, esistenziale, sociale, letterario, ideologico. Ogni testo può essere studiato valutando il contesto storico, la parafrasi, le figure retoriche, la metrica. Non solo ma va anche detto che ogni lirica può scaturire dal sentimento, dall'osservazione o dalla trasfigurazione. Inoltre non sempre un poeta si basa sulla realtà oggettiva ma spesso anche sulla vita segreta delle cose e della natura. Nel Novecento tutto diventa ancora più complesso. Basta pensare a Eliot e Pound con le loro citazioni colte e il loro montaggio. Nel secolo scorso sono stati molti gli ismi letterari. In Italia agli inizi del Novecento l'Ermetismo non era affatto di facile comprensione sia perché in esso era presente l'Orfismo (connotato dal valore sacrale della poesia e dalla ricerca costante di assoluto e infinito) sia perché i testi erano colmi di simboli, analogie e sinestesie. Negli anni Sessanta si registra un notevole cambiamento. Erano contro l'Ermetismo sia i poeti di Officina (Pasolini, Roversi, Volponi, Fortini, Leonetti) che i Novissimi (gruppo 63), ma anch'essi non erano di facile comprensione. Da un lato i poeti di Officina avevano buoni intenti: volevano il rinnovamento, erano contro l'intimismo degli ermetici, erano contro i reazionari. Dall'altro lato erano anche contro il Neorealismo, uno dei pochi ismi del Novecento (insieme ai crepuscolari) i cui autori si facevano capire da tutti. Forse nel Neosperimentalismo erano presenti troppe premesse teoriche. Anche la Neoavanguardia era ammirevole negli intenti perché contro il neocapitalismo, contro l'egemonia culturale e l'estetica dominante, contro la mercificazione dell'arte. Però spesso spiazzava i lettori per i suoi non sensi, il suo linguaggio multidisciplinare, i suoi shock verbali, la ricerca di essere originali a tutti i costi. Infine la poesia degli anni Settanta con il Neo-orfismo cambia di nuovo le carte in tavola perché prende le distanze sia dalla Neoavanguardia che dal Neosperimentalismo, ma il linguaggio poetico è sempre oscuro e di non facile decifrazione. Per capirne di più basta leggere due antologie poetiche: "La parola innamorata" e "Il pubblico della poesia". Il poeta comunque da decenni non ha più alcun status e la poesia contemporanea è divenuta marginale. Molti scrivono. Pochi leggono. C'è anche troppa creazione ma è scarsa la fruizione. La poesia contemporanea è determinata talvolta dall'egocentrismo, dal narcisismo, dall'autobiografismo. È una poesia talvolta autoreferenziale e non comunicativa. I poeti sono sempre più appartati. Il loro messaggio talvolta non è chiaro. Il gradimento del pubblico è scarso. I giornali raramente recensiscono libri di poesia. Nelle Facoltà di Lettere i poeti contemporanei non trovano spazio. Il fatturato dei libri di poesia in Italia è inferiore all'1% del fatturato globale. I libri di poesia nella stragrande maggioranza dei casi finiscono al macero. I poeti sono stati sostituiti e rimpiazzati socialmente da cantanti e cantautori. Sono molteplici i motivi di questa situazione e non li analizzeremo ora. Comunque oggi i poeti viventi sono sconosciuti al grande pubblico. Come sono cambiati i tempi da quando Vico scriveva che i poeti sono i primi storici delle nazioni! Oggi è innegabile che la poesia di questi anni è in crisi e alcuni critici l'hanno definita minimalista. La lirica di questi tempi è talvolta illeggibile e non memorabile. Comunque non bisogna essere ottimisti né apocalittici.
Poesia e moralità:
È sempre difficile giudicare la qualità delle poesie. È vero che è improponibile il paragone tra la poesia di un bambino di prima elementare e una di Montale. Ma spesso le differenze non sono così marcate. Un tempo si consideravano la metrica e l'eufonia. Oggi non più. Decenni fa in Italia si considerava anche la persona del poeta, che doveva essere assennato e ponderato. Al poeta si richiedevano delle virtù come una certa moralità e la saggezza. Se era sregolato allora era solo un erudito e/o un immaturo. Non poteva considerarsi persona di cultura. Si guardava il comportamento. Si considerava soprattutto l'etica. Si giudicava la condotta. C'era molto moralismo. D'altronde anche la Neoavanguardia valutava la persona (che doveva essere schierata ideologicamente). Loro erano gli unici puri e onesti. Consideravano anche la poetica. Quindi il contenuto veniva giudicato in modo fazioso perché secondo loro il linguaggio era "ideologia". Insomma si doveva combattere. Erano in trincea. Bisognava condannare la borghesia. Quindi bisognava per forza di cose odiare i piccoli borghesi. È chiaro che la Neoavanguardia ha avuto anche dei meriti come quello di rinnovare il linguaggio, inventare il pluristilismo, etc etc. Le due "chiese" comunque si sono appropriate della cultura nella seconda metà del Novecento. La maggioranza della gente se ne fregava. Negli anni Settanta le nuove generazioni erano perse nella droga o nella politica. La letteratura era ritenuta cosa di poco conto e non incisiva. Addirittura era ritenuta evasione. Molti giovani di allora pensavano ad altro e si rovinavano con altro: l'eroina o il terrorismo. La stessa poesia da allora è stata relegata ai margini e non si è più ripresa. Giudicare le poesie è sempre impresa ardua e risente di una certa soggettività. Spesso è questione di gusto più che di criteri estetici.

Poesia e ideologia:
Quali qualità deve possedere un artista per essere tale? Sono sicuro che a questa domanda molti risponderebbero che deve avere talento. Ma forse questo è un prerequisito fondamentale ma non sufficiente. Vittorio Sgarbi in "Lezioni private" scrive che un artista deve avere uno stile. Per esempio un poeta deve avere una visione del mondo. Successivamente avrebbe una poetica (ovvero una dichiarazione di intenti) e uno stile. Un artista di conseguenza secondo tale concezione deve anche essere un intellettuale, che riflette sul mondo e che rappresenta una coscienza critica per gli altri. Secondo Sgarbi l'artista è tale innanzitutto per il proprio pensiero (che deve contraddistinguersi per una certa originalità) e questo è valido sia per chi appartiene alla tradizione che per chi appartiene ad una avanguardia. Secondo altri si può scrivere anche senza una piena consapevolezza di sé stessi e del mondo, ma in fondo sono un'esigua minoranza. Molti critici la pensano come Sgarbi. Altra cosa importante oltre al pensiero è quella che alcuni chiamano la posizione intellettuale. Un artista può esprimere dissenso, consenso o non schierarsi rispetto alla politica e al potere. Per Gramsci ogni artista doveva essere un intellettuale organico. Sartre nella presentazione a "I tempi moderni" proponeva l'engagement. Lo scrittore era da ritenersi sempre responsabile. Non doveva scrivere per i posteri ma per i contemporanei. Non doveva evadere dalla realtà ma essere sempre testimone. Però molti altri erano per una posizione intellettuale meno impegnata politicamente. Per Saba i poeti dovevano essere "sacerdoti dell'eros". Anche D'Annunzio faceva dire a Claudio Cantelmo ne "Le vergini delle rocce" che gli artisti dovevano soltanto difendere la bellezza. Ma in fondo era in buona compagnia. Lo stesso Dostoevskij scriveva che la bellezza avrebbe salvato il mondo. Chissà cosa avrebbero pensato oggi di questa epoca in cui l'arte è soprattutto ricerca del nuovo a tutti i costi e provocazione fine a sé stessa?
Lo stile comunque può essere giudicato subito dai critici letterari, mentre le scelte politiche devono essere comprese e interpretate almeno dopo qualche decennio. Il rischio infatti è quello di essere troppo faziosi e di confondere l'estetica con l'ideologia. In alcuni casi c'è la possibilità di confondere l'estetica con l'etica. Non ci scordiamo che in alcuni autori l'appartenenza politica è più che una presa di posizione politica una scelta dettata da idealismo. Per alcuni artisti il liberalismo, il comunismo, il socialismo, la socialdemocrazia, l'anarchia sono categorie dello spirito. Non dimentichiamoci neanche che furono pochi gli intellettuali a opporsi all'entrata in guerra e al fascismo. Condanniamo pure il loro fascismo ma bisogna anche considerare obiettivamente le loro opere artistiche. Lo stesso dicasi per altre ideologie e altri regimi. Facciamoli però processare dagli storici, anche se si può legittimamente mostrare una certa repulsione per i loro atteggiamenti e comportamenti. Condanniamoli pure come uomini ma non rimuoviamo totalmente gli artisti che sono stati e neanche quello che hanno rappresentato per gli uomini della loro epoca.
Poeti di ricerca e neolirici:
Forse è troppo riduttiva la distinzione tra poesia di ricerca (sperimentatori del verso) e poesia neolirica. Non è detto che tutto lo sperimentalismo porti per forza di cosa sempre al rinnovamento del linguaggio e al rovesciamento di prospettive. In fondo anche alcuni poeti lirici o neo-orfici possono essere originali ed innovativi: non è assolutamente detto che siano sempre dei manieristi o degli epigoni. Non è detto inoltre che questa distinzione tra i due generi di poesia possa racchiudere tutte le dicotomie concettuali ed espressive (comprensibile/difficile, tradizione/innovazione, impegnato/reazionario, etc. etc.). Per quanto riguarda la comprensibilità dei testi la Dickinson scriveva che si doveva dire la verità in modo criptico, mentre K. Popper sosteneva che niente è così facile che scrivere in modo difficile e che tutti coloro che scrivono devono porsi come dovere la chiarezza espositiva (però era un filosofo). La realtà in poesia è che i componimenti dovrebbero in teoria cercare sempre di raggiungere i vertici della significazione. Però i poeti spesso cercano termini ricercati, talvolta antiquati, perché li considerano più consoni. I poeti tra gambo e stelo scelgono sempre il secondo vocabolo, anche se non sarebbe necessario. Anche i poeti in fondo hanno il loro gergo. Mi sembra che Pasolini avesse dichiarato a riguardo che esistesse in poesia un codice classista del linguaggio. Ma non è forse riduttiva questa distinzione tra poesia di ricerca e neolirici? Non potrebbe essere considerata anche una poesia aforistica come quella dell'ultimo Montale, degli Shorts di Auden, dell'ultimo Cesare Viviani? Non sarebbe forse originale se questo genere di poesia aiutasse a chiarire i pensieri, portasse talvolta a "pensare contro sé stessi" per dirla alla Cioran (il riferimento è alla sua opera "La tentazione di esistere")? Naturalmente una scrittura aforistica rischia sempre di essere troppo didascalica oppure ostensiva. Ma in fondo anche gli sperimentatori o i neolirici rischiano anch'essi di perdersi in virtuosismi, di innamorarsi troppo delle parole. I rischi ci sono per tutti. Comunque la distinzione autentica che dovrebbe essere fatta è tra chi cerca di descrivere/raggiungere/ rendere tutta la complessità del reale (il rischio è quello di rendere ancora più complicato e di più difficile comprensione ciò che è già complesso) e tra chi cerca di semplificare la realtà (il rischio è quello di rendere tutto troppo semplicistico, di creare delle smagliature da cui evade il reale). Queste dovrebbero essere le due scuole di pensiero (ma forse sarebbe meglio dire due atteggiamenti esistenziali) di una poesia, che allora potrebbe essere veramente ricerca di senso. Ma forse è solo una utopia. Però la distinzione basilare è tra chi cerca di raggiungere la soglia del dicibile e chi cerca la sostanza delle cose, l'essenziale. Questi a mio modesto avviso sono i due modi di porsi in estrema sintesi. Poi a prescindere dal tipo di atteggiamento chiunque può essere o meno innovativo. Per cercare l'essenziale intendo l'estrema sintesi del reale. La soglia del dicibile non è detto che sia estrema sintesi. L'essenziale lo si raggiunge con il levare. È la caratteristica tipica della scrittura epigrammatica. La soglia del dicibile invece la si raggiunge con il battere, con l'accumulo: significa cercare di descrivere in modo esaustivo la realtà, di comprenderla in modo totalizzante.
giu 272022

Una tematica può essere trattata, sviscerata nei modi più disparati. Infinite possono essere le chiavi interpretative, infinite le chiavi di lettura. Ci sono molti autori che trattano la depressione, sono depressivi, sono deprimenti. Ma la questione non è tanto come affrontare una tematica. A volte mi chiedo perché certi autori scelgano quell'argomento. Mi chiedo quanto ci sia di razionale e di irrazionale, di conscio e dell'inconscio. Comunque la natura della tematica e lo stile con cui viene trattata dipendono dalla visione del mondo, dalla personalità, dalla cultura, dall'esperienza, etc etc. Si ritorna al discorso delle ossessioni. Ogni autore ha le sue. Ogni autore ha le sue fissazioni. Difficile discostarsi da esse. Anche quando si sceglie un argomento del tutto nuovo apparentemente originale ecco che ritornano schemi, costanti, stilemi, manie, tare psicologiche. A vedere bene sembra che le varianti di ogni autore siano infinitesimali. Se leggiamo "Gli indifferenti" constatiamo quanto ci sia del Moravia successivo in quel libro, quanto anticipi ciò che verrà dopo in quel romanzo. La prima opera di un autore è allora l'anteprima di quel che verrà dopodomani? Come dicono molti ogni scrittore è destinato a ripetere il primo libro?
In Meditazione milanese Gadda dedica un metro capitolo ai fini e scrive che «gli n tendono agli n+1 ma non sanno a cosa tendono, ché, se lo sapessero, gli n+1 non esisterebbero già". L’uomo forse tende ad n+2, ad n+3, ad n+infinito. Questo significa che gli uomini vogliono progredire infinitamente la loro conoscenza. L’uomo vuole incrementare il sapere continuamente. Ma siamo sicuri che scrivere significhi progredire all'infinito, evolversi ad libitum? Oppure si rimane sempre lì?
Dante aveva le sue ossessioni (Beatrice e la metrica), era ossessionato, è ossessionante per i lettori, aveva un tratto di personalità ossessivo (si veda per esempio come era un maniaco delle forme chiuse e come seguisse rigorosamente certe regole). Ecco spiegato perché non sono un dantista o un dantologo. In un certo qual modo non studiare Dante è un modo per preservare quel poco che resta della mia salute mentale. Non voglio idealizzare le mie ossessioni, vere o presunte, come fece lui con Beatrice. Mi ricordo di Paolo e Francesca, di Ciacco, del sodomita Brunetto Latini, del suicida Pier della Vigna, del conte Ugolino che mangiò i figli, del fatto che Dante mise Maometto all'inferno, di Virgilio, di Beatrice appunto, di Cacciaguida, del pigro Belacqua, dell'invettiva di Dante con Sordello, di Maria Pia de' Tolomei, di Piccarda Donati. Insomma mi ricordo qualcosa, anche se poco. Ho delle vaghe reminiscenze. Sento molti altri autori più vicini a me per l'epoca, le tematiche, la cosiddetta affinità intellettuale. Di solito nei confronti di Dante ci sono due atteggiamenti contrapposti: 1) chi sa Dante a mente e lo ritiene fondamentale per la formazione culturale. 2) chi pensa che la Divina Commedia non dovrebbe essere insegnata nelle scuole.

Per avvicinare Dante ai giovani di oggi ci sono le pubblicazioni della Divina Commedia in prosa, che non sono uno scempio né un'assurdità. Si possono acquistare con poche decine di euro. Lo so che alcuni insegnanti hanno la loro impostazione. Devono insegnare agli studenti che quella terzina incatenata Niccolò Tommaseo la interpretava in un modo, mentre invece Francesco de Sanctis in un altro. Se invece per esempio compri il Decameron in prosa moderna (si pensi alla curiosità dei corsi e ricorsi storici e di quanto con la pandemia il Boccaccio sia diventato di nuovo attuale), "tradotto" da Aldo Busi (ed è un grande merito), hai solo quell'interpretazione. Però forse hai un poco le idee più chiare. È vero comunque che la lettura di queste opere, attuali o meno, devono aiutare a leggere la complessità attuale. Affrontare oggi il mondo significa sfidare la complessità. La scuola poi è questione più di prestazione che di competenza. Ma aver studiato qualche canto della Divina Commedia può aiutare a interpretare la realtà. La cultura poi, non dimentichiamolo, non è solo conoscenza esplicita da richiamare alla mente ed esporre in una conferenza, ma è anche conoscenza implicita. Ciò significa che anche delle nozioni ormai dimenticate possono essere considerate come basi della nostra formazione culturale. Anche libri letti e poi dimenticati hanno plasmato e plasmano i circuiti del nostro hardware intellettuale, delle nostre sovrastrutture intellettuali. Noi siamo anche i libri che abbiamo letto. Anche quelli possono salvarci. Quindi anche se è un poco noioso e a volte non se ne vede l'utilità pratica fa anche bene a uno studente sapere le differenze interpretative de "I promessi sposi" tra Angelo Marchese e Luigi Russo, tra chi riteneva che Manzoni credesse in un deus absconditus e chi in un deus ex macchina. Va anche bene imparare ciò che ha scritto la critica sulla redenzione etico-religiosa di Renzo nella notte sull'Adda oppure leggere attentamente l'ultimo capitolo de "I promessi sposi" e imparare che per Manzoni la realtà non è mai idilliaca, che l'idillio non esiste mai. In fondo, anche se preferisco altri autori stranieri, sapere qualcosa di Dante e Manzoni significa sapere qualcosa dell'Italia, degli italiani, di ciò che eravamo: capire come siamo diventati ciò che siamo oggi e capire qualcosa in più di noi. Se non ho fatto mai del male a una mosca (e la tentazione di fare del male agli altri talvolta ce l'avrei veramente, talvolta mi immagino di fare del male a chi non posso soffrire, ma poi desisto), se freno i miei impulsi aggressivi (anche bestiali) forse è anche per i libri letti, per le mie riflessioni su di essi. Ma i libri letti, un poco studiati e dimenticati fanno parte del nostro bagaglio, del nostro retroterra culturale. Ci riparano anche dal male che ci fa il mondo e la vita. Sono quelle pagine dimenticate ormai che forse ci permettono di metabolizzare il male. Forse qualcosa resta delle nozioni apprese a scuola, anche se solo inconsciamente e resta al di sotto della nostra soglia quotidiana di consapevolezza. In fondo i libri basta averli capiti, metabolizzati. Cosa importa se certe nozioni cadono nell'oblio? Certo bisognerebbe ripassare. Ma riprendere certi libri di scuola, ormai polverosi e incartapecoriti, mi immalinconisce, mi intristisce profondamente. Rimarrò con alcune dimenticanze e alcune lacune. Non dimentichiamocelo mai: ognuno ha le sue lacune, ognuno è analfabeta in qualche ramo dello scibile. A volte, certi termini di Dante e Manzoni saranno arcaici, desueti. A tratti la loro concezione del mondo ci sembrerà distante anni luce. In fondo anche se ci siamo dimenticati di quelle pagine, di quelle nozioni in un certo qual modo ci hanno formato come uomini e donne. Però trovo una forzatura bella e buona il fatto che fino a pochi anni fa per superare un concorso nello Stato dovevi sapere certe nozioni di letteratura italiana, un poco stantie, mentre invece gli esaminatori magari soprassiedevano su alcune nozioni basilari e imprescindibili riguardanti la professione di quell'impiegato. Così come trovo assurdo l'esame di maturità, come è concepito oggi. Il poeta Maurizio Cucchi qualche anno fa si stupì del fatto che all'esame oggi chiedono le stesse cose che chiedevano a lui decenni fa. La maturità è datata, retrograda. Ma gli insegnanti sono esenti da colpe se i programmi ministeriali delle materie non cambiano. Come rendere attuale la scuola? Come modernizzarla? È proprio alla scuola che si deve chiedere il compito di interpretare la realtà attuale? È la scuola che deve avere la missione di decifrare il mondo attuale? Cosa può dire la scuola sull'uomo contemporaneo e sul mondo attuale? Cosa far studiare ai ragazzi della storia a loro più vicina? Come distinguere tra cronaca e storia? Esiste forse un modo oggettivo? Assolutamente no.

Spesso è necessario almeno un secolo perché certi fatti storici vengano valutati con serenità di giudizio e imparzialità. Per valutare con obiettività e con equanimità i fatti spesso bisogna esserne distanti. Dico semplicemente che per esempio oggi gli storici non sarebbero sufficientemente equipaggiati di obiettività nel valutare il conflitto tra Israele e Palestina. Inoltre il susseguirsi degli eventi è incalzante, inarrestabile. Il mondo moderno è caratterizzato da un dinamismo impressionante. Di punto in bianco ecco presentarsi - quando nessuno se lo aspetta - una svolta epocale, per cui al momento è difficile fare disamine o trovare modelli esplicativi adeguati. Si pensi all'undici settembre. Fino ad allora quanti occidentali sapevano le distinzioni tra sunniti, sciiti? Ci eravamo a mala pena "abituati" alle istigazioni al suicidio per uccidere gli infedeli da parte di Khomeini e degli Ayatollah, ma non pensavamo certo che Bin Laden colpisse al cuore l'America. Tutto a un tratto ecco presentarsi una contrapposizione inaspettata tra la solita America gendarme del mondo e gli uomini-kamikaze della Jihad. Per il momento questa è attualità, è cronaca. Quanto tempo ci vorrà per metabolizzare questi fatti e farli divenire storia? Non è un caso quindi che ultimamente la ricerca storica sia in crisi. C'è addirittura chi propone la "microstoria", ovvero restringere il campo d'indagine a dei fatti e delle situazioni particolari e più facilmente documentabili.
E' chiaro che la storia non può essere mai totalmente obiettiva, ma lo storico può avvicinarsi asintoticamente all'obiettività. In questa sede non voglio nemmeno parlare dei libri sulla resistenza di Pansa. Alcuni rimuovono le testimonianze dei vinti e nascondono gli orrori generati dalla loro parte. Ma la verità viene sempre fuori. Nonostante i negazionisti, che sono i peggiori storici. Niente di nuovo sotto il sole: sono sempre esistiti. Attualmente esistono i negazionisti dell'Olocausto, così come i negazionisti delle foibe. Tempo addietro in Turchia esistevano anche i negazionisti del genocidio armeno da parte dell'impero ottomano, che oggi è stato riconosciuto sia dall'Onu che dal Parlamento europeo. In tutto questo bailamme mi sembra assurda la domanda che si pone Spengler ne "Il tramonto dell'Occidente", ovvero se la storia ha una sua logica. Non credo affatto che la storia abbia una sua logica, semmai infinite contraddizioni, orrori e atrocità. Si pensi che addirittura i nazisti hanno confezionato i paralumi con la pelle degli ebrei e i rivoluzionari francesi hanno conciato l'epidermide dei reazionari.
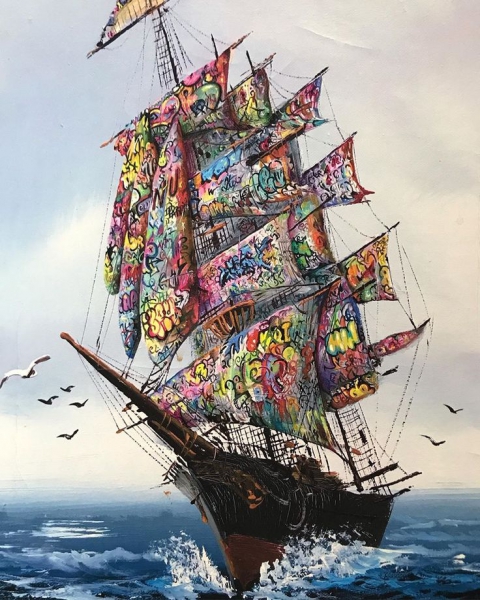
E quale deve essere il rapporto tra scuola e sapere scientifico? Cosa può insegnare oggi la scuola se molti studenti andranno domani a fare un lavoro che oggi ancora non esiste? Jung riguardo al rapporto tra i progressi della scienza e l'umanità aveva scritto: "i voli spaziali sono soltanto una fuga da sé stessi, perchè è più facile andare su Marte o sulla Luna che penetrare nel proprio io". In attesa di nuovi stadi evolutivi e di nuove fasi antropologiche l’uomo contemporaneo, la cui psiche non è più una struttura equilibrata e bilanciata, può dimenticare sé stesso nella prassi o nel nuovo misticismo del corpo, ma mai giungere alla sintesi degli opposti, mai approdare alla totalità, considerando lo iato tra natura e arte, tra natura e cultura, tra natura e civiltà. L’uomo contemporaneo non ha più la vitalità sufficiente per vivere il dionisiaco, né la saggezza per giungere all’apollineo. La società di massa e i media non aiutano. Le sensazioni, le informazioni, le notizie sono eccessive e invece di fagocitarle finiamo noi stessi per essere fagocitati da queste. Anche le quisquilie più irrilevanti, se si tratta di fatti che riguardano i vip, diventano cronaca. Poi interi massacri di popoli lontani vengono taciuti. D’altronde sono i paradossi della modernità. Decenni fa un radiodramma di Orson Welles fu scambiato per un notiziario e creò il panico perché molti americani cedettero che l’America fosse stata invasa dagli extraterrestri. Oggi nessuna notizia crea più scompiglio. In un attimo la novità si perde nel dimenticatoio. Sorel aveva profetizzato che la modernità sarebbe stata caratterizzata sostanzialmente dalla velocità e dalla violenza. Era stato lungimirante. Oggi infatti le notizie vengono presentate e scompaiono rapidamente e nella maggioranza dei casi trattano di cronaca nera. Tutto finisce per essere sciatto, ovvio, banale, risaputo. Un tempo certi libri vengono messi all’indice. Oggi niente fa più scandalo. I romanzi sono troppo lunghi per essere letti. Anche il minimalista e postmoderno Carver, maestro ineguagliabile della short story non è conosciuto al grande pubblico. Allo stesso tempo nessun saggista prova più un’indignazione per essere un vero pamphlettista. Il mondo è proteiforme. Nazioni, identità, appartenenze, culture stanno scomparendo. Il tessuto sociale si sta disgregando. Stanno scomparendo le comunità e la comunicazione fatica. L’individuo è atomizzato. La massa è anonima. Il potere è così neutro da apparire impalpabile. Su tutto prevale l’immagine, la cupidigia, il culto del denaro ed un’etica del lavoro, che se analizzata risulta riprovevole moralmente. La trilogia di Mastronardi (“Il maestro di Vigevano”, “Il calzolaio di Vigevano”, “il meridionale di Vigevano”) è eloquente a riguardo, illustra chiaramente la grettezza e l’arrivismo della borghesia votata esclusivamente al profitto. Questa è la civiltà dell’immagine e le masse sono idolatre, solo pochi solitari rabbiosi trovano la forza per essere iconoclasti. L’uomo contemporaneo non sa come utilizzare la libertà. Una libertà inaudita rispetto ai secoli precedenti, ma in fin dei conti una libertà apparente. Dostoevskij aveva già affrontato questa problematica. Paradossalmente potremmo anche concludere che se l’uomo utilizza la libertà come il protagonista di “Delitto e castigo” allora ben venga un Grande Inquisitore, che lo affranca da ogni tipo di libertà, perché ritiene l’uomo un essere immaturo e irresponsabile. La cultura occidentale si sta dissolvendo. L’America ha voluto colonizzare anche il nostro immaginario, volendo far credere nei loro film che gli americani hanno una villetta a schiera con tanto di barbecue e di canestro, i figli al college (che tra l’altro ha dei costi elevati perché non conoscono il significato dell’espressione “diritto allo studio”) , una moglie che va con le amiche a giocare al bridge e un ragazzo che ti porta il giornale ogni mattina. L’affluent society insomma, dimenticandosi di presentare al mondo i senzatetto senza uno straccio di assistenza sanitaria. Il declino è inarrestabile. Lo scrivo a costo di passare per catastrofista. Però noto che queste tematiche non sono contemplate dalle fraseologie dell’ortodossia culturale, che piuttosto cerca di giustificare l’esistente.
giu 262022
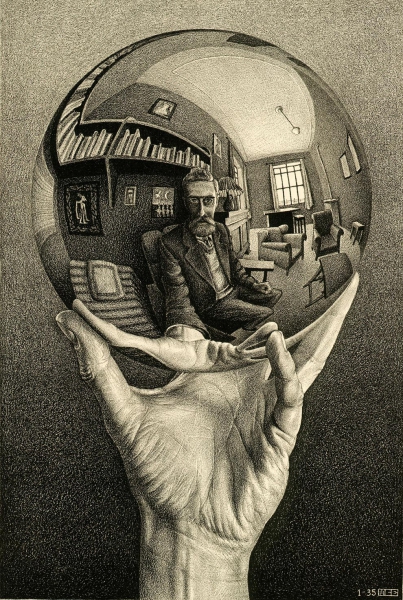
Il secolo, che ci siamo appena lasciati alle spalle, è stato un secolo policromo, ricco di ismi, correnti letterarie, correnti critiche. Per quanto riguarda la creatività letteraria si è assistito a una molteplicità di forme espressive e comunicative. Diverse sono state le correnti letterarie in Italia: il Decadentismo, il Crepuscolarismo, il Futurismo, l’Ermetismo, il Neorealismo, la Neoavanguardia, il Postermetismo, il Neosperimentalismo, il Neo-orfismo. Se consideriamo anche l'Europa bisogna ricordarci anche dell'Espressionismo, del Simbolismo, del Dadaismo e del Surrealismo. Non sono naturalmente mancate le polemiche, come quelle tra tradizione e Neoavanguardia e come quelle tra neorealisti e postermetici. Mai come nell’arco del ’900 la letteratura ha registrato dei mutamenti così radicali. Nel primo Novecento la letteratura italiana passò dall’estetismo dannunziano all’Ermetismo, che stilisticamente si distingueva per le sue analogie, le sue sinestesie e per l’assolutezza della parola poetica; da un punto di vista etico si registrava il passaggio dai vizi e dal lusso sfrenato di D’Annunzio a una letteratura - come quella ermetica - intesa come impegno e testimonianza civile. Se si considera le riviste questo cambiamento di rotta, questa svolta dal dannunzianesimo a un ruolo nuovo di letterato avvenne ancora prima. Infatti “La Voce”, nella prima fase diretta da Prezzolini, fu una rivista “militante”, che si pose problematiche filosofiche e sociali, come la questione meridionale e la politica del trasformismo giolittiana. In prosa si passò dagli epigoni del Verismo all’antiromanzo, cioè ad un romanzo-saggio in cui si dissolveva il personaggio e predominavano il contenutismo, i sociologismi e gli psicologismi. I protagonisti dei romanzi del '900 sono quasi tutti inetti e/o nevrotici a cominciare dai personaggi di Svevo. Ma nella maggioranza dei casi la causa del disagio esistenziale è ignota. Solo nel "Memoriale" di Volponi la paranoia del protagonista ha un motivo certo, ovvero l'espulsione dalla fabbrica a causa della tubercolosi.
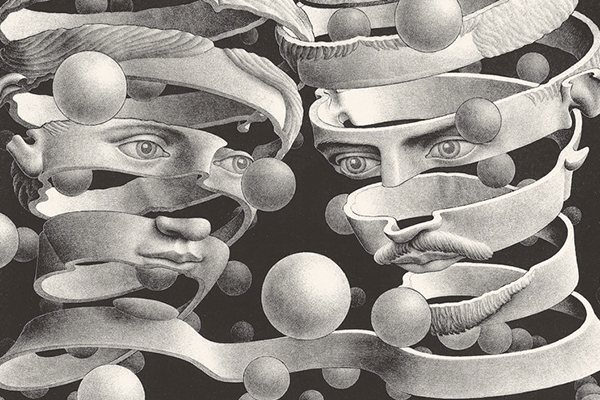
Molti scriveranno della nevrosi, ma Tobino con "Le libere donne di Magliano" sarà colui che affronterà il tema della follia nel modo più realistico. Uno dei pochi che resiste alla tentazione dell'inettitudine è Fenoglio. Per lui si tratta semplicemente di osservare e trascrivere ("see and transfer"), come riesce a fare magistralmente ne "Il partigiano Johnny". Raramente il malessere esistenziale dell'uomo contemporaneo passa in secondo piano. Le tematiche dell'inettitudine e della follia vengono però eluse da alcuni grandi romanzi del '900, che trattano in modo esemplare le conseguenze del nazi-fascismo: "Il giardino dei Finzi-Contini" di Bassani (l'emarginazione degli ebrei), "Se questo è un uomo" di Primo Levi (il lager), "Cristo si è fermato ad Eboli" di Carlo Levi (il confino). Durante il periodo della guerra e dell'immediato dopoguerra la letteratura italiana è contrassegnata dall'impegno morale e politico. L'unico che si concede un divertissment è Vasco Pratolini con "Le ragazze di San Frediano". Anche in poesia avvennero dei mutamenti radicali. Si passò dalle reminiscenze petrarchesche-leopardiane del Canzoniere di Saba a un frammentismo, talvolta prosaico. Il Novecento non è stato caratterizzato solo dall'originalità delle correnti letterarie, ma anche da quella dei singoli autori. Si pensi per esempio alle innovazioni introdotte da Ungaretti, che fu il creatore del versicolo. Nel Novecento comparve nel mondo della scrittura anche l'altra metà del cielo. Furono protagoniste della scena letteraria la poetessa Ada Negri ed Elsa Morante, che scrisse capolavori come "L'isola di Arturo" e "La storia". Ci si ricordi anche di Natalia Ginzburg, che in "Lessico famigliare" ritrasse l'ambiente culturale torinese antifascista, di cui fecero parte Pavese, Adriano Olivetti, Carlo Levi, Giacomo Debenedetti, Carlo Levi. Diverse sono state le correnti della critica: lo storicismo marxista, il crocianesimo, lo strutturalismo, la critica psicanalitica. Non vanno nemmeno dimenticati gli apporti più recenti della semiotica e dell’ermeneutica nell'ambito della critica letteraria. La letteratura nel secolo appena trascorso non è stata considerata solo a livello sintattico, stilistico, simbolico, ma i critici del ’900 hanno indagato a 360 gradi sul rapporto autore-opera e sul rapporto lettore-opera. Attualmente non è ancora possibile fare il bilancio del '900, valutare obiettivamente la portata di correnti letterarie e autori, stimare effettivamente l'eredità di questo secolo, appena trascorso. Può accadere anche che autori, che nel corso della loro vita ebbero fortuna critica, vengano dimenticati e che autori, che non conobbero grande notorietà un tempo, vengano rivalutati. Ciò sta in parte avvenendo con D'Arzo, Silone, Comisso, Brancati, Manganelli, Guido Morselli, D'Arrigo. La letteratura del ’900 è stata contrassegnata da innumerevoli svolte epocali e da profonde trasformazioni. Tutto ciò per aderire maggiormente alle realtà sociali, economiche, politiche, antropologiche di un secolo colmo di errori, orrori, nefandezze di ogni genere. Tutto ciò per riuscire a decifrare la successione, mai fino ad allora così veloce, di avvenimenti. Il Novecento è stato un secolo intenso; ricco di paradossi e rompicapi da risolvere, di enigmi da decifrare.
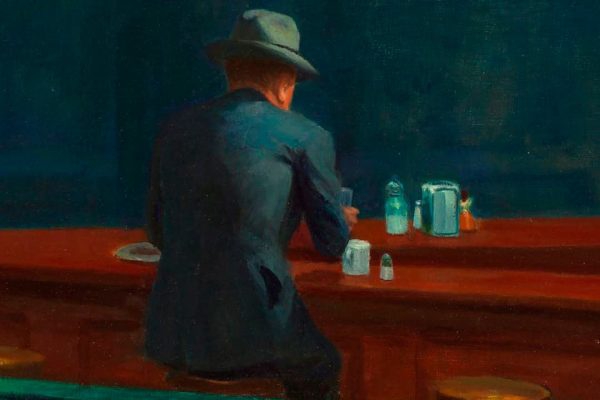
Illustri filosofi hanno cercato di rintracciare la causa principale della crisi della modernità. Freud scrisse del "disagio della cività", Max Weber della "gabbia di acciaio". Per Nietzsche l'origine di tutti i mali è il nichilismo, per i marxisti il plusvalore, l'alienazione, i rapporti di produzione, i mezzi di produzione, per i cattolici la secolarizzazione, per gli esistenzialisti l'angoscia della scelta. Per Husserl il mancato ritorno al mondo della vita, per Mounier l'individualismo, per Dewey il fatto che il mondo sia aleatorio e rischioso. Per Niezsche Dio è morto, gli strutturalisti invece annunciano la morte dell'uomo. Ma forse non esiste una sola causa alla crisi della modernità. Forse sono molte le cause. La letteratura italiana del '900 ha cercato di intraprendere la sfida al labirinto gnoseologico-culturale, di cui parlò Calvino. Una sfida difficile, ma allo stesso tempo anche affascinante. La letteratura italiana del '900 proprio come uno dei personaggi più famosi di Pirandello - il fu Mattia Pascal - ha dovuto rischiare più volte il proprio patrimonio (in questo caso la propria tradizione) come chi gioca al casinò, darsi per morta e cambiare identità per ritrovarsi e ritrovare il senso di un mondo, sempre più arcano e sfuggente. Talvolta ha assunto rischi folli in modo ludico, presentando i lati più grotteschi e più comici della realtà. Si pensi ad esempio a Landolfi, a Zavattini, a Malerba, ad Achille Campanile, a Cavazzoni.
giu 262022
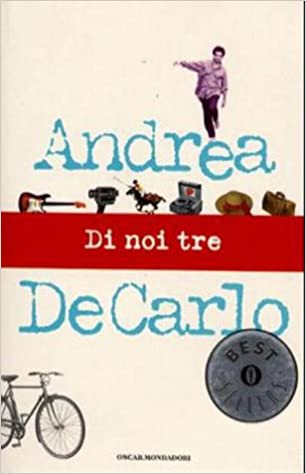
Vi consiglio di leggere due romanzi sulla giovinezza. Il primo è "Di noi tre" di Andrea De Carlo, che ha una trama avvincente e che si legge tutto di un fiato. L'io narrante è Livio, ma i protagonisti sono tre: Livio, Misia, Marco. Il primo ha appena discusso la tesi in storia antica e ha polemizzato con la commissione di laurea. La stessa sera incontra Misia. Livio rimane colpito da questa ragazza bionda nel marasma di una cantina (dove si balla) perché emana "una luce speciale", "un'aria luminosa", "una naturalezza leggera". Per arrivare a conoscerla si intromette addirittura nella lite tra lei e il suo ragazzo, subendo l'aggressione del tipo. Poi Livio inizia a frequentare assiduamente Marco, che lo vuole coinvolgere in uno dei suoi tanti progetti strampalati: fare un film senza alcun tipo di finanziamento. I due devono perciò trovare attori non protagonisti, organizzare la troupe, scrivere la sceneggiatura, decidere la scenografia, gli interni e gli esterni. Livio presenta Misia a Marco e la coinvolge nel film. A questo punto Livio avverte che tra Misia e Marco è nata un'intesa. Della sofferenza causata da questa delusione sentimentale non c'è traccia nel libro. Livio è come se rimuovesse questa frustrazione. Comunque quest'ultimo diventa un pittore affermato grazie all'interessamento di Misia, che riesce a organizzare una mostra dei suoi quadri. Anche il film ha successo e porta alla ribalta Marco come regista e Misia come attrice. Marco addirittura diventa quasi un mito, prigioniero del suo stesso personaggio. Rifiuta la mondanità, detesta l'ambiente dello spettacolo, rifiuta lavori. Non voglio però raccontare tutta la trama. Dirò solo che i colpi di scena si susseguono tra Barcellona, Londra, Buenos Aires. A mio avviso le tematiche di questo romanzo sono due: 1) l'amicizia tra i tre che riesce anche a destare dal torpore esistenziale Livio, il quale alla fine riesce a dominare i propri sbalzi di umore (muovendosi rasoterra, così basso che non ha nessun posto dove cadere...De Carlo cita questo verso di Bob Dylan). 2) la critica nei confronti della società moderna in cui tutti si vendono: chi vende il corpo, chi l'intelletto, chi la dignità. Tuttavia le scelte di vita di tutti i protagonisti sono antitetiche a questa legge di mercato.
A mio avviso questo è un libro da leggere. Sono a conoscenza naturalmente che molti critici letterari storcono il naso ogni volta che si parla di un libro di Andrea De Carlo perché le sue opere vengono considerate troppo commerciali. De Carlo infatti è uno dei pochi che riesce a vendere senza essere un letterato e neanche un personaggio televisivo. Probabilmente alcuni invidiano allo scrittore la prolificità. Secondo me questo è il suo romanzo migliore. Riguardo a De Carlo sono dell'idea che avessero ragione Italo Calvino, che fu il suo talent scout, e Carlo Bo, che lo criticò positivamente.
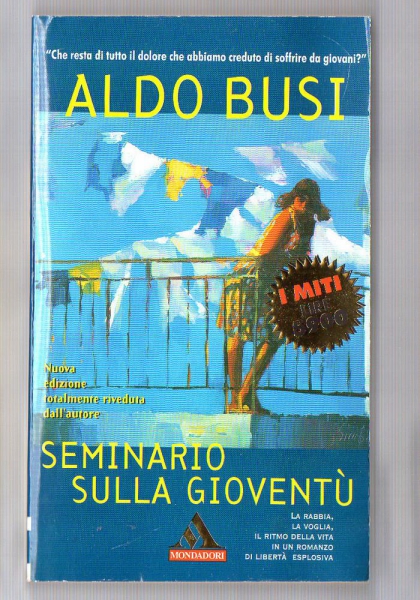
Il secondo romanzo è "Seminario sulla gioventù" di Aldo Busi. La frase che mi ha colpito di più di questo capolavoro è l'incipit del libro: "Che resta di tutto il dolore che abbiamo creduto di soffrire da giovani? Niente, neppure una reminiscenza". Il tempo e la maturità rimarginano ferite ritenute allora letali. Ma il vero fulcro del romanzo è lo stesso Busi, che ci mette dentro il corpo, l'animo, la rabbia, la disperazione, il cinismo, l'ironia disincantata. Tra un susseguirsi di mestieri per mantenersi, tra una ricaduta del trigemino e un incontro furtivo, Busi ci spiega tutti i meccanismi di quello che lui chiama "sessualterrorismo". Come scrive Busi uno fa tanta fatica "per sfuggire allo scemo del villaggio e al genio, e si ritrova giullare di una fighetta turistica". Il protagonista infatti per riuscire a barcamenarsi, pur essendo omosessuale, si fa mantenere da Arlette, sopportando a stento le sue amiche con le loro vanità, narcisismi e frivolezze. Il protagonista in un crescendo di insofferenza nei confronti del perbenismo si vendica dei suoi amanti, borghesi dalla reputazione immacolata, con ricatti e stoccate. Il protagonista esamina a fondo l'emarginazione che subisce dalla società e analizza i vizi segreti di coloro che sono insospettabili, pur avendo una doppia vita. Un'altra felice intuizione di Busi è la seguente: "le vere personalità sono quelle inventate: non c'è grandezza dove non c'è violenza". Come a dire che Busi è diventato un grande scrittore perché ha dovuto sopportare e accettare persone e mestieri, che se avesse avuto la possibilità di scegliere avrebbe rifiutato categoricamente.
Alcuni potrebbero chiedersi perché leggere questi due romanzi. A mio avviso servono a far riflettere in questo mondo dove tutti vanno di corsa e dove le menti non fanno altro che immagazzinare dati. Questi due romanzi fanno riflettere: fanno riflettere sulla giovinezza. Penso proprio che potrebbero essere definiti due romanzi generazionali. Non solo ma non sono mai noiosi. Non sono certo pretenziosi e non sono assolutamente due metaromanzi, genere in voga tra gli intellettuali. Inoltre Cioran scrisse: "quello che so a sessanta anni lo sapevo altrettanto a venti. Quaranta anni di un lungo, superfluo lavoro di verifica...". Ebbene a mio modesto avviso tutti abbiamo bisogno di fare questo "superfluo lavoro di verifica", anche se potrebbe sembrare paradossale di primo acchito. Talvolta non c'è niente di così necessario delle cose apparentemente superflue.
giu 262022
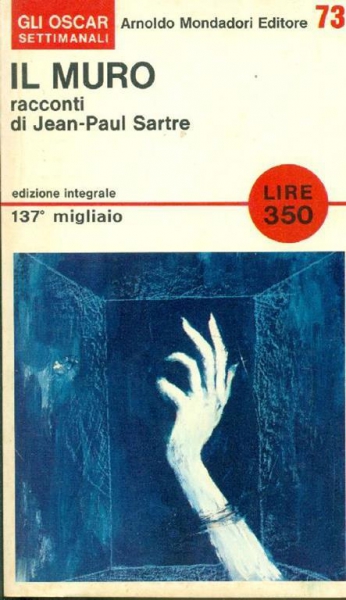
Ritengo sia interessante paragonare “La nausea” di Sartre a un suo racconto, pubblicato un anno dopo, intitolato “Il muro”. Ne “La nausea” il protagonista Roquentin, dopo aver viaggiato per il mondo, si trova in una cittadina a fare ricerche storiche su un personaggio minore del Settecento. Queste ricerche lo portano spesso alla Biblioteca dove conosce l’autodidatta, che si erudisce leggendo per ordine alfabetico gli autori. L’autodidatta è una figura importante del romanzo perché il suo atteggiamento nei confronti dell’umanità è agli antipodi di quello del protagonista. L’autodidatta dichiara di essere socialista e di amare l’umanità. Pur tuttavia gli ideali non trovano corrispondenza nella vita dell’uomo, che viene addirittura scoperto a molestare un ragazzo in biblioteca. Roquentin ha viaggiato per tutto il mondo. Ma se è vero che per Sartre alla nausea si può contrapporre solo l’avventura, è altrettanto vero che il protagonista guardandosi indietro si rende conto di aver avuto solo storie e non avventure. Da quattro anni si è lasciato con Anny, la sua donna, che nel frattempo è diventata un'obesa depressa. Anny non gli interessa più, così come non gli interessano più le sue ricerche storiche. Mentre scrive questo capolavoro, Sartre ha in mente la sua filosofia dell’ “uomo solo”. Ma quest’opera, strutturata come un romanzo poliziesco, è anche un feroce attacco alla borghesia. La nausea causa nel protagonista l’estraneità degli oggetti, la percezione distorte delle cose e della propria immagine. Non riesce nemmeno a conciliarsi con l’immagine che gli rimanda lo specchio: un uomo addirittura estraneo a sé stesso. A mio avviso la nausea è dovuta principalmente alla illogicità dell’esistenza. Per dirla in termini esistenzialisti è determinata dal riconoscimento della “deiezione”, cioè dal fatto dell’essere gettati nel mondo senza saperne il motivo. Non solo, ma Sartre in questo suo capolavoro registra fedelmente lo scarto tra la richiesta chiarificatrice e classificatrice della logica umana e l'aspetto frammentario e dispersivo della realtà. Roquentin è sospeso tra solipsismo e scetticismo. Ma non ha certezze né riguardo al proprio modo di essere né riguardo al mondo esterno. Sartre svela sia la fallibilità della conoscenza interiore che la limitatezza e la pochezza dell'agire umano. Il rapporto tra protagonista ed esperienza non è però solo quello del divenire temporale, ma è anche quello della negazione di ogni forma di relazione tra simili. Mi viene in mente l'esistenzialismo positivo di E.Paci, filosofo oggi ormai dimenticato. Per Paci non è possibile essere soltanto idealisti (cioè prendere in esame solo "il pensiero per il pensiero") né soltanto esistenzialisti (cioè considerare solo "l'esistenza per l'esistenza") né avere soltanto dei presupposti etici (cioè considerare solo "il valore per i valori"). Bisogna invece attuare una sintesi tra queste tre sfere dell'universo umano. Sartre per tutto il romanzo analizza solo il pensiero e l'esistenza: è invece totalmente assente qualsiasi fondamento etico, che possa risollevare Roquentin. Il protagonista de “La nausea” non ha un’ideale per vivere. Questa sarà poi l’unica ancora di salvezza secondo Sartre, che infatti successivamente scriverà in un suo saggio: “l’uomo è costantemente fuori di sé; solo progettandosi e perdendosi fuori di sé egli fa esistere l’uomo e, d’altra parte, solo perseguendo fini trascendenti”.

Ma nel suo racconto “Il muro” Sartre fa sfoggio di un umorismo tragico, che era totalmente assente nel suo primo capolavoro. Qui il protagonista è un anarchico spagnolo, condannato a morte per le sue idee. Viene messo in una cella con altri due condannati e deve passare la notte più lunga della sua vita: all’alba lo fucileranno. La luce entra da alcuni spiragli e da piccola apertura sul soffitto, da cui si può intuire uno squarcio di cielo. Ma il cielo non comunica né simboleggia niente. Ha la morte nell’anima, ma non ha paura di soffrire. Gli altri sono sempre l’inferno e la compassione lo disgusta. Oramai è preparato a morire perché passare tutta la notte ad aspettare la morte significa “vivere venti volte l’esecuzione”. Nonostante questo il protagonista ritiene che morire sia la cosa meno naturale del mondo. Non ha nemmeno più ideali. Dell’anarchia e della liberazione della Spagna non gli interessa più niente. Al mattino però gli danno un’opportunità: deve scegliere se essere fucilato o dire dov’è il suo amico Gris. Il protagonista sa che Gris si è nascosto in casa dei suoi cugini, ma nonostante questo preferisce morire. E prima di morire ha una trovata comica. Vuole gabbare i soldati, dicendo che Gris si trova al cimitero. Vuole immaginarsi la scena di quegli uomini in uniforme che corrono tra le tombe.

Ma Gris ha abbandonato la casa dei cugini e si è rifugiato davvero al cimitero. Il protagonista ha salva la vita. Mi viene naturale paragonare la notte insonne che passa il protagonista de “La nausea” in un albergo di commessi viaggiatori a questa notte terribile, che passa il protagonista de “Il muro”. E’ questa la chiave di volta per capire il rovesciamento di prospettiva che Sartre attua in questo breve racconto. Ne “La nausea” il grande scrittore fa un’analisi minuziosa dei paradossi dell’esistenza, scrive una fenomenologia del disagio interiore. Il protagonista tuttavia ha libertà di scelta e d’azione. Ne “Il muro” invece si trova di fronte al paradosso dei paradossi della vita: la morte che nullifica ogni scelta e ogni malessere interiore. Il filosofo Adorno a proposito dell’esistenzialismo scrisse che la scelta alla fin fine era tra crepare o crepare. E se per K. Jaspers l’uomo di fronte alla morte si può aggrappare alla fede, molto più difficoltoso è il rapporto con la finitezza e la precarietà dell’esistenza per un esistenzialista ateo come Sartre. Ma viene in soccorso la trovata comica e il protagonista si salva, ridendo dell’assurdità dell’esistenza e della morte. Sartre ne "Il muro" dà scacco matto alla nausea e alla morte.
giu 252022
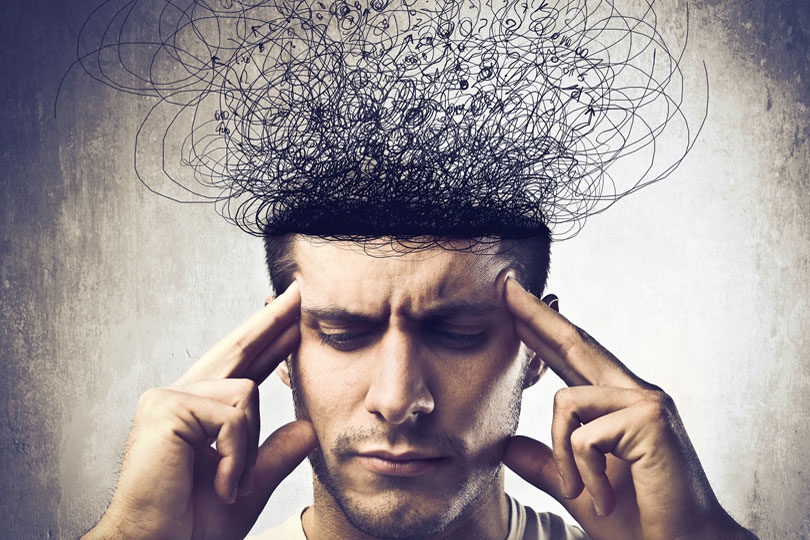
Epitteto nel "Manuale" scrive: "Tra le cose che esistono, le une dipendono da noi, le altre non dipendono da noi. Dipendono da noi: giudizio di valore, impulso ad agire, desiderio, avversione, e in una parola, tutti quelli che sono propriamente fatti nostri. Non dipendono da noi: il corpo, i nostri possedimenti, le opinioni che gli altri hanno di noi, le cariche pubbliche e, in una parola, tutti quelli che non sono propriamente fatti nostri."
Il teologo protestante Niebuhr nella sua "Preghiera della serenità": "Dio, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso, e la saggezza per conoscerne la differenza".
Noi esseri umani rispetto agli animali abbiamo un maggiore margine di libertà. Noi abbiamo dei riflessi che fisiologicamente sono degli automatismi dei muscoli o dei nervi a degli stimoli esterni. Si pensi al medico che ci controlla i riflessi per vedere il nostro stato di salute. Ma molto probabilmente non abbiamo degli istinti come gli animali. Sembra infatti che non ci siano più schemi innati nella nostra specie. Anche il sesso sarebbe appreso. Oggi si ritiene che gli uomini abbiano delle pulsioni, freudianamente intese. Al massimo bisognerebbe distinguere tra pulsione e bisogno. La fame, la sete e il sonno sono dei bisogni. Il sesso e l'aggressività sono delle pulsioni. Il bisogno è sempre impellente. La pulsione non è una necessità. Uno può avere anche voglia di fare sesso ma rimandare oppure non fare sesso. La vera coazione a ripetere è il bisogno. Quindi sembra che le pulsioni ci offrano una maggiore scelta. Comunque non c'è da rallegrarsi troppo. Sembra infatti secondo la scienza che siamo molto più determinati di quello che si credeva un tempo quando si credeva molto di più nel libero arbitrio. Siamo determinati biologicamente, storicamente, economicamente, socialmente e culturalmente. Siamo determinati quindi anche dall'ambiente. Un tempo tutto ciò si chiamava destino. È l'antica disputa tra determinismo e libero arbitrio. In psicologia le persone che hanno un locus of control interno pensano di essere artefici del loro destino. Coloro che hanno il locus of control esterno invece sono fatalisti. Secondo recenti studi coloro che hanno il locus of control interno reagiscono meglio alle malattie, agli eventi traumatici, alle situazioni avverse. Nel caso fosse un'illusione pensare di poter avere il controllo per alcuni è un'illusione necessaria. Ma il libero arbitrio, se esiste, ha un certo range. La libertà ha un suo margine. Nessuno riesce a riconoscere con esattezza la linea di demarcazione tra cose che dipendono da noi e altre che non dipendono da noi. Ci sono cose più grandi di noi: questo è accertato. Il libero arbitrio, sempre se esiste, non è circoscrivibile; è indefinito.
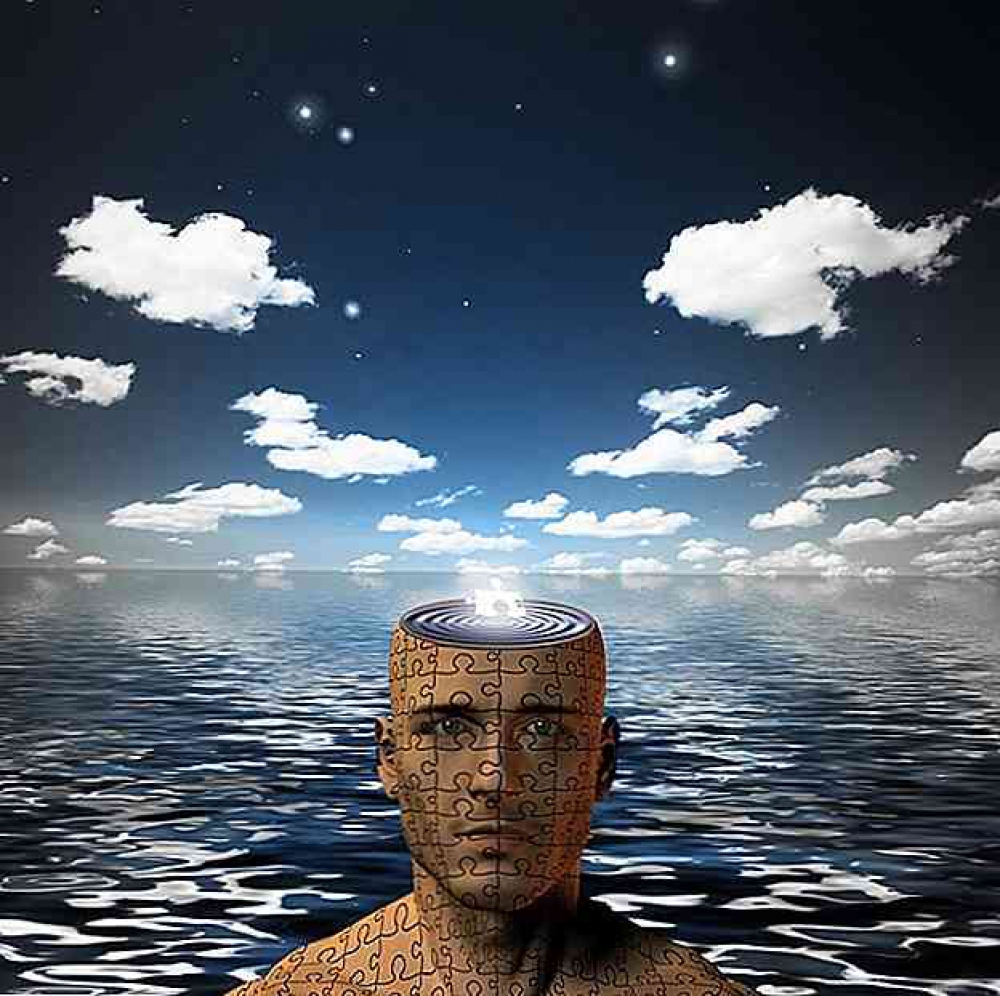
Quando facevo l’università e studiavo gli esami di Fondamenti anatomo-fisiologici e Psicologia Fisiologica mi toccava studiare un tomo, che si intitolava “Principi di neuroscienze” di Kandel e dei suoi collaboratori. A volte mi chiedevo dove fosse localizzato il pensiero umano, da dove nascesse. Si sapeva già allora che l’area del piacere era costituita dal nucleo accumbens e dall’area tegmentale ventrale, che esisteva una corteccia visiva, che esisteva una corteccia motoria, che l’ippocampo fosse fondamentale per memorizzare. Ma mi chiedevo dove nascesse il pensiero e non trovavo risposte. Secondo i cognitivisti la mente era come un computer, un elaboratore di informazioni, e io mi chiedevo chi l’avesse programmata. L’ipotesi più plausibile è che il pensiero non sia localizzabile ma sia generato dall’intera mente. Ho letto recentemente un articolo scientifico della prof. Maria Pia Viggiano, secondo cui le attività cerebrali, i processi chimico-fisici del cervello determinano ogni “presa di decisione”, ogni nostra intenzione. Tutto ciò è scientificamente provato. Non a caso la prof. Viggiano cita gli studi di Benjamin Libet. Gli esperimenti di Benjamin Libet ci lasciano perplessi e allibiti. Da essi scopriamo che gli esseri umani agiscono in base a dei processi che li portano a decidere 500 millesimi di secondo più tardi dell’attivazione neurale che predispone alla decisione stessa. Secondo le parole della dott.ssa Irene Sanità Gigante: "Il cervello, con un’onda che corrisponde alla “preparazione dell’azione”, anticipa di 500 millisecondi la “sensazione di consapevolezza dell’azione”. Quindi il cervello prepara l’azione prima che l’individuo senta la necessità di compierla". Però allo stesso tempo Libet ha scoperto che noi stessi possiamo inibire l’azione. Questo lascia spazio a molti dubbi interpretativi. Qualcun altro studioso ci ricorda naturalmente che i pensieri a loro volta causano altre reazioni chimiche nel cervello. Cosa è che precede il pensiero? La coscienza o l’inconscio? I ricercatori toscani Massimo Cincotta e Fabio Giovannelli scrivono in un articolo scientifico che “il nostro agire è frutto dei processi inconsci”. Mi viene in mente la volontà di Schopenhauer, ovvero quella forza cieca e irrazionale, che domina il cosmo. Forse è quella che governa la nostra mente. Secondo alcuni studiosi il pensiero nasce da stimoli esterni. Anche se siamo al buio e in silenzio a fare meditazione in una stanza i pensieri scaturirebbero allora da uno stato di deprivazione sensoriale momentanea. Insomma il pensiero non nasce dal nulla. È il classico circuito… sensazione, percezione, pensiero. Ma in fondo percezione, pianificazione, esecuzione sono dovute all’intera attività del nostro cervello. Il pensiero può nascere dalla esperienza oppure dalla riflessione.

Molti pensieri sono frammentari, raggiungono appena la soglia di coscienza, sono effimeri, sfuggono irreprensibili dopo qualche istante, vengono subito dimenticati: fa parte della natura umana. Spesso i nostri pensieri sono già stati pensati da altri. Vygotskij trattò del nostro linguaggio interiore, dimostrando che quel monologo ininterrotto, quel discorrere tra sé e sé sarebbe risultato incomprensibile agli altri. Così scriveva in “Pensiero e linguaggio” (1990:363; 365): «La prima e la più importante caratteristica del discorso interno è la sua particolarissima sintassi. […] questa particolarità si manifesta nella frammentarietà apparente, nella discontinuità, nell’abbreviazione del discorso interno rispetto a quello esterno. [C’è] una tendenza assolutamente originale all’abbreviazione della frase e della proposizione, nel senso che conserva il predicato e le parti della proposizione che gli sono legate a spese dell’omissione del soggetto e delle parole che gli sono legate.” È molto difficile avere dei pensieri originali. Forse esiste il mondo delle idee platoniche che è lo stesso per tutti gli uomini e non possiamo che “pescare” in quel mare magnum. Poi ci sono diversi pensieri che scaturiscono da ruminazione oppure da schemi prefissati. Non tutti i pensieri sono validi. Ci sono anche le ossessioni, le idee fisse, che sono disfunzionali per ognuno. A ogni modo la nostra mente di solito vaga, va di palo in frasca. Virginia Woolf, Faulkner, Joyce ci hanno mostrato come vaga la mente di ognuno col flusso di coscienza. Il grande poeta Auden ha descritto in modo magistrale sia la condizione esistenziale che lo stato mentale ricorrente dell’uomo contemporaneo, condensando tutto in poche parole: “I suoi pensieri vagavano giù e su dal sesso a Dio senza punteggiatura”. Ma siamo così sicuri che sia la mente a generare i pensieri oppure Qualcosa o Qualcuno più grande? Per Aristotele Dio era “pensiero di pensiero”. Oppure riusciremo a pensare quando ci accordiamo con “l’anima del mondo” descritta da Platone. E se i nostri pensieri fossero governati più dal Caso che da una causalità con il mondo esterno? Tom Wolfe in “La bestia umana” sostiene: “Dato che la coscienza e il pensiero sono prodotti interamente fisici del tuo cervello e del sistema nervoso, e dato che il tuo cervello arriva alla nascita con un imprinting completo, che cosa ti fa pensare di avere un libero arbitrio? Da dove dovrebbe venire? Quale “fantasma”, quale “mente”, quale “io”, quale “anima”, quale qualsiasi cosa che non si faccia immediatamente catturare da quelle sprezzanti virgolette dovrebbe traboccare spumeggiante dal calice del cervello per offrirtelo?”. Forse il libero arbitrio è solo una illusione, forse è tutto predeterminato. Mi ricorda Cioran che in “Sillogismi dell’amarezza” scrive che un matto gli aveva detto: “Quando mi faccio la barba, chi mi impedisce di tagliarmi la gola, se non Dio?”. A quei tempi i rasoi erano molto affilati e perciò pericolosi. Vasco Rossi, lettore di testi filosofici, riprende pari pari questo interrogativo di Cioran e in una canzone scrive: “Tra farmi la barba e uccidermi che differenza c’è?”. Quelli che Freud definiva Eros e Thanatos non sono anch'essi, se esistono, delle idee che generano altre idee? Ma l’impulso vitale o il desiderio di morte, che siano istinti o meno, da cosa derivano? Mi dico a volte che anche il nostro ambiente non dipende da noi e probabilmente siamo ben poca cosa perché niente dipende da noi. Forse il libero arbitrio è necessario perché è necessaria l’illusione del controllo. Forse la circolarità è infinita. Forse è tutto un regresso all’infinito delle cause e non si riesce a rintracciare, identificare la causa prima. Forse i nostri pensieri dipendono dal trauma della nascita, così come ogni nostra nevrosi, come descritto da Otto Rank. Forse è in quel caos di luce e rumore che nascono i primi pensieri del neonato. E se tutto fosse causato da eventi precedenti la nostra vita fetale? Dopo anni di riflessione e letture sono punto e a capo, in una situazione di stallo. Questa grande problematica dell’origine del pensiero non trova risposte certe. Questa è la domanda delle domande per un razionalista e ha come conseguenza la presa di coscienza di una certa irrazionalità della vita umana e del mondo. La nostra razionalità è molto limitata, addirittura è probabile che sia una falsa certezza. Ma ciò non ci deve far aggiungere irrazionalismi gratuiti a già tanta irrazionalità. Non ci sono certezze assolute ma solo ipotesi più o meno plausibili. Il pensiero umano ha molte implicazioni filosofiche e psicologiche. Forse non si possono studiare i cervelli umani con il cervello e i pensieri umani con i nostri stessi pensieri: forse ci imbattiamo di fronte ad un eterno Uroboro. Forse brancoliamo nel buio e per comodità postuliamo la libertà e di conseguenza la responsabilità delle nostre azioni. Se il futuro fosse già scritto, se tutto dipendesse dal destino allora che senso avrebbe la giustizia umana? Forse è fuori luogo fare dei parallelismi con il mondo della microfisica e ritenere che l’uomo è indeterminato come una particella subatomica. Forse le particelle subatomiche sono indeterminate per i limiti intrinseci degli strumenti fisici attuali e lo sono solo adesso, allo stato attuale delle conoscenze. Forse tutto dipende dal caos o da Dio, anche se io fatico spesso a vedere una intelligenza superiore in tante atrocità umane e fatico spesso a intuire armonie prestabilite.
giu 242022

Monod ne "Il caso e la necessità" parla di "male dell'anima" dell'uomo contemporaneo. Per farla breve sono la mancanza di animismo (cioè non pensare più che le cose, gli animali, la natura abbiano anch'esse un anima) e il postulato di oggettività a causare il malessere dell'uomo odierno, secondo Monod. Insomma è colpa della scienza e a dirlo non è un umanista ma uno scienziato, un premio Nobel. In parole povere il vero male dell'anima è che l'uomo considera sé stesso e il mondo ormai senza anima. Nemmeno l'anima del mondo esiste più. Forse l'anima delle cose e del mondo erano riflessi dell'anima dell'uomo, ormai non pervenuta, scomparsa. Forse il problema è che noi siamo, le cose sono, la vita è e l'essere, qualsiasi essere, è dolore. Forse il dolore è anche dovuto a ciò che non siamo, a ciò che le cose e la vita non sono. Forse il male risiede, come intuì Pessoa, nella "stanchezza di esistere delle cose". In Montale abbiamo " il male di vivere", "l'anello che non tiene". Ungaretti in "La pietà" si sente "esiliato in mezzo agli uomini" e "Attaccato sul vuoto/ Al suo filo di ragno,/ non teme e non seduce/ se non il proprio grido". Eliot scrive "La terra desolata". Nessuno quindi sa con certezza se il male è nell'anima o nella vita. Nessuno sa qual è la radice del male. Tutto ciò è al di fuori della nostra portata. Di certo si sa che spesso il male sembra avere il sopravvento. C'è una quota parte di male ineliminabile, inestirpabile. Kant lo chiamava male radicale. Cristianamente il male esiste per tre motivi plausibili: 1) perché fa parte di un disegno divino imperscrutabile e non comprensibile all'uomo 2) per l'esistenza del diavolo 3) perché Dio ha dato il libero arbitrio all'uomo.
Forse per uno solo di questi motivi, forse per tutti i motivi. Fatto sta che siamo sempre circondati dal male. Ma cosa è il male? Il male può essere inteso sia come dolore, ingiustizia, peccato, mancanza, non essere, privazione del bene. Come rapportarsi a esso? Quale senso dare al male?
Per il poeta Maurizio Cucchi "il male è nelle cose" come il titolo omonimo del suo primo bel romanzo, il cui brano è molto eloquente: "Comunque, secondo me, le cose ci sono, ci sono e basta. La colpa non è di che le trova, e forse neanche di chi le adopera. In fondo il loro potenziale è sempre nel programma. E forse il male è proprio nel programma. L’uomo non crea un bel niente" (p.90).
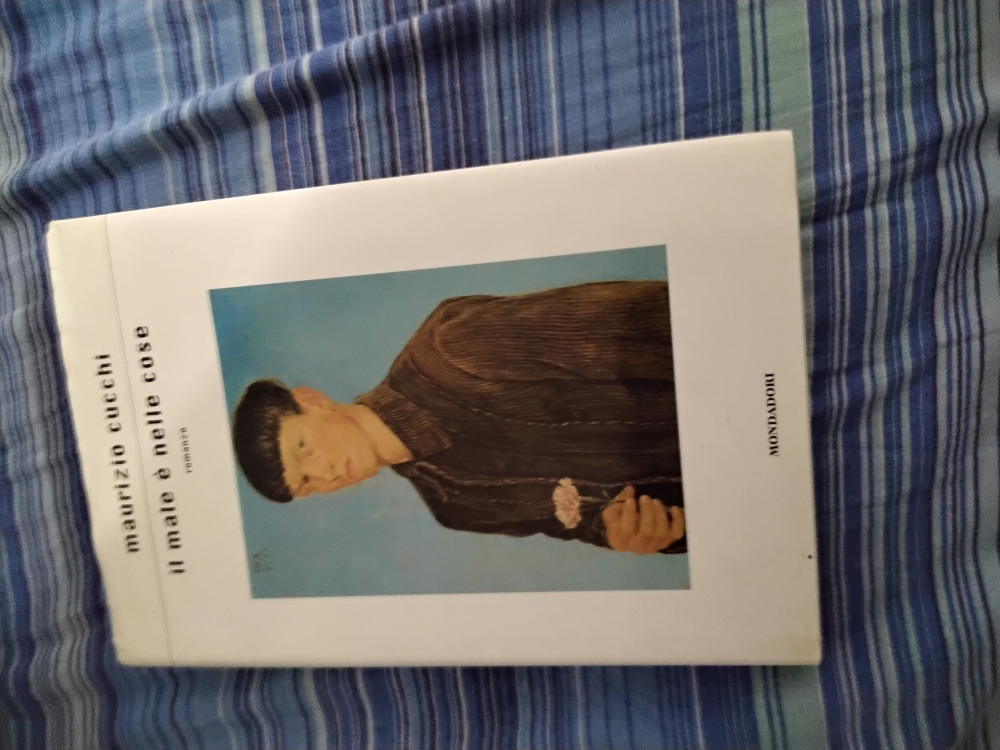
La colpa è quindi del programma, ovvero della vita e del mondo: ipotesi più che plausibile. E da questo che proviene tanto disagio? A ogni modo il romanzo di Cucchi è da leggere perché la narrazione è sapiente e non è per niente un concione. È un bel libro, scritto bene. Ne rileggo spesso alcuni brani. Penso che Cucchi come posatore sia sottovalutato, se consideriamo tutti i suii brani, a partire da "Il viaggiatore di città". Ogni giorno comunque la solita noia, il solito smarrimento, la solita estraneità. Poi la notte giunge improvvisa ad addormentare noi e le cose. Abbiamo un'anima rabberciata per la vita odierna. Potremmo affermare che questa vita moderna è senza anima. E se il male fosse dappertutto, sia nell'uomo che nelle cose? L'uomo fa male alle cose. Le cose fanno male all'uomo. L'uomo usa le cose per fare del male. Il circolo è vizioso. Per Husserl bisogna "ritornare al mondo della vita", mettere tra parentesi la scienza. Bisognerebbe perciò percepire le essenze, riappropriarsi della quotidianità, cogliere la bellezza della natura. L'etnometodologia studia le conversazioni comuni, le pratiche, le interazioni della vita quotidiana. E se la vita però fosse altrove, come nel romanzo di Milan Kundera? E se il male fosse nell'inafferrabilità, dell'inattingibilità dell'esistenza? E se il cerchio non fosse destinato a chiudersi? Ci sono cose buone e belle. Ci sono cose cattive. Ci sono istanti buoni e cattivi. Bisogna anche cercare di difendersi dalle cose, dagli istanti, dagli altri cattivi. Bisogna anche saper chiudere gli occhi, saper tollerare, incassare, lasciar andare, lasciar passare. La vita può far male. Egoisticamente una persona che legge o che scrive si fa del bene momentaneamente, anche se il male sembra invincibile.

Forse il male sta nella morte di Dio (Nietzsche), nell'ingiustizia economica e nell'uomo ridotto a merce (Marx), nell'inautenticità dell'esistenza (Heidegger), nell'insensatezza e nell'aleatorietà dell'esistenza (Beckett, Ionesco), nella razionalità limitata (H. Simon), nella lotta per la vita (Darwin), nella civiltà repressiva e nella rinuncia pulsionale (Freud), nella crisi etica e nella perdita di valori (molti filosofi). Forse tutte le altre problematiche sono conseguenti a questi filoni di cose. Forse tutto origina dai mali individuati da Nietzsche, Marx, Heidegger, H. Simon, Darwin, Beckett, Ionesco, Freud, etc etc. Forse tutti gli altri derivano da essi, sono dei sottoproblemi. Di solito anche gli intellettuali privilegiano solo uno di questi aspetti della vita. Ci sarebbe bisogno invece di una cura che prevedesse tutti questi piani della realtà. Come sosteneva Federico II di Svevia bisognerebbe far vedere le cose come sono. Le cose però non sempre sono come appaiono. Poi il passaggio ulteriore è intuire l'essenza dell'apparenza e quindi manifestarla. Rendere evidenti le cose per quello che sono veramente è molto impegnativo. Ma ci sono anche le cose che non sono (gli "oggetti eterni" di Whitehead, ovvero le idee, i valori, le essenze). Scrive Remo Ceserani che Pascoli ha fiducia di "far parlare le cose". Ma per altri autori la coscienza è alienata e quindi non ci può essere corrispondenza veritiera con le cose oppure ontologicamente non si può giungere alle cose. Come scriveva Sant'Agostino "la verità abita nell'interiorità dell'uomo". Ma se l'interiorità è falsa, malata, alienata, inadeguata, lacerata tutto il resto percepito sarà tale anch'esso. Forse assistiamo all'impotenza delle parole. Le parole non sempre rappresentano fedelmente le cose. Il male è un corpo estraneo nell'uomo ma è anche un nemico interno. Infine bisognerebbe far vedere l'uomo come è e non è. Ma qual è con certezza la vera natura umana? L'uomo può essere bestiale o angelicato. Probabilmente l'origine di tutto è che siamo fatti male noi, ma anche le cose e il mondo. Bisognerebbe perciò fare piena luce sul male nostro e delle cose? Ne siamo davvero capaci? La letteratura sa trattare il male, lo sa affrontare, lo sa mostrare. Ma la letteratura non è mai un male. Poeti e scrittori si propongono di arrivare al fondamento dell'essere, intanto assumono un atteggiamento depressivo, nominano, sognando di ritornare nel ventre materno. Gli artisti cercano per tutta la vita quello che Borges chiamava un nuovo filone di cose. Però se non ci prepariamo al male esso ci prenderà totalmente alla sprovvista. È spesso all'improvviso che si presenta il male e per affrontare le cose bisogna essere sopratutto pragmatici. Non scordiamoci mai. La letteratura può rappresentare il male. Può condannarlo. Il male probabilmente è in me come nel mondo: è dappertutto. C'è violenza in me e nel mondo. Non ci si salva. Ogni istante almeno apparentemente è un bivio. Si brancola nel buio. Le certezze sono poche a onor del vero. La vita, stare al mondo è un compito arduo.
giu 242022

Negli anni Settanta andava di moda Marx. Molti facevano corsi accelerati di marxismo, studiavano i riassunti dei riassunti senza leggere i libri di Marx e ciò nonostante si dichiaravano ferventi marxisti. Alcuni erano marxisti-leninisti. Altri erano maoisti. C’era chi leggeva Tronti, Panzieri, Toni Negri: i filosofi e politici dell’operaismo italiano. C’era chi si dichiarava gramsciano perché voleva l’egemonia culturale della sinistra. A sinistra tutti volevano fare gli intellettuali organici, anche persone improvvisate. Per i riformisti era d’obbligo sapere la teoria keynesiana. Ancora oggi ci sono molti keynesiani tra i progressisti. Insomma ci voleva l’intervento pubblico per far ripartire l’economia. A destra andava di moda leggere Nietzsche e Heidegger. Il superomismo di Nietzsche poteva portare all’autoesaltazione. Nietzsche non può però considerarsi responsabile del nazismo se non in modo molto indiretto, come del resto Marx per i regimi comunisti. Il pensiero di Nietzsche fu deformato dalla sua sorella e da Hitler. L’antisemitismo di Nietzsche inoltre non era dispregiativo e violento, ma basato sulla paura indotta dalla superiorità culturale ebraica. Molto probabilmente Hitler odiava gli ebrei per questioni personali e perché aveva letto il falso documento dei protocolli dei savi di Sion, non per colpa di Nietzsche. Heidegger era compromesso con il nazismo, ma non era nazista per quello che sosteneva, piuttosto per quello che non scriveva, per quello che ometteva. Per capire cosa è stato il nazismo bisogna leggere la Arendt e non Heidegger, ciò che la filosofa definisce banalità del male e ciò che scrive a riguardo del totalitarismo, anche se la sua concezione dello stato totalitario non è a mio avviso universale ma ancorata a quell’epoca e a quel contesto storico, sociale, politico. Heidegger quindi può essere letto da tutti. Non c’è bisogno di condannarlo a priori né a posteriori. Naturalmente Heidegger è un grandissimo filosofo, scrive cose molto profonde sul nichilismo, sull’esistenza, sull’arte, sul declino della società occidentale, che nessuno aveva detto prima di lui. Inoltre in Italia il miglior interprete e intenditore del filosofo tedesco è stato Emanuele Severino, uno studioso attento e molto equilibrato, che non ha mai travisato il pensiero di Heidegger. Sono state tuttavia mode culturali. Certo ci può essere stato qualche facinoroso che tirava per la giacchetta il pensiero di questo o quel filosofo. Questo deve essere messo in conto. Per molti si trattava di mode. Solo pochi padroneggiavano la disciplina e gli argomenti.

Solo pochi studiavano severamente la materia ed erano veramente versati. Per molti si trattava di rimasticature, echi lontani, deboli influssi, vagheggiamenti. Acculturarsi di filosofia politica, di economia politica era comunque una imposizione dall’alto, i partiti lo esigevano e naturalmente erano disposti a fare scuola agli iscritti. Sempre negli anni Settanta andava di moda a destra leggere Tolkien oltre ad Evola, Guénon, Spengler, Jünger. Era quasi un imperativo categorico. Per i liberali italiani era un dovere culturale leggere Croce e Gobetti. Negli anni Novanta per i liberali era quasi d’obbligo leggere Popper. I primi ad occuparsene nel nostro Paese del filosofo austriaco furono Dario Antiseri e Marcello Pera. Sempre negli anni Novanta e nei primi anni del Duemila i liberali necessariamente dovevano guardare alle teorie dell’economista von Hayek, che non voleva l’intervento statale a differenza di Keynes. Negli anni Novanta e nei primi anni del Duemila tutti i riformisti italiani leggevano o citavano Rawl e la sua teoria della giustizia. Per chi era di sinistra era un obbligo dover sapere qualcosa della teoria del potere di Foucault, del suo concetto di biopolitica, della decostruzione e del logocentrismo di Derrida, così come bisognava aver letto i libri di Chomsky, che criticava l’imperialismo americano. Qualche decennio fa erano di moda anche la psicanalisi, lo strutturalismo, la semiologia. Poi sono finite le mode culturali o comunque non hanno la grande presa di un tempo sulle persone. Sono finite le ideologie e quindi le grandi mode culturali a esse strettamente connesse. Un tempo chi si occupava e si interessava di politica leggeva decine di libri ogni anno, leggeva ogni giorno più quotidiani. Era una minoranza, una cerchia di persone non dico intellettuali ma di buone letture. Ogni ideologia aveva sempre bisogno di pensatori, libri, teorie che continuassero a giustificarla. Una ideologia non era qualcosa data per sempre. Perché aderisse efficacemente alla realtà c’era sempre bisogno di correttivi e aggiornamenti. Inoltre per ogni ideologia spuntavano come funghi dei critici e di conseguenza gli intellettuali di parte dovevano prendere le contromisure a quelle critiche. Insomma era il gioco delle parti, le solite schermaglie culturali. Ogni ideologia aveva bisogno di nuovi ideologi che la reinterpretassero e la rinnovassero continuamente.

D’altronde noi esseri umani siamo degli esseri incompiuti. Per trovare compiutezza abbiamo bisogno di cultura: alcuni studiosi chiamano ciò antropopoiesi. L’ideologia un tempo doveva essere appresa, capita, interiorizzata, ma anche creduta. Il marxismo come il fascismo erano anche degli atti di fede che duravano tutta la vita. Un tempo si giurava fedeltà per tutta la vita a una ideologia. Un tempo credevano alle ideologie, erano innamorati delle idee, credevano alcuni di avere la verità in tasca. Poi per alcuni era breve il passo dalla ideologia alla ubriacatura ideologica o al delirio ideologico, ma in questi casi era questione più che altro del lato Freud, di personalità di base. Certamente c’era chi usava l’ideologia in modo strumentale per violenza e sopraffazione. Oggi buona parte dell’elettorato è incerto, indeciso, si astiene dal voto. Un tempo mia nonna si vestiva in modo impeccabile per andare a votare. Era un giorno memorabile quello delle elezioni. Le persone si vestivano bene, non perdevano un capello. Adesso la politica italiana è molto più pragmatica. I politici non parlano più di convergenze parallele. Sono più diretti e non c’è bisogno che la base si acculturi. Si fanno comprendere da tutti. I politici di tutti gli schieramenti oggi sono molto social. Utilizzano il web per fare diffondere le loro idee. Usano post brevi di Facebook, commentano i fatti del giorno con un tweet. Insomma ecco l’elogio della comprensibilità e della brevità. E se fosse questa non dico la democrazia dal basso ma una nuova forma di democrazia rappresentativa? Dell’ideologia è rimasto ben poco: il minimo indispensabile per dare una identità ai partiti e ai loro iscritti, per creare delle contrapposizioni tra di essi. La falce e il martello sono stati deposti in soffitta, a torto o a ragione. Sono finiti il senso di appartenenza, la fedeltà, la coerenza. Sono finiti simboli, pratiche, riti. Bisogna farsene una ragione. Se ne facciano una ragione anche coloro che hanno scannato e si sono scannati per l’ideologia. Nel frattempo le multinazionali hanno conquistato i mercati e hanno avuto la meglio su tutte le nazioni. Ma in fondo di cosa avevano bisogno l’Italia e gli italiani? Di stabilità politica, di sobrietà, di competenza, di lungimiranza, di oculatezza. Ideologia o non ideologia, tutto questo nella prima repubblica non c’è mai stato. Vedremo in futuro, se avremo futuro.
giu 242022
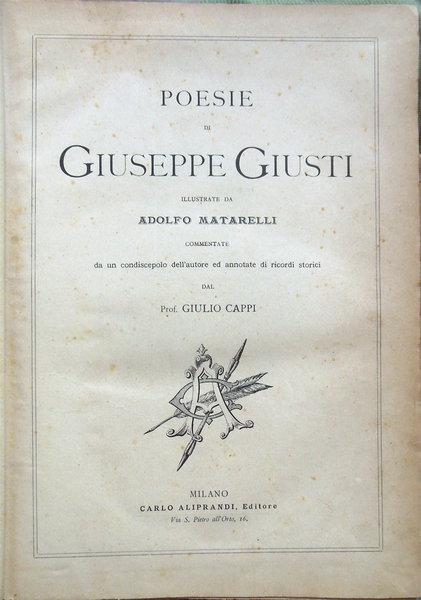
Giuseppe Giusti nacque a Monsummano nel 1809. Dopo aver frequentato diversi collegi toscani, si iscrisse a legge all’università di Pisa. Divenne avvocato, però non esercitò mai la professione. Visse la maggior parte della vita a Pescia. Affetto da tubercolosi polmonare si trasferì a Montecatini per curarsi. Morì di tisi a Firenze nel 1850 e fu sepolto a San Miniato. Nel corso della sua breve vita ebbe modo di conoscere Alessandro Manzoni. Fu anche accademico della Crusca e deputato al parlamento di Firenze. Il Giusti fu un liberale illuminato e uno dei migliori poeti satirici italiani della ’800. Anche Benedetto Croce si occupò della sua arte e lo definì "poeta prosastico". Il nostro avanzò critiche nei confronti delle istituzioni e delle ambizioni individuali. Le sue opere satiriche sono perfettamente aderenti alla realtà dell'epoca; presentano parodie e tratteggiano tipologie di persone senza alcun moralismo: i politici voltafaccia, i nobili esterofili, gli arricchiti, i falsi preti, i governanti indolenti. Il poeta comunque non si atteggia mai a censore di vizi e non è mai paternalista. Giunge sempre alla comicità, enfatizzando certi tratti ed esasperando certe caratteristiche di figure, che esistevano realmente ai suoi tempi. Il Giusti fu un artista colto, ferrato nella cultura classica e nella tradizione letteraria. Nelle sue poesie però fa la caricatura del potente, ma non offre una parola di conforto al povero. Certamente non fanno parte del suo retroterra poetico l'impegno civile e la partecipazione emotiva del Porta e del Belli, che riuscirono a dare risalto nei loro lavori a quel popolo, che fino ad allora non aveva mai avuto voce.

Il nostro poeta tratta spesso e volentieri di crapule e baldorie di persone, che non vivono in ristrettezze economiche. Resta da definire però se questo sia un difetto o un pregio. Infatti se da un lato può apparire distaccato, dall'altro non fa mai demagogia, non si abbandona a facili utopie e non ha la presunzione di dire qualcosa alla gente, che soffre e fatica. I poemetti satirici dei suoi "Scherzi" sono stati riconosciuti pregevoli all'unanimità, hanno avuto vasti consensi sia all'epoca (anche Gino Capponi era un grande estimatore del poeta), sia nel '900 (si pensi al Palazzeschi). Meno apprezzato dalla critica letteraria invece per le opere intime e di carattere sentimentale. Anche se in alcune liriche si può identificare il carattere risorgimentale, il Giusti non fu un mazziniano perché timoroso del popolo e di eventuali insurrezioni popolari. Comunque sono costanti nei suoi versi l'avversione per lo straniero conquistatore e il patriottismo. Difficile collocarlo politicamente. Fu davvero un liberale singolare in quel tempo: né un neoguelfo alla Gioberti, né un federalista come Cattaneo. Il Guerrazzi, suo avversario politico, disse di lui che scardinò lo stabile della società del periodo, avendo però paura dei calcinacci. Non mancano critici letterari che hanno una visione più giacobina dell'opera del Giusti. La sua produzione poetica è vasta e originale. Tocca gli argomenti più disparati. Spazia dall’ambito politico-sociale a quello storico. Notevole l’uso sapiente del poeta della metrica italiana. Prima dell’avvento nel ’900 del verso libero i poeti utilizzavano soprattutto l’endecasillabo (che non è necessariamente un verso di undici sillabe, ma l’importante è che abbia l’accento tonico sulla decima sillaba e un altro accento tonico sulla quarta o sulla sesta). Il Giusti invece varia prosodia continuamente. Spesso utilizza quinari e settenari. Più raramente usa le strofe saffiche (tre endecasillabi ed un quinario) e le ottave. Si può notare la sua autoironia in vari componimenti. Ad esempio in “Rassegnazione e proponimento di cambiar vita” scrive: “in quanto al resto, poi non mi confondo: / faccia chi può con meco il prepotente: / io me la rido e sono indifferente”. Il suo umorismo però talvolta è pervaso da un sentimento di nostalgia come nell’opera “Le memorie di Pisa”, in cui descrive la goliardia degli studenti universitari toscani.

La poesia satirica che mi ha divertito di più è l' "Apologia del lotto", che tra l'altro è ancora attuale. Il Giusti decanta i pregi del lotto, tra cui diventare signori con pochi soldi, far fare studi approfonditi sull'interpretazione dei sogni. Come se non bastasse scrive che il Lotto è l'unica fede rimasta al popolo e che giocando non si rischia la libertà, come invece accadde a Galileo che fu processato per aver professato la verità nell'ambito scientifico. Ma leggendo tra le righe, si capisce che lo Stato non perde mai e che chi è contento della sua condizione economica non gioca di certo al Lotto. La sua opera più famosa è senz’ombra di dubbio la raccolta di proverbi toscani. Popolari per i toscani e gli appassionati di letteratura anche poesie come “Lo stivale” e “Sant’Ambrogio”. Nella prima opera il Giusti adopra l’allegoria dello stivale per narrare le tribolazioni storiche dell’Italia: le dominazioni straniere, gli avvicendamenti di principi e regni dall’epoca dell’impero romano fino ai suoi tempi. Il poeta scrive: “Per un secolo e più rimasto vuoto,/ cinsi la gamba a un semplice mercante”. Questo verso sta a significare che solo durante il tempo dei Comuni l’Italia visse un periodo di relativa libertà, anche se la Sicilia era dominata dagli stranieri. Il capolavoro finisce con l’appello all’unità nazionale. Il Giusti scrive infatti: “E poi vedete un po’: qua son turchino, / là rosso e bianco, quassù giallo e nero;/ insomma a toppe come un Arlecchino: / se volete rimettermi davvero/ fatemi con prudenza e con amore, / tutto d’un pezzo e tutto d’un colore”. In Sant’Ambrogio invece il poeta tratta della dominazione austriaca. All'inizio della poesia l'artista dichiara che è stato considerato anti-tedesco solo perché in alcuni suoi versi ha parlato male degli sbirri. Ma nel finale il poeta ha una levata di umanità anche per i soldati austriaci, che sono lontani da casa e costretti a vivere in un paese straniero. Anche loro che in fondo sono gente comune "l'hanno in tasca". Solo i regnanti ci guadagnano sempre grazie all'antico "divide et impera". Anche la poesia dal titolo "Gingillino" gode di una certa fama. Il poeta descrive un tipo conformista e arrivista, che ingannando gli altri riuscirà a mettere le mani in pasta. Divenuto dottore in legge Gingillino va nella capitale per cercare un posto. Lì diventa "un birro", cioè un ufficiale della polizia e conosce l'ex-cuoca di un notabile, che gli dà tutti i consigli giusti per fare carriera: scansare i liberali e chi pensa con la propria testa, non parlare mai di libri e di giornali, arrufianarsi con il superiore, lodarlo a più non posso, riferirgli i pettegolezzi. Non ho voluto fare un saggio critico sul Giusti, anche perché non ne sarei in grado. Ho voluto invece dare un consiglio di lettura nel modo più semplice possibile. Leggete il Giusti. Le sue rime sono divertenti e mai scontate. Personalmente lo ritengo geniale per il suo estro e la sua arguzia. A mio modesto avviso è uno dei pochi poeti italiani di tutti i secoli che sappia sorridere e accantonare la tragicità.
giu 242022
Molte piante negli ultimi anni hanno raggiunto la fioritura a fine inverno. Si è parlato infatti di primavere anticipate. La natura è sempre più imprevedibile. Gli agricoltori rischiano molto a livello economico perché anche in caso di gelate tardive tutto va alla malora. Si pensi alla fioritura anticipata della frutta come ciliegie, susine, mele e pesche. Si consideri soltanto a come in alcuni anni è fiorita prima la mimosa. Recentemente si sono registrati notevoli sbalzi termici. Si pensi negli ultimi anni anche alle grandinate e ai danni del maltempo, sempre poco prevedibili. Un tempo non esistevano più le mezze stagioni secondo un noto luogo comune. Adesso non esistono quasi più le stagioni, forse a causa dell’inquinamento e del surriscaldamento del pianeta. La natura sembra impazzita. L’agricoltura può risentirne in caso di fioriture anticipate o tardive. Basta ricordarsi di quanto può compromettere la produzione di olio la fioritura anticipata dell’ulivo. Guardiamo i vigneti. Ma queste sono solo piccole beffe della natura nei confronti dell’uomo. Pensate all’invasione di cavallette in Africa, che ha costretto a fare la fame a 20 milioni di persone.

Nel nostro piccolo in Italia abbiamo avuto la diffusione esponenziale delle nutrie, che erano utilizzate per la pellicceria. Alcune fuggirono dagli allevamenti e altre vennero liberate in modo incosciente. Ma tutto ciò non ha compromesso niente fortunatamente. La situazione almeno per ora è sotto controllo. Pensate al riscaldamento climatico in Antartide, che ha causato lo scioglimento dei ghiacciai. Pensate più recentemente all’enorme invasione di topi in Australia. Pensate ad un fenomeno come quello dello spiaggiamento delle balene.

La natura può essere molto crudele. Può essere matrigna come pensavano Leopardi e Voltaire (dopo il terremoto di Lisbona). Altri pensatori hanno considerato positivamente la natura come San Francesco nel “Cantico delle creature ” e come Spinoza con il suo “Deus sive natura”. C’è chi vede nella natura una nemica e chi l’immagine di Dio. In definitiva la natura può far male all’uomo con cataclismi e siccità, ma anche l’uomo con l’industrializzazione ha fatto molto male alla natura. Dalla rivoluzione industriale a oggi l’uomo ha rovinato il pianeta. Probabilmente oggi siamo alla fine dell’Antropocene. Pensate solo all’inquinamento. Osservate solo tutta la plastica che c’è nel mare. L’umanità deve prendere provvedimenti tempestivi. Bisogna pensare anche a un futuro remoto. L’uomo contemporaneo vuole dominare e manipolare a suo piacimento la natura. Vuole solo servirsene senza rispettare fauna e flora.

Ma non rispettando l’ecosistema, non rispetta nemmeno sé stesso. Non possiamo uccidere la balena perché viviamo per ora nel suo ventre. Per ora non c’è stata nessuna intercessione divina che ha fatto in modo che la balena ci vomitasse su una serena spiaggia, come Giona. Ricordando Moby Dick di Melville non bisogna comportarsi come Capitan Achab perché non si salva, mentre si salva invece Ismaele. Dobbiamo accettare il lato terribile della natura. Dobbiamo rispettare la natura perché è il nostro habitat naturale. È al momento il solo mondo di cui disponiamo, ma gli interessi di alcuni potenti e di alcune nazioni ricche sembrano avere il sopravvento su tutto e su tutti. Il futuro del pianeta è lo stesso futuro dell’umanità. Jonas non a caso parla di etica della responsabilità, di pensare anche alla vita di coloro che verranno, di avere uno sguardo lungimirante ed a lungo termine. Staremo a vedere. Per dirla alla Popper “il futuro è ancora aperto”.
giu 232022
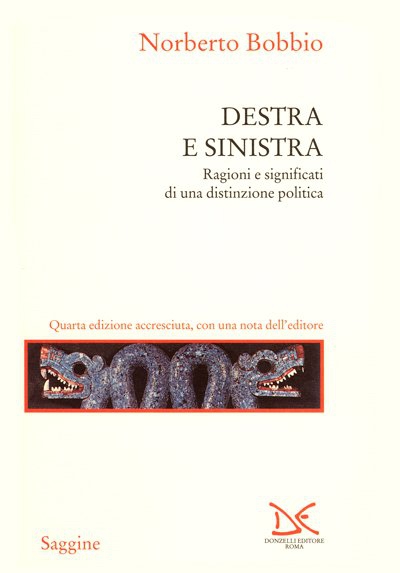
Dopo tre quarti d'ora a parlare di politica io e Lele concludiamo così:
"è tutto un darselo a intendere."
Secondo recenti studi esiste ancora la cosiddetta "eredità politica". I genitori fanno proselitismo, educano, formano, influenzano. I figli li imitano. Questo accade 6/7 volte su dieci. Oppure i figli in piccola parte vogliono "uccidere" il padre, si contrappongono, perché c'è un rapporto conflittuale, un complesso edipico da risolvere, come successe nel '68. Plausibile l'ipotesi di Adorno sulla personalità autoritaria. Secondo Adorno il fascismo era determinato da una educazione rigida, repressiva, autoritaria. Si tenga però presente che l'avalutatività delle scienze umane è un'utopia e che allora molta sociologia, molta psicologia contenevano in sé la teoria implicita che chi era progressista era sano psichicamente oltre che nel giusto. Tutto ciò era in buona parte giustificato perché gli studiosi progressisti in gran parte erano memori degli orrori del nazifascismo, ma ancora non conoscevano a dovere quelli dei regimi comunisti. Le loro conclusioni non corrispondevano totalmente al vero, se si ragiona a rigore di logica e se si conosce un minimo la natura umana. È presumibile che anche dittatori e persone comuni comuniste possano avere o possano avere avuto aspetti patologici correlati significativamente alla loro ideologia. Come scrive Andreoli di ogni scelta politica si potrebbe dare una "lettura psicoanalitica". C'è anche la questione dell'età. Secondo un celebre aforisma di Pitigrilli "si nasce incendiari e si finisce pompieri". C'è anche chi vota non in modo affettivo/emotivo ma in modo razionale, facendo un'analisi costi/benefici. Sono quelli che votano chi difende i loro interessi. In modo opposto ci sono ricchi che votano il partito comunista anche per eliminare o ridurre il loro senso di colpa di essere privilegiati.

Secondo le scienze umane l'ideologia sarebbe definita come "un complesso di credenze, opinioni e valori che orientano un determinato gruppo sociale o un individuo; tale insieme di credenze, inoltre, è condiviso all’interno di un gruppo e ne sostiene le azioni" (Carraro e Bortolotti, 2020, p. 337). Ma recentemente è nata la psicologia politica, ovvero lo studio delle variabili psicologiche che decidono l'orientamento politico. Secondo alcuni studi l'orientamento politico è "predeterminato geneticamente", addirittura sarebbero individuati i geni del conservatorismo o del progressismo. Io sono rimasto agli studi degli psicologi nelle carceri che per esempio hanno evidenziato quanto i brigatisti rossi spaziassero dal delirio di onnipotenza alla mania di persecuzione, croce e delizia di quella che loro consideravano una sorta di guerra tra guardie e ladri.

Bobbio ha scritto il long seller "Destra e sinistra" che ha venduto centinaia di migliaia di copie ed è stato tradotto in tutto il mondo. Per Bobbio "destra" e "sinistra" erano "reciprocamente esclusivi e congiuntivamente esaustivi". Il libro è ancora attuale, sebbene sia stato pubblicato nel 1994. Bobbio era uno dei più grandi filosofi italiani, molto acuto e altrettanto rigoroso. Non le mandava a dire. Scrisse che il fascismo era dovuto anche alla compromissione del popolo italiano, che non era esclusivamente colpa di Mussolini e dei gerarchi: ebbe il coraggio di dire e scrivere che anche la popolazione italiana, sebbene avesse l'attenuante dell'ignoranza a quei tempi, aveva avuto un'ubriacatura ideologica, si era fatta lusingare, sedurre, incantare, ipnotizzare dai fascisti della prima ora, diventando essa stessa fascista, ed era in un certo qual modo responsabile del fascismo. Bobbio considerava certamente la propaganda del partito fascista, ma chiamava gli italiani a un esame di coscienza collettivo. Bobbio sapeva che il fascismo era stato, per così dire, "nazionalizzazione delle masse". Il filosofo sapeva esattamente come era avvenuta l'ascesa di Mussolini. Anche per via della dittatura e della violenza esercitata comunque furono pochissimi gli italiani a non aver pagato il pedaggio al fascismo. Bobbio evidenziò anche i meriti della Resistenza d'altra parte. Per chiarire il giudizio di Bobbio sulla compromissione degli italiani durante il regime basta citare il titolo di un suo saggio sulla memoria e i valori della Resistenza: "eravamo ridiventati uomini". Insomma fu sempre attento ad analizzare con obiettività luci e ombre degli italiani e dell'Italia. Quindi per l'autorevolezza, la competenza, l'onestà intellettuale, il rigore morale quando venne pubblicato questo volume, filosoficamente accurato ma leggibilissimo, molti pendevano dalle labbra di Bobbio, volevano ascoltarne le interviste, si recavano ad acquistare il libro. Ma davvero come scrive Bobbio sinistra è uguaglianza, emancipazione, bisogno e destra è diseguaglianza, tradizione, merito? Per alcuni queste categorie sono desuete, non hanno più modo di esistere, come cantava Gaber. Personalmente penso che oggi molti tifino un orientamento politico, un partito politico come si fa con una squadra di calcio, senza avere idee precise o valori di riferimento stabili e certi. Non hanno molti la preparazione adeguata, le conoscenze teoriche. Non sono aggiornati. Non seguono la politica. D'altronde il discorso è complesso. Tutti hanno il diritto/dovere di votare. Calvino lo mise in evidenza con "La giornata di uno scrutatore". Il voto per tutti è uno dei valori fondanti della nostra democrazia. Continuo però a pensare che ci sia gente che si tira la zappa sui piedi. Comunque molti votano cosa hanno votato i loro genitori (se esiste il partito ancora o se c'è un minimo di continuità), intrattenendo spesso un rapporto di natura clientelare con gli uomini di quel partito. Chiamatele pure conoscenze, pubbliche relazioni, conoscenze utili, amicizie interessate. È insomma anche un do ut des. Pochi si acculturano e si documentano per la politica. Hanno anche ragione. Anche io sono tra questi. Nessuno sta dietro alla politica come accadeva negli anni '70. Non dico che esista il voto di scambio, ma quasi. Di solito ci sono i referenti politici, che io per esempio non ho. In Italia come dichiarò l'allora ministro del lavoro Poletti per trovare un lavoro sono importanti esperienza e curriculum, ma più di tutto le relazioni sociali: per Poletti era più importante andare a giocare a calcetto con gli amici o a cena con ex compagni di scuola che andare all'ufficio di collocamento (visto che fino a pochi anni fa solo il 4% dei disoccupati trovava lavoro grazie a esso). Fortini scriveva: "...Gli oppressi/ sono oppressi e tranquilli, gli oppressori tranquilli/ parlano nei telefoni, l’odio è cortese, io stesso/ credo di non sapere più di chi è la colpa". Se un tempo in chiave marxista gli oppressi erano i proletari e gli oppressori i capitalisti e gli imperialisti oggi si dovrebbe parlare di gruppi dominatori e gruppi dominati, di categorie avvantaggiate e di categorie svantaggiate. Oggi il mondo non è più wasp comunque. In realtà il discorso è sfumato e complesso. Come scrive Bailey lo status di persona svantaggiata è multidimensionale. Non esiste più la categoria unica sulla base del capitale. Ci sono varie dimensioni come il genere, l'età, l'etnia, il grado di istruzione, lo stato di salute, l'orientamento sessuale. Ma in Italia almeno esistono anche stereotipi e conseguenti discriminazioni sulla base dell'appartenenza politica. Gli italiani, pur essendo disinformati ed essendosi disaffezionati alla politica, si odiano ancora in base alle categorie politiche; chi è di destra odia le cosiddette zecche, chi è di sinistra odia i fascisti. Ancora oggi non c'è una riappacificazione, una conciliazione tra le due parti. Ci sono sempre almeno due fazioni, c'è una logica della contrapposizione. Ci sono sempre nella popolazione la suddivisione tra Don Camillo e Peppone, tra guelfi e ghibellini. Siamo un popolo emotivo, litigioso. Si vien sempre chiamati a stare da una parte, bisogna sempre sapere da che parte stare in Italia. Nessuno si può esimere. Il voto in teoria è segreto, però dimmi chi voti: così si potrebbe riassumere tutto. Si può diventare falchi o colombe. Si può essere galline azzannate da volpi. Si può far la fine delle volpi, che dopo aver azzannato le galline, venivano uccise e qui da noi in Toscana a chi le uccideva gli venivano regalate le uova delle galline. Il potere come al solito divide e governa. In Toscana per esempio esiste una tradizione rossa dovuta alla fondazione del partito comunista a Livorno, alle tante case del popolo un tempo, alla diffusione di circoli Arci oggi, alle tante cooperative rosse. In Toscana un semplice liberale apartitico può essere penalizzato. In Veneto lo è altrettanto un comunista. Gli italiani discriminano, ghettizzano, emarginano, danno amicizia e amore, includono o escludono, favoriscono oppure ostracizzano, offrono opportunità socioeconomiche oppure non le danno in base al colore politico, eppure al governo vige la logica del consociativismo e della spartizione. Tutto è già deciso. Il saggio di Bobbio è in bella vista nella mia libreria, lo tengo sempre a portata di mano. Adriano Sofri in "Altri hotel" scriveva che era in disaccordo con le equazioni di Bobbio sinistra=uguaglianza e destra=libertà. Anche Vittorio Foa proponeva che se la destra significava liberalismo la vera libertà invece stava a sinistra. Bobbio naturalmente vedeva distante, ma non aveva la sfera di cristallo.

Su una cosa aveva totalmente ragione: la destra si basava allora su un concetto dell'antropologia tradizionale, ovvero gli uomini non sono uguali e bisogna valorizzare la diversità. Personaggi come Almirante volevano esaltare le differenze individuali. Dagli anni '90 in poi all'egemonia culturale della sinistra opponevano l'egemonia mediatica berlusconiana. Oggi la destra è populista e parla di identità. La sinistra vuole la fluidità. Oggi la sinistra ha il merito maggiore di difendere i diritti civili e forse non riesce a difendere a dovere i precari. La destra un tempo, come sostiene Bobbio, era inegualitaria, prendendo come riferimento Nietzsche. Bisogna leggere anche "La sinistra nell'era del karaoke" di Bobbio, Bosetti, Vattimo. Quest'ultimo scriveva a riguardo: "Credo di vedere delle spiegazioni di questo conservatorismo della sinistra italiana: essa, o almeno una gran parte di essa, si è liberata lentamente, negli ultimi decenni, del mito della rivoluzione e ha scoperto relativamente da poco il valore che hanno le regole del gioco. Questo spiega in termini non puramente denigratori perché oggi la sinistra sembra più arroccata in difesa della Costituzione" (pp.21-22). Forse essere di sinistra significa oggi come ieri difendere le minoranze e sentirsi una minoranza, che è o si sente élite. Come dice Nanni Moretti in "Caro diario": "Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io, anche in una società più decente di questa, mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Ma non nel senso di quei film dove c'è un uomo e una donna che si odiano, si sbranano su un'isola deserta perché il regista non crede nelle persone. Io credo nelle persone. Però non credo nella maggioranza delle persone. Mi sa che mi troverò sempre d'accordo e a mio agio con una minoranza...".
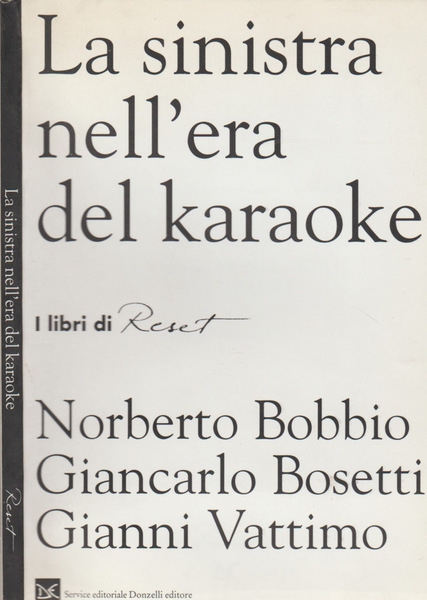
E la destra invece? E adesso come è da questo punto di vista la destra? Oggi i punti programmatici dei partiti sembrano assomigliarsi tutti. Qualcuno dice che la sinistra non esiste più e la destra è troppo camaleontica. Poi oggi si registra il primato dell'economia sulla politica. Che cosa conta la politica italiana così provinciale in un mondo dominato dal nuovo neocolonialismo delle lobby economiche e delle multinazionali? Nessuno vuole più fare la rivoluzione. Chi potrebbe farla è pur sempre "uno svantaggiato integrato". Gli esclusi non hanno forza né voce in capitolo. Ma esiste più il senso di appartenenza? Oppure non esistendo più le classi non esiste più la coscienza di classe e non esistendo più le ideologie non esiste più l'amore per la politica? Talvolta ho la vaga sensazione che chi dice che sinistra e destra non esistono più non vuole schierarsi, non vuole dichiararsi oppure addirittura vuole mistificare la realtà. Il saggio di Bobbio ha avuto a mio avviso il merito, piccolo o grande che sia stato, di innalzare la discussione politica, di far volare alti gli italiani, in un Paese allora sclerotizzato sulla distinzione netta tra berlusconiani e antiberlusconiani, al punto da regredire politicamente, mantenere lo status quo per anni, non evolvere, arenandosi nelle secche e non facendo le riforme. Ma anche qui il consociativismo alla fine aveva la meglio: i politici progressisti facevano accordi sottobanco, pubblicavano libri con le case editrici del nemico, andavano a fare ospitate nelle reti Mediaset, sempre prezzolati. Per molti intellettuali progressisti duri e puri Berlusconi era un imprenditore illuminato perché permetteva loro di essere pubblicati o di scrivere sui suoi giornali. Nel frattempo Berlusconi si impossessava di buona parte del Paese e decine di migliaia di persone erano suoi dipendenti. Sicuramente il saggio di Bobbio va letto comunque, anche per essere contro e per dissentire. È un saggio tascabile, colto, penetrante, divulgativo e chiaro. Bobbio fa delle pregevoli argomentazioni e solleva interrogativi validi ancora oggi. Ecco perché ha avuto meritatamente questo successo inaudito, forse impensabile. È ancora molto attuale a mio avviso, ma anche se fosse datato avrebbe il merito di ricordarci come eravamo, come pensavamo, su quali problemi ci accapigliavamo quasi trenta anni fa. In ogni caso va letto.
giu 232022
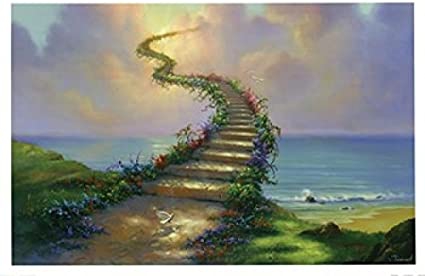
Il gruppo 63 aveva teorizzato lo "schizomorfismo" nella scrittura, ovvero ci doveva essere una mimesi (una copia che riproducesse rispecchiamento) tra un mondo schizofrenico e le forme letterarie. Se in particolare per Sanguineti l'ideologia era sempre linguaggio (primo passo per smascherare l'inganno della realtà) per la neoavanguardia (di cui lo stesso Sanguineti faceva parte) bisognava compiere un ulteriore passo avanti: denunciare la follia del mondo, riproducendola fedelmente nella letteratura. Il mondo per Sanguineti era folle e ingiusto per il predominio dell'ideologia capitalistica. Nel gruppo 63 non veniva esplicitata la natura della follia del mondo. Il mondo era folle fisiologicamente, ontologicamente? Oppure il capitalismo selvaggio, che sfruttava alcuni uomini e la natura, era un agente catalizzatore? Il capitale era il motivo scatenante di tutto? Oggi sappiamo che il comunismo non è la panacea di tutti i mali. Ma la questione restava irrisolta. Secondo una diagnosi di natura la schizofrenia negli uomini era causata da un'eccessiva produzione di dopamina nel sistema mesolimbico. Ma cosa causava la follia del mondo? Che questo fosse un crazy world, che tra l'altro scatenava nevrosi e psicosi nei cittadini che vi si adattavano, l'aveva già scritto Fromm. Era il "disagio della civiltà" studiato, primo tra tutti, da Freud. Quindi la follia non solo scatenava in taluni disadattamento, ma in alcuni era l'effetto dell'integrazione a questo mondo. Perché trattare dei pochi folli quando era l'intero mondo a essere folle? Era la follia del mondo che contagiava gli esseri umani, che perpetuavano a loro volta le dinamiche perverse e ingiuste del sistema folle. La follia, intesa in senso erasmiano, può essere rivelatrice di conoscenza e verità. Il folle può coincidere con il saggio. Appartenendo a un mondo apparentemente altro, può vedere cose che le persone comuni non vedono e arrivare dove gli altri non arrivano. Scriveva in una sua celebre poesia Zanzotto: "Mondo, sii, e buono;/ esisti buonamente". Ma il mondo non è mai buono. Ha troppe brutture. Montale in una sua poesia scriveva:
"Se il mondo va alla malora
non è solo colpa degli uomini.
Così diceva una svampita
pipando una granita col chalumeau
al Cafè de Paris.
Non so chi fosse. A volte il Genio è quasi
una cosa da nulla, un colpo di tosse."
La colpa è di tutti e di nessuno? Il mondo va male non solo per gli uomini ma anche per Dio allora? La domanda fondamentale dell'etica cristiana è la seguente: "Se esiste Dio perché allora c'è il male?". Questa è la teodicea cattolica e non solo. La domanda che si fa un cattolico è: perché un essere onnipotente, infinitamente buono e misericordioso non ha fatto un mondo buono? E poi mi chiedo anche perché se Dio ha fatto a sua immagine e somiglianza gli uomini ha messo in noi anche la capacità di essere violenti e fare del male? Perché un Dio buono non ha fatto gli uomini buoni? Perché ci sono uomini più propensi a fare del male, essendo più predisposti dalla loro natura e/o dalle circostanze? La colpa è degli uomini ma anche di Dio che ha dato loro il libero arbitrio? Cosa può fare la letteratura di fronte a tutto ciò? Per Carlo Bo la letteratura deve essere come la vita. Per Bo la letteratura e la vita sono "strumenti di ricerca e quindi di verità: mezzi per raggiungere l’assoluta necessità di sapere qualcosa di noi, o meglio di continuare ad attendere con dignità, con coscienza una notizia che ci superi e ci soddisfi". Sempre Bo scriveva: "sappiamo che la letteratura è una strada, e forse la strada più completa, per la conoscenza di noi stessi, per la vita della nostra coscienza". Però per Bo la vita del letterato doveva essere pura o quantomeno coerente all'opera. Da tempo immemorabile a questo proposito ci sono critici letterari interessati anche alla vita dell'artista e altri meno. E ancora sempre per Bo gli autori dovevano essere di specchiata moralità e agire secondo coscienza. E allora gli autori con coscienza infelice o falsa coscienza? Per Giorgio Manganelli la letteratura è menzogna. La letteratura, quando va bene, è un "come se" per il grande scrittore. Ma se il mondo è diventato favola, come scriveva Nietzsche, allora Manganelli è nel giusto perché la letteratura come menzogna rispecchia la menzogna del mondo. Ci sono diversi modi in cui approcciare la realtà per uno scrittore o un poeta:
pensare che il mondo sia vero e riprodurlo con la verità dell'artista
pensare che il mondo sia vero e opporsi con la menzogna dell'artista
pensare che il mondo sia falso e opporsi con la verità dell'artista
pensare che il mondo sia falso e riprodurlo con altrettanta falsità
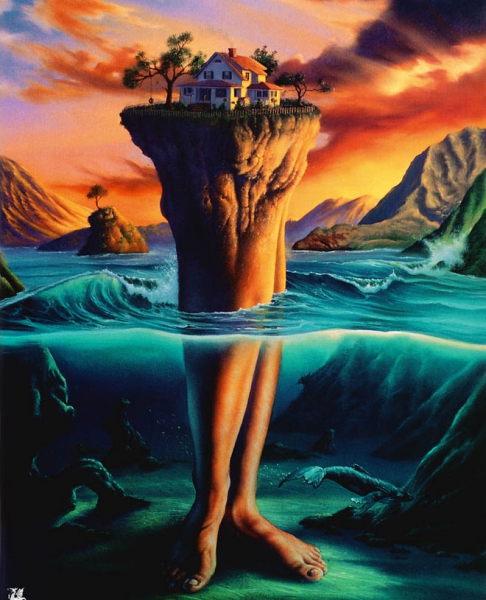
Il mondo quindi può essere considerato vero o falso e poi essee capovolto, rovesciato con la scrittura. Ma qui la faccenda si complica ulteriormente perché verità e menzogna, falso e vero, possono essere mischiati e non c'è modo di dividerli, separarli. Oppure l'uomo non è più in grado di saper distinguere oggi il vero e il falso, di modo che vero e falso sono un tutt'uno inscindibile. Nessuno sa con certezza assoluta lo statuto né l'essenza della realtà. Inoltre per farla diventare letteratura la realtà va analizzata e sintetizzata correttamente. Quanti sono in grado di farlo? Riprendendo Nietzsche ne "Il crepuscolo degli idoli" non solo il vero può essere "inattingibile" ma anche il falso. Secondo l'ipotesi di Nietzsche il vero è inconoscibile. È naturale che se non si può distinguere il falso dal vero non si può neanche discernere tra il bene e il male. Noi occidentali abbiamo un'idea cumulativa del sapere, tendiamo alla verità perché pensiamo di potervi avvicinare sempre più, passo dopo passo, tassello dopo tassello, gradino dopo gradino. Come scrisse Emerson: "il saggio cerca la verità. Lo sciocco crede di averla trovata". Wittgenstein in "Della certezza" scrive: "Se il vero è ciò che è fondato, allora il fondamento non è né vero né falso". Ma quale è è cosa è il fondamento? La verità poggia su fondamenti instabili. Kant proponeva lo schematismo trascendentale. Le categorie con cui conosciamo la realtà per Kant erano innate e universali. Invece Umberto Eco ha messo in dubbio tutto ciò con l'esempio dell'ornitorinco che ha alcune caratteristiche dei mammiferi ma non è mammifero, bensì oviparo. Di conseguenza le categorie e gli schemi cognitivi non sono un a priori, ma spesso sono a posteriori, ovvero storicamente e culturalmente determinate. E poi anche se sapessimo la verità quale senso dovremmo darle e con esso quale senso dovremmo dare alla nostra vita? Ma c'è un altro problema insormontabile. Merleau-Ponty ne "La fenomenologia della percezione" scriveva che "la scienza non è stata per nulla capace di illuminare la natura dell'esperienza soggettiva". E ancora cosa è la coscienza? Grazie a cosa siamo coscienti?
E poi si aggiunge la difficoltà che viviamo nell'epoca delle post-verità, in cui si crede alle bufale del web, alle fake news, alla disinformazione, senza cercare la verifica e il controllo dei fatti. Trovo che questa frase sia inoppugnabile: "Il fatto moderno è che noi non crediamo più in questo mondo” (G. Deleuze, L’immagine-tempo. Ubulibri, 1989, p. 191).

E se la vita è liquida per dirla alla Bauman (ovvero precaria, imprevedibile, piena di incognite, estremamente mutevole) allora anche la verità potrebbe essere altrettanto "liquida". La vita comunque nella migliore delle ipotesi, in assenza di certezze, dovrebbe essere una ricerca incessante, spesso infruttuosa, si spera non vana. Jung scrisse che qualsiasi visione del mondo era da considerarsi solo un'ipotesi. Come cantava Enrico Ruggeri nella vita dovremmo morire crescendo.
Infine come scritto nell'Ecclesiaste il sapere accresce il dolore, ma è anche vero che la sofferenza accresce il sapere. Ma siamo così convinti di conoscere? E se la verità che ha il conforto e la sicurezza della conoscenza condivisa fosse solo un'illusione? Siamo poi così sicuri che possa verificarsi l'etica del discorso, la situazione discorsiva ideale di Habermas, secondo cui i dialoganti si dimostrano chiari, sinceri, comprensibili, onesti intellettualmente? Siamo certi che si possa mettere in pratica i dettami di Habermas sull'agire comunicativo? E se tutta la vita fosse illusione? Se questa vita non fosse che sogno?
giu 232022
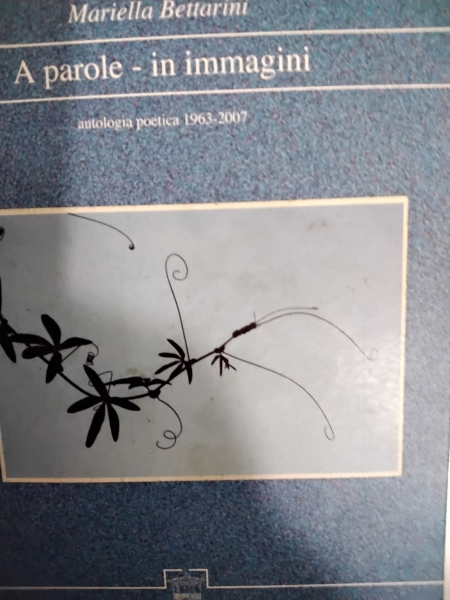
Molti anni fa dopo che le inviai via email un mio saggio breve sulla poesia contemporanea, riletto oggi molto acerbo e pretenzioso, Mariella Bettarini, che ne individuò i punti di forza, omettendo probabilmente quelli deboli per bonaria indulgenza, mi inviò per posta ordinaria la raccolta di tutte le sue poesie, insomma la sua opera omnia lirica, intitolata “A parole – in immagini” (antologia poetica 1963-2007) per la casa editrice “Gazebo”. Per inciso scrivo che la poetessa è sempre stata un’instancabile animatrice e operatrice culturale, ha fondato la rivista letteraria “Salvo imprevisti” (oggi dirige “L’area di Broca”), ha fondato la casa editrice “Gazebo”, ha ottenuto vasto consenso dalla critica, ha colloquiato con molti protagonisti letterari del secondo Novecento, ha tenuto a battesimo molti giovani in poeti. Ha anche curato il libro capolavoro di Alice Sturiale. Un’altra curiosità: è stata anche inserita nell’enciclopedia tematica dell’Espresso Grandi Opere anni fa. Un’altra cosa: non partecipa a premi letterari perché sa come scriveva Ferlinghetti che la poesia non è una gara. Mi invitò comunque anche a una riunione letteraria a casa sua, ma declinai l’invito. A quel tempo ero un piccolo commerciante. Firenze distava poco più di 60 km col treno. C’era il rischio di perdere l’ultimo treno della sera e ritrovarsi sotto stazione tutta la notte. Avevo anche paura del confronto serrato perché non sono un abile oratore. Avevo e ho molte lacune. Avevo paura di un terzo grado o anche di una persona che mi facesse le pulci. Ma forse il vero motivo è che avevo paura di deludere le aspettative. Non ero più abituato alle discussioni intellettuali. Non ero più allenato mentalmente. Soffrivo di timor panico, ovvero di ansia a parlare in pubblico. E poi perché andare? Non ero un letterato. Il mio futuro lavorativo era molto incerto. Avevo altre grane. Le ricordai via email che erano tempi grami per la poesia e che i poeti, aspiranti, sedicenti o effettivi dovevano parlare d’altro e utilizzare la diglossia, parlare nel modo più semplice possibile con la gente. Ciò nonostante mi misi a leggere tutto il suo volume. Sapevo che era un dono prezioso. Ma vivevo in quel periodo una mia crisi interiore e faticavo a esprimere un mio parere articolato. Poi dove pubblicare una mia recensione? Non avevo più un sito né un blog. Inoltre mi arrampicavo sugli specchi perché oltre alle mie contrarietà prettamente interiori, personali mi imbattevo in una voce che faceva dell’unicità la sua caratteristica precipua. La sua poesia sembrava paradossalmente essere a sé stante, autonoma, eppure le sue strutture portanti erano fatte dalla tradizione letteraria novecentesca. Insomma la sua opera si riassumeva nella celebre formula letteraria “tradizione+innovazione”. Ero in un periodo in cui la mia passione per la poesia contemporanea si stava affievolendo. Mi chiedevo a che pro leggere e scrivere? Ma quel libro mi ridava un poco di passione, riaccendeva il desiderio di capire.

La Bettarini però scompigliava le mie certezze poetiche. La sua bravura mi dava addirittura fastidio perché aveva un modo di concepire e fare poesia completamente diverso da come intendevo farlo io. C’era una profondità mista a un’originalità che mi spiazzava. Il suo talento poetico creava in me dei dubbi e delle perplessità. La sua era una poesia sfaccettata in cui confluivano varie anime e molti echi. Era difficile dire la propria e chiudere i miei pensieri così su due piedi come ero abituato a fare. Non era una poesia facile. Ci sarebbe voluto tempo e una certa disposizione d’animo e io rimandai, rimandai e poi abbandonai l’idea di farmene un’idea mia. Ma non c’era niente che non andasse in lei o nella sua poesia; ero solo io che non ero nel momento migliore per accoglierla, farla mia, interiorizzarla. La sua voce arrivava dritta dritta dagli anni ’60, attraversava tutti gli anni ’70 e ’80. Quelle realtà e quel modo di percepirle mi sembravano distanti da me. Eppure con quel passato e con quella poetessa dovevo fare i conti. Non ero un filologo acuto per valutare il suo mutamento linguistico, se era o meno cambiata poeticamente. Quella sua poesia così densa e sostanziosa mi arrivava tra capo e collo all’improvviso e non mi lasciava affatto indifferente. Mi piaceva. Le sue poesie avevano ritmo, musicalità, proprietà di linguaggio, vera intellettualità. Ma da un certo punto di vista mi disturbavano un poco perché non le avevo scritte io e erano totalmente altro da me o almeno sembravano tali di primo acchito. Ma ne ero veramente certo? E se fossimo stati molto più simili di quel che pensavo? A ogni modo non ero certo di niente. Avevo visitato il suo sito. Avevo visto che era stata una maestra. Mi ricordai che anche il miglior poeta pontederese, ovvero Dino Carlesi, era stato maestro elementare. La cosa mi piaceva perché avevo un’ottima opinione dei maestri elementari e mi ricordavo che secondo ricerche internazionali l’unico insegnamento ritenuto valido ed efficiente in Italia era proprio quello elementare. Ma passiamo oltre. Alcuni critici avevano parlato del suo neorealismo fiorentino. Ma la sua poesia era allo stesso tempo complessa concettualmente e denotata da una grande ricchezza lessicale. Immagini, espressioni verbali, metafore, descrizioni, simboli venivano declinati nei modi più disparati: molte erano le tematiche e ancora di più le loro variazioni. La Bettarini col suo modo schietto, confessionale e al contempo discreto metteva in scena tutte le sue sfumature dell’animo. Ma un dato di fatto assodato era che la poetessa scriveva sempre col cuore in mano, pur facendolo con pudore e senza quell’effusione presente in molti, che Sanguineti detestava. Un’altra cosa era che la Bettarini con il suo impegno civile, poetico, letterario, sociale, politico era lì a testimoniarmi e a indicarmi che bisognava di nuovo imparare a vivere sia dal punto di vista privato che pubblico, riprendendo un celebre verso della Achmatova. E imparare di nuovo a vivere significava anche imparare di nuovo a sentire, a pensare, a relazionarsi col prossimo.

Sapevo che quel libro e quella sua dedica erano importanti, erano uno stimolo per me, erano il segno che dovevo continuare a scrivere saggi brevi. Ma quel volume stava anche a certificare un pezzo di poesia fiorentina e poi universalmente italiana. Le lessi una dopo l’altra, ma senza cercare di scorgere metamorfosi interiori né differenze stilistiche. Avvertivo innanzitutto una forte personalità, anche se la presenza dell’io non era assolutamente ingombrante, e il fatto di essere di fronte alla storia di una vita. Ogni poesia si intrecciava con la sua esistenza. L’una richiamava l’altra. Nel volume molto corposo c’erano anche alcuni capitoli delle tesi di laurea che trattavano della sua poesia. Un altro motivo che mi faceva desistere dallo scrivere un commento o una nota critica era che ormai mi trovavo di fronte a una poetessa già riconosciuta, mi trovavo di fronte al fatto compiuto. Che altro avrei avuto da dire? Che altro avrei avuto da aggiungere? Sarebbe stato presuntuoso tentare un nuovo approccio critico. Dovevo farmi da parte e così feci. Mi occupai d’altro. Avevo altri problemi che mi passavano per la testa. Lasciai il libro in un angolo della mia biblioteca. Ogni tanto lo leggiucchiavo di nuovo. Mi sentivo un ingrato a non avergli dedicato del tempo, a non aver scritto niente, a non essermi soffermato. Ero irriconoscente. Ma allo stesso tempo ero ormai convinto che non avrei mai più firmato nessuna recensione per nessuna rivista letteraria. Una cosa che scrissi alla Bettarini, dopo averla letta, è che la sua lingua era impreziosita da tanti toscanismi senza mai forzare troppo la mano e senza mai rivendicare con orgoglio, come fanno moltissimi nostri corregionali, la toscanità. Ora mi viene in mente che in tempi di milanesizzazione nello scritto e nella dizione della lingua italiana la poetessa con la sua opera si opponeva a questa imposizione, quasi questo obbligo morale per chi scrive o opera nei mass media. Già prima dell’avvento di Berlusconi in poesia era egemone la linea lombarda. Una volta addirittura molti anni fa lessi in un muro di una stazione ferroviaria del Nord una scritta leghista, secondo cui non si doveva più parlare toscano. Ma forse, più realisticamente parlando, la poetessa dall’Isolotto provava a concepire una nuova idea della poesia, della letteratura, della cultura, della società, dell’Italia stessa. Queste righe naturalmente non sono un’esegesi. Non voglio fare un’analisi testuale o critica. Era solo un chiarimento doveroso mischiato con alcuni ricordi e con alcune impressioni provate all’epoca. Quel volume è sopravvissuto al trasloco, in cui ho buttato diversi libri e altri li ho regalati alla biblioteca. Lo conservo ancora. Ne sono intimamente orgoglioso di averlo con me. A distanza di anni talvolta rileggo qualche poesia. Non l’ho sottolineato come faccio di solito perché so che è prezioso. Queste righe erano un atto dovuto. Niente di più.
giu 232022

La prova tangibile che i poeti non se li fila nessuno è l’inesistenza del gossip poetico. Se non c’è gossip poetico è perché non interessa nessuno. Cosa volete che importi alle gossippare di professione sotto l’ombrellone o in portineria di poeti e letterati? Se qualche circolo letterario o qualche piccola casa editrice cercasse di ravvivare il mondo poetico con del gossip poetico non alimenterebbe niente, non produrrebbe niente di positivo. Nel migliore dei casi il gossip poetico finirebbe per scimmiottare maldestramente il gossip dello spettacolo. Qualcuno potrebbe sostenere, neanche troppo paradossalmente, che il vero gossip poetico dai tempi di Freud in avanti è la critica psicoanalitica o biografica, che dir si voglia (per intendersi quella che parla delle emorroidi e non degli epistemi, come annotava Montale). Certo a vantaggio di certo psicologismo va detto che il biografismo spesso determina la postura autoriale, lo stile, parte dell’opera, ma non andiamo oltre: il pessimismo cosmico di Leopardi non scaturisce totalmente dal fatto che fosse gobbo, anche se in certa parte ci può influire. Ritornando alla contemporaneità, questo disinteresse totale nei confronti della poesia va avanti da decenni; uno dei segni inequivocabili è che la poesia, almeno quella italiana, sia totalmente fuori dallo show business. La realtà è che la poesia non rientra nel mondo dello spettacolo. Tutti sono artisti nel mondo dello spettacolo, ma per un poeta o una poetessa non c’è mai posto. Nessun poeta di belle speranze ha un agente, un manager. Nessuno caga i poeti. Come distinguere poi il buono dal mediocre? Un tempo l’unico posto concesso dalla televisione generalista, parlo di anni fa, era alla Corrida: qualche spazio veniva lasciato a certi dilettanti allo sbaraglio, che si esponevano al pubblico ludibrio. Ma la stessa televisione generalista ha spesso dileggiato il mondo dell’arte. Vi ricordate quando anni fa Ezio Greggio faceva vedere un quadro e poi sentenziava scherzosamente “tavanata galattica”. La cultura, l’arte, vere o presunte, dovevano sempre subire la presa in giro in nome di una presunta superiorità goliardica. Ogni pretesto, ironico o no, era un modo per dare addosso all’arte. C’era comunque un altro modo di ammazzare l’arte ed era quello di trattarla in modo noioso e soporifero, come accadeva spesso in RAI anni fa. Talvolta oggi si ha l’impressione che qualche poeta cerchi a tutti i costi l’occasione buona per rientrare nel mondo dello spettacolo, cercando di tirare per la giacchetta alcuni cosiddetti vip. Affari loro! Si accontentino pure delle briciole di visibilità che il mondo delle cosiddette “star” danno loro! Eppure un poeta autentico non dovrebbe ambire alla fama a tutti i costi. È vero che per ogni autore esiste il diritto/dovere di essere conosciuto. Ma ciò richiederebbe un minimo di etica, di dignità, di coerenza! Capisco che vivere una vita in perfetto anonimato e con scarsissima riconoscibilità può rovinare il carattere o addirittura la psiche. È altrettanto vero che bisognerebbe avere un minimo di saggezza per godersi pienamente l’anonimato, che – diciamocelo onestamente – la poesia dà. Alcuni/e invece non si accorgono di questi benefici. In definitiva minore è il rumore del mondo circostante e più facile è raccogliersi in meditazione o ammirare le bellezze della natura. Non a tutti capita di essere citati dalla Isoardi per lasciare Salvini come accadde a Gio Evan, che a onor del vero poeta non è e infatti la critica letteraria non lo considera minimamente, nonostante la notorietà (ma tante persone si accontentano beatamente dei surrogati della poesia). Comunque è meglio così. I poeti non avranno gruppi di ammiratrici né bagni di folla, ma possono fare anche giri in centro senza essere disturbati. È vero che un poeta qualsiasi non gode di alcun privilegio, però non ha neanche hater e stalker. Alla stragrande maggioranza dei poeti e delle poetesse non tocca il benessere materiale, a meno che non abbiano una famiglia agiata alle spalle. Pubblicare, andare alle conferenze, incontrarsi con altri letterati, comprarsi libri per rimanere aggiornati sono cose che hanno un costo. È rarissimo che uno con la poesia faccia pari. Di solito ci rimette. E allora vi chiederete voi chi lo fa fare ai poeti? Semplicemente la passione, l’abnegazione, l’amore per la poesia. In fondo oggi tutti sono poeti e nessuno è poeta. Una volta un cantautore diceva molto snobisticamente che oggi scrive poesie anche la casalinga di Voghera. In quel che diceva in un modo molto sbagliato forse un fondo di verità c’era. Di sicuro oggi il tasso di scolarizzazione è aumentato rispetto a qualche decennio fa. La produzione poetica è cresciuta di pari passo. Ci sono talmente tanti premi inutili e talmente tante case editrici non selettive che le cosiddette persone comuni non sanno distinguere chi ci marcia su e chi vale. Per non sbagliare si affidano ai mass media. Così acquista credibilità solo chi viene visto in televisione. Ma i poeti non vengono invitati in televisione di solito; se va di lusso al poeta o alla poetessa viene dato lo spazio di un minuto su RAI3 in tarda serata o di notte. La verità è che la poesia non fa ascolti. Molto probabilmente decenni fa davano spazio a Montale, Ungaretti, Pasolini perché non c’era l’audience e poi i tempi sono cambiati, per alcune cose in peggio e per altre in meglio. Parliamoci chiaro: è mortificante per una poetessa avere studiato, letto, scritto per una vita e non essere considerata dai mass media, mentre la showgirl svampita, dopo qualche passaggio televisivo, ha notorietà e soldi che lei non ha mai avuto in tutta la sua esistenza. È il mercato, purtroppo. Quando Rino Gaetano cantava “allestite anche le unioni dalle dite di canzoni” erano gli anni ’70. Da anni calciatori e showgirl sono sulle prime pagine dei rotocalchi. Vengono celebrati i loro amorazzi, che talvolta sfociano in un matrimonio. Loro hanno la centralità del gossip. Loro hanno l’esclusiva. Ma vuoi mettere starsene in disparte? Ma vuoi mettere essere sconosciuti ai più? Anche perché essere conosciuti ai più come poeti o poetesse non necessariamente è una bella nomina. Molti concepiscono il poeta come persona astrusa che rincorre le farfalle ed è completamente fuori dal mondo. Per molti romani dell’epoca Amelia Rosselli era solo una che scriveva poesie e intendevano ciò in modo canzonatorio, addirittura spregiativo.

Joyce in “Ritratto dell’artista da giovane” scriveva: “Non servirò ciò in cui non credo più, si chiami questo la casa, la patria o la Chiesa: e tenterò di esprimere me stesso in un qualunque modo di vita o di arte quanto più potrò liberamente e integralmente, adoperando per difendermi le sole armi che mi concedo di usare: il silenzio, l’esilio e l’astuzia”. Queste parole sono completamente estranee a certi poeti e poetesse, presenzialisti/e, sempre pronti/e a declamare i loro versi in questo o quel festival. Alcuni/e sono come la gramigna. Sono ossessivamente presenti. Non possono fare a meno di farsi conoscere nei circoletti. Il massimo della soddisfazione e del narcisismo è quando qualcuno chiede loro degli autografi. Hanno coronato il sogno della vita. Tutto sembra basarsi sulla riconoscibilità immediata. Alcuni/e cercano il riscontro del pubblico. Invece sarebbe meglio dosare le forze, centellinare le presenze, essere più preziosi, farsi desiderare di più. Il rischio, a forza di darsi a tutti, è quello di venire a noia. Il mondo quotidiano però è avaro di gratificazioni e di successo per i poeti. Quando si incontrano i poeti talvolta diventa una piccola gara a chi ce l’ha più lungo o a chi è più bella: io ho pubblicato più copie, io ho pubblicato con una casa editrice importante, io ho pubblicato su più riviste letterarie, io ho vinto più premi, io sono in più antologie scolastiche. La cosa paradossale è che se pubblicamente dichiarano la rimozione dell’io lirico in poesia, nei fatti, nei social, nei loro siti internet, nella vita privata cercano l’affermazione del loro io a tutti i costi.
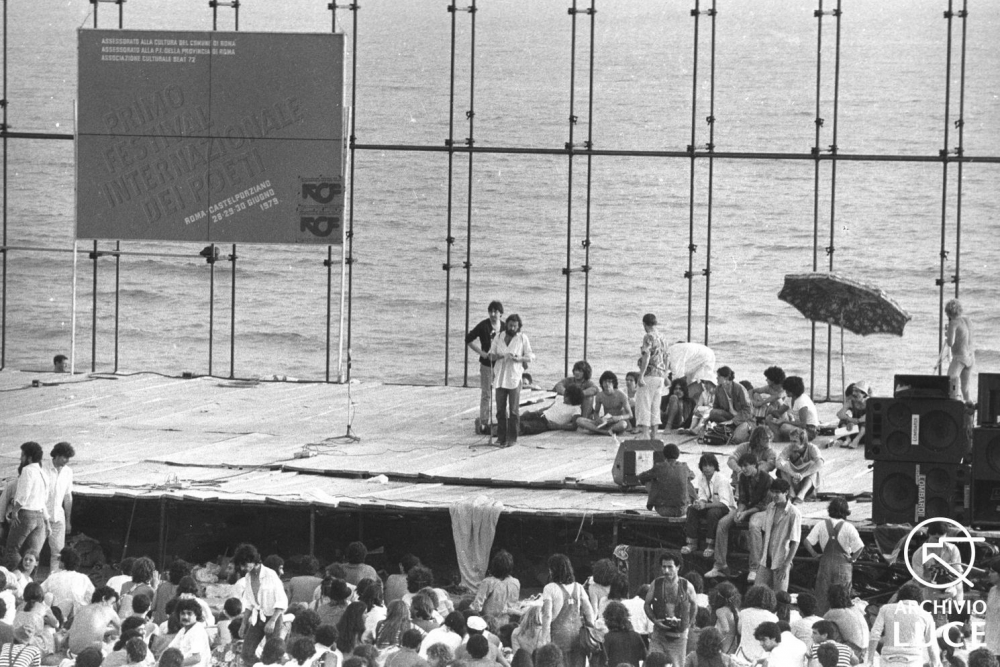
(Nella foto il festival di Catelporziano)
Mai scoperchiare questo vaso di Pandora perché chi descrive pubblicamente questo stato di cose viene criticato, zittito, biasimato in tutte le forme. Gli anni passano per tutti, ma l’importante per certi poeti è avere qualcosa di cui vantarsi nell’angusto mondo delle patrie lettere. Chi denuncia pubblicamente la situazione comatosa in cui versa la poesia italiana è un frustrato, un deluso, un fallito, un aspirante poeta mai riconosciuto. Alcuni dicono che sono cose vere, però non vanno dette. Personalmente a casa mia meno per meno fa più. Personalmente non mi diverto a constatare questo stato di cose, ma lo faccio per spirito di servizio. Ritengo anche che sia questione di avere un minimo di onestà intellettuale e di dire come vanno le cose. Certo ci sono ripicche, invidie, gelosie, compromessi, conflitti, antipatie, simpatie, favoritismi, ostracismi. Anche i poeti sono esseri umani. Allo stesso tempo come canta De Gregori quando tra “buoni poeti ne trovi uno vero è come andare lontano, viaggiare davvero”. Eppure di poeti e poetesse buoni/e e anche ottimi/e ci sono, esistono. Allo stesso tempo non hanno visibilità né dalla critica né dai mass media. Un tempo i poeti che valevano avevano molta più importanza nella cultura. Oggi invece sono relegati a un ruolo marginale, vengono messi in un angolo nascosto. Non c’e da stupirsi se il cosiddetto popolo non considera i poeti, visto che gli stessi letterati, studiosi e appassionati non ne hanno a cuore. Ci sono troppi addetti ai lavori che si occupano di poesia e non l’amano, anzi l’hanno in odio. Eppure ci sono poeti e poetesse brave che meriterebbero successo, denaro, amore. Il sistema invece li respinge, li ricaccia indietro. E loro si estraniano, non partecipano più. La loro funzione sociale sarebbe quella di combattere il sistema dall’interno.

Tutto ciò viene continuamente disatteso e cosa resta in fondo? Un atteggiarsi anticonformista, una posa composta di dolore talvolta mai provato, un piangersi addosso tra sodali, un’elemosinare goffo di consensi. Comunque talvolta per questo scompenso, per questa scarsa considerazione perenne alcuni, non potendo gridare al mondo quanto valgono, finiscono per immalinconirsi, incattivirsi, imbastardirsi, in taluni casi giungono alla smania di grandezza, alla megalomania, al delirio di onnipotenza. Fondamentale è passare sopra queste debolezze umane, queste piccole inezie e prendere il buono: dai poeti e dalle poetesse non bisogna prendere assolutamente le loro tare psicologiche, invece bisogna esclusivamente amare i loro versi. Forse bisognerebbe ricordarsi più spesso ciò che scriveva Rilke: “l’arte è solo una maniera di vivere, e ci si può preparare a essa vivendo”. Spesso ho constatato che poeti più o meno riconosciuti non avendo l’amore dal pubblico e non avendo talvolta pubblico vivono tra rabbia e rassegnazione, in uno stato caratterizzato da grandi delusioni e piccole illusioni. In fondo qualcuno dirà che la poesia stessa è un’illusione, ma anche la vita e il vivere quotidiano che cosa è basato se non sull’illusione costante che tutto domani possa andare meglio? Siamo costretti a vivere di piccole illusioni. Tutti quanti, poeti e no.