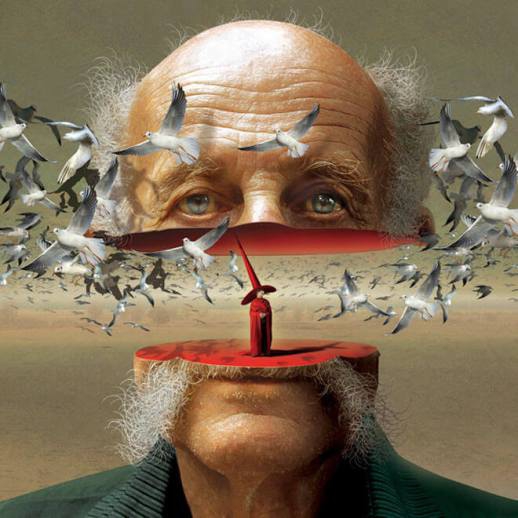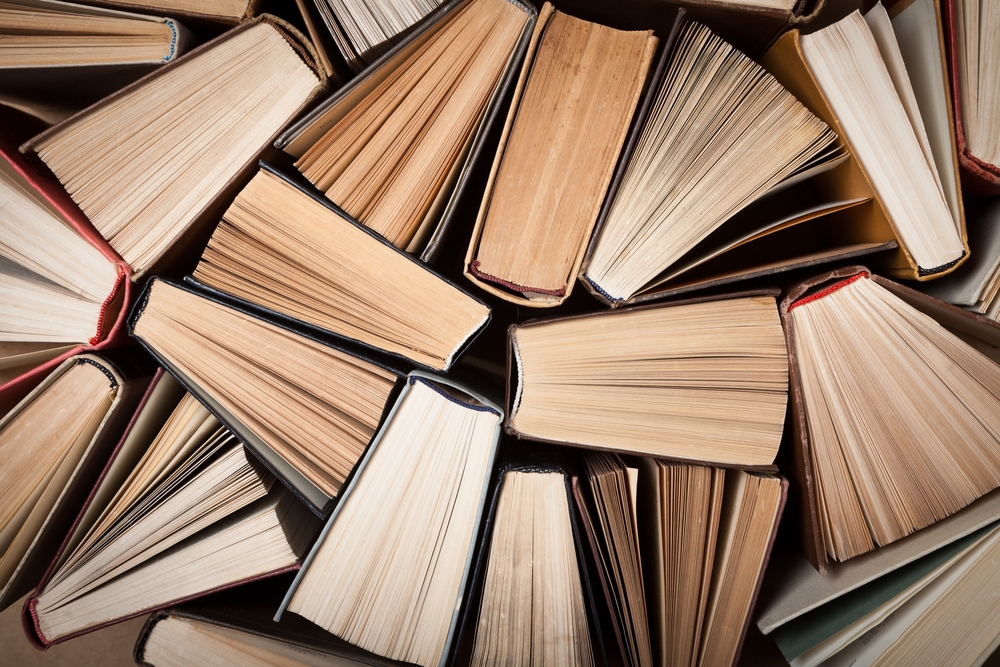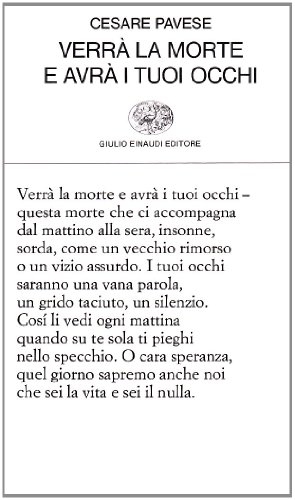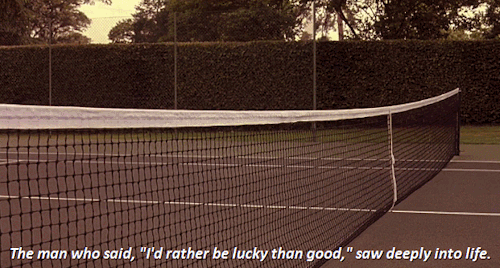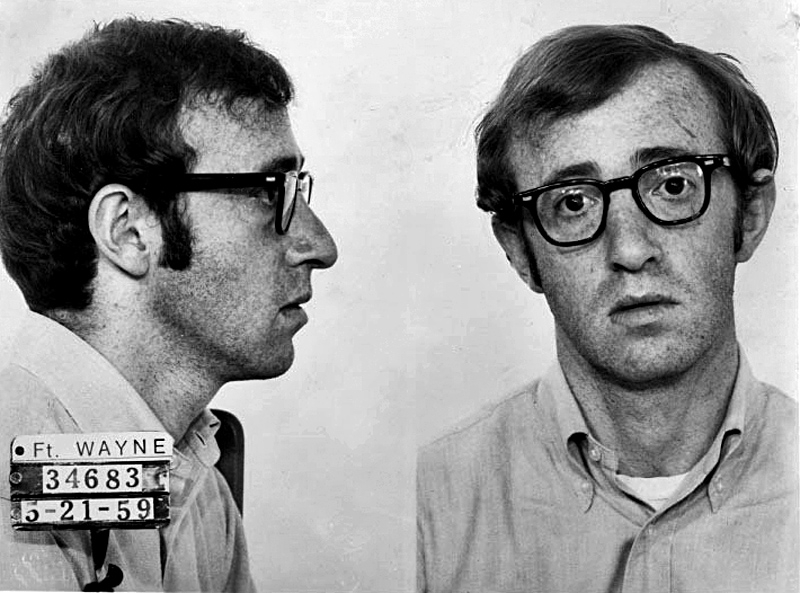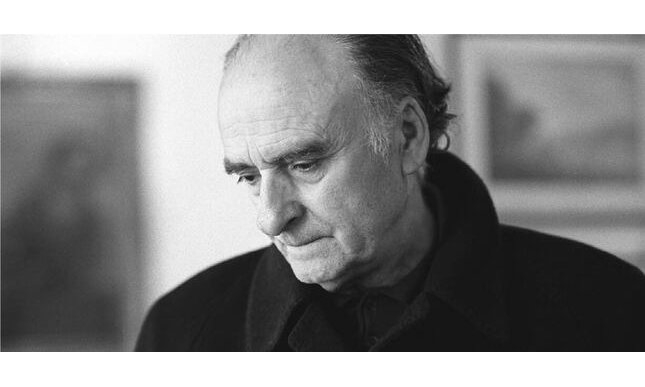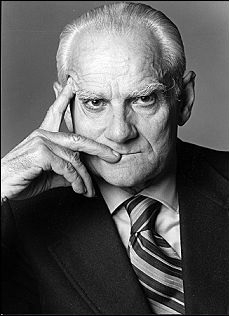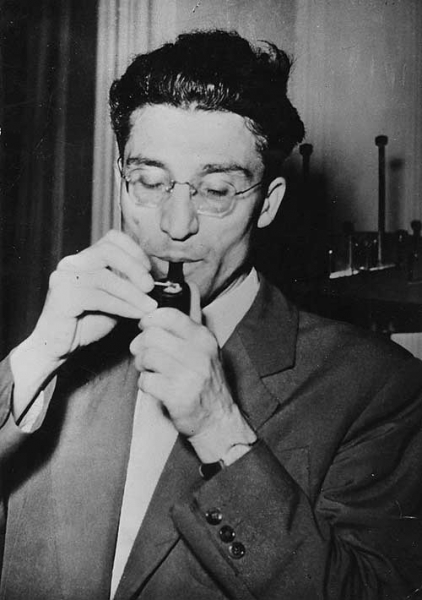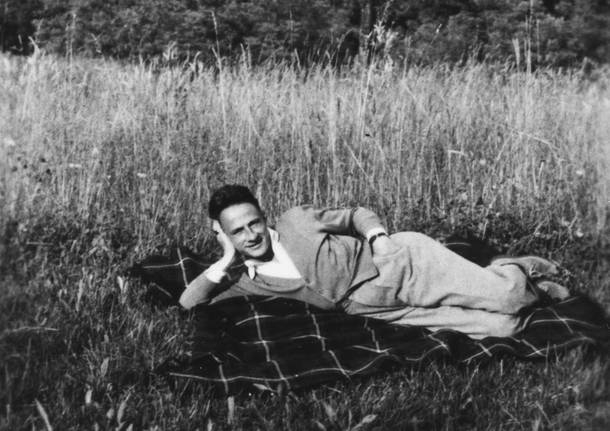mag 032024
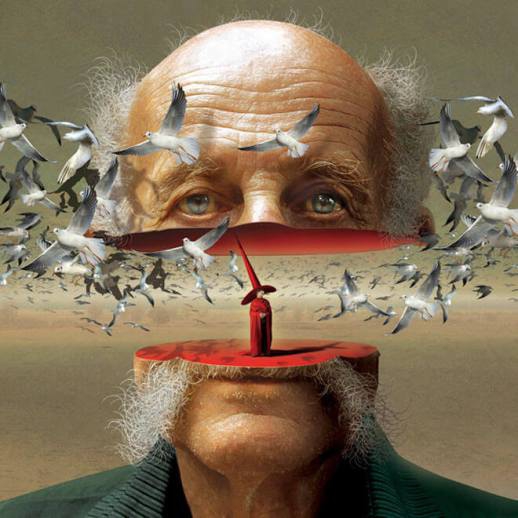
Secondo alcuni grandi autori (Freud, secondo alcuni aspetti Jung, Mieli, etc) in natura l'umanità sarebbe bisessuale. Freud definisce il bambino “perverso polimorfo”. Jung parla di Anima e Animus. Per Mieli nei primi anni siamo tutti pansessuali e poi è l'educazione che ci determina e ci inibisce. Ma è un'ipotesi, anche se accreditata, dato che questi autori hanno analizzato migliaia di casi e al mondo siamo 8 miliardi. Secondo la condotta Kinsey solo il 10% degli uomini avevano avuto rapporti omosessuali. Per i biologi ci sono circa 1500 specie animali che hanno comportamenti omosessuali. Ci sono alcuni studiosi che pensano che noi in natura siamo come i Bonobo kissing. Quindi è del tutto errata la convinzione che l'omosessualità sia contro natura. Ungaretti, intervistato a riguardo da Pasolini, sosteneva (e io ora semplifico) che la cosiddetta diversità, se esiste, non è contro natura, ma è prevista dalla natura. C'è chi sostiene che gli antichi greci e i latini erano tutti bisessuali e l'omofobia è arrivata con l'avvento del cristianesimo. Attualmente la Chiesa considera la sessualità omosessuale un peccato, ma, ammesso e non concesso che lo sia, non è reato, mentre per molto tempo è stato considerata tale: si ricordi a tal proposito Oscar Wilde e Turing, tanto per fare due nomi! Ancora oggi c'è uno stigma sociale nei confronti delle persone Lgbt. Secondo la scienza l'omosessualità è una variante assolutamente non patologica del comportamento sessuale umano. Ma probabilmente questa definizione è limitante. Potrebbero essere diverse le ipotesi: potremmo essere in natura tutti eterosessuali, tutti omosessuali oppure eterosessuali e omosessuali oppure ancora eterosessuali, omosessuali e bisessuali oppure di nuovo tutti bisessuali. E poi alcuni ipotizzano un continuum eterosessuale versus omosessuale, altri pensano che tutto sia "dicotomico". Le cose poi si complicano ulteriormente perché esistono i metrosexual, la fluidità sessuale, la transessualità, etc etc. La teoria del gender farà dei danni? Qualsiasi tipo di educazione può fare dei danni, anche l'educazione vittoriana, il metodo Montessori, lo stesso cattolicesimo: dipende chi e in che modo insegna, dipende il tipo di sensibilità e personalità degli allievi. I bambini dati in affidamento agli omosessuali possono subire gravi danni? Non è scientificamente accertato, molto probabilmente è una grande panzanata. Inoltre quei bambini cresciuti nella povertà avrebbero danni maggiori rispetto a essere adottati da dei genitori civili e omosessuali (ammesso e non concesso che subiscano del danni, crescendo con genitori omosessuali). Per quanto mi riguarda conosco coppie eterosessuali molto più disfunzionali delle coppie omosesssuali! Al di là di cosa siamo in natura, dell'interazione tra natura e cultura, della costruzione sociale dell'identità di genere ognuno ha diritto a essere come vuole e come si sente: importante è che non faccia del male agli altri. Ognuno ha anche diritto a vivere il suo orientamento sessuale e la sua sessualità, esibendosi oppure vivendo con discrezione, sempre considerando che l'outing è più che legittimo e il coming out molto spesso è una forzatura illegittima, una violenza psicosociale. Rivedevo in questi giorni “Salò o le 120 giornate di Sodoma” di Pasolini. Non entro nel merito dell'anarchia del potere, del fascismo, del film “disturbante”, ma mi ha colpito la domanda di un personaggio: a cosa può portare un desiderio frustrato? Se un desiderio frustrato può portare alla deriva psicologica, a cosa può portare una sessualità totalmente repressa o nascosta? Non dimentichiamoci che gli omosessuali nei secoli, almeno qui in Italia, sono stati, per così dire, “castrati”, costretti a non vivere la loro sessualità e i loro sentimenti. Chi non è eterosessuale deve far valere i suoi diritti. È chiaro però che ognuno dovrebbe vivere la propria sessualità come meglio crede e il resto del mondo non dovrebbe etichettare, spettegolare, calunniare, diffamare e giudicare. Se tutti si guardassero bene dentro, decidessero come vivere la loro vita senza cercare di rovinarla agli altri (mi riferisco agli omofobi, ai transfobi) questo sarebbe un grande passo in avanti per la civiltà occidentale: la libertà di sspressione non è solo libertà di dire la propria opinione, ma di esprimere sé stessi secondo le proprie inclinazioni e i propri gusti. La sostanza di questo articolo qual è? Che essendo certi di poco o niente riguardo la sessualità non dovremmo giudicare ed essere giudicati, così di primo acchito, ma solo per comportamenti assolutamente gravi ed eticamente riprovevoli, che non riguardano assolutamente le scelte e l'orientamento sessuale. E qui il cerchio si chiude.
apr 222024

Ho dei momenti non dico di obnubilamento totale, ma di lieve rassegnazione, di sconforto leggero, pervaso dal nichilismo. Cammino per le strade, guardo la gente e penso. Mi dico che ognuno porta a giro sé stesso, che ognuno gira a vuoto, che ognuno parla a vuoto ma mai del suo vuoto, che ognuno è preda della noia, che ognuno non è alla fine sicuro di niente, anche se si convince di avere certezze. Come si dice in Toscana, l'unica certezza è la morte, se si escludono le verità della scienza e le ovvietà. Ma a livello esistenziale e metafisico non c'è nulla di certo… parlo di certezze assolute. E le persone fanno gruppo per passare il tempo, ammazzare la noia e talvolta si amano, talvolta si detestano. Annotava Pavese nel suo diario che le persone si incontrano, fanno l'amore, si amano e che anche lui avrebbe voluto fare come loro. Forse l'unica via di uscita, l'unica ancora di salvezza è proprio l'amore, anche una parvenza o l'illusione dell'amore. Leggevo qualche giorno fa che degli studenti avevano chiesto a un grande antropologo qual era il primo segno di civiltà della specie umana. Tutti pensavano all'opponibilità del pollice, alla stele, alla ruota, alla scoperta del fuoco, allo sviluppo della corteccia frontale, al culto dei morti, alla fabbricazione dei primi utensili. No. Lui rispose che il primo segno di civiltà era un femore rotto e poi guarito. Quindi essere curati e curarsi delle persone: questa è l'essenza della civiltà umana. E però io non amo, né sono amato da una donna. La mia vita sociale è prossima allo zero. E io sono out, fuori dal giro. Sono solo, ma mi perdo qualcosa o qualcuna veramente? Sarà questo il senso di sfinimento di cui parla Franco Arminio? Eppure lui ha successo, case, moglie, figli, fan. Oppure è solo una posa la sua? Mi dico che qui e ora l'importante è fare soldi, apparire, scopare: il soggetto cartesiano è stato spodestato e ora dal cogito ergo sum siamo passati al coito ergo sum. E io, sia ben inteso, non faccio soldi, non appaio, non scopo. Non ho nemmeno un ruolo definito. Vogliamo tutti possedere, consideriamo tutto e tutti come merce, guardiamo alla praticità e all'utilità di ogni cosa, di ogni persona e finiamo per essere impossessati dal vuoto, dalla noia, dal non senso. Come ben nota Andrea Inglese su Nazione Indiana per Freud pulsione di morte e coazione a ripetere sono strettamente connessi. Tutti fanno, sono sempre in azione, senza capire che questa società è intrisa dal cupio dissolvi. C'era il mio professore di storia della filosofia, Accame, che scriveva in un suo libro, già negli anni ‘90, che tutti avevano sempre da fare, che anche chi non aveva niente da fare sembrava indaffarato. Non è forse questo il modo migliore per riempire il vuoto esistenziale e non pensare? Mi chiedo io: ma dove correte? Per arrivare dove? Dove correte, se vi aspetta la morte? Eppure l'etologo e scrittore Giorgio Celli, che aveva fatto anche parte del gruppo '63, ci aveva già avvertito: "Il cervello ha tradito la specie umana". L'ingegno e la scienza sono al servizio di governi che fanno guerre sanguinarie. Al progresso scientifico non è seguito lo sviluppo storico ed etico. Gli scienziati hanno recentemente stabilito che non siamo nell'Antropocene, ma siamo ancora nell'Olocene. Ma, al di là di ciò, in questa prossima, possibile apocalisse non c'è forse la mano dell'uomo, non ha forse una causa antropica questo disastro? Lo so. Questo è un ottimo sito letterario e io dovrei trattare seriamente di letteratura e poesia. Ho sempre cercato di farlo. Però questa volta voglio essere sincero e parlare di me, anche se talvolta parlando d'altro si finisce per parlare di sé stessi e viceversa, in una incomprensibile eterogenesi dei fini. A volte mi chiedo: i libri che leggo mi servono davvero per vivere meglio? I libri che ho letto e che leggo mi riguardano veramente oppure sono solo un accumulo di nozioni, utili soltanto a fare i cruciverba della Settimana enigmistica, che poi non compro neanche più? Leopardi scriveva che la poesia vera accresce la vitalità. Ma davvero le poesie lette e quelle che ho scritto hanno accresciuto la mia vitalità? Sartre scriveva che ogni uomo è sempre circondato da sé stesso. È questo il problema? Oppure ognuno vive con i suoi sofismi, i suoi piccoli rancori quotidiani, “scordando che tutti avremo due metri di terreno”, come cantava tempo fa Guccini? Mi dico che la miglior cosa è vivere in superficie, abolire la profondità, lo spirito, il pensiero. Ma questo basta? L'importante è avere una scopamica. Questo è l'obbligo sociale per un uomo rispettabile, per un maschio che si rispetti. A volte mi chiedo cosa sono disposto a fare per rompere la mia solitudine e non trovo una risposta. Mi chiedo che senso ha leggere e scrivere. Mi chiedo che senso abbia tutto questo e se sono io che non so dare un senso. Ma forse sono solo i problemi pseudoesistenziali di un cinquantenne che ha tempo da perdere. Intendiamoci: non sono questi i drammi. La cosa migliore però è non pensare. Alcuni mi potrebbero rispondere: “ma cosa vuoi? La vita è questa. È sempre fatta dalle solite cose. Quando si arriva a una certa età si mette famiglia oppure si sopporta la solitudine”. Oppure mi potrebbero dire: “pensa a chi muore sul lavoro e alle tragedie dei familiari “. E avrebbero ragione. Ogni giorno ha il suo segreto e naturalmente mi sfugge. Ma forse il senso delle cose è più vicino e tangibile di quel che penso.
feb 242024

Carpe diem? Tutti dicono di cogliere l'attimo. Vige il carpe diem, insomma, in questa società. Ma quale attimo va colto? Va scelto con cura o ponderatezza l'attimo oppure bisogna cogliere qualsiasi attimo? E bisognerebbe stare tutta la vita a cogliere l'attimo oppure ogni tanto si può riposarci, mettersi in disparte ad osservare gli altri che colgono gli attimi? Ognuno colga il suo attimo perché ognuno ha le sue opportunità, ma cogliere l'attimo da antico e saggio consiglio di vita è diventato oggi un fattore imprescindibile di ogni esistenza. Che poi l'attimo è fuggente e bisognerebbe prendere l'eternità di quell'attimo! Le neuroscienze ad esempio ci insegnano che non viviamo mai pienamente il presente, che al massimo viviamo in un passato molto prossimo. Essere meditativi non paga. Bisogna essere attivi e vitali, a costo di perdersi in un vortice di vitalismo disperato, che sfugge a ogni logica. Gli artisti o aspiranti tali però devono anche cogliere il ricordo, l'immagine, il pensiero, il senso dell'attimo vissuto. L'arte consiste nell'eternare, nell'immortalare gli istanti vissuti, che poi è un modo di cogliere e vivere nuovamente l'attimo. Ma vivere pienamente e scrivere dignitosamente sono per alcuni due cose inconciliabili. Vivere e scrivere sembrano agli antipodi. Carpe diem? C'è chi dice che prima bisogna vivere, quindi scrivere. Secondo questa scuola di pensiero bisognerebbe scrivere ciò che si vive. Ma ci sono molti artisti schivi e riservati che fuggono dalla vita quotidiana (perché la quotidianità è alienata, è inautentica, è non vita), si rifugiano in un angolo tutto loro, si mettono al riparo dalle offese e dagli orrori del mondo per concentrarsi meglio, per meditare a lungo proprio sull'esistenza. Questi artisti scrivono per provare l'epifania, ovvero l'illuminazione interiore. Scrivono per vivere e per loro l'essenza della vita è la scrittura: scrivere quindi è la fonte sorgiva della gioia. Carpe diem? Eliot scriveva che si impara sia per esperienza pratica che per conoscenza teorica. Gli artisti corrono il rischio di eternare più la vita immaginata che quella reale, ma poi qual è la vera vita? Perché l'attimo immaginato non va bene? Perché non va bene cogliere anche quello? E poi perché cercare un confine tra sogno e realtà? Sono comunque istanti immortalati, selezionati dagli artisti, dal caso o da Dio? Questo non lo sapremo mai. Cammino sui lungarni e poi sotto i loggiati di Pisa. Prendo dei vicoli, assorto nei pensieri. Vago senza meta. Pioviggina e non ho l'ombrello. Poi viene fuori il sole. Cosa significa ora cogliere l'attimo per me in questo momento? Cercare di approcciare una passante o una barista, nel 99,9% dei casi prendendomi un due di picche? Bermi una birra a un bar? Telefonare a un amico? Continuare a cercare una bancarella di libri usati? Continuare a camminare fino a Piazza dei miracoli? Continuare a vagare e poi ritornare alla stazione senza assentarmi da me stesso? Cogliere l'attimo vuole solo significare divertirsi come fanno tutti? Comunque molti artisti si ritirano nella loro stanza oppure guardano per ore dalla finestra o si mettono a osservare la vita circostante a un tavolino di un bar in attesa non di cogliere l'attimo ma che l'attimo li colga. Montale aveva delle muse e delle agnizioni. Certe donne erano viste come “divinità terrestri” che lo ispiravano; solo loro erano capaci di cogliere l'attimo ma anche di farlo sognare, pensare, meditare, scrivere: “Ti guardiamo noi della razza di chi rimane a terra”. Carpe diem? Pensiamo all’atteggiamento mentale di chi fa meditazione o si mette a riflettere sul letto nel silenzio e nella penombra. Si dice che queste persone rimangono in ascolto del mondo e di sé stessi. Carpe diem? È un atteggiamento apparentemente passivo. È l'ozio in attesa di diventare fertile, produttivo. È l'attesa dell'ispirazione o che quantomeno affiori un'idea. Per gli antichi l'ozio anche etimologicamente veniva prima del negotium, ovvero del lavoro. Oggi l'ozio è condannato da tutti, è considerato totalmente improduttivo. L'unico tempo libero non condannabile è quello dei pensionati, come premio di una vita di lavoro. Il disoccupato è visto principalmente come uno che non ha voglia di lavorare o che è incapace di lavorare. I frutti dell'ozio postmoderno possono essere anche pregevoli artisticamente o culturalmente, ma sono visti come semplice espressione di dilettantismo e di hobby, se non diventano business. Eppure i grandi creativi hanno avuto lunghi periodi di ozio infecondo spesso prima di creare o scoprire cose memorabili. La psicologia del pensiero ci insegna che in ogni fase creativa è necessario un periodo d'incubazione, preceduto dalla preparazione e seguito dall'intuizione felice. Spesso per riuscire ad avere un'idea originale, uno spunto interessante bisogna stare per giorni a non fare apparentemente niente, mentre in realtà i pensieri vengono rimuginati, si rielaborano inconsciamente i contenuti, si approccia un problema a 360 gradi, magari anche infruttuosamente. Sono pensieri sottotraccia che si affollano, fino a quando uno emerge, fa chiarezza, ristruttura cognitivamente il compito da risolvere. Per l'ozio ci vuole un silenzio preparatorio e una stanza tutta per sé. Pascal non aveva torto quando scriveva che molti mali dell'umanità derivano dall'incapacità degli uomini di starsene chiusi da soli nella loro stanza. Per stare bene con gli altri e per non creare danni agli altri bisogna stare prima di tutto bene con sé stessi. Carpe diem? E poi l'attimo non si può cogliere anche da soli con sé stessi? Perché bisogna per forza cogliere l'attimo con gli altri, magari perdendosi nella frenesia e nella superficialità della vita sociale? Perché bisogna per forza essere socievoli e mondani per cogliere l'attimo? Perché poi cogliere l'attimo deve essere un obbligo sociale e perché le occasioni bisogna cogliere sempre insieme agli altri? Carpe diem? Bisogna amare occasionalmente, divertirsi in modo sfrenato e va bene anche sballarsi, fino ad autodistruggersi. Ho chiesto una volta molti anni fa a un amico dopo una storia d'amore finita male con una donna: preferisci che lei ti abbia lasciato, scomparendo per sempre, dopo averla amata anche carnalmente, oppure preferivi che lei fosse una tua amica per tutta la vita senza mai andarci a letto? La risposta è stata che era meglio la prima cosa, perché per come siamo fatti noi uomini occidentali e per come è fatta la società bisogna agire, amare, concludere, finalizzare, avere un'altra conquista nel carnet degli amori. In definitiva l'importante è aver vissuto, anche se a larghi tratti in certe persone gli automatismi psicologici e il volere altrui sembrano fare da padrone. Invece bisognerebbe fare, pensare, volere ciò che più ci aggrada. A volte sembra che la vita vada da sé autonomamente, indipendentemente dalla nostra volontà. Carpe diem? Sembra che in questa continua ricerca della felicità più effimera e banale possibile dell'uomo occidentale la cosa peggiore è non aver vissuto pienamente, non aver colto la palla al balzo, aver sprecato tempo, avere dei rimpianti. Secondo la nostra mentalità comune è meglio sbagliare molto e vivere nel disordine, nel caos invece di isolarsi a riflettere, a diventare esseri più spirituali. L'estroflessione sociale è un dovere. Ho la vaga impressione che vivere troppo intensamente a lungo possa portare a un senso di vuoto, di smarrimento, di esaurimento, di noia. Una vita troppo mondana può arricchire ma anche logorare e abbruttire. La leggerezza può tramutarsi in pesantezza insostenibile. Poi ci si guarda indietro, si fa un bilancio esistenziale e la coscienza rimorde, perché sono troppi gli errori commessi, troppe le cose e le persone importanti lasciate e perdute per sempre, irrimediabilmente. Carpe diem? E poi a tutta questa retorica del carpe diem è sottesa implicitamente la concezione che il tempo è denaro e che non bisogna mai perdere tempo, ovvero il fatto che bisogna consumare tutto e tutti, anche la propria vita, anche sé stessi, fino all'ultima fibra. Carpe diem?
feb 072024

Nella foto Eros Alesi (1951-1971)
Tomasi di Lampedusa scrisse un solo romanzo, “Il gattopardo”. Salinger oltre a “Il giovane Holden” pubblicò solo tre libri in vita e altri racconti su riviste. Pessoa pubblicò in vita solo su riviste letterarie. Campana ebbe la gloria postuma solo per “I canti orfici”. Svevo scrisse solo tre romanzi e poche pagine di un quarto, intitolato “Il vecchione”, rimasto incompiuto per l'incidente automobilistico mortale. Del poeta romano Eros Alesi, scomparso a soli 19 anni, resta un solo libro, “Che puff. Il profumo del mondo. Sballata”, edito da Stampa alternativa. Del poeta Giuseppe Piccoli, nonostante in vita avesse pubblicato dieci sillogi in piccole case editrici, resta oggi solo il volume “Fratello poeta”, edito da Lietocolle. Insomma si può scrivere poco, pubblicare ancora meno e passare alla storia. Oggi però le case editrici forzano la mano. Uno scrittore deve battere il ferro finché è caldo. Quindi deve essere molto prolifico. Spesso deve pubblicare un libro all'anno. Poco importa se le opere sono più commerciali che letterarie. Poco importa se tutto questo va a discapito della qualità. Poco importa se i libri di uno scrittore si assomigliano tutti troppo e risultano poco originali. In teoria una creatività veramente rispettabile presupporrebbe tempi lunghi per l'incubazione, per la stesura, per l'editing. In teoria ci vorrebbe talento, impegno, fatica ma anche pazienza, calma. In teoria non dovrebbero essere fatte pressioni indebite agli scrittori. Uno scrittore in teoria dovrebbe prendere tempo, correggere, aggiungere, tagliare, rivedere, pensarci sopra. In pratica ci sono le esigenze editoriali. In pratica anche gli scrittori devono guadagnarsi il pane e tengono famiglia. Inoltre un romanzo scritto nel 2024 potrebbe non interessare nessuno e risultare datato pubblicato dieci anni dopo. Aspettare tempi più propizi non avrebbe senso, perché tempi più propizi non ci saranno! Quindi non avrebbero più senso oggi il riserbo, la discrezione, la gelosia degli scritti inediti che rimanevano nei cassetti dei letterati del secolo scorso. Custodire gelosamente le proprie opere, sperando che i posteri possano apprezzare e capire è mera illusione, è una mistura di follia e albagia. Oggi l'imperativo è pubblicare, anche sul web, ma pubblicare. Un'altra osservazione: nessuno sa oggi chi e cosa resterà tra mezzo secolo, quali saranno gli autori memorabili. Pessoa per alcuni al suo tempo era solo un alcolizzato, Campana per molti era un pazzo, Morselli e Tomasi di Lampedusa per molti erano solo dei dilettanti che vivevano di rendita, molti crepuscolari per gli uomini della loro epoca erano solo dei tisici. E oggi? Oggi è molto difficile dire chi resterà. Degli indicatori che forniscono una certa predittività ci sono, come la pubblicazione con grandi case editrici, la vittoria di premi importanti, il consenso critico dei più autorevoli italianisti. Ma ciò che conta per molti è affermarsi in vita, avere successo, prestigio, riconoscimento, soldi vita natural durante, perché tanto la gloria postuma è una grande incognita, probabilmente non salva l'anima, ammesso e non concesso che esistano l'anima e l'aldilà. Un proverbio dei pigmei recita: “se non qui e ora, che cosa importa dove e quando?”
gen 232024

Supponiamo che abbiano ragione i critici letterari e i veri intenditori di poesia e narrativa. Supponiamo che il loro parere sia più competente, autorevole, sensato rispetto al pubblico. Supponiamo che esistano ancora dei canoni e dei criteri interpretativi per valutare talento, originalità, qualità di un libro. Ebbene per le persone competenti o supposte tali ogni giorno si consuma una triplice ingiustizia nei confronti degli autori da parte dell'editoria e del mercato. Questa triplice ingiustizia viene appena accennata, spesso sottaciuta dagli addetti ai lavori, che si rassegnano ormai a questo stato di cose. Invece ciò va detto e tutti ne devono prendere coscienza. Premetto che le grandi case editrici vogliono sempre più far cassa e quindi pubblicano libri che possono vendere. Premetto che per le grandi case editrici sono più importanti il marketing, il social marketing, il posizionamento, il positioning branding (quanto un libro o un autore possano occupare la mente del lettore) della qualità. Luciano De Crescenzo quando approdò alla grande editoria pensò di primo acchito che ora sarebbe stato libero totalmente di esprimere la propria creatività e di essere apprezzato per questo, ma si ritrovò qualche giorno dopo a essere costretto a fare riunioni con esperti di marketing, che snocciolavano dati, statistiche, sondaggi. Premetto che le grandi case editrici hanno una politica editoriale diversa rispetto al passato, ovvero non reinvestono una parte consistente dei loro profitti nella pubblicazione di autori di nicchia per tutelare la qualità della loro editoria. Persino le grandi case editrici accettano passivamente le dinamiche del mercato e spesso sono restie a cercare di imporre un libro di qualità sul mercato. Premetto che molte piccole case editrici spesso pubblicano ogni cosa, facendo l'editing opportuno, per fare cassa. D'altronde l'editoria è industria culturale. Quindi perché stupirsi? Le case editrici, piccole, medie o grandi devono pur sopravvivere e cercare di fare utili. Chi cerca di far presente queste dinamiche editoriali spesso viene fatto rientrare dal sistema nella categoria degli odiatori o dei rosiconi.
Abbiamo perciò una triplice ingiustizia, come scrivevo prima:
1) ci sono influencer e vip che pubblicano con grandi case editrici solo perché hanno follower e non si meriterebbero assolutamente di venir pubblicati. Spesso i loro libri hanno bisogno di un grandissimo lavoro di editing oppure i loro libri sono scritti addirittura da ghost writer.
2 ) ci sono autori di piccole case editrici che non hanno talento e vengono pubblicati solo perché hanno sborsato dei soldi.
3) ci sono autori di piccole case editrici che hanno talento, ma sono costretti a pubblicare a pagamento, perché non sono ritenuti “collocabili” dalle grandi case editrici per la logica di mercato che ho detto.
L’editoria quindi, sempre più succube del mercato, commette ogni giorno delle ingiustizie sulla pelle degli autori, illudendoli, ostracizzandoli, addirittura emarginizzandoli.
Credits: foto dell'amico Emanuele Morelli
gen 032024
Alcuni sostengono che scrivere aforismi sia semplice, addirittura facile. In realtà è un'arte. Si potrebbe discutere se sia un'arte minore o meno. Se i proverbi sono saggezza popolare, gli aforismi racchiudono la cultura e la saggezza degli autori. Ci sono autori che devono esclusivamente la loro fama agli aforismi, come ad esempio Morandotti. Ma il punto debole degli aforismi non è che chiunque può crearli, ma che esprimono spesso una certa soggettività e che la verità è un poligono con tanti lati quanti sono gli uomini, come scriveva Gioberti. Forse l'inganno degli aforismi è che promettono leggi generali, insomma oggettività e tutto ciò viene deluso, disatteso talvolta.
Indro Montanelli creava degli aforismi. Poi nelle conversazioni li citava e li attribuiva a grandi scrittori. Nessuno contestava o aveva da ridire. Ma si potrebbe fare anche il contrario: prendere degli aforismi di pensatori famosi e poi dire che sono nostri. Non tutti si accorgerebbero della truffa. Questo significa che l'aforisma è una massima, una sentenza, un pensiero, una battuta: insomma un'opinione spesso e dipende perciò non dalla logica ma dall'autorevolezza di chi ha creato la frase. L'aforisma non è un sillogismo. Con buona pace di Karl Kraus che vedeva in esso "una mezza verità" oppure "una verità e mezzo". Era solo una battuta. Una provocazione. Sempre a tal proposito si deve ricordare che si possono trovare aforismi che affermano una cosa e altri l'esatto contrario. Celebre è l'aforisma di Longanesi a tal proposito: "Eppure, è sempre vero anche il contrario". Ad esempio Pittigrilli nel "Dizionario antiballistico" invertiva gli aforismi. Umberto Eco a riguardo ha definito questo genere di aforismi cancrizzabili, cioè reversibili. Altre volte l'aforisma si rivela una generalizzazione indebita, per cui oltre ad una piccola verità contiene una piccola bugia. L'oggettività lasciamola a quelle che un tempo venivano chiamate scienze esatte. Alcuni potrebbero definire l'aforisma un'osservazione acuta. Ma anche in questo caso potremmo ricordare Popper, secondo cui prima di ogni osservazione ci sono sempre delle aspettative inconsce (e soggettive). Non parliamo poi delle frasi motivazionali, che spesso sono delle ipersemplificazioni di quella branca della psicologia spicciola, che è chiamata crescita personale. Nessuno è depositario di verità: neanche di mezze verità. E la verità umana è sempre provvisoria. Ecco il punto debole degli aforismi, che è anche quello di tutta la cultura umanistica.
gen 032024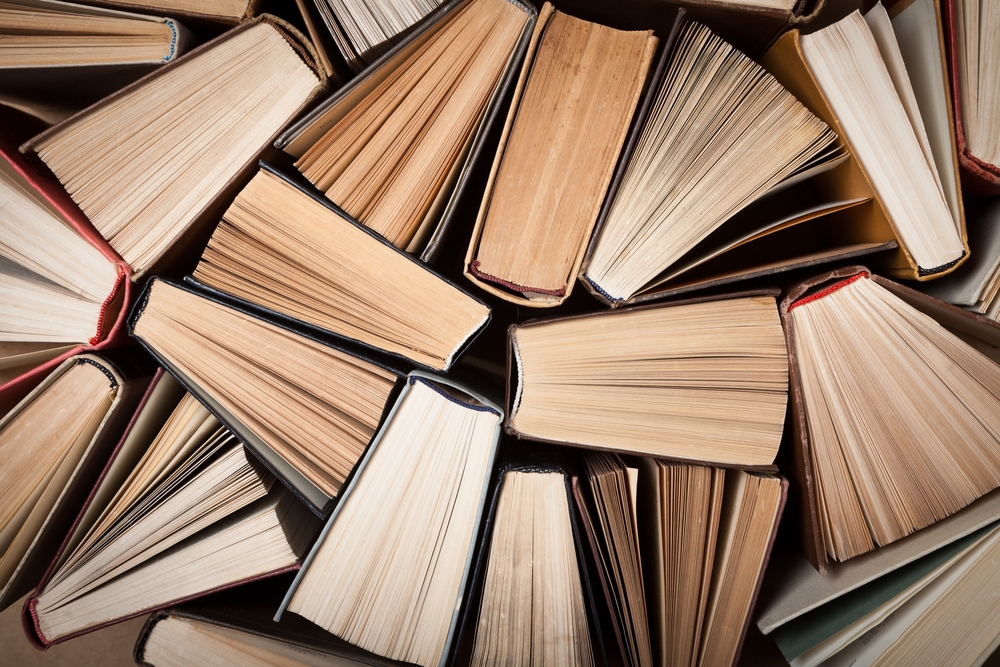
Se un tempo il web era fonte di guadagni esclusivamente per ingegneri, laureati in informatica, smanettoni autodidatti capaci, oggi anche gli umanisti o comunque chi ha una formazione scolastica umanistica possono iniziare a guadagnare qualcosa, ad arrotondare, talvolta fino a farne una professione. Certo i ricavi sono ancora molto minori rispetto agli informatici. Sembra però che il web stia andando verso una nuova fase, dove conterà anche la scrittura e la padronanza del linguaggio. Non a caso sono aumentate notevolmente le iscrizioni alla facoltà di informatica umanistica: informatica e umanesimo, due cose antitetiche qualche decennio fa, che oggi possono unirsi. Per prima cosa un "umanista" può fare l'articolista. Può scrivere articoli su commissione, iscrivendosi a siti, chiamati marketplace, come Melascrivi. È il cosiddetto "paid to write". Inoltre un articolista può collaborare con testate giornalistiche online, facendosi pagare per ogni articolo oppure in base alle visualizzazioni ottenute dall'articolo. Esiste il mestiere di copywriter, che non comprende solo la scrittura di articoli, ma si occupa anche di pubblicità ed è più complesso. Esiste la figura del content creator, ovvero del creatore di contenuti, non solo scritti ma anche su Instagram e audiovisivi. Esiste il web content editor, che corregge gli errori ortografici, di sintassi, di punteggiatura nei siti e apporta migliorie ai testi. Rispetto all'editor classico, che lavora in una casa editrice, questo mestiere richiede meno meticolosità, meno fatica. Esiste il web content writer, che scrive completamente contenuti per siti e blog, occupandosi anche del posizionamento sui motori di ricerca, della cosiddetta Seo optimization. Un'altra occasione per guadagnare è quella di fare i book influencer, recensendo i libri. Ci sono i book blogger, i booktuber, gli Instagram book influencer. Ci sono anche i recensori su Tik Tok, più precisamente su BookTok. Costoro possono diventare collaboratori di case editrici.
Ci sono due piccole grandi insidie per tutti questi lavori:
- non copiare perché per i siti Wordpress ad esempio c'è la possibilità del Check duplicate content, che permette di controllare se un testo è inedito oppure se è già presente nel web e perché esistono software antiplagio, anche gratuiti, di cui sono ormai provvisti quasi tutti gli insegnanti di scuola superiore e i docenti universitari.
- pagare sempre le tasse. Spesso uno può essere pagato tramite paypal, postepay o bonifico bancario. Ma bisogna dichiarare questi soldi. La Guardia di Finanza può accertare facilmente e oggettivamente l'evasione. Anche gli youtuber, in questo caso i booktuber devono pagare le tasse. Anche qui l'evasione è facile da accertare oggettivamente. È meglio in questi casi aprire una partita Iva. È comunque molto meglio lavorare per un periodo gratis, costruendosi una buona reputazione online, accumulando esperienze e referenze nel curriculum, che essere evasori.
dic 222023

Ho guardato le varie definizioni di posizionamento nei più importanti vocabolari. Ebbene nessun vocabolario menzionava il significato di posizionamento in letteratura. Con questo termine si intende l'orientamento di uno/a studioso/a, insomma di un/a letterato/a in base all'ismo, ai maestri che ha avuto, alla scuola a cui appartiene, alla linea di ricerca, alla prospettiva di carriera, etc etc. Quindi è una sorta di orientamento culturale/letterario, secondo cui un/a studioso/a sceglie di studiare un genere, degli autori, un filone invece che altri. Dal conflitto delle interpretazioni scaturiscono i vari posizionamenti, che a loro volta generano ulteriori conflitti delle interpretazioni in una sorta di circolo vizioso o virtuoso illimitato. Tutto ciò è lecito, legittimo, anzi fisiologico, naturale, perché appartiene ontologicamente alla letteratura, che grazie a Dio risente di una certa opinabilità e di una certa discrezionalità per ogni giudizio critico. L'mportante è che il posizionamento e il conflitto delle interpretazioni, che si richiamano a vicenda e che sono strettamente connessi, non vengano strumentalizzati per favori, vendette, simpatie, idiosincrasie o per fini commerciali. In ogni giudizio critico sarebbe richiesto il massimo dell'obiettività e dell'imparzialità, per quel che è umanamente possibile. Insomma un critico si dovrebbe astrarre dalle meschinerie e dalle piccinerie, dovrebbe volare alto e dimostrare onestà intellettuale. Ma probabilmente queste erano probabilmente problematiche di un tempo, perché oggi i critici letterari hanno sempre meno importanza, meno potere nella formazione del gusto dei lettori e sono proprio questi ultimi a decidere il canone. Quindi oggi la questione del nesso tra posizionamento e conflitto delle interpretazioni è secondaria, mentre la questione principale è quanto la scarsità di competenza e di buon gusto dominino il mercato editoriale e di conseguenza il successo. Così oggi il problema dei problemi non è il conflitto delle interpretazioni ma la sociologia, la fenomenologia del gusto letterario dei lettori.
dic 032023
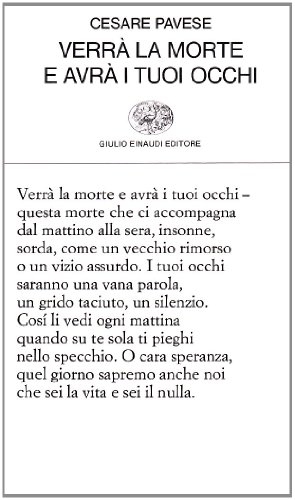
La collana di poesia Einaudi, detta anche "collana bianca" o semplicemente "bianca" per via del colore della copertina, è il non plus ultra della poesia italiana. È la pubblicazione più prestigiosa. È molto selettiva, molto esclusiva; infatti di solito vengono pubblicati ogni anno dagli 8 ai 10 volumi e alcuni talvolta sono di autori stranieri. La poesia non vende in Italia: in media i nuovi volumi vendono 2000 copie con picchi di 4000, ma l'Einaudi fa cassa con l'intero catalogo, visto e considerato che è dal 1964 che pubblica poeti autorevoli, molti memorabili. Essendo molto selettiva e pubblicando pochissimi poeti c'è anche del risentimento tra gli esclusi. Essere pubblicati nella bianca significa diventare personaggi, significa assurgere alla notorietà, seppur di nicchia, perché la poesia è di nicchia. In primis i poeti sperimentali lanciano i loro strali e parlano a chiare lettere di ingiustizia, accusando poi per estensione tutta la grande editoria di marginalizzare la poesia di ricerca. Altri invece criticano negativamente i poeti einaudiani, sostenendo che siano antiquati, che si limitino a fare il compitino, che non abbiano da dire niente, etc, etc. È vero che la maggioranza dei poeti "einaudiani" sono neolirici con alcune eccezioni, come ad esempio Attilio Lolini e Cesare Viviani, che, pur essendo a grandi linee lirici, sono a tratti anche assertivi-aforistici. Se ci limitiamo a una classificazione in neolirici e poeti di ricerca, però si capisce che questa distinzione è troppo limitante, dato che Aldo Nove e Tiziano Scarpa sono di difficile collocazione a mio modesto avviso. Un tempo vennero pubblicati nella bianca anche poeti sperimentali come Roberto Roversi, Paolo Volponi, Andrea Zanzotto. Sorge spontanea una domanda: se oggi i poeti sperimentali non vengono pubblicati, è per via di una scelta ideologica e stilistica dell'Einaudi o perché i nuovi autori di questo filone non sono ritenuti degni, non sono ritenuti all'altezza? I critici della bianca sono apocalittici: per loro non si salva nessun poeta pubblicato nella bianca. Ci sono poeti veri, aspiranti o sedicenti però che hanno ambizioni sbagliate e sono megalomani: bisogna sapersi accontentare e accettare le scelte editoriali, anche se sono sfavorevoli. Un poeta deve accettare non solo premi, consensi ma anche rifiuti e no. Poi ci sono alcune critiche a mio avviso legittime: se scorriamo l'intero catalogo le poetesse sono poche e lo stesso dicasi per i poeti meridionali. A mio modesto avviso, vista la grande scrematura che fa l'Einaudi, per utilizzare una terminologia medica e psicologica, sono molti di più i falsi negativi dei falsi positivi, ovvero ci sono molti poeti validi non pubblicati nella bianca ma molto spesso i poeti pubblicati lì sono validi e originali. Insomma la bianca è sinonimo di alta qualità e tutti ambiscono a pubblicare lì. Un motivo ci sarà. Un tempo i letterati sostenevano che i poeti memorabili pubblicassero con grandi case editrici e le piccole case editrici fossero una fossa comune per i restanti poeti su cui sarebbe sceso l'oblio. Oggi è sempre più difficile dire chi passerà alla storia o meno. Di certo ci sono una miriade di blog letterari, di riviste di poesia online, di piccola editoria a pagamento che riescono a dare una visibilità insperata già venti o trenta anni fa e che sono il segno inequivocabile di un grande fermento poetico che esiste in Italia. Ma la bianca resta la bianca e ve lo scrive uno che ha smesso da qualche anno di scrivere "poesie" e non ha mai inviato i suoi versi all'Einaudi. Queste due realtà poetiche non devono essere mondi paralleli: blog e riviste online continuino a fare da cassa di risonanza ai poeti riconosciuti e l'Einaudi cerchi anche del buono tra i poeti del web. Le due cose non si devono considerare mutuamente esclusive, perché non lo possono essere se si ha a cuore la poesia italiana contemporanea.
ott 192023
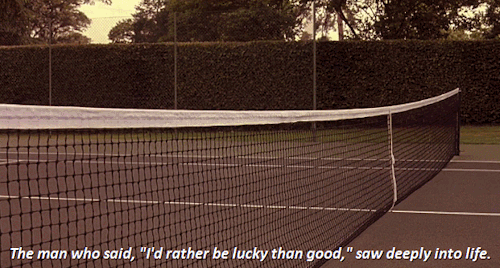
Victor Hugo parla di successo nel 1862 ne “I Miserabili”, volume I, cap. XII:
“Riuscire: ecco l’insegnamento che cade, a goccia a goccia, a strapiombo dalla corruzione. Sia detto di sfuggita, il successo è una cosa abbastanza odiosa. La sua falsa somiglianza con il merito inganna gli uomini. Per la folla, la riuscita ha quasi lo stesso profilo della supremazia. Il successo, questo sosia del talento, ha un solo zimbello: la storia. Ai nostri giorni una filosofia quasi ufficiale è entrata in dimestichezza con il successo. Riuscite: è teoria. Prosperità presuppone capacità. Vincete alla lotteria: siete un uomo abile. Chi trionfa è venerato. Nascete con la camicia: tutto vi sarà dato. Abbiate fortuna, avrete il resto; siate felice, vi crederanno grande. L'ammirazione contemporanea non è che miopia”.
Per gli indiani esiste il karma: se sei povero e malato, è semplicemente perché ti sei comportato male nelle vite precedenti. Per i calvinisti se hai denaro e successo, è perché sei in grazia di Dio, perché sei un eletto. Gli antichi greci credevano fermamente nel Fato, che sovrastava il volere e le capacità degli uomini.
Si pensi al valorosissimo Aiace che difese il cadavere di Achille, ma Ulisse con la sua furbizia riuscì ad avere le armi del defunto; Aiace impazzì e massacrò un gregge di pecore, credendole soldati nemici, e poi si suicidò per la vergogna. Roberto Vecchioni negli anni Settanta scrisse appunto un'ironica canzone su Aiace, di cui riporto il testo:
"E non sembravi più nemmeno quello
che dalle porte esce guardando il cielo
gridava a Dio con tutta la sua voce
"Sterminaci se vuoi, ma nella luce..."
E il mare grande quando vien la sera
e Dio è lontano per la tua preghiera
qui c'è chi parla troppo e c'è chi tace
tu sei di questi, e al popolo non piace
Chi ha vinto è là che che vomita il suo vino
e quel che conta in fondo è l'intestino
la la la la la la Aiace la la la la la la
la la la la la la Aiace la la la la la la
la la la la la la Aiace la la la la la la
la la la la la la Aiace la la la la la la
E il coro degli Achei che si diletta
hai perso e questo è il meno che ti aspetta
ti stanno canzonando mica male
vai un po' a spiegare quando un uomo vale
Dovevi vincer tu, lo sanno tutti
tu andavi per nemici e lui per gatti
ma il popolo è una pecora che bela
gli fai passar per fragola una mela
Chi ha vinto è là che che vomita il suo vino
e quel che conta in fondo è l'intestino
la la la la la la Aiace la la la la la la
la la la la la la Aiace la la la la la la
la la la la la la Aiace la la la la la la
la la la la la la Aiace la la la la la la
E tu fai fuori mezzo accampamento
ne volano di teste cento e cento
salvo far l'inventario e veder poi
che non sono i tuoi giudici, son buoi
Allora per un mondo che è un porcile
ti val bene la pena di morire
dimmi cosa si prova in quel momento
con la spada sul cuore ed intorno il vento
Fa grande sulla tenda le ombre il fuoco
ma dai, che è stato solamente un gioco
la la la la la la Aiace la la la la la la
la la la la la la Aiace la la la la la la
la la la la la la Aiace la la la la la la
la la la la la la Aiace la la la la la la"
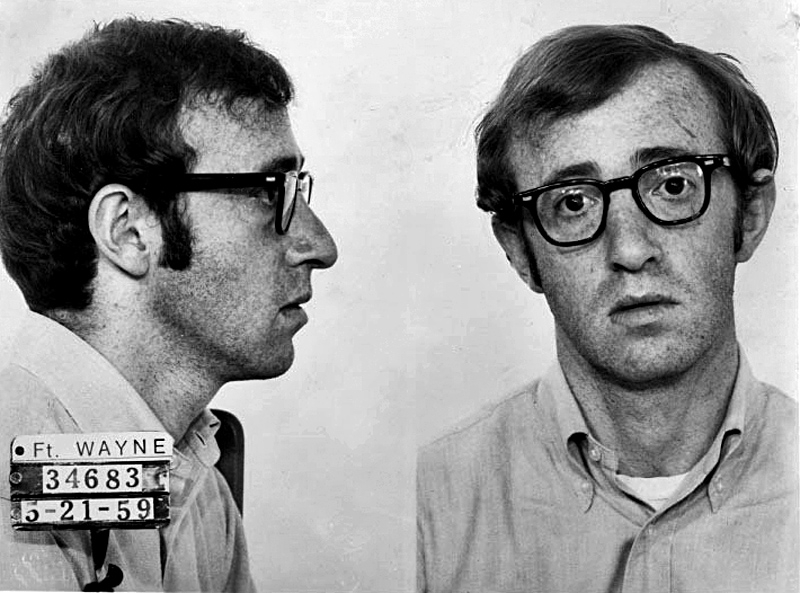
Si apre con questa riflessione il film del 2005 Match Point di Woody Allen: “Chi disse ‘Preferisco avere fortuna che talento’ percepì l’essenza della vita. La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna nella vita. Terrorizza pensare che sia così fuori controllo. A volte in una partita la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po’ di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no, e allora si perde.“
E ancora si pensi che avere talento è una dote innata, quindi una fortuna, anche se il talento va saputo coltivare. Ma bisogna che qualcuno valorizzi e riconosca il talento e qui rientra in gioco la fortuna!
Per Machiavelli il principe deve avere virtù e fortuna. Per alcuni cattolici secoli fa la peste era una punizione divina, un flagello di Dio! Ma quanto è importante la fortuna nella vita degli uomini? Alcuni credono così tanto nel libero arbitrio, nel merito, nel sacrificio, nell'impegno da sottovalutare il ruolo determinante della fortuna. Costoro non pensano a quanto siamo fortunati quando abbiamo salute. Non pensano che basta una cellula del corpo impazzita a scatenare un tumore. E non dipende da noi. Oh certo dipende anche dallo stile di vita!?! Ma ci sono persone che hanno un cattivo stile di vita e non si ammalano, mentre altre hanno un buon stile di vita e si ammalano! Non pensano costoro -chiamiamoli pure coloro che si credono padroni della loro sorte e artefici del loro destino- a quanto siano casuali gli incontri e gli avvenimenti di ogni vita. Non pensano che siamo insignificanti gocce nel mare. No. Non esistono i self made man. Oh certo bisogna saper sfruttare le occasioni! Non bisogna perdere i treni giusti!
Oh lo so?!! Le persone che si sentono arrivate non fanno che citare la frase di Seneca: "La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l’occasione”. Ma quante cose sono andate bene e che non dipendevano da lei nel destino di una persona di successo? Ai fattori esterni e la casualità queste persone così sicure di sé non si soffermano mai a pensare. In fondo nascere in un paese ricco invece di uno povero, nascere da genitori benestanti e che ti amano invece che da genitori poveri e che ti maltrattano, nascere sani invece che malati, nascere intelligenti invece che stupidi, incontrare le persone giuste nei primi anni di vita invece che le persone sbagliate, essere ricambiati dalla persona di cui si è innamorati o meno non sono tutte cose che rientrano nella fortuna? Purtroppo ci si accorge del ruolo determinante della fortuna solo quando ci manca. Ma questo non significa che esistano anche il merito, il sacrificio, l'impegno. C'è chi crede che tutto dipenda dalla fortuna o dal merito. I pareri sono spesso così polarizzati. No. Non esiste una dicotomia, un aut aut impietoso: non è questione di merito o fortuna, ma di merito e fortuna quando uno riesce. Le due cose non sono mutuamente esclusive. Spesso dipende da entrambe le cose, ma nessun uomo può valutare la vita propria o altrui obiettivamente: lo può fare solo Dio, se esiste. Spesso quando uno riesce nella vita è perché ha fatto tutto bene ma anche perché gli è andato tutto bene. È difficilissimo valutare quanto in ogni vita pesino il merito e la fortuna. Ci sono gli arrivati presuntuosi che pensano che tutto sia merito loro, ma ci sono anche invidiosi e maligni che pensano che un uomo abbia avuto successo solo perché fortunato. Per la psicologia chi ha un locus of control interno, cioè chi pensa che la vita dipenda dalla sua volontà più che da fattori esterni, ha una maggiore autoefficacia e raggiunge più frequentemente gli obiettivi prefissati. Ma la psicologia ha anche scoperto l'errore fondamentale di attribuzione, cioè la tendenza sistematica delle persone di attribuire la causa di un'azione all'individuo invece che a fattori esterni, anche quando oggettivamente non è così. Ci sono molte ricerche che lo confermano e sembra che l'errore fondamentale di attribuzione sia più frequente nelle culture individualistiche, come in quelle occidentali ad esempio. Ancora una volta abbiamo casualità versus causalità! Però dobbiamo smetterla di pensare che sia esclusivamente colpa sua se a qualcuno le cose nella vita vanno male! Insomma i fattori in gioco, sia interni che esterni, nella vita sono tanti. Ecco perché Darwin non era un darwinista socioeconomico a differenza di Galton e altri.
ott 022023
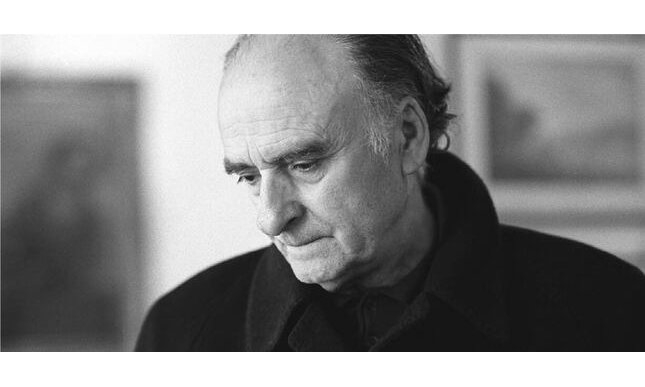
Innanzitutto non sappiamo neanche chi ha creato l’espressione Nord-Est: forse il giornalista Meccoli, forse lo scrittore Carlo Sgorlon. Insomma la paternità del termine è incerta! A livello letterario il Nord-Est è i Colli Euganei in cui vive i suoi ultimi anni Petrarca; è Goldoni; è "Le confessioni di un italiano" di Nievo, "Le ultime lettere di Jacopo Ortis" del Foscolo, la Trieste di Svevo, Joyce, Saba, i libri di Meneghello, Rigoni Stern, Parise, Berto, Commisso, Buzzati, David Maria Turoldo, Mauro Corona, Tiziano Scarpa, etc etc. Comunque il Nord-Est veniva definito anni fa come la locomotiva d’Italia, come il Giappone d’Italia. Alcuni intellettuali snob lo vedevano come un’area di arricchiti, che si erano dannati per il benessere. Alcuni vedevano questa zona, una delle più ricche della penisola, come una massa di alcolizzati ignoranti, che davano l’anima per la loro "fabbrichetta". È vero che questa zona è passata da essere una roccaforte democristiana a essere un feudo leghista dopo Tangentopoli. È vero che parte della popolazione del Nord-Est odia Roma e il meridione, che vede come una massa di assistiti e mangiapane a tradimento da cui si vorrebbe separare (alcuni gridavano anni fa: "Roma ladrona! Secessione!"), e l’antipatia è ricambiata. In realtà però oltre a un reddito pro capite elevato ad esempio i veneti possono vantare alti punteggi nelle prove Invalsi, molto superiori a quelli della media nazionale, e una percentuale di laureati del 32%, più alta, tanto per dire, del 4% della civile e colta Toscana. Inoltre il Nord-Est si contraddistingue per una grande mobilità sociale: qui meglio che da altre parti l’ascensore sociale esiste e vi sono pochi disoccupati. In quest’area il dipendente può licenziarsi e poi diventare imprenditore. I Benetton e i Del Vecchio sono solo la punta dell’iceberg, perché dietro c’è una realtà industriale consolidata di distretti, di piccole imprese, di artigiani. A onor del vero negli ultimi anni un poco di crisi economica ha investito anche il Nord-Est: si pensi ad esempio anni fa a piccoli imprenditori che scoperchiavano i loro capannoni per non pagare l’Imu. Come si spiega comunque questo miracolo economico? Per molti il lavoro duro dà i suoi frutti a lungo termine. Alcuni scrittori e saggisti, come Giuseppe Genna, ritengono che la Lombardia e il Veneto siano stati influenzati dalla dominazione asburgica e parlano di calvinismo per questa zona. Si riferiscono al legame tra etica protestante e capitalismo studiato da Max Weber. In parole povere le persone cercherebbero a tutti i costi di arricchirsi per sentirsi dei predestinati, degli eletti. Insomma uno lavora, guadagna e per questo si ritiene un prescelto, pensa di essere in grazia di Dio. Non a caso l’economista Giorgio Roverato ha definito l’industriale Pietro Marzotto un "imprenditore calvinista", considerando anche il suo senso di responsabilità e di etica negli affari. Il calvinismo però è una dimensione soggiacente, un influsso segreto e antico, secondo questa scuola di pensiero, che condiziona la mentalità dei veneti ad esempio. Secondo quest’ottica potremmo affermare che in queste zone la popolazione è inconsciamente calvinista per certi tratti, mentre si professa cattolica praticante. Non vi tragga in inganno il romanzo "Va’ dove ti porta il cuore" di Susanna Tamaro, che tratta anche della facoltà di psicologia di Padova negli anni Settanta: una realtà particolare e a sé stante nel mondo veneto. Non vi traggano in inganno le memorie di chi ha studiato a Padova: la realtà studentesca goliardica è una goccia nel mare del pragmatismo e dell’efficientismo veneto. Non vi traggano in inganno le feste dei ricchi di Cortina, né il microcosmo letterario del premio Campiello, né i nobili veneziani che vivono di rendita: il Nord-Est è lavoro duro, ricerca di guadagno a tutti i costi, è gente che fa il doppio e anche il triplo lavoro per arricchirsi! Il miracolo del Nord-Est è dato in gran parte dalla fatica e allo stesso tempo dall’odore di miseria, che veneti e friulani hanno sentito per secoli: basta ricordare che in passato è stato un popolo di emigranti, diffusi in tutto il mondo; basta ricordare le venete che facevano le balie nel Sud o a quante famiglie d’origine veneta ci siano a Latina! Basta ricordare le vicissitudini dei poveri contadini narrate dal Ruzzante! Per lo psichiatra Vittorino Andreoli bisogna però stare attenti, perché il benessere produce anche emarginazione, che a sua volta causa follia. Questo circolo vizioso benessere-emarginazione-follia, teorizzato nel saggio "La violenza", spiega perché nel Nord-Est ci sono tanti giovani fin dagli anni Novanta che muoiono all’alba dal ritorno delle discoteche per incidente stradale, di solito dopo essersi ubriacati e drogati, e spiega anche perché da trent’anni ci sono auto-pirata, che uccidono passanti. Ma perché i figli di industriali, di agiati commercianti e liberi professionisti si drogano? Il Nord-Est si è arricchito molto rapidamente, i genitori sono troppo indaffarati e troppo occupati sul lavoro per pensare ai figli, il brusco passaggio da una società contadina a una realtà industriale ha lasciato alcuni giovani senza valori. Il Nord-Est negli anni Novanta, nonostante fosse una delle zone più ricche d’Italia, era anche caratterizzata da un alto tasso di suicidi tra giovani. Perché giovani che apparentemente avevano tutto finivano per autodistruggersi? Perché nonostante avessero agi, macchine costose, immense comitive, amori facili si suicidavano? A cosa era dovuto questo smarrimento, questo disagio esistenziale, questo senso di vuoto? Il grande poeta Andrea Zanzotto parlava di "progresso scorsoio", di come la corsa agli schei abbia determinato la distruzione del paesaggio e abbia fatto scomparire quella comunità di persone propria della civiltà contadina.

Eppure il Nord-Est è anche cultura, tradizione; questa zona è anche un luogo dell’anima, un’entità metafisica. Altri profondi conoscitori di quest’area a ogni modo pongono l’accento sulla mancanza di solidarietà e sull’impoverimento delle relazioni umane di questi ultimi decenni. Per lo scrittore Massimo Carlotto, che tramite il noir affronta le problematiche della sua regione con crudo realismo, dietro il benessere del Nord-Est si cela anche la criminalità organizzata. Lo scrittore Vitaliano Trevisan in "Works" tratta anche lui della cruda realtà del Nord-Est, ci racconta dei tanti mestieri fatti per tirare avanti, tra cui anche quello dello spacciatore. Trevisan racconta di come sia stato mandato da suo padre da adolescente a lavorare in fabbrica per lavorare e guadagnare. Ci narra ancora una volta dell’illegalità diffusa. Sempre Trevisan ci spiega quanto sia difficile scegliere di fare lo scrittore in Veneto, mentre tutti pensano a produrre. Ancora una volta gli scrittori odierni dissacrano il sogno del Nord-Est e mettono in evidenza che qualcosa è stato perduto in questo sviluppo così rapido. Da ricordare anche il film di Antonio Padovan "Finché c’è prosecco c’è speranza" che scandaglia certe magagne, certe dinamiche economiche e psicosociali del ricco Veneto. Ah gli schei! Croce e delizia! L’arricchimento smodato e il capitalismo selvaggio in fondo sono un male antico di quest’area: basta vedere il grande monologo civile sul disastro del Vajont di Marco Paolini per farsene una ragione!
set 092023

(Nella foto io a sinistra con l'amico Emanuele Morelli)
Quando si è giovani si vive un dramma per una storia d'amore finita male o per un innamoramento non corrisposto. Ci sembrano così importanti i nostri amori, fortunati o meno, quando sono fattarelli inessenziali per il resto del mondo. Spesso la nostra ragione e la nostra memoria funzionano in modo molto "fazioso": pensiamo e ricordiamo per molto più tempo quando siamo stati lasciati, traditi o non corrisposti rispetto a quando noi abbiamo lasciato, tradito e rifiutato. La nostra mente - almeno nella giovinezza - è masochista. Così una ragazza comune, che gli ha detto "no", diventa la musa di un aspirante poeta. Molti giovani vogliono rendere partecipi tutti del loro amore, delle qualità, della bellezza della loro amata e allora lo scrivono su tutti i muri della loro città. Non è forse così? Non trovate che sia così? Qualcuno dirà che sono solo generalizzazioni. Io rispondo che senza generalizzazioni non ci sarebbe conoscenza e nemmeno si camperebbe! Ogni giorno facciamo delle generalizzazioni. Continuiamo allora con le generalizzazioni. Da giovani si vuole cambiare il mondo. È più difficile invece trovare persone mature che vogliano farlo. La giovinezza, secondo statistiche e ricerche, è anche la fase più creativa della vita; i geni hanno fatto scoperte o creato capolavori spesso da giovani. Ciò nonostante la maggioranza dei giovani non sfrutta queste potenzialità perché affaccendata in tutt'altro. A ogni modo nella giovinezza si è maniaco-depressivi, come non mai. Basta poco per toccare il cielo o vivere in un inferno terreno. Ci sono degli errori giovanili che determinano, decidono il resto della nostra vita e che finiamo per pagare vita natural durante, come scrive Mario Luzi. Ci sono persone che immolano la giovinezza sull'altare dello studio o del successo e finiscono per rimpiangerla per tutta la vita. Beato è chi ha vissuto la giovinezza da giovane e non chi ha avuto una giovinezza posticcia in là con gli anni! Di alcuni si dice non a caso: "non è mai stato giovane". Bisogna essere giovani da giovani, che non è una tautologia, come potrebbe sembrare. Gli studenti non vedono l'ora di laurearsi e lavorare. I fidanzati non vedono l'ora di sposarsi e fare figli. E non sanno che quello è il periodo migliore della loro vita! È molto difficile vivere pienamente la giovinezza, ma quasi impossibile è saperla apprezzare proprio quando si è giovani. Le Nazioni Unite hanno stabilito che si è giovani dai 15 ai 24 anni, ma la giovinezza oggi è una fase che si protrae spesso più a lungo. Se chiediamo quando hai smesso di essere giovane, i più non rispondono a una certa età ma pensando a quando è finito un amore, a quando hanno iniziato a lavorare, a quando è morta una persona cara. La giovinezza è quindi percepita soprattutto interiormente più che anagraficamente, ma ciò non toglie che possa essere una percezione errata. Un altro problema, anche se è vero che non si può essere giovani per tutta la vita, è che si invecchia troppo presto. La maturità comunque è anche l'approdo di equilibrio e di un minimo di stabilità per i più. Alcuni sostengono che la gioventù è il periodo più bello della vita. Altri come lo scrittore Nizan sostengono l'esatto contrario. Io ritengo che sia una stagione molto altalenante dal punto di vista degli umori. Comunque nella giovinezza diamo un'importanza esclusiva a quel che chiamano amore sia per una questione ormonale che per la nostra insofferenza alla solitudine. Dobbiamo accoppiarci e non possiamo stare soli. Nella giovinezza possiamo vivere sia gli amori platonici che il sesso sfrenato. La giovinezza è una mistura esplosiva di idealismo, materialismo, sentimentalismo, spesso mal assortiti e mal combinati. Da giovani si è innamorati delle idee, dell'amore e si è dipendenti dal sesso. La nostra psiche e il nostro organismo difficilmente ci consentono di ripetere queste cose in altre stagioni della nostra vita. Con l'avvento della maturità non è che ristrutturiamo cognitivamente ed emotivamente tutto ciò: è solo che abbiamo meno energie, siamo più esperti e pensiamo molto meno alle nostre questioni sentimentali perché incombono altri problemi più pratici come i soldi, la salute, la famiglia, etc etc. Nella maturità non abbiamo più la forza, la fantasia e l'ingenuità di idealizzare una donna. Alcuni potrebbero obiettare e sostenere che non è vero e che ci sono milioni di anziani nel mondo che si innamorano di donne molto più giovani. La maturità però non è solo un fatto anagrafico. La maturità è anche rassegnazione e accettazione; è anche assennatezza. Non si può vivere in un ridicolo infantilismo cronico. C'è scritto anche nell'Ecclesiaste che esiste per ogni cosa un suo momento. Ogni stagione della vita ha la sua bellezza e tutto sta a saperla cogliere. A mio avviso è un'illusione quella di sentirsi "forever young" per tutta la vita. No. Non si può fare i giovanotti a vita. Eppure, come si suol dire, al cuore non si comanda. Innamorarsi, almeno inizialmente, è un vero toccasana a tutte le età: è il miglior antidepressivo naturale, ma ha anch'esso le sue controindicazioni e le sue ripercussioni negative, perché è bello finché dura, fino a quando si spera di essere corrisposti o fino a quando si è corrisposti, ma poi? Poi bisogna raccogliere i cocci e farlo a cinquant'anni o a sessanta è molto più difficile e più gravoso. A una certa età è più difficile riprendersi da una delusione; è più impegnativo recuperare le forze. In più innamorarsi significa talvolta lasciarsi con la moglie e sorbirsi la separazione con addebito: non tutti possono permettersi la separazione o il divorzio, perché rischiano di diventare padri poveri. Inoltre si potrebbe vedere tutto da un'altra ottica: Hölderlin ad esempio sosteneva che solo quando è passata amiamo e rimpiangiamo la giovinezza. È molto meglio rassegnarsi perché a mio avviso è la miglior forma d'amor proprio e di rispetto per sé stessi piuttosto che inseguire elisir di eterna giovinezza. La maturità, almeno quella interiore, è consapevolezza dei nostri limiti e rinuncia. Lo so. Molti storceranno il naso, perché nella nostra società domina incontrastato il giovanilismo. E a questo punto come non fare una citazione abusata e ricordare della Magnani, che diceva ai truccatori: "Non toccare le mie rughe. Le ho pagate care". La presa di coscienza di qualcosa che volge al termine è espressa magistralmente in questi versi della grande poetessa Lamarque: "A vacanza conclusa dal treno vedere/ chi ancora sulla spiaggia gioca si bagna/ la loro vacanza non è ancora finita:/ sarà così sarà così/ lasciare la vita ?"
Non sono versi illuminanti?
ago 222023

Uno degli indagati per lo stupro di gruppo di Palermo così scriveva nella chat: "Eravamo cento cani su una gatta, ma la carne è carne". Nel 2022 in Italia gli omicidi sono stati 314 e ci sono stati 126 femminicidi. Fino al 18 agosto i femminicidi nel 2023 erano 75. Che cosa non ha funzionato e non funziona? La responsabilità è individuale, ma la cultura dell'odio ha la meglio sugli agenti di socializzazione (famiglia, parrocchia, scuola). E cosa può la letteratura su questi giovani? Al bando le belle parole da anime belle, i giri di parole, le elucubrazioni mentali degli intellettuali! No. Cari e care insegnanti, la vostra letteratura impartita come un obbligo, un'imposizione può fare davvero pochissimo per i giovani. Forse ha una ricaduta positiva solo per un'esigua minoranza, una ristrettissima cerchia, per cui l'umanesimo diventa una passione. L'umanesimo è troppo inattuale, troppo antiquato. No. Insegnare il dolce stil novo, la donna angelicata, Dante e Petrarca non ha più presa sui giovani. I giovani non sentono questa grandezza e la avvertono come troppo lontana. No. Cari insegnanti, non vi illudete per dei bei temi, perché la maggioranza ripete come pappagalli le nozioni, ma non assimila i valori che cercate di trasmettere loro. Non vi illudete: anche l'educazione civica e l'educazione sessuale potrebbero pochissimo o nulla. Forse alcuni di voi diranno: "cerchiamo di fare poco per quei pochi che è già molto. Non essere apocalittico. Non essere catastrofico". Ma la sottocultura che viviamo ogni giorno ha sempre la meglio. Per assimilare un poco di cultura ci vuole un minimo di sforzo e di sacrificio. Assimilare sottocultura è facile e automatico. Non richiede sforzi. Poi il bombardamento della sottocultura è ripetitivo, ossessivo, ossessionante. La sottocultura usa a meraviglia il condizionamento classico e anche quello operante. La maggioranza silenziosa approva e dà ricompense a chi assimila sottocultura, perché essa stessa è sottocultura diffusa. E poi è sempre più difficile distinguere la cultura dalla sottocultura! Una maggiore scolarizzazione non necessariamente comporta una maggiore educazione. C'è però sempre meno rispetto per la dignità umana e le regole del vivere civile. No. Cari filosofi e care filosofe, Kant, Spinoza, etc etc non servono più. No. Cari poeti e care poetesse, non potete nulla contro questo mondo e discutete pure di assertività, rimozione dell'io lirico, oggettività, sentimentalismo, giusta distanza e giusto distacco da cose e persone. Non potete nulla contro la massa omologata e informe. Forse è chiedere troppo alla letteratura, alla poesia, considerate dai più sempre più ornamentali, accessorie, pleonastiche, insomma inutili. La mentalità comune, quella la fanno una televisione generalista per nulla pedagogica, i mass media sempre più bombardanti, sensazionalistici e qualunquisti, il porno di massa, il gruppo dei cosiddetti pari, i bar, le discoteche, le curve degli stadi. Niente ci può salvare da questo bestiario. La poesia che rispecchia un mondo troppo impoetico non è vera poesia e la vera poesia è cosa da folli. Il rischio è troppo elevato. Potreste rimetterci reputazione, salute, forse la pelle.
Sventolate bandiera bianca, anzi ammainatela proprio la bandiera. La sconfitta è inesorabile. La letteratura non è più incisiva. Non plasma più le coscienze della maggioranza e se è sempre stata elitaria, oggi lo è molto di più. La letteratura non è più formativa. Educa il gusto di pochissimi. Un tempo gli stessi poeti maledetti vivevano la letteratura e la poesia come degli anticorpi contro la barbarie diffusa. Dario Bellezza in "Invettive e licenze" scriveva: "Ignoro il corso della storia. So solo/ la bestia che è in me e latra". La poesia era quindi autoconoscenza della propria Ombra, della parte più oscura e rimossa. Prenderne consapevolezza era già un primo passo importante per migliorare, per evolvere. No. Cari umanisti, non siete più assediati. Arrendetevi. Non potete niente all'atto pratico. Rischiereste solo la vostra incolumità per niente. La Fortezza Bastiani è stata già conquistata. Il nemico ha così vinto che è dentro ognuno di noi e noi siamo nemici di noi stessi. La colpa è della società? E allora è anche nostra. La barbarie si è già annidata ovunque. Noi stessi siamo i Tartari e non sappiamo neanche riconoscerci come tali.
lug 282023
Alain Elkann qualche giorno fa ha scritto un racconto sul suo viaggio in treno verso Foggia. L'ha pubblicato su "la Repubblica". Ha dato dei lanzichenecchi (soldati mercenari, barbari e feroci, responsabili del sacco di Roma) a dei ragazzi settentrionali che parlavano di ragazze e di dove e come rimorchiare (al night oppure sulla spiaggia). È diventato il tormentone di questo luglio. Sui social si sono sbizzarriti con le offese allo scrittore, con i meme, etc etc. I quotidiani sono andati a nozze con le polemiche. Il racconto è stato divisivo: alcuni giornalisti l'hanno difeso a spada tratta, dicendo che la maleducazione oggi dilaga, mentre altri opinionisti l'hanno definito snob, elitario, classista. Alcuni hanno fatto da avvocati difensori, perché lui è un giornalista e uno scrittore affermato, oltre al fatto di essere il padre dell'editore. Altri lo hanno attaccato per invidia sociale. Insomma c'è stata poca obiettività e su tutto ha prevalso l'emotività. C'è chi si è identificato in Elkann e chi nei "lanzichenecchi". Certo a passare da intellettuale raffinato a radical chic con la puzza sotto il naso il passo è breve. Elkann ha delle scusanti: 1) probabilmente non si mischia con gli italiani. Non è avvezzo. Vive nell'alta società 2) i letterati sono spesso snob.
Inoltre va dato merito a Elkann di averci messo la faccia e di aver avuto il coraggio di manifestare la sua insofferenza. Certe cose molti le pensano ma non le dicono! Elkann ha avuto il coraggio di risultare impopolare. Però mi chiedo io: su "la Repubblica" uno può scrivere tutto ciò che gli passa per la testa? Classista poi? Quei ragazzi, come lui del resto, erano in business class. Io che faccio parte del volgo non ho mai viaggiato in business class. Quei ragazzi erano quindi di buona famiglia e con molti soldi; erano agiati, forse ricchi. Certo forse un pochino classista lo scrittore a ogni modo lo è stato e oltre che essere una cosa di cattivo gusto è anche anacronistico, dato che oggi le classi sociali non esistono più; esistono le differenze culturali, di istruzione; esistono le varie fasce di reddito e le differenze di patrimonio, ma le classi sociali oggi non più. E poi erano nordici! Che dire allora delle esternazioni antisiciliane di anni fa del pur bravo, meritevole e umano Roberto Vecchioni? Certo viene da chiedersi cosa avrebbe scritto e quali strali sarebbero venuti fuori se Elkann si fosse trovato a viaggiare sul treno rapido Taranto-Ancona in seconda classe nel bel mezzo degli anni Settanta come Rino Gaetano (mi riferisco a "Mio fratello è figlio unico").
Cosa sarebbe successo se Elkann si fosse imbattuto la mattina dell'ultimo dell'anno sul diretto Pisa-Firenze negli anni Novanta in gruppi di giovani ubriachi che offendevano tutti e molestavano le ragazze, totalmente ubriachi e fumati? Cosa avrebbe scritto Elkann se si fosse trovato nello scompartimento un gruppo di ultras facinorosi in trasferta, che spaccavano mezzo treno, pronti a menare le mani, comportandosi come fossero impuniti e intoccabili? Posso dire che a Elkann è andata bene, perché non era solo, aveva dei compagni di viaggio e su certi treni quasi deserti in Italia le ragazze vengono anche stuprate e i viaggiatori possono essere aggrediti e rapinati. Ci sono stati addirittura dei casi di controllori feriti con l'accetta o con il coltello solo perché volevano far pagare la multa a chi non aveva biglietto! E poi quei giovani che hanno passato tutto il tempo a parlare di ragazze e di calcio avevano un grande pregio: parlavano di cose futili, ma non se ne stavano per tutto il viaggio con i telefonini, immersi totalmente nel mondo virtuale. E poi mi chiedo io cosa ha trovato di così grossolano nei discorsi di quei ragazzi? È una topica degli italiani di tutte le età parlare delle donne, raccontandosi fin nei minimi dettagli in modo boccaccesco le avventure. Dottor Alain (so bene che non mi leggerà) ma lei in quale mondo edulcorato e ovattato vive? Un conto è vivere nell'Iperuranio o quantomeno in una torre eburnea e un altro è la realtà quotidiana di molti! Oh lo so in casa sua i suoi figli non hanno mai parlato di ragazze in quel modo, anche perché essendo milionari (o forse miliardari) le ragazze cadono ai loro piedi e non devono certo conquistarsele. Ah come sono volgari dottor Elkann questi nostri (non suoi) "amori ancillari" per dirla alla Guccini! E poi sarà vero che le cose sono andate veramente come raccontate? Se dei ragazzi si mettessero a parlare di ragazze, oggi che a 11 anni iniziano a guardare Youporn, ebbene lo farebbero in modo molto osceno. Insomma lo scrittore si è scandalizzato davvero per poco, se così sono andate le cose, e si dovrebbe scandalizzare per ben altro, ma gli stessi italiani dovrebbero scandalizzarsi per gli incendi dolosi, la cattiva gestione del dissesto idrogeologico, della cosa pubblica, etc etc. Un grande critico e italianista ha difeso Elkann scrivendo che non sempre l'io lirico coincide con l'autore. E allora è pura finzione? È tutto uno scherzetto? Non c'è niente di autobiografico? Su…via…non nascondiamoci dietro a un dito! E poi in letteratura non esistono opere molto più "sboccate" di quei discorsi di quei lanzichenecchi? Se quei ragazzi erano lanzichenecchi, vorrei sapere cosa ne pensa Elkann de "I ragionamenti" dell'Aretino? Non dico di fare come Pasolini che viveva gomito a gomito con i ragazzi di borgata, ma ogni tanto al Nostro scrittore famoso stare in mezzo alla gente, quella vera e che non arriva alla terza settimana del mese, farebbe bene! Certo ho guardato da ragazzo molto spesso la trasmissione televisiva condotta da Elkann e mi sarei aspettato qualcosa di meglio da una persona sobria, elegante, intellettuale, educata come lei. Mi sarei aspettato un altro aplomb. E poi "la Repubblica" non è uno sfogatoio. Ma a onor del vero oggi noi nip (not important person) possiamo scrivere ogni fesseria sui social, quasi impuniti, e al contempo i vip, che non hanno più paura di nessuno, possono dire, scrivere, fare ciò che vogliono (salvo poi bollare noi, il popolo come degli hater patologici). In definitiva oggi, nip o vip, si prendono licenze poetiche, che decenni fa sarebbero state impensabili.
Io porrei l'accento comunque sul fatto che lo scrittore sia ipersensibile e abbia un limite di sopportazione molto basso. E poi vorrei far ricordare a tutti che stare in società significa sopportarsi a vicenda. Invece di leggere il Financial Time consiglierei allo scrittore di rileggere "Il trattato sulla tolleranza" di Voltaire e poi anche quello di Locke. Bisognerebbe prima di misurare la disumanità e l'ignoranza altrui fare i conti con la propria: discorso valido per tutti. Inoltre bisognerebbe ricordare il concetto di non-luogo di Augè. Il treno è un non-luogo, dove per alcune ore bisogna convivere forzatamente con degli sconosciuti, nostro malgrado. Ma essendo un non-luogo ha anche dei vantaggi, specialmente se il viaggio è a lunga percorrenza: si può conoscere gente nuova, si può raccontare a sconosciuti la nostra vita, confidandoci totalmente, oppure si può inventare vite immaginarie. E vorrei concludere scrivendo a coloro che danno addosso a Elkann che chiunque nella sua vita ha apostrofato il prossimo con brutte parole (non siamo ipocriti), attribuendogli gli epiteti di gentaglia, rozzo, incivile, troglodita e peggio ancora. Anzi dare del lanzichenecco non è una grave offesa, non è troppo volgare e dispregiativa. Ma allo stesso tempo bisogna ricordare che siamo sempre i lanzichenecchi di qualcuno, come ha ricordato lo scrittore Paolo Di Paolo. E chissà…forse lo stesso Elkann era un lanzichenecco per il suocero Gianni Agnelli!
lug 142023
L'Innamoramento è qualcosa che proviamo tutti nella vita. Lo hanno provato anche santi e assassini, orgiastici e casti, papi, milionari e barboni. Hanno un bel dire certi/e che dicono agli altri: "tu non sai cos'è l'amore", come se fosse qualcosa di esclusivo, qualcosa che riguarda solo loro, perchè hanno nobiltà d'animo, perché gli altri sono incapaci d'amare. In realtà è un sentimento universale, la cui fisiologia (si pensi alla descrizione che ne fa Stendhal) e la cui neurochimica sono ben noti (l'ho già scritto in un altro articolo, ma lo ribadisco, dato che tanti faticano ad accettare questa cosa). Secondo studi recenti sappiamo che negli innamorati si registra un aumento di dopamina e una diminuzione di serotonina. Ogni innamorato è euforico, ossessivo e se viene rifiutato cade spesso in una fase depressiva. Ogni innamorato "impazzisce". Non a caso nella letteratura Tristano e Isotta bevono un filtro d'amore che fa loro trasgredire le regole sociali e l'Orlando furioso perde il suo senno sulla luna. Ma se qualcuno vi dice che non avete mai provato la comunione delle anime, la fusione dei corpi, perché non siete mai stati ricambiati quando eravate innamorati, voi canticchiategli la canzone di Madame "Il bene nel male", dove dice: "L'amore è di chi prova amore e non di chi lo riceve". Ma perché ci innamoriamo sempre dello stesso tipo di persone oppure sempre di persone diverse? C'è chi dice che cerchiamo sempre una persona opposta per completarci meglio e quindi spiega tutto con la complementarità, mentre altri dicono che cerchiamo una persona simile ("chi si somiglia, si piglia"). In realtà la questione è mal posta. Secondo Freud ci sono solo due tipi di innamoramento, ovvero due tipi di scelta dell'oggetto "pulsionale": l'innamoramento narcisistico (in cui si proietta spesso la miglior parte di noi sull'altra persona, idealizzandola) oppure l'innamoramento anaclitico (deriva dal greco, significa appoggiarsi a, in cui si fa riferimento agli archetipi parentali, ovvero alle figure genitoriali, ci si appoggia quindi a una figura genitoriale; ci si ricordi ad esempio del complesso di Edipo, in cui il bambino si innamora della madre).

(tramonto alla Sozzifanti. Foto di Emanuele Morelli)
Secondo Freud quando scegliamo un (s)oggetto d'amore lo possiamo fare solo in due modi: trovando il nostro io nell'altra persona (innamoramento narcisistico) o trovando una figura genitoriale nell'altra persona (tipico è l'esempio della donna che cerca il padre negli uomini). Ma a mio avviso, e qui vado contro Freud, esistono anche uomini che si innamorano molto anti-edipicamente di donne che sono opposte e inverse rispetto alle caratteristiche della madre. Può accadere comunque che una persona abbia nella sua vita tre innamoramenti narcistici e cinque innamoramenti anaclitici oppure dieci innamoramenti narcisistici oppure dieci innamoramenti anaclitici e questo spiegherebbe di volta in volta la grande somiglianza o la grande varietà delle persone amate: capite che non è proprio la stessa cosa della complementarità, mentre è vero che nell'innamoramento narcistico troviamo una persona che ha dei tratti simili a noi, anche e soprattutto perché ci siamo rispecchiati in lei. Invece chi ha sofferto di depressione anaclitica nell'infanzia, dovuta alla perdita di un genitore, di entrambi oppure dell'abbandono di uno o entrambi tenderà ad avere da adulto/a degli innamoramenti anaclitici. A ogni modo di solito le persone nella vita tendono a innamorarsi solo in un modo (narcisistico o anaclitico). Che tipi di innamoramenti erano quelli di Dante e Petrarca? Forse narcisistici, ma nessuno può dirlo con esattezza. Inoltre esistono anche altre due teorie: ci sono psicologi che ritengono che l'innamoramento sia dovuto a una scelta autonoma, quasi razionale, non credendo al colpo di fulmine, e ci sono studiosi che riprendono il concetto di desiderio mimetico di R.Girard, secondo cui i nostri desideri prendono come riferimento i desideri altrui e noi imitiamo gli altri anche nel desiderio, detto in parole povere, noi desideriamo, secondo questa teoria, ciò che desiderano gli altri. In questi tempi di omologazione di massa e di conseguenza di omologazione dei gusti il concetto di desiderio mimetico è sempre più importante. Comunque la scelta del (s)oggetto d'amore in buona parte dei casi è eterodiretta, anche se si dice che si è liberi d'amare. Come vedete la faccenda è complicata, articolata, controversa, di non facile interpretazione.
lug 052023

Lo scriveva già Schopenhauer: "La vita è un pendolo che oscilla tra il dolore e la noia". E Leopardi scriveva che la morte "ogni gran dolore, ogni gran male annulla". Una delle più importanti domande che si fa la filosofia dalla notte dei tempi è la seguente: "Perché l'uomo soffre?"
La prima domanda della teodicea (cosa si può dire di Dio) è la seguente: "perché, se esiste Dio, esiste anche il male?", cioè ci si chiede quale sia il senso ultimo, escatologico, finale del male. In medicina ci sono state diverse teorie del dolore: dal localizzazionismo, alla teoria del cancello (che, nonostante alcune lacune, aveva il merito di dare la priorità della percezione del dolore al midollo spinale e al sistema nervoso centrale), ad altre più recenti. Si usa distinguere il dolore fisico da quello esistenziale. Ogni volta che proviamo dolore ci chiediamo: "perché proprio a me?"
Spesso non riusciamo a trovare un senso, una ragione. Consideriamo quasi sempre il nostro dolore di primo acchito un'ingiustizia o una cosa assurda, che sfugge alla nostra comprensione. Ma dovremmo chiederci anche "perché proprio a me?" quando ci toccano delle cose belle nella vita.
Noi esistiamo anche per assorbire, comprendere il dolore altrui. Gli altri sono importanti per noi non solo perché ci possono aiutare a ridurre o a eliminare il nostro dolore, ma perché con gli altri possiamo condividerlo e gli altri possono capirlo, rincuorandoci, sollevandoci. Stare in società significa anche alleviare le pene altrui e farsi alleviare le pene proprie. In una società decente il dolore si rispetta e si condivide. In una società un minimo umana la partecipazione al dolore supera l'indifferenza generale. C'è chi sostiene che esista il dolore perché esiste il male. Eppure si cerca sempre di trovare un senso al dolore, una sua utilità, un insegnamento e mille risvolti positivi. Insomma non tutto viene per nuocere. Eppure molto spesso quando soffriamo ci chiediamo che ce ne facciamo del nostro dolore, in definitiva a quale pro? La risposta non sempre è facile e immediata, spesso non è portata di mano. Il fatto che il dolore non venga distribuito equamente lo consideriamo una grande ingiustizia e viene subito da pensare che a molte brave persone vengono date sofferenze atroci, mentre noti farabutti se la spassano e si godono una bella, lunga vita. Insomma la constatazione che non è uguale per tutti è sempre molto amara, a volte rabbiosa. I moralisti e la Chiesa, stessa secoli fa, pensavano che la peste fosse una punizione divina. Eppure la Bibbia con la storia di Giobbe ci avverte che anche gli uomini giusti possono avere tutte le sfortune e le afflizioni di questo mondo. La stessa Chiesa ha considerato spesso più tardi il dolore come un'espiazione su questa Terra dei propri peccati. Questa nostra società è edonista, ovvero c'è una ricerca smodata di ricerca del piacere, ed è anche biopolitica, come ci insegna Foucault, ovvero cerca di eliminare il dolore e rimandare sempre più in là la morte di ognuno. Eppure c'è in ognuno di noi un lato sadomasochistico, più o meno pronunciato, che ci fa provare piacere a causare dolore agli altri e a noi stessi (si pensi ai comportamenti autodistruttivi, agli atti autolesionistici, ai cattivi stili di vita). A onor del vero nessuno sa con certezza se il dolore è maestro di vita. Secondo la psicologia consideriamo il dolore una fonte inesauribile di insegnamento per ridurre la nostra dissonanza cognitiva. Eschilo e i tragici greci erano dell'idea che il dolore aumentasse la conoscenza, la consapevolezza esistenziale. Cristianamente parlando il dolore è una prova a cui ci sottopone Dio e che ci fa crescere e maturare. A leggere attentamente Epicuro ci accorgiamo che riteneva già l'assenza di dolore un piacere. A conti fatti potremmo pensare che, una volta passato un dolore, non provarlo più è già un grande piacere, un grande sollievo, un'enorme fortuna. Ma purtroppo l'uomo, ogni uomo, dà per scontato il fatto di stare bene, non si rende conto che l'assenza di dolore è una manna dal cielo, a meno che non incappi nel dolore fisico, esistenziale, nel lutto, nella malattia, in un trauma, in una perdita affettiva. Nel dolore si scoprono le cose veramente importanti e prioritarie della vita, si eliminano quelle superflue: il dolore probabilmente ci rende davvero più umani, più saggi, più veri. Il dolore è il più efficace rasoio di Occam: ci fa vedere gli altri sotto una luce nuova, ci fa tagliare molti rami secchi inutili della nostra vita. Per Leopardi il patimento, ovvero soprattutto il dolore fisico, rende l'uomo più umano e meno insensibile ai problemi altrui. L'uomo però non accetta il dolore, soprattutto il proprio, perché siamo tutti biologicamente e ontologicamente molto egoisti nel nostro intimo. E perché? Perché, come ha scoperto la psicanalisi il dolore è l'anticamera della morte e l'uomo inconsciamente si ritiene immortale. Il nostro inconscio si considera immortale e questo è il motivo per cui ci svegliamo di soprassalto ogni volta che sogniamo di morire. Noi inconsciamente non accettiamo il dolore non solo per un fatto di sopportazione e di resistenza fisica e/o psicologica ma perché non accettiamo la nostra morte. Da giovani il nostro inconscio ha il predominio sulla rassegnazione della ragionevolezza: si considera la morte un evento talmente improbabile da pensarci immortali. Emblematico è il capolavoro "La morte di Ivan Il'ič" di Tolstoj. Il protagonista, il sillogismo "Cesare è un uomo. Tutti gli uomini sono mortali. Cesare è mortale" poteva accettarlo e capirlo perfettamente ma non riferito a sé stesso. Per Heidegger l'esistenza dell'uomo contemporaneo è inautentica, perché si perde nella curiosità, nell'equivoco, nella chiacchiera, nel "si dice". Ecco allora che per il filosofo tedesco l'unico modo per essere autentici è essere per la morte, cioè pensare alla morte come "possibilità di non esserci". Eppure l'uomo secondo Pascal trova qualsiasi escamotage, qualsiasi divertissement per non pensare alla morte. Rimuovere il dolore e la morte fanno parte della natura umana, perché fanno molta paura sotto ogni punto di vista. Vivere in superficie, con grande leggerezza ci viene così spontaneo e immediato. Oggi molto più che in passato. L'ars moriendi di conseguenza è ormai oggi scomparsa.
lug 022023
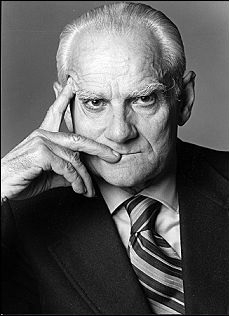
Consideriamo il rapporto tra Moravia e Freud. Per Dominique Fernandez in “Il romanzo italiano e la crisi della coscienza moderna” Freud va considerato un garante intellettuale di Moravia. Secondo la Fernandez Moravia si è incamminato da solo autonomamente sulle stesse tematiche, scandagliate da Freud. Moravia come Freud considera la sessualità un’esigenza dell’essere umano. Per il cattolicesimo invece il sesso è considerato un peccato. Moravia è freudiano anche nella sua concezione dell’amore. Per lo scrittore l’amore è come Freud un investimento oggettuale da parte di pulsioni sessuali, in vista di un puro e immediato soddisfacimento sessuale. Per Freud nella mente di ogni individuo esistono tre istanze psichiche: Io, Es, Super-Ego. Ma questa struttura tripartita della mente ha una sua precisa cronologia secondo Freud. Alla nascita e nei primi anni di vita è presente solo l’Es. Successivamente si forma l’Io. Quindi per ultimo il Super-Ego (verso i 3-5 anni). La dottrina di Freud è stato spesso accusata di pansessualismo. Tutto dipende e scaturisce dal sesso. Per Freud la sessualità riveste un’importanza fondamentale nell’eziologia della nevrosi. Il disagio della civiltà dell’uomo moderno per Freud si gioca tutto sul rapporto tra esigenze naturali innate (quindi anche sessuali) e civiltà. Anche per Moravia tutto ha inizio dall’Es. Anche Moravia mette in primo piano la libido nei suoi romanzi. Anche per Moravia libido e nevrosi sono strettamente connesse. Inoltre Freud non accenna nel suo lavoro a quelle che chiamiamo oggi subpersonalità e neanche Moravia lo fa nei suoi scritti.
“L’uomo a una dimensione” di Herbert Marcuse compare in Italia nel 1967. E’ una delle opere preferite dai sessantottini. Il sociologo marxista Marcuse diventa uno dei maestri di pensiero del’68. Non riesco a capire come mai la critica letteraria non abbia mai rilevato non dico l’influenza diretta di Marcuse sul pensiero di Moravia, ma perlomeno dei richiami, delle somiglianze, delle analogie. Marcuse nel terzo capitolo de “L’uomo a una dimensione” tratta della DESUBLIMAZIONE REPRESSIVA, ovvero della desublimazione imposta dal Potere. In parole povere un popolo sublimante può cambiare le cose, può fare anche la rivoluzione. Un popolo desublimato invece non può niente. La desublimazione avviene nell’arte moderna ad esempio, con lo sfruttamento commerciale delle espressioni artistiche e con la fruizione semplicistica di grandi opere dei maestri di pensiero. Faccio un esempio dello sfruttamento commerciale dell’arte: mettere Mozart come sottofondo di una pubblicità, mettere le frasi dei poeti o gli aforismi dei letterati nei cioccolatini eccetera eccetera. Entrambi questi processi tolgono il carattere rivoluzionario delle opere artistiche. Ma esiste per Marcuse anche una desublimazione repressiva sessuale nella società. Intendiamoci bene: il piacere non è solo sessuale. Ci sono svariate fonti di piacere, di cui il sesso è la più popolare e il più intenso. Altri piaceri sono: il vino, il fumo, il cibo, viaggiare, vedere film, leggere libri , etc, etc. Ma secondo Marcuse il Potere cerca di canalizzare tutta la libido dell’uomo moderno nella sessualità. La razionalità tecnologica ad esempio ha permesso all’uomo diverse comodità, però allo stesso tempo gli ha tolto il piacere del contatto con la natura. Marcuse fa un esempio preciso: nella società moderna i fidanzati o gli sposi fanno l’amore in macchina oppure in camera da letto. Non certo come nella società contadina, in cui potevano fare l’amore in un campo. Ma nel campo esisteva il contatto con la natura, nell’abitacolo di un automobile no. Marcuse scrive che nel caso del far l’amore in un prato “l’ambiente partecipa all’investimento libidico” e di conseguenza “la libido si effonde al di là delle zone erogene immediate, in un processo di sublimazione non repressivo”, nel caso del farlo in macchina no. La società industriale secondo Marcuse è più permissiva: il sesso viene permesso anche sul luogo di lavoro ad esempio, i richiami sessuali possono essere proposti anche in televisione. Secondo Marcuse anche i movimenti dei lavoratori nella catena di montaggio sono un richiamo al piacere genitale. Secondo Walker infatti “i movimenti ritmici interdipendenti” generano soddisfazione erotica. E Marcuse inoltre cita anche Sartre che ne “La ragione dialettica” scrive: “nei primi tempi delle macchine semiautomatiche, certe inchieste hanno mostrato che le operaie a cottimo si lasciavano andare, lavorando, a fantasticherie d’ordine sessuale, rivedevano nella mente la camera, il lume, la notte…..”. Però il piacere viene incanalato solo e soltanto verso la genitalità, di conseguenza la quantità di piacere è minore. Per dirla alla Brel esiste la passione (erotica), ma tra i due sessi è scomparsa la tenerezza. Il rafforzamento dell’erotismo inoltre secondo Marcuse causa una minore energia aggressiva: la coscienza infelice dell’uomo moderno sarebbe perciò fermata dall’attuazione della rivolta tramite questo processo di desublimazione repressiva. Allo stesso tempo per gli esseri umani di quest’epoca l’erotismo sarebbe l’unica fonte di piacere e l’unica valvola di sfogo. Ecco allora che al momento dell’amplesso l’uomo ci mette non solo il piacere, ma anche tutta la sua disperazione, la sua infelicità per come stanno le cose. L’orgasmo nella società consumistica è l’unica via di uscita per tutte le frustrazioni e le oppressioni subite. Ecco perchè ne “L’uomo che guarda” di Moravia le amanti del padre del protagonista sono capaci di “un coraggio diabolico”. Ecco perché gli amanti non lo fanno con delicatezza, con tenerezza, ma con violenza, brutalità, con istinto animalesco. Ecco perché nella stragrande maggioranza dei romanzi di Moravia i personaggi fanno spesso sesso in camere d’albergo, macchine, camere da letto, etc etc…..ma raramente in aperta campagna. Resta però da stabilire quale sia il rapporto tra Marcuse e Moravia. Sono arrivati alle stesse intuizioni da soli? Marcuse ha subito l’influenza di Moravia o viceversa? È un'analogia forzata quella tra Moravia e Marcuse? Mi sono avventurato troppo? Tutto questo è da stabilire.
giu 072023Vorrei prendere in rassegna alcuni diari di scrittori e fare una considerazione a largo raggio. Ho scelto dei diari perché per me sono al contempo sguardi di dentro, testimonianza e memento mori.
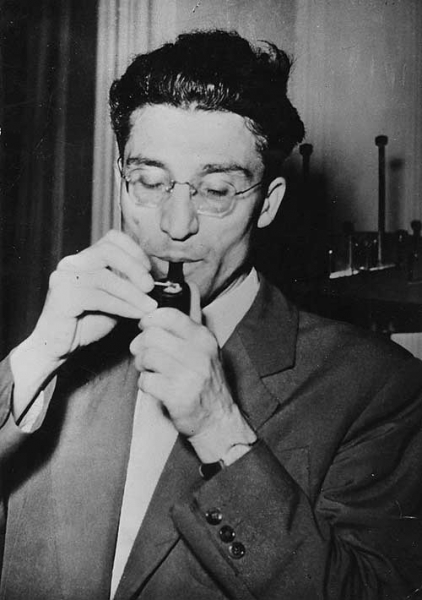
"Il mestiere di vivere":
I più conoscono Pavese per essere stato l'autore di romanzi come "La luna e i falò", "Il compagno", "La bella Estate". Meno conosciute invece le sue riflessioni sulla vita, sulla poesia, sulla letteratura, presenti nel suo diario, costituito da annotazioni che vanno dal 1935 al 1950. Nemmeno i colleghi dell'Einaudi si immaginavano la sua disperazione, il suo feroce senso di solitudine. Questi aspetti li conobbero con la pubblicazione postuma di questo diario, dopo il suo suicidio nel 1950 a Torino in una camera d'albergo. Solo allora ebbero modo di leggere attentamente nelle pieghe più scure del suo animo e comprendere la sua paura di vivere, il suo terrore per il sesso e per le donne. Italo Calvino, che era uno degli amici, non aveva mai presentito nulla a riguardo. Quest'opera è permeata da un pessimismo di fondo, da una sfiducia continua verso gli altri. L'uomo Pavese non coltivava la speranza e questo si legge a chiare lettere. Forse la speranza la perse definitivamente dopo essersi innamorato, senza essere corrisposto, dell'attrice americana Costance Dowling. Però l'intellettuale -come ha intuito felicemente Sergio Solmi- si ribellava all'uomo e con questo diario si difendeva dall'idea del suicidio. Infatti pochi giorni prima di uccidersi scriveva sul suo diario: "Tutto questo fa schifo. Non parole. Un gesto. Non scriverò più". Questa è l'ultima frase di Pavese ed è una grande testimonianza del valore terapeutico della scrittura. Leggendo questo diario, si possono trovare considerazioni illuminanti sulla letteratura. Ne riporto alcune. Il 10 novembre 1938 annota: "La letteratura è una difesa contro le offese della vita". Il 22 marzo 1947 scrive a riguardo dei grandi temi della letteratura moderna: "Hemingway ha la morte violenta, Levi il confino, Conrad la perplessità dei mari del Sud, Joyce lo stereoscopio delle parole-sensazione, Proust l'inafferrabilità degli istanti, Kafka la cifra dell'assurdo, Mann il ripetersi mitico dei fatti". Allo stesso tempo si possono trovare riflessioni cariche di delusione, massime pervase da un sentimento di estraneità nei confronti della vita. Il 17 novembre del 1937 scrive: "È incredibile che la donna adorata venga a dire che i suoi giorni sono vuoti e tormentosi ma che di noi non vuole saperne". Il 21 novembre dello stesso anno troviamo: "No, non sono pazzi questa gente che si diverte, che gode, che viaggia, che fotte, che combatte, tanto è vero che vorremmo farlo anche noi".
"Il diario degli errori":
Nel “Diario degli errori” ci troviamo di fronte a una raccolta di scritti, che vanno dal 1950 ai primi anni settanta. Flaiano dipinge quell’Italia con pennellate colorate di ironia e pessimismo. Per capire di più dello scrittore bisogna ricordare che i rapporti con Fellini non erano sempre idilliaci e che l’unica figlia Luisa soffriva di problemi mentali, dovuti a una grave encefalite. Apparentemente il tema predominante di questi scritti è il viaggio. Ma questo può andare bene solo a chi vuole restare in superficie. In realtà Flaiano lo scrive subito, all’inizio del libro, che la noia e la malinconia ci perseguitano, ovunque andiamo. Ce lo dice subito che è meglio non viaggiare. I viaggi sono solo un pretesto per pensare ai paradossi dell’Italia. Flaiano elimina le mezze bugie e ci presenta mezze verità intaccate di scetticismo. Nei suoi scritti riflette totalmente l’essenza della sua personalità. È polemico, sarcastico, a tratti cinico, sempre disincantato. È un individualista, al di fuori di ogni logica di partito. È avverso al conformismo e all’impegno politico, in cui intravede sempre scaltro opportunismo. Intendiamoci: ha un orientamento politico, è antifascista ed anticomunista allo stesso tempo. Però non si schiera. Le sue annotazioni, i suoi divertenti calembour mettono alla gogna i malcostumi diffusi dell’epoca, svelano la pochezza dei falsi miti e delle false coscienze. L’Italia è un Paese in cui prevale l’idealismo. I politici non parlano chiaro. Gli intellettuali scrivono spesso libri poco comprensibili per chi non ha un bagaglio umanistico. Le leggi possono essere decifrate solo dagli avvocati. E Flaiano riassume questo atteggiamento culturale scrivendo che in Italia non esiste la verità perché la linea più breve tra due punti è l’arabesco. Non c'è speranza. Non c'è via di fuga. Non c'è ancora di salvezza. Flaiano non salva nessuno, neanche se stesso. Il suo pessimismo a mio avviso è sintomatico di una sua crisi interiore. Ma ecco un suo pensiero di questo “Diario degli errori”: “Italia, paese di porci e di mascalzoni. Il paese delle mistificazioni alimentari, della fede utilitaria (l’attesa del miracolo a tutti i livelli), della mancanza di senso civico (le città distrutte, la speculazione edilizia portata al limite), della protesta teppistica……”. Infine Flaiano ci ricorda che "vivere è una serie ininterrotta di errori, ognuno dei quali sostiene il precedente e si appoggia sul seguente. Finiti gli errori, finisce tutto”.
"L'età del Jazz":
Avevo letto la raccolta di saggi di Cioran, intitolata “Esercizi di ammirazione”, ed ero rimasto favorevolmente colpito dal commento che il filosofo aveva fatto su “The crack up” (in italiano"Il crollo") di Fitzgerald. All’improvviso una sera in una libreria mi imbatto in un Oscar Mondadori, intitolato “L’età del Jazz”. Mi metto a sfogliarlo e lo compro subito. Questo libro raccoglie annotazioni di diario, lettere, taccuini e quel che mi interessava più di tutto “La trilogia del fallimento”, tre saggi brevi in cui il grande scrittore descrive la sua condizione esistenziale e svela i suoi fallimenti. Fitzgerald aveva subito bruciato le tappe, raggiungendo il successo con “Di qua dal Paradiso” e con “Il grande Gatsby”. Negli anni '20 con la moglie Zelda era nel vortice della mondanità di New York. Stanchi della vita frenetica di New York, andarono a vivere sette anni in Costa Azzurra. Tuttavia non approdarono alla serenità. Fitzgerald diventò alcolizzato; alla moglie Zelda venne diagnosticata la schizofrenia. La parola Jazz è stata sinonimo di tre cose in quegli anni: sessualità, danza e musica. Erano gli anni del proibizionismo. Le ragazze si tagliavano i capelli e andavano a bere alcol nei locali clandestini insieme ai ragazzi. Ma alla fine Fitzgerald scopre che è stato tutto vano, che niente è restato di quegli anni. Le illusioni sono crollate. Il grande sogno è stato perduto per sempre. Questi li definisce i colpi che vengono dall’esterno. Ma esistono - come lo scrittore sa - anche i colpi che vengono dall’interno ed è questo lato Freud, che personalmente ritengo interessante. Alla base di tutto c'è un blocco psicologico, una sensazione di scacco matto esistenziale. Ho avuto l'impressione netta che tante conoscenze e tante amicizie con personaggi importanti, ricchi e colti non l'abbiano arricchito interiormente ma svuotato. Fitzgerald ritorna in sé. Scrive della propria inettitudine, del proprio torpore, della propria apatia. Con la mondanità aveva cercato di costruirsi invano un’ampia rete sociale, ma alla fine si accorge della perdita della sua identità. Si rende conto di non aver mai fatto scelte autentiche. Con questi scritti riconosce il fallimento e descrive addirittura che il proprio mondo interiore si è decostruito. Tutto inizia con l’insonnia. Ma la notte insonne diventa successivamente metafora della sua condizione esistenziale perché – secondo lo scrittore - nella notte dell’anima sono sempre le tre del mattino. L’autore chiarisce a sé stesso ed al pubblico la sua crisi, paragonando la sua esistenza a un piatto incrinato. Racconta di essersi ritirato dal mondo per due anni allo scopo di catturare silenzi interiori. Per due anni non ha vissuto nel mondo comune, ma in un mondo strettamente intimo e privato. La sofferenza interiore lo costringe a pensare e a scavare dentro sé stesso. Nonostante la crisi, Fitzgerald si interroga e cerca nessi logici, ma la cosa più interessante è che lo scrittore all’improvviso scopre il lato oscuro della sua personalità. Lì scorge contraddizioni ed enigmi: in una parola sola intravede l’abisso.
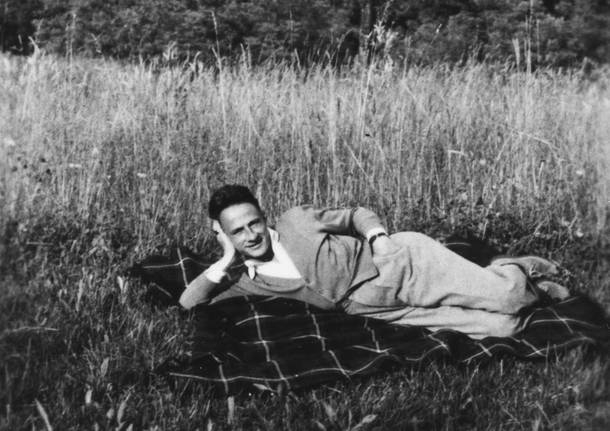
(Nella foto Morselli)
"Diario" di Guido Morselli:
Morselli proveniva da una famiglia agiata. Si laureò in legge. Lavorò per un breve periodo come impiegato. Fece la guerra. Poi scelse di non lavorare. Il padre, obtorto collo, accettò il volere del figlio e gli dette una modesta rendita. Per tutta la vita fu "un eterno dilettante". Tutte le case editrici rifiutarono i suoi romanzi. Eppure oggi è riconosciuto come un grande scrittore e un maestro di ucronie[1]! Anche Italo Calvino rifiutò i suoi lavori[2]. Eppure Calvino è stato anche un talent scout di scrittori come Daniele Del Giudice e Andrea De Carlo! Dopo il suicidio Calasso ebbe il merito di pubblicare le sue opere con Adelphi. Attualmente Morselli è letto dalla comunità letteraria. Diciamo che è un autore di nicchia. Giovani studiosi come Gilda Policastro, Alessandro Gaudio e Linda Terziroli si sono occupati di lui. Nel suo diario si dimostra un intellettuale a tutto tondo, capace di spaziare su vari rami dello scibile. Troviamo speculazioni filosofiche, considerazioni letterarie, riflessioni sulla vita. Riporto fedelmente una annotazione del suo diario, datata 6 novembre 1959: "Tutto è inutile. Ho lavorato senza mai un risultato; ho oziato, la mia vita si è svolta nella medesima maniera. Ho pregato, non ho ottenuto nulla. Sono stato egoista, sino a dimenticarmi dell'esistenza degli altri; nulla è cambiato né in me né attorno a me. Ho amato, sino a dimenticarmi di me stesso; nulla è cambiato né in me né attorno a me. Ho fatto qualche poco di bene, non sono stato compensato; ho fatto del male, non sono stato punito. Tutto è ugualmente inutile". Qualcuno potrebbe pensare che Morselli vedesse Dio come una entità suprema lontana, che si interessava pochissimo dell'uomo. In realtà lo scrittore, a onor del vero, considerava Dio addirittura "una psicosi". Tuttavia, seppur schivo e appartato, non era misantropo. Come scrive il 22 febbraio 1947: "Ieri sera prima di dormire ho riveduto me stesso (...), tornando a casa. Non avevo mai sentito così profonda pietà degli uomini come rivivendo l'immagine di quest'uomo che attraversava piazza del Mercato". Morselli alla fine non scriveva che per pochi amici intellettuali. Non ebbe mai il riscontro del pubblico. Il suo dramma era quello di non avere un ruolo. Per il mondo non era niente e non si occupava di niente. Per i suoi concittadini era solo un tipo stravagante e bislacco. Forse si suicidò perché sentì che tutto era "vanità di vanità", come scritto nell' "Ecclesiaste", oppure per "troppo amore della vita", come ebbe modo di scrivere. Nel mondo di oggi (in cui esistono una comunità letteraria online, i lit-blog, gli ebook e l'editoria a pagamento) ci saranno altri Morselli? Oppure il talento è destinato ad emergere sempre? Lo sapranno solo i nostri posteri.
Conclusioni:
"Le confessioni" di Sant'Agostino e "Le confessioni" di Rousseau sono opere di autoanalisi salvifiche per gli autori, dato che sono espiatorie. I "Saggi" di Montaigne hanno il merito di scoprire l'io dinamico e si contraddistinguono per il relativismo culturale, per il rispetto della dignità della propria persona oltre che di quella altrui. Invece le opere di Pavese, Fitzgerald, Morselli, Flaiano sono testimonianze della crisi di coscienza, ma non la risolvono. I loro autori sono messi alla prova e fanno naufragio. A mio avviso erano tutti troppo orgogliosi per chiedere aiuto. Accenno solo brevemente a "L'ombra e la grazia" di Simone Weil. In questi pensieri, estratti dal suo diario, la mistica dichiara che bisogna "accettare il vuoto", "distruggere l'io", "desiderare senza oggetto": obiettivi quasi impossibili per raggiungere alla fine la grazia di Dio. Mi chiedo se non c'è salvezza allora per coloro che non hanno la fede. Nelle opere di Pavese, Fitzgerald, Flaiano, Morselli c'è "l'ombra" senza "la grazia". Forse è per questo motivo che i loro nodi non si sciolgono e noi li sentiamo "nostri fratelli" per dirla alla Baudelaire. Simone Weil e Sant'Agostino sono encomiabili, ma quasi inarrivabili. Allo stesso tempo viene da chiedermi se si può rinsavire e salvarsi solo grazie all'altro, come vi riesce Pirsig grazie al figlio[3]? Ma quale è poi la causa della crisi di questi scrittori? Era solo la loro vita inautentica o quella di tutti? La loro crisi era psichicamente endogena oppure sintomo del declino della civiltà occidentale? Dipendeva da una interazione? Era esclusivamente loro il cupio dissolvi o era rappresentativo di una intera società? Difficile dirlo. Le loro crisi a mio avviso sono emblematiche riguardo alla condizione umana. A livello esistenziale siamo tutti unici e irripetibili. Dal punto di vista ontologico siamo una infinitesima parte del tutto. L'uomo nei secoli dei secoli è rimasto in conflitto tra queste due forze antagoniste, tra la sua grandezza e la sua miseria, tra il considerarsi un miracolo oppure una nullità. Con la contemporaneità le cose sono ulteriormente peggiorate. Le tragedie delle due guerre mondiali, la recente massificazione e burocratizzazione, una società consumistica e tecnologica hanno spersonalizzato ancora di più l'uomo contemporaneo, facendolo sentire sempre di più una nullità. Si è compiuta oggi la disantropomorfizzazione. Sono state molte le critiche al nostro mondo occidentale, definito "società opulenta" (da J. K. Galbraith), civiltà dell'immagine, società dei consumi, società di massa, "società dello spettacolo" (da Debord), etc etc. Per Marx la causa di tutti i mali è il capitalismo, per Nietzsche e i suoi epigoni il nichilismo, per Max Weber la razionalizzazione, per i cattolici la secolarizzazione, per Husserl "la crisi delle scienze europee"[4], per gli esistenzialisti l'angoscia della scelta, per gli anarchici lo Stato e l'autorità, per Freud la repressione degli istinti, per Camus l'assurdo, per positivismo e neopositivismo la metafisica, per McLuhan i condizionamenti dei mass media, per Jonas la mancanza di un'etica della responsabilità[5], per altri l'individualismo, per altri ancora la tecnocrazia, etc etc. Inoltre per Fromm nella contemporaneità è aumentata l' "aggressività maligna"[6] dell'uomo. Allo stesso tempo l'uomo occidentale ha sempre vissuto una grande conflittualità tra carnalità e spiritualità. Ci si ricordi del mito dell'auriga di Platone. Spesso l'uomo occidentale è un mistico bloccato, come Cioran, e allo stesso tempo un "pornografo inibito"[7], come si definiva in una sua poesia Sanguineti. Sono queste le concause che hanno portato alla crisi Pavese, Fitzgerald, Morselli, Flaiano? Forse avevano avvertito tutto questo? Difficile stabilirlo. Psichiatri come Krapelin, K. Jamison, L. Bretagna, Cassano, P. Duke, G. Hochman hanno stabilito un legame tra nevrosi e creatività. Ma se ciò fosse dovuto ad una causa esogena? In questa sorta di Repubblica di Licurgo è forse più probabile che gli artisti sviluppino delle nevrosi? Forse la stessa razionalità tecnologica ha complicato le cose agli scrittori. Tutto al mondo d'oggi deve essere fatto in nome dell’efficienza e del progresso.Tutti devono avere una utilità pratica. Non a caso due importanti scuole di pensiero americane contemporanee sono il pragmatismo e l'utilitarismo. Per dirla alla Moravia l'uomo oggi è un mezzo e non più un fine. La civiltà vuole costruire strade dovunque e fabbricare macchine sempre più veloci. Dell’evoluzione civile, etica, artistica e spirituale poco importa. Però Jung dichiarò che era più facile andare su Marte o sulla luna che penetrare nel proprio io. La scuola non può permettersi il lusso di educare all’autonomia di pensiero. Eppure è stata proprio l'obbedienza acritica all'autorità, lo spirito gregario, l'eseguire ordini imposti dall'alto a fare diventare molti tedeschi dei criminali nazisti (gli psichiatri la chiamano "sindrome di Norimberga" e la Arendt la chiamava "banalità del male")! Insomma gli umanisti sono dei falliti. In fondo sono sempre più coloro che disprezzano l'arte e la poesia come Bazarov in "Padri e figli". Vince in questo sistema antiumanista chi guadagna soldi. Vince chi si integra socialmente, chi arriva e si adegua al conformismo. Però anche chi scrive libri di successo e si realizza come artista non è detto che si realizzi come uomo: lo dimostrano Pavese, Fitzgerald, Flaiano. Oggi le cose sono degenerate; molti bestseller (la maggioranza sono bestseller di consumo) sono frutto di un mix di furbizia, marketing, ricerca grossolana di intrattenimento. Ci sono anche molti lettori, che pensano che i libri di Fabio Volo, Moccia, Susanna Tamaro siano dei capolavori. I lettori sono in fondo consumatori come altri. Seguono le mode e molto spesso fanno scelte eterodirette perché come sosteneva Gillo Dorfles si è ridotto l'elemento proiaretico[8]. Forse però, oggi come non mai, si può assistere al superamento di concezioni come quelle di cultura alta e di cultura bassa. Forse oggi anche gli intellettuali più raffinati sono Midcult[9]. Forse anche loro sono contaminati dalla cultura di massa. Quindi forse non c'è alternativa. Oggi sono pochi contro il sistema e l'ideologia del mercato, l'unica che è rimasta. Spesso con la scusa che il sistema si combatte dall'interno si finisce per accettare qualsiasi compromesso. Scrivere oggi significa adeguarsi ai dettami della società, cioè diventare commerciali, oppure fallire. Non c'è niente di nuovo sotto il sole: Eco aveva già distinto tra apocalittici ed integrati. Cercare di approdare al cosiddetto nervo delle cose, a una verità umana, per quanto parziale, significa fallire. Per la filosofia l'arte contemporanea dovrebbe provocare shock, straniamento, spaesamento: insomma un rovesciamento di prospettiva nei lettori. Spesso però gli scrittori di oggi non sono più impegnati. Ho sempre pensato che attualmente un'opera d'arte per essere tale richieda la presa di coscienza di una problematica e debba fornire una nuova chiave interpretativa del mondo. Però anche i creatori di opere d'arte non è detto che si affermino commercialmente né che si realizzino come uomini. Inoltre quanto dolore c'è talvolta anche nell'integrarsi socialmente! L'argomento viene trattato anche nel romanzo "Fiorirà l'aspidistra" di Orwell. Ogni artista dovrebbe scegliere idealisticamente se essere in o out dallo show-business. Invece oggi molti scelgono opportunisticamente, ma c'è sempre un prezzo da pagare quando si vende l'anima al successo o alla gloria postuma. Pavese, Fitzgerald, Flaiano non sembravano avere bisogno di niente ed invece non riuscivano a rapportarsi al mondo. Si adattavano al mondo, snaturandosi. Scrivevano capolavori e avevano successo, ma non riuscivano a trovare un senso. Come scriveva Pavese: "In genere è per mestiere disposto a sacrificarsi chi non sa altrimenti dare un senso alla propria vita". Ognuno in gioventù idealizza persone, mitizza luoghi e si pone aspirazioni irrealizzabili. Vivere significa spesso anche resistere e continuare, prima del definitivo rien ne va plus. Perdere significa talvolta maturare, crescere. Come scrive Guccini in "Canzone di notte n°3" anche "perdere ogni tanto ci ha il suo miele". Forse per uno neuropsichiatra riduzionista[10] questi scrittori erano solo depressi. Forse oggi psicofarmaci efficaci riducono l'ideazione di molti artisti, ma li salvano dal suicidio. Oppure i veri artisti sono destinati comunque a fallire a livello esistenziale, metafisico, commerciale. In fondo l'editoria fa parte anche essa dell'industria culturale e non guarda in faccia nessuno; non riserva un trattamento di favore a nessuno, neanche ai più talentuosi. Forse è sempre stato così. Forse la caratteristica precipua e intrinseca dello scrivere oggi è il fallimento. L. F. Celine era molto lucido a riguardo ed affermò: "I posteri saranno i cinesi e quelli se ne fregheranno altamente della mia letteratura fessa”. Sono memorabili anche le parole di Beckett, che valgono in senso lato: "Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio"[11].
Note
[1] Ucronia è un'opera di fantasia, spesso di fantascienza, in cui l'autore si immagina un fatto immaginario e lo sostituisce a un reale fatto storico. Gli autori di ucronie si chiedono cosa sarebbe successo se la storia fosse andata diversamente. Ogni ucronia si basa su una ipotesi controfattuale. Morselli ne scrisse due. In "Contro-passato prossimo" si immagina che la prima guerra mondiale sia stata vinta dagli Imperi centrali. In "Roma senza Papa" si immagina che il Papa si ritiri a Zagarolo.
[2] Potete trovare la corrispondenza tra Calvino e Morselli al seguente indirizzo:
http://mvl-monteverdelegge.blogspot.com/2013/03/caro-morselli-caro-calvino-il-no-di.html
[3] "Lo Zen e l'arte della manutenzione della bicicletta", Milano, Adelphi, 1988. Non è un diario ma un romanzo in parte autobiografico. Il figlio di Pirsig morì accoltellato a 23 anni.
[4] Per Husserl la società occidentale è in crisi perché le scienze oggettivano e quantificano tutto. In fondo già Galileo aveva stabilito la matematizzazione delle scienze. Husserl è stato profetico, se si pensa al fatto che il dottor Duncan MacDougall ha pesato l'anima. Secondo quest'ultimo le persone, morendo, perderebbero 21 grammi.
[5] Per Jonas dovremmo agire, mostrando responsabilità anche verso i posteri e l'ambiente.
[6] Fromm in "Anatomia della distruttività umana" scrive che l' "aggressività benigna" è quella necessaria per la sopravvivenza ed è quindi biofila. Invece l' "aggressività maligna" è quella ad esempio del sadico, finalizzata al piacere di opprimere l'altro, ed è necrofila. Secondo Fromm la competizione esasperata, la ricerca ossessiva di produttività, le frustrazioni della società hanno aumentato la distruttività umana. L'uomo in fondo è l'unico primate che non uccide i propri simili per sopravvivenza ma per altri motivi.
[7] Sanguineti usa questa espressione in "Reisebilder 16", pubblicata in "Wirrwarr", Milano, Feltrinelli, 1972.
[8] proiaretico, ovvero in estetica che riguarda una scelta autonoma, fatta in base alla propria inclinazione e al proprio gusto. È sempre attuale "La ballata della moda" di Tenco, che è morto nel 1967.
[9] Mi riferisco al libro "Masscult e Midcult" del sociologo Macdonald. Per quest'ultimo, il Midcult era "un terzo livello [...], una cultura media rappresentata da prodotti d'intrattenimento che prendevano a prestito anche stilemi dell'avanguardia, ma che era fondamentalmente Kitsch".
[10] Secondo il riduzionismo delle neuroscienze i disturbi dell'umore e i nostri stati mentali sono determinati dalla quantità di neurotrasmettitori. La depressione sarebbe causata esclusivamente da un deficit di serotonina. Saremmo quindi molto più determinati biologicamente di quello che si riteneva un tempo. Secondo la fenomenologia invece è l'esperienza vissuta che determina la visione del mondo di un individuo. Secondo la psicanalisi gli psicofarmaci inibiscono i sintomi, ma non possono niente sul disagio interiore di cui sono espressione.
[11] Citazione tratta dalla novella "Worstward Ho" (1983), che in un’edizione italiana è stato tradotta con il titolo "Peggio tutta", pubblicata in "In nessun modo ancora", Torino, Einaudi, 2008.