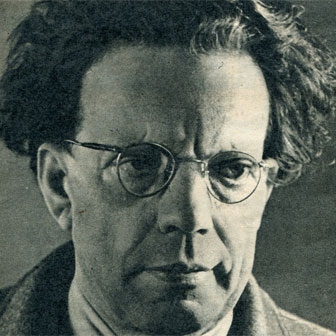Sulla complessità e la schiettezza di Mariella Bettarini...
giu 232022
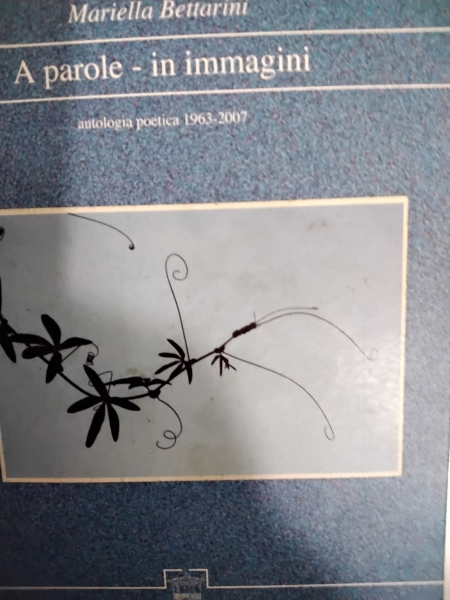
Molti anni fa dopo che le inviai via email un mio saggio breve sulla poesia contemporanea, riletto oggi molto acerbo e pretenzioso, Mariella Bettarini, che ne individuò i punti di forza, omettendo probabilmente quelli deboli per bonaria indulgenza, mi inviò per posta ordinaria la raccolta di tutte le sue poesie, insomma la sua opera omnia lirica, intitolata “A parole – in immagini” (antologia poetica 1963-2007) per la casa editrice “Gazebo”. Per inciso scrivo che la poetessa è sempre stata un’instancabile animatrice e operatrice culturale, ha fondato la rivista letteraria “Salvo imprevisti” (oggi dirige “L’area di Broca”), ha fondato la casa editrice “Gazebo”, ha ottenuto vasto consenso dalla critica, ha colloquiato con molti protagonisti letterari del secondo Novecento, ha tenuto a battesimo molti giovani in poeti. Ha anche curato il libro capolavoro di Alice Sturiale. Un’altra curiosità: è stata anche inserita nell’enciclopedia tematica dell’Espresso Grandi Opere anni fa. Un’altra cosa: non partecipa a premi letterari perché sa come scriveva Ferlinghetti che la poesia non è una gara. Mi invitò comunque anche a una riunione letteraria a casa sua, ma declinai l’invito. A quel tempo ero un piccolo commerciante. Firenze distava poco più di 60 km col treno. C’era il rischio di perdere l’ultimo treno della sera e ritrovarsi sotto stazione tutta la notte. Avevo anche paura del confronto serrato perché non sono un abile oratore. Avevo e ho molte lacune. Avevo paura di un terzo grado o anche di una persona che mi facesse le pulci. Ma forse il vero motivo è che avevo paura di deludere le aspettative. Non ero più abituato alle discussioni intellettuali. Non ero più allenato mentalmente. Soffrivo di timor panico, ovvero di ansia a parlare in pubblico. E poi perché andare? Non ero un letterato. Il mio futuro lavorativo era molto incerto. Avevo altre grane. Le ricordai via email che erano tempi grami per la poesia e che i poeti, aspiranti, sedicenti o effettivi dovevano parlare d’altro e utilizzare la diglossia, parlare nel modo più semplice possibile con la gente. Ciò nonostante mi misi a leggere tutto il suo volume. Sapevo che era un dono prezioso. Ma vivevo in quel periodo una mia crisi interiore e faticavo a esprimere un mio parere articolato. Poi dove pubblicare una mia recensione? Non avevo più un sito né un blog. Inoltre mi arrampicavo sugli specchi perché oltre alle mie contrarietà prettamente interiori, personali mi imbattevo in una voce che faceva dell’unicità la sua caratteristica precipua. La sua poesia sembrava paradossalmente essere a sé stante, autonoma, eppure le sue strutture portanti erano fatte dalla tradizione letteraria novecentesca. Insomma la sua opera si riassumeva nella celebre formula letteraria “tradizione+innovazione”. Ero in un periodo in cui la mia passione per la poesia contemporanea si stava affievolendo. Mi chiedevo a che pro leggere e scrivere? Ma quel libro mi ridava un poco di passione, riaccendeva il desiderio di capire.

La Bettarini però scompigliava le mie certezze poetiche. La sua bravura mi dava addirittura fastidio perché aveva un modo di concepire e fare poesia completamente diverso da come intendevo farlo io. C’era una profondità mista a un’originalità che mi spiazzava. Il suo talento poetico creava in me dei dubbi e delle perplessità. La sua era una poesia sfaccettata in cui confluivano varie anime e molti echi. Era difficile dire la propria e chiudere i miei pensieri così su due piedi come ero abituato a fare. Non era una poesia facile. Ci sarebbe voluto tempo e una certa disposizione d’animo e io rimandai, rimandai e poi abbandonai l’idea di farmene un’idea mia. Ma non c’era niente che non andasse in lei o nella sua poesia; ero solo io che non ero nel momento migliore per accoglierla, farla mia, interiorizzarla. La sua voce arrivava dritta dritta dagli anni ’60, attraversava tutti gli anni ’70 e ’80. Quelle realtà e quel modo di percepirle mi sembravano distanti da me. Eppure con quel passato e con quella poetessa dovevo fare i conti. Non ero un filologo acuto per valutare il suo mutamento linguistico, se era o meno cambiata poeticamente. Quella sua poesia così densa e sostanziosa mi arrivava tra capo e collo all’improvviso e non mi lasciava affatto indifferente. Mi piaceva. Le sue poesie avevano ritmo, musicalità, proprietà di linguaggio, vera intellettualità. Ma da un certo punto di vista mi disturbavano un poco perché non le avevo scritte io e erano totalmente altro da me o almeno sembravano tali di primo acchito. Ma ne ero veramente certo? E se fossimo stati molto più simili di quel che pensavo? A ogni modo non ero certo di niente. Avevo visitato il suo sito. Avevo visto che era stata una maestra. Mi ricordai che anche il miglior poeta pontederese, ovvero Dino Carlesi, era stato maestro elementare. La cosa mi piaceva perché avevo un’ottima opinione dei maestri elementari e mi ricordavo che secondo ricerche internazionali l’unico insegnamento ritenuto valido ed efficiente in Italia era proprio quello elementare. Ma passiamo oltre. Alcuni critici avevano parlato del suo neorealismo fiorentino. Ma la sua poesia era allo stesso tempo complessa concettualmente e denotata da una grande ricchezza lessicale. Immagini, espressioni verbali, metafore, descrizioni, simboli venivano declinati nei modi più disparati: molte erano le tematiche e ancora di più le loro variazioni. La Bettarini col suo modo schietto, confessionale e al contempo discreto metteva in scena tutte le sue sfumature dell’animo. Ma un dato di fatto assodato era che la poetessa scriveva sempre col cuore in mano, pur facendolo con pudore e senza quell’effusione presente in molti, che Sanguineti detestava. Un’altra cosa era che la Bettarini con il suo impegno civile, poetico, letterario, sociale, politico era lì a testimoniarmi e a indicarmi che bisognava di nuovo imparare a vivere sia dal punto di vista privato che pubblico, riprendendo un celebre verso della Achmatova. E imparare di nuovo a vivere significava anche imparare di nuovo a sentire, a pensare, a relazionarsi col prossimo.

Sapevo che quel libro e quella sua dedica erano importanti, erano uno stimolo per me, erano il segno che dovevo continuare a scrivere saggi brevi. Ma quel volume stava anche a certificare un pezzo di poesia fiorentina e poi universalmente italiana. Le lessi una dopo l’altra, ma senza cercare di scorgere metamorfosi interiori né differenze stilistiche. Avvertivo innanzitutto una forte personalità, anche se la presenza dell’io non era assolutamente ingombrante, e il fatto di essere di fronte alla storia di una vita. Ogni poesia si intrecciava con la sua esistenza. L’una richiamava l’altra. Nel volume molto corposo c’erano anche alcuni capitoli delle tesi di laurea che trattavano della sua poesia. Un altro motivo che mi faceva desistere dallo scrivere un commento o una nota critica era che ormai mi trovavo di fronte a una poetessa già riconosciuta, mi trovavo di fronte al fatto compiuto. Che altro avrei avuto da dire? Che altro avrei avuto da aggiungere? Sarebbe stato presuntuoso tentare un nuovo approccio critico. Dovevo farmi da parte e così feci. Mi occupai d’altro. Avevo altri problemi che mi passavano per la testa. Lasciai il libro in un angolo della mia biblioteca. Ogni tanto lo leggiucchiavo di nuovo. Mi sentivo un ingrato a non avergli dedicato del tempo, a non aver scritto niente, a non essermi soffermato. Ero irriconoscente. Ma allo stesso tempo ero ormai convinto che non avrei mai più firmato nessuna recensione per nessuna rivista letteraria. Una cosa che scrissi alla Bettarini, dopo averla letta, è che la sua lingua era impreziosita da tanti toscanismi senza mai forzare troppo la mano e senza mai rivendicare con orgoglio, come fanno moltissimi nostri corregionali, la toscanità. Ora mi viene in mente che in tempi di milanesizzazione nello scritto e nella dizione della lingua italiana la poetessa con la sua opera si opponeva a questa imposizione, quasi questo obbligo morale per chi scrive o opera nei mass media. Già prima dell’avvento di Berlusconi in poesia era egemone la linea lombarda. Una volta addirittura molti anni fa lessi in un muro di una stazione ferroviaria del Nord una scritta leghista, secondo cui non si doveva più parlare toscano. Ma forse, più realisticamente parlando, la poetessa dall’Isolotto provava a concepire una nuova idea della poesia, della letteratura, della cultura, della società, dell’Italia stessa. Queste righe naturalmente non sono un’esegesi. Non voglio fare un’analisi testuale o critica. Era solo un chiarimento doveroso mischiato con alcuni ricordi e con alcune impressioni provate all’epoca. Quel volume è sopravvissuto al trasloco, in cui ho buttato diversi libri e altri li ho regalati alla biblioteca. Lo conservo ancora. Ne sono intimamente orgoglioso di averlo con me. A distanza di anni talvolta rileggo qualche poesia. Non l’ho sottolineato come faccio di solito perché so che è prezioso. Queste righe erano un atto dovuto. Niente di più.