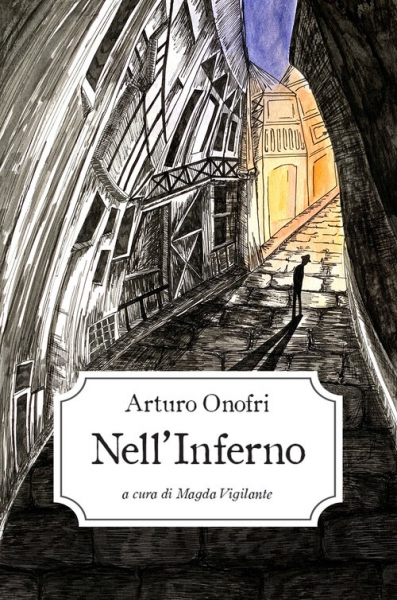set 142022

Analisi e commento di "Così siamo" di Andrea Zanzotto:
Dicevano, a Padova, “anch’io”
gli amici “l’ho conosciuto”.
E c’era il romorio d’un’acqua sporca
prossima, e d’una sporca fabbrica:
stupende nel silenzio.
Perché era notte. “Anch’io
l’ho conosciuto”.
Vitalmente ho pensato
a te che ora
non sei né soggetto né oggetto
né lingua usuale né gergo
né quiete né movimento
neppure il né che negava
e che per quanto s’affondino
gli occhi miei dentro la sua cruna
mai ti nega abbastanza.
E così sia: ma io
credo con altrettanta
forza in tutto il mio nulla,
perciò non ti ho perduto
o, più ti perdo e più ti perdi,
più mi sei simile, più m'avvicini.
Sarò possibilista dal punto di vista metrico. Il primo verso potrebbe essere un endecasillabo, se usiamo la dialefe. Il secondo verso è un decasillabo. Il terzo verso è un doppio settenario, sempre se consideriamo la dialefe. Il quarto verso è un endecasillabo, sempre con dialefe. Il quinto verso è un settenario. Nei primi cinque versi di Zanzotto, in questi due primi periodi, mi sembra che le parole debbano essere soppesate, ponderate. Nessuna parola è di troppo in questa lirica e ogni parola è al posto giusto: ciò denota una precisione chirurgica nella nominazione. Se non utilizziamo la dialefe invece gli endecasillabi sono solo due (uno è l’ultimo verso della poesia). Inizialmente si noti l’iperbato. Il romorio è un termine desueto per indicare un rumore persistente, incessante. Solo l’acqua sporca e la fabbrica scalfiscono il silenzio. Nelle prime due frasi il grande poeta si rifà metricamente alla tradizione, alternando due endecasillabi (uno solo se non contiamo con la dialefe) a un doppio settenario e a due settenari. Successivamente ci sono diversi ottonari, diversi novenari, diversi settenari e svariati enjambements. I versi sono liberi, ma c’è il rispetto delle regole metriche. In questa lirica non abbiamo ancora lo Zanzotto de “Il galateo in bosco”, che con il suo ipersonetto rinnova la tradizione del sonetto “classico”. Qui Zanzotto non tratta del petèl (della lingua dei lattanti) né della “psicanalessi” né utilizza il suo plurilinguismo. Qui Zanzotto non gioca con il linguaggio, non è in bilico tra balbettio e sproloquio, né tra afasia e amnesia. Qui non c’è ancora lo Zanzotto che tratta degli ossari del Montello. Qui ancora non c’è l’io “male sbozzolato” e neanche “Io – in tremiti continui, – io – disperso e presente”. Il poeta mette da parte psicologismi e nevrosi, insomma “l’esistere psichicamente”. Zanzotto qui doveva ancora diventare il poeta sperimentale, quello che si riferiva al significante (a Saussure, a Lacan), assolutamente non legato alla neoavanguardia, ma che però aveva fatto la sua gita a Chiasso (come voleva Arbasino) e aveva cultura non provinciale ma europea. Il poeta doveva ancora utilizzare il dialetto. Zanzotto doveva ancora diventare il poeta che voleva salvaguardare a tutti i costi il suo amato Veneto dall’industrializzazione selvaggia, dallo scempio edilizio, dall’inquinamento. C’è un fatto personale da un certo punto di vista che mi lega alla grande poesia di Zanzotto: avevo amici in giovinezza a Pieve di Soligo, Conegliano, Vittorio Veneto. Sono stato in quei posti. I miei amici mi raccontavano di questo loro grande poeta, di questo loro grande concittadino, schivo e riservato. Ho conosciuto anche io quei luoghi. Sia ben inteso che il Veneto che ho visto io è più quello cantato da Zanzotto che quello narrato a tinte fosche da Carlotto (con tutto il rispetto e la stima per quest’ultimo). A ogni modo questo componimento è tratto da “IX ecloghe”, raccolta scritta tra il 1957 e il 1960. Zanzotto doveva far ancora sua la frase di Hölderlin “siamo segni senza significato”, anche se leggendo attentamente questi versi memorabili c’erano già tutte le premesse, ma è altrettanto vero che qui il poeta è alla spasmodica ricerca di un’autentica significazione, che però naturalmente non trova, dato che di fronte alla morte ogni parola di conforto, di consolazione è vana. In questa lirica c’è un lutto e il suo tentativo di rielaborare il lutto. Ora anche il poeta è morto da anni, ma questo capolavoro è ancora attuale, ci parla ancora a noi e di noi perché la grande poesia è eterna. In fondo suo padre è morto, ma è stato eternato, immortalato. Zanzotto è morto, ma ha avuto gloria postuma e noi ancora lo leggiamo. La grande poesia quindi rende immortali. Qui c’è solo un brevissimo cenno descrittivo al contesto, all’ambiente nel terzo, quarto, quinto verso. Non c’è nessun bozzetto paesaggistico e non c’è nessuna descrizione minuziosa, ma vengono riportate alcune frasi degli amici del padre (a cui questa poesia è dedicata). Il verso più terribile è questo: “neppure il né che negava”. Il padre ormai se pensiamo al mondo dei viventi e al mondo del visibile non è più nulla. Però anche il poeta è allo stesso tempo nulla perché vive nella precarietà esistenziale e come tutti è prossimo alla fine. Il poeta cerca uno spiraglio, una fessura (la cruna), ma invano. Non è con la percezione usuale e nemmeno con la ragione che si trova un pertugio di speranza, ma come vedremo più tardi solo con un atto di fede nella propria umanità e nella propria interiorità (ricordando cosa diceva Sant’Agostino sul rapporto tra interiorità e verità). È impossibile per la ragione umana pensare a qualcuno che esiste ma che è non è più niente né nessuno, né oggetto né soggetto.

Mentre nella parte centrale era il “né”, ripetuto più volte (queste iterazioni determinano il ritmo di questi versi) a condizionare ogni periodo e a negare la presenza del padre su questa Terra, è decisiva negli ultimi sei versi la particella avversaria “ma”, che determina tutto. Nella parte centrale c’era quell’avverbio “vitalmente” poi seguito da “ho pensato” che era una sorta di eufemismo, un modo elegante e meno brusco per non usare le parole “morte”, “morto”: Zanzotto infatti non utilizza concetti banali come “passato a miglior vita”, eppure non utilizza nemmeno termini mortuari né necrofili. Se nei primi versi sembrerebbe che di un morto resti soltanto l’averlo conosciuto di persona, nell’ultima parte c’è l’affermazione della memoria, della vita, di una nuova vita, anche se mai esplicitata pienamente. Lo testimonia l’espressione “E così sia”, ripresa dalle formule liturgiche, che dimostra il fatto che questa splendida poesia è una preghiera laica. Zanzotto credeva nel divino. Non fu casuale a mio modesto avviso se criticò positivamente e promosse la poesia di David Maria Turoldo. Ritornando a questo componimento, a onor del vero, sono importanti tre parole che condizionano il discorso: “ma io credo”. Zanzotto fa un atto di fede, quello di credere con tutta la sua forza in tutto il suo nulla (dato che ogni uomo è poca cosa, essendo carnale e mortale). Altrettanto importante è la convinzione che ne consegue: “perciò non ti ho perduto” perché le parole, i gesti dei morti restano nella memoria dei vivi e prepotentemente ritornano quando meno uno se lo aspetta. A mio avviso in questo modo anche non essere più il né che nega significa ancora una volta che la doppia negazione afferma. Eppure la morte è terribile perché è fortissimo il contrasto tra assenza e presenza. L’autore ebbe a dichiarare che la poesia è “un elogio della vita”, però -aggiungo io- la morte nullifica non solo ogni poter essere ma ogni nostra dicibilità. La morte è l’evento clou, il trauma finale. Se esiste il trauma della nascita, quello della separazione dalla madre, esiste anche il trauma della morte, quello della separazione dai propri cari dal morente e del morente dai propri cari. Comunque è da notare è che il grande poeta quando tratta della morte lo fa con chiarezza memorabile, evitando citazioni, astrazioni, raffinatezze. Zanzotto di fronte alla morte non è mai troppo sentimentale né distaccato, ma sempre coinvolto e partecipe. Non è mai troppo semplice né troppo complesso. Sa trovare la giusta distanza e la giusta dimensione. Sa trovare le parole esatte. Si veda ad esempio “Idioma”, raccolta scritta tra il 1975 e il 1986, in cui compaiono una poesia dedicata a Maria Fresu, vittima della strage di Bologna (di cui non restò più niente, morta insieme alla figlia), e il Tato padovano. In quest’ultimo componimento l’autore scrive dell’anima immortale. In fondo questa concezione religiosa, ma prima di tutto metafisica, era già presente in questo componimento. Non è un caso che in ogni civiltà per fondare un’etica o anche solo una nuova cultura ci sono sempre stati due punti insostituibili: l’immortalità dell’anima e l’esistenza di Dio o delle divinità. È stato così per gli antichi greci. È stato così per gli illuministi, che credevano nella ragione in modo quasi totalizzante, ma erano anche deisti (credevano cioè in una sorta di panteismo). In fondo non è necessario e non l’ho fatta apposta una parafrasi di questo testo. Basta ricordarsi del titolo: “Così siamo”. Per ognuno, indistintamente, suona la campana, citando Hemingway.
lug 272022
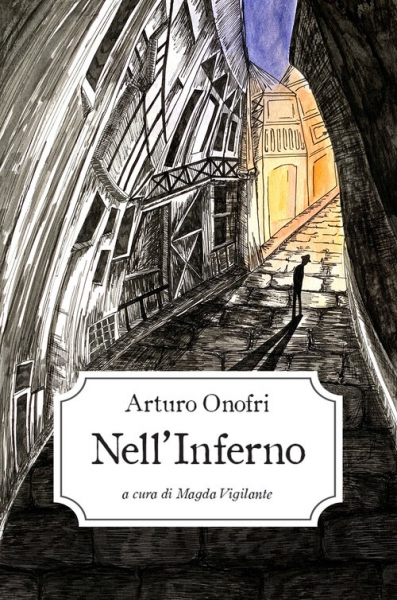
Questi tre racconti, editi in un volume dalla Pandilettere, di Arturo Onofri, poeta metafisico e scrittore (1885-1928) rappresentano a mio modesto avviso delle autentiche rivelazioni. Non lo scrivo per essere celebrativo perché Onofri è un letterato memorabile, che ha in modo inequivocabile segnato il '900 per l'originalità e la qualità della sua scrittura. Dell'importanza di Onofri ne è la controprova che una esperta italianista come Magda Vigilante ha dedicato una prefazione di quaranta pagine, facendo una disamina accurata dei racconti. Cercherò quindi di fare una breve rassegna di questo libro, spoilerando il meno possibile per non togliere istinto di acquisizione e gusto della lettura. Farò delle considerazioni di carattere personale, senza parlare della sua vita, del suo apprendistato, delle sue frequentazioni e delle sue collaborazioni con le riviste letterarie. Il primo racconto si intitola "Il pollice esercitato" (che sta a significare il talento coltivato) e tratta il tema della creazione artistica e della ispirazione con tutte le difficoltà del caso (la creta non è mai molle, indipendentemente dal fatto che si cerchi la mimesi, la trasfigurazione, la creazione ex novo). Come ci ricorda la Vigilante le idee in questione non sono quelle dell'Iperuranio, ma sono spiritelli maligni. Forse il poeta vuole suggerirci che la vera creatività spetta alle donne oppure solo a madre natura: forse solo loro hanno la vera capacità di generare. Le stesse idee sono signore algide e scostanti. Ho letto recentemente che le idee veramente innovative e originali scaturirebbero in modo casuale secondo i neuroscienziati e che addirittura la loro frequenza potrebbe essere descritta dalla distribuzione statistica di Poisson: semplificando ogni idea sarebbe un evento raro e fortuito nelle menti più creative. Ecco quindi la fatica di Sisifo della creazione artistica. Insomma Onofri aveva anticipato i tempi. Il secondo intitolato "I due" mette in scena sia il tema del doppio che quello psicologico del falso Sé (più che dell'Ombra junghiana a mio modesto avviso). Alla fine viene da chiedersi chi sia il personaggio autentico, se la figura in carne e ossa oppure il sembiante. Uno è il Sé autentico e l'altro è la maschera sociale, colui che rispetta codici e convenzioni borghesi. Il terzo intitolato "Inferno" esamina il perturbante in senso freudiano. Il protagonista prova allo stesso tempo repulsione e attrazione verso la donna, descritta inizialmente come orrida. Il lettore viene spiazzato più volte con alcuni straniamenti, con alcuni colpi di scena. Perché una scena sia effettivamente perturbante per Freud deve essere ambivalente emotivamente, deve essere familiare ed estranea al contempo. Onofri si dimostra un artista enigmatico, simbolista, decadente, esoterico (non a caso studiò l'antroposofia steineriana) in questi tre racconti, a cui lasciamo libera interpretazione agli acquirenti del volume; in questa sede ho voluto solo dare delle indicazioni di massima. D'altronde l'arte si caratterizza per la sua polisemia e ambiguità. Ognuno quindi può dargli il suo significato. Posso solo affermare che Onofri nei suoi racconti accosta elevazione spirituale e spavento, grazia e solitudine, levità ed angoscia, orfismo e scissione, purezza e terribilità. Sulla scena si affaccia prepotente il mistero, l'irrazionale sotto la forma di ossessione, di paura. Senza mai cadere nell'intimismo c'è una propensione innata alla penetrazione psicologica. Sono ineludibili lo sgomento e la sorpresa dei protagonisti, che sono tra la veglia e il sonno, quasi in uno stato di reverie e hanno delle apparizioni sconvolgenti. Onofri dà forma al materiale informe dell'onirico. Getta un ponte tra conscio e inconscio, trovando archetipi senza scandagliare oscenamente i segreti recessi dell'anima. Lavora di cesello e l'oscuro non è mai incoerente né incongruo. La sua prosa -per quanto subisce echi, risonanze, influssi- è suggestiva e mai suggestionata da nessun altro autore. Centrali sono le visioni e le analogie di Onofri. Non imita né prende a prestito alcunché. Piuttosto si rifà sporadicamente ed episodicamente alla tradizione. Per dirla alla Peirce il poeta era mosso da autentico amore per la conoscenza, era all'instancabile ricerca della verità. Non è forse un caso che amò diverse dottrine, ma non divenne mai dottrinario? E ora veniamo all'inghippo: quella di Onofri è una prosa poetica? E ancora si può cercare un discrimine tra poesia e prosa poetica?

Voglio sgomberare il campo da ogni possibile fraintendimento: è impossibile a mio avviso fare una distinzione oggettiva tra poesie in versi e prose poetiche. Di distinzioni se ne possono fare ma sono solo soggettive e a mio avviso stucchevoli. Mi auguro che non lo si faccia per faziosità o per partito preso. È sempre arduo stabilire una relazione tra prosa e poesia oppure una linea di confine. C'è chi sostiene che non vi sia più una grande differenza tra i due generi e che per vendere più copie molti poeti farebbero meglio a non andare a capo. Ricordo a tutti che condannare la prosa poetica può voler dire giudicare negativamente i capolavori di Pagliarani e Bertolucci. Perché condannare un certo ibridismo? Per quale motivo? Inoltre ricordatevi che per i puristi del verso scrivere in versi liberi significa andare a capo arbitrariamente ed è considerato alla stessa stregua dello scrivere in prosa. Il verso libero è il lasciapassare e allo stesso tempo la diretta conseguenza della prosa poetica. È meglio non mettere steccati e paletti. Nel secondo Novecento non l'hanno fatto. A mio avviso è lecito scrivere in ogni modo. È sempre meglio non fare restrizioni di nessuna sorta e permettere ogni tipo di libertà. Preferisco per quel che mi riguarda essere onnicomprensivo e inclusivo ai massimi livelli. Un poeta può dimostrare la propria versatilità e scrivere in ogni modo: Onofri ne è stato l'esempio lampante e ha dimostrato tutta la sua versatilità. Un poeta deve avere sempre la massima libertà espressiva. Di conseguenza può utilizzare qualsiasi registro espressivo, che deve essere considerato comunque espressione artistica. Può anche adottare il pluristilismo. La poesia in versi liberi può essere a mio avviso poesia come, anche la prosa poetica può essere allo stesso tempo poesia. Tutto il resto è polemica sterile fatta per amor della polemica. Personalmente non cerco ossessivamente come fanno taluni una linea di demarcazione tra poesia e non poesia. Cerco solo di distinguere solo ciò che mi emoziona da ciò che non lo fa, ciò che mi fa pensare da ciò che non lo fa. I tre racconti di Onofri mi hanno colpito favorevolmente, mi hanno emozionato. Una cosa che contraddistingue la sua scrittura è il fatto che, nonostante le innumerevoli variazioni della lingua italiana dagli anni di stesura a oggi, essa sia ancora comprensibile e chiara senza l'ausilio di alcuna nota: ciò dimostra la capacità comunicativa dell'Onofri. Quella del poeta romano è a ogni modo una prosa lirica, è quella che un tempo veniva chiamata prosa d'arte. Per tutte queste ragioni il volume meriterebbe di essere letto.
giu 122022

Valentino Zeichen (Fiume 1938- Roma 2016) è stato un grande poeta italiano. Tommaso Landolfi scriveva che gli artisti dovevano stare a contatto con il popolo, dovevano quindi viaggiare in terza classe. Ma il grande Landolfi, scrittore sopraffino, fu un giocatore dissoluto, che dilapidò parte del patrimonio di famiglia: almeno nacque e visse per un certo periodo di tempo in una certa agiatezza economica. Zeichen fu anche lui un dandy ma povero scannato. Da giovane conobbe anche il riformatorio. Visse in una baracca lungo fiume a Roma. Zeichen visse perciò sempre in terza classe e poco mancò che lo mandassero via anche da lì. Sapeva cosa fossero gli stenti. Conosceva quanto fosse difficile mettere insieme il pranzo con la cena. La sua arte di arrangiarsi può ricordare in piccola parte “Seminario sulla gioventù” di Aldo Busi. Ma se Busi visse per alcuni anni in ristrettezze economiche invece Zeichen fece la miseria per tutta la vita con grande dignità. Se è vero che frequentava salotti della Roma bene lo faceva più per rompere la solitudine, per essere nel mondo, per aggiornarsi sulle tendenze culturali e su ciò che capitava in Italia che per vendersi al migliore offerente. Era un autodidatta. Non aveva compiuto studi regolari. Ma non era naif. Ormai di poeti naif non ne esistono più. Conosceva a menadito la tradizione letteraria, filosofica, in senso lato tutta quella umanistica. Era un intellettuale vero e non solo a grandi linee, onnivoro e versatile. Noi nel pisano diciamo di un cane che tutto gli fa filo, nel senso che sta attento a tutto e a tutti. Ebbene Zeichen era così, annusava tutto e tutti, bastava un piccolo spostamento d’aria per metterlo in allerta: lo incuriosivano tutto e tutti, era incuriosito da tutto e da tutti. Non era solo il grande talento o la sua biografia originale ad averlo fatto diventare un grande poeta ma una spiccata vivacità intellettuale. Ciò che colpisce di Zeichen è che nonostante la vita grama, agra (ricordando Bianciardi) sia riuscito a mantenere una grande onestà intellettuale, a coniugare coerenza e lucidità, oltre che avere un grande senso di ironia. Sapeva anche essere autoironico, prendersi in giro senza autocommiserarsi più di tanto su dove lo avesse portato la sua vita. Insieme a Luigi Di Ruscio e Alda Merini il nostro fu un grande irregolare delle patrie lettere. Rispetto alla Merini Zeichen fu più stabile psicologicamente, mentre a differenza di Di Ruscio fu consacrato poeticamente molto prima, pubblicando subito con Guanda e Mondadori. Inoltre tutti gli altri poeti, a torto o a ragione, si prendevano più sul serio o forse prendevano solo più sul serio la funzione sociale dell’artista in questa società. Erano gli anni in cui molti si perdevano in un finto ribellismo o facevano i rivoluzionari da salotto. Il nostro invece non aveva queste illusioni, se così si possono definire. Eppure lui molto più di altri avrebbe potuto rivendicare il fatto di essere un artista non appartenente a nessuna borghesia, né per estrazione né per formazione. Molti credevano nell’impegno politico, diventavano militanti. L’unico modo che aveva il nostro di fare politica era scrivere ironicamente della sua condizione, senza atteggiarsi a maestro di vita o a grande saggio. In definitiva dopo aver fatto diversi lavori “il suo rifiuto sdegnoso del lavoro” , così descritto da Valerio Magrelli, era anch’esso un atto politico oltre che poetico. Dario Bellezza, per quanto suo amico, gli diceva che doveva alzare l’asticella e fare più sul serio. Zeichen riusciva a scrivere tra il serio e il faceto, arrivando a fare autentica poesia da una arguta battuta di spirito; aveva questa rara qualità quando il motto di spirito spesso non raggiunge la letterarietà nei più. Non a caso il poeta pubblicò un libro di aforismi poetici. Zeichen era un grande poeta perché sapeva scrivere d’amore, cosa più unica che rara di questi tempi, ma non solo: sapeva parlare di tutto e mettere a disposizione la sua cultura a tutti, nonostante la sua poesia fosse caratterizzata da un alto coefficiente intellettuale (trattava anche di Kafka, Rubens, Popper, Bruno Giordano, Giotto, Duchamps, Umberto Eco e delle bellezze artistiche di Roma). La compianta poetessa e professoressa Biancamaria Frabotta scrisse: «Chi non intende la differenza che esiste fra un poeta intelligente e un poeta dell’intelligenza, legga la raccolta completa delle poesie di Valentino Zeichen […]. Zeichen scrive come vive, e viceversa. Il che, a un secolo di distanza da D’Annunzio, può fare anche notizia. E notizie della sua insolita biografia non ne son mancate, a causa della ghiotta curiosità dei media che ancora non cessano tributare incensi al personaggio, trascurando il poeta che è oggi in Europa, io credo, uno dei più originali e duraturi». Se qualcuno, aspirante suicida, mi chiedesse se la vita vale la pena di essere vissuta oppure se mi confessasse di non saper come tirare avanti gli consiglierei di leggere le poesie di Zeichen. Aveva moltissimi motivi per farla finita, ma tirò sempre avanti. Questo non solo perché sapeva prendere la vita alla leggera secondo alcuni o così com’è secondo altri, ma perché era anche uomo di fortemente tempra morale. Certo i suicidi sono quasi sempre depressi, ma leggere Zeichen consola, conforta e il poeta ti indica la strada maestra. La sua intera opera può essere letta anche come un manuale di sopravvivenza interiore, come un libro di istruzioni per non autodistruggersi. Zeichen non era depresso (e questo non è un merito né una virtù), ma a differenza di alcuni non era neanche deprimente (alcuni sono farraginosi, tortuosi, arzigogolati, pesanti). Nonostante mille difficoltà, innumerevoli lavori, Zeichen sapeva che aveva una missione nella vita: scrivere, scrivere, scrivere. Si ricordi che il poeta in “Area di rigore” scherzava addirittura sulla sua insufficienza cardiaca e con la sua poesia, per quanto elaborata e mai facilona, riusciva a fare della “metafisica tascabile”. Un altro grande merito del poeta fu quello di smarcarsi totalmente dalla tradizione lirica precedente e anche di non farsi abbindolare dalle mode letterarie, che imperversavano in quegli anni. Zeichen sapeva prendere da tutti, ma sentiva, pensava, scriveva senza rifarsi a nessuno: aveva uno stile tutto suo, inconfondibile. Nel tratteggiare la sua figura ho finito per parlare poco della sua poesia, ma quello che mi stava più a cuore era l’esempio umano e non solo quello letterario. Zeichen fu esemplare perché non si abbatteva mai; un’altra cosa che mi piace è il suo vitalismo sereno, mai accattivante né disperato; per il resto leggendo le sue poesie ognuno può farsi un’idea e constatare la sua bravura, almeno quella quasi universalmente riconosciuta dalla critica. Sicuramente Zeichen è importante perché pochissimi sono i poeti poveri e autodidatti. Molti autori diventano poveri, facendo i poeti. Zeichen lo fu sempre. Fu un’eccezione. Dispiace che sia conosciuto soltanto dalla ristretta cerchia dei letterati e della comunità poetica. Purtroppo quando cala il sipario di un protagonista della poesia contemporanea scendono sulla sua figura il silenzio e l’oblio. Eppure dimenticarlo è un piccolo torto e non conoscerlo è anche un’ingiustizia più grave, soprattutto nei confronti di sé stessi. Per come ha vissuto e per come è stato dimenticato possiamo affermare che la società civile italica, la stessa cultura italiana hanno compiuto un’altra ingiustizia. Senza Zeichen si può vivere, ma sensibilmente peggio. Riconoscere di aver bisogno di leggerlo è un piccolo passo avanti della propria evoluzione interiore, se di evoluzione si può parlare. Non a caso quando sono un poco giù di morale mi metto a rileggerlo. Non sono poesie che so a memoria, ma sono i suoi componimenti che mi mettono di buon umore. Talvolta mi illuminano l’esistenza. Spesso mi rispecchio nei suoi versi, talvolta mi ci ritrovo fedelmente. E lo ammiro perché nelle sue condizioni materiali ed esistenziali precarie non si è mai perso d’animo, non si è mai abbattuto, non si è mai affranto. Da Zeichen si può apprendere non solo qualche lezione di poesia ma anche molte lezioni di vita. Nonostante mille problemi non se la prendeva mai col mondo. Forse perché Zeichen in fondo la pensava come Montale quando faceva dire a una svampita che se il mondo va male non è solo per colpa degli uomini.
giu 112022
Attilio Lolini (1939-2017) è stato un ottimo poeta, sconosciuto ai più, mai presenzialista, sempre in disparte, appartato. Eppure con il suo libro “Notizie dalla necropoli” aveva vinto il premio Viareggio, era un autore Einaudi, aveva scritto un libro epistolare con Sebastiano Vassalli. Si era fatto conoscere pubblicando con “Salvo imprevisti”, rivista fondata dalla poetessa Mariella Bettarini. Poi aveva pubblicato alcune sillogi con la piccola casa editrice indipendente ma di qualità “L’obliquo” di Brescia. Era una persona schiva, ieratica. Non cercava la fama a tutti i costi, il successo nazionalpopolare. Da questo punto di vista si può fare un’analogia con il poeta Roberto Roversi, che nonostante la popolarità ottenuta per la collaborazione con Lucio Dalla, collaborava anche a riviste letterarie non sempre rinomate. È stato scritto dalla critica che la poesia loliniana era caratterizzata dalla rabbia e da un maledettismo toscano, che affondava le sue radici nell’anarchismo. Ma questo maledettismo non era mai autocompiacimento né gesto di arruffianamento per compiacere i suoi corregionali; non era mai una politica grezza da abbracciare (come invece certi comici, molto guitti) per piacere ai toscani, che non lo conoscevano. In Lolini non c’era servilismo di nessun tipo nei confronti di nessuno. Sapeva sempre mantenere la sua dignità. C’è chi ha definito la sua poesia come “tragicomica”. Vassalli l’aveva definita come “un frizzante antidoto alla trombonaggine diffusa nel piccolo mondo antico delle patrie lettere” e sempre Vassalli aveva scritto che Lolini non voleva fare nessuna carriera letteraria. Un’altra sua caratteristica era il suo realismo disincantato. Il poeta non frapponeva veli lui e la realtà, ma neanche tra la realtà e il lettore. Era come si suol dire molto diretto e senza filtri. Si può leggere tutto d’un fiato Lolini per poi ritornare a rileggerlo e riflettere sulle sue piccole amare verità. Se è vero che il mondo è fatto di frammenti eterogenei Lolini aveva una certa omogeneità stilistica (che in letteratura si chiama coerenza interna) e prendeva in rassegna molti aspetti della realtà, pur rimanendo fedele a sé stesso. Eppure il poeta si è rinnovato col tempo, ha tradotto nella sua poesia la maturità e la consapevolezza acquisite. Croce o delizia, questo non lo so, ma in “Carte da sandwich” rispetto a “Notizie dalla necropoli” si potevano notare molto meno invettive e più rassegnazione. Per capire Lolini e i suoi versi spesso senza punteggiatura bisogna ricordarsi uno degli Shorts di Auden: “I suoi pensieri vagavano dal sesso a Dio senza punteggiatura” e però considerare che il nostro trattava di tutto, omettendo il sesso (forse perché pudico, forse perché poteva fuorviarlo dalla sua denuncia sociale, dal suo impegno civile, a cui era spesso teso). Uno dei suoi obiettivi era “strapazzare, maltrattare Madame la poesia”. Nei suoi componimenti troviamo barboni, alienati, poveri ed emarginati di ogni risma. Lolini pone l’accento sulle contraddizioni effettive del capitalismo. Il poeta denuncia l'(in)civiltà dei consumi. Qualche piccola contraddizione era insita anche in lui: per esempio era contro i poeti laureati come Montale e pur tuttavia anche lui nelle sue clausole finali dispensava sentenze, piccoli giudizi epigrammatici come il grande poeta ligure negli ultimi anni. Chi vuole fare poesia aforistica in Italia non può prescindere da Lolini. Le sue liriche sono immediate, leggibili, comprensibili, non artefatte, prive di richiami intertestuali, di citazioni colte, di rimandi, di descrizioni prolisse, con cui molti pensano di impreziosire i loro scritti, senza pensare che li appesantiscono e che così facendo allontanano sempre più i lettori. Leggendo Lolini mi chiedo di che cosa è fatto un pensiero umano, di quante sinapsi chimiche ed elettriche, di quante aree cerebrali ci vogliono per una sintesi poetica come la sua, di quale qualità di circuiti neuronali necessitano certe espressioni verbali, certe sequenze rapide di versicoli, certe immagini mentali così limpide e apparentemente semplici. Eppure nonostante questo talento Lolini è vissuto quasi nell’anonimato, senza che nessuno lo lodasse, gli chiedesse un autografo al bar. È la testimonianza più pura che si può vivere senza cercare a tutti i costi un passaggio televisivo né senza stare a idolatrare chi lo ha ottenuto. Inutile sognare la rivoluzione se poi siamo i primi a subire le dinamiche ricattatorie e gli specchietti delle allodole dello show business! Leggendo Lolini si ha modo di riflettere anche su questo. La sua poesia era contrassegnata, nonostante la leggerezza che la pervadeva, da un certo spessore culturale. Non a caso si rifaceva ai libri sapienziali dell’Antico Testamento, come l’Ecclesiaste. Forse non aveva mai cercato la gloria perché sapeva che era tutto vanità di vanità. In fondo sembra dirci Lolini con i suoi versi, con un ghigno beffardo, con un sorriso malcelato che tanto perdere o vincere è uguale, che tanto alla fine saremo tutti sconfitti. Il poeta in questo senso adotta un pessimismo lucido, visto come vanno la vita e il mondo, senza però mai sconfinare nel nichilismo totale. Se tutti sono d’accordo nel constatare che i soldi sono importanti nella vita e fanno la corsa all’oro, il nostro, che esercitò il mestiere di giornalista, ci rammenta che si può anche vivere senza cercare a tutti i costi le comodità del benessere, ma che si può anche vivere all’insegna del minimalismo esistenziale. In un’epoca di crisi economica e di impoverimento generale Lolini ci descrive una vita qualsiasi, senza grandi amori e senza soldi, fatta soprattutto di tanto grigiore, ma ci ricorda, senza atteggiarsi a eroe quotidiano, che non è affatto disdicevole viverla, rifuggendo i mille canti delle sirene. Lolini ci racconta della noia della provincia, di una non vita perlopiù, fatta di giorni sempre uguali e dove non succede mai niente. A che pro viene da chiedersi darsi tanto da fare? In questo senso mi sembra proprio che il vero maledettismo di Lolini sia rintracciabile in quella “indolenza astiosa” di cui parla egregiamente la filosofa Ilaria Gaspari nel suo primo libro “L’etica dell’acquario”, senza scordarsi che in Lolini, essendo senese c’è più gentilezza e meno rissosità e meno rozzezza di un pisano tipico (cosa già notata da Curzio Malaparte). In fondo un toscano molto pigro come Belacqua aveva incantato prima Dante e poi Beckett. Quindi perché un poeta come il nostro non deve incantarci con i suoi flash, i suoi personaggi, la sua solitudine, che non si incaglia mai nel Nulla assoluto? C’è sempre il salvagente dell’ironia a cui si aggrappa. C’è sempre un quid imprecisato e indefinibile che salva Lolini dal Vuoto e dall’abisso. Il poeta non enfatizza mai le debolezze della carne né le vette dello spirito. Dà per scontato che siamo tutti deboli e peccatori, che pochissimi sono i santi e che bisogna avere comprensione per questa povera umanità. C’è nel nostro una grande pietà cristiana, mai manifestata ma sempre implicita, sottintesa, quasi messa tra parentesi. Lolini non prendeva da De André, né viceversa, ma viene spontaneo un accostamento tra i due. Infatti il celebre cantautore scriveva:
“…Se tu penserai e giudicherai
Da buon borghese
Li condannerai a cinquemila anni
Più le spese,
Ma se capirai, se li cercherai
Fino in fondo,
Se non sono gigli son pur sempre figli
Vittime di questo mondo.”
————–
————–
————–
Ma entrambi avevano avuto un esemplare maestro in Umberto Saba, che molto tempo prima di loro in “Città vecchia” scriveva:
————-
————
“Spesso, per ritornare alla mia casa
prendo un’oscura via di città vecchia.
Giallo in qualche pozzanghera si specchia
qualche fanale, e affollata è la strada.
Qui tra la gente che viene che va
dall’osteria alla casa o al lupanare
dove son merci ed uomini il detrito
di un gran porto di mare,
io ritrovo, passando, l’infinito
nell’umiltà.
Qui prostituta e marinaio, il vecchio
che bestemmia, la femmina che bega,
il dragone che siede alla bottega
del friggitore.
la tumultuante giovane impazzita
d’amore,
sono tutte creature della vita
e del dolore;
s’agita in esse, come in me, il Signore.
Qui degli umili sento in compagnia
il mio pensiero farsi
più puro dove più turpe è la via.”
———–
———–
———–
In definitiva Lolini si salva dal precipizio, dopo averlo scrutato per un periodo di tempo indefinito. Ma in lui prevale sempre l’istinto di autoconservazione. Il vero enigma riguardo a Lolini è proprio perché l’impulso vitale avesse la meglio su Thanatos. Forse non c’era un motivo plausibile, una spiegazione logica. A volte la vita va vissuta e amata senza pensarci su e senza chiedersi la ragione. Anche per questo a mio modesto avviso va letto.