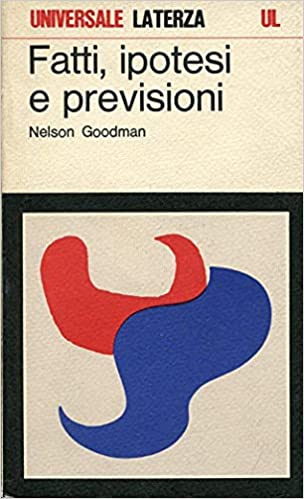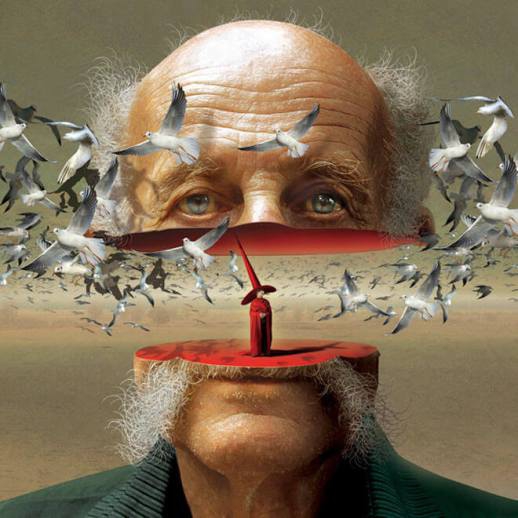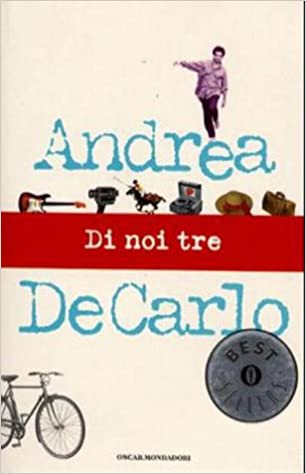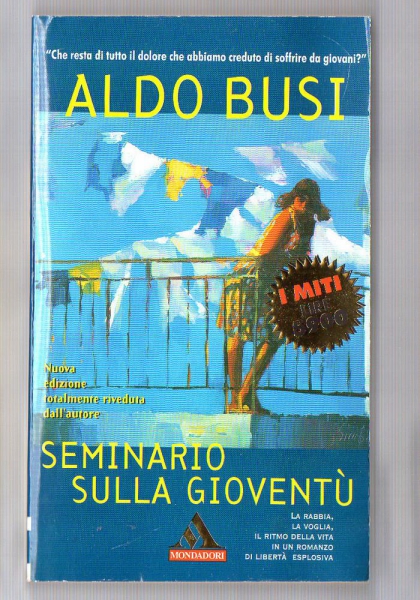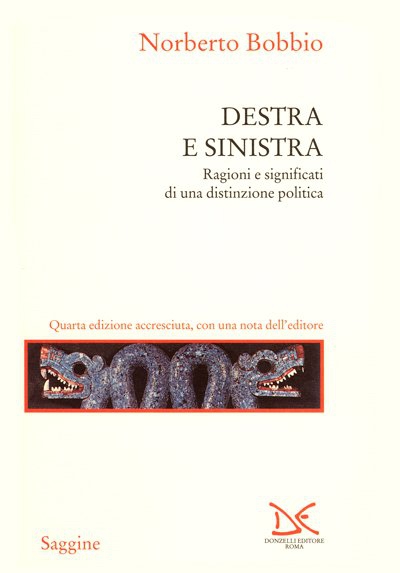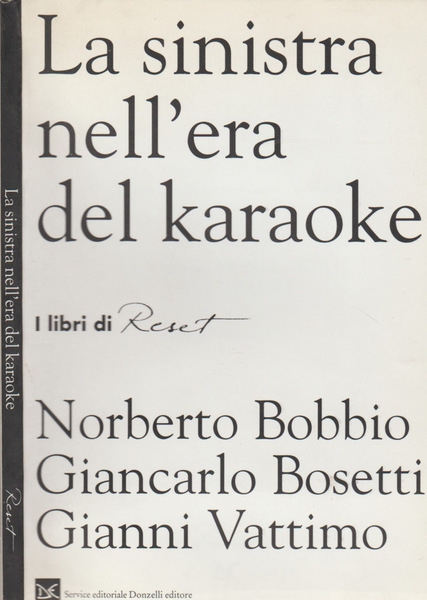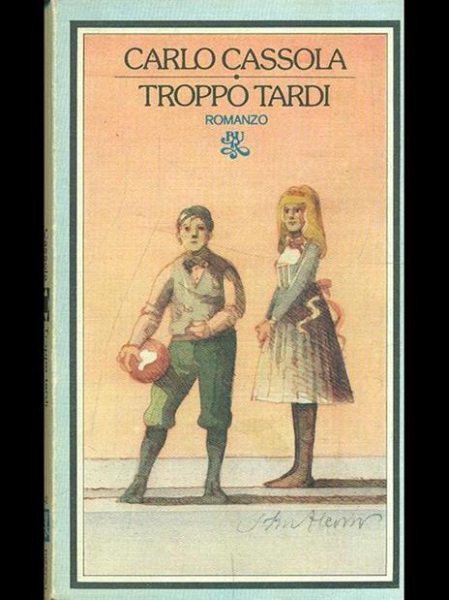lug 252024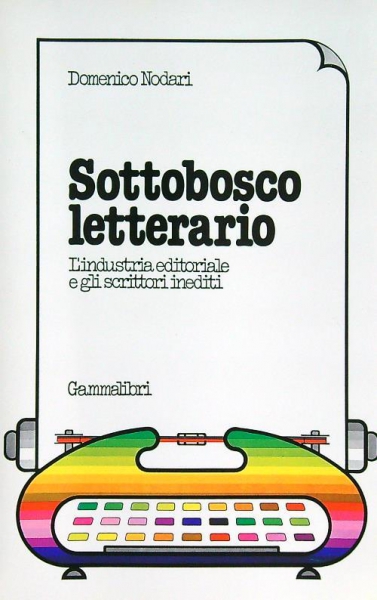
Leggevo in questi giorni “Sottobosco letterario” di Nodari, un libro del lontano 1978. È una raccolta di lettere di aspiranti scrittori e poeti alle case editrici. Allora il fenomeno dell’editoria a pagamento esisteva, ma non era così diffuso ed esteso come oggi. Quindi molti di questi aspiranti artisti erano colmi di frustrazione, di rabbia, che si tramutava spesso in megalomania. Probabilmente la megalomania in gran parte derivava anche da un narcisismo smodato, fondato su un’ignoranza di fondo. C’è da dire che oggi il livello di scolarizzazione si è alzato e probabilmente ora ci sono più aspiranti, ma anche il livello di letterarietà si è elevato. Forse oggi c’è più decenza e nessuno oggi forse propone storie universali della stupidità e trattati sulla masturbazione (ma ci sono anche, ad onore del vero, saggi ben scritti sul rapporto tra masturbazione e anarchismo individuale). Questo libro fu oggetto di critiche per l’operazione non proprio corretta: alcuni sostenevano che venivano messe alla berlina le aspirazioni, talvolta legittime, di persone in buona fede. Molte di queste lettere fanno ridere perché rivelano il lato folle di molti aspiranti dell’epoca tra smanie di grandezza, ricatti, lusinghe, arrufianamenti, etc etc. Più che letteratura è uno spaccato sociologico e psicologico su chi voleva fare letteratura in Italia negli anni ‘70: circoscriviamo e delimitiamo bene il campo di indagine. Però non sappiamo veramente il valore letterario di queste opere, quindi ci manca un tassello importante per giudicare o meno se erano scriventi da strapazzo o meno. In quegli anni l’unico modo per essere riconosciuti era la pubblicazione di un libro. Non c’era Internet. O si pubblicava o si rimaneva dei carneadi a vita. I destinatari appartenevano a ogni fascia di età, a ogni classe sociale. C’erano autori colti e naif. Adesso libri come questo non se ne pubblicano più. Adesso chi vuole pubblicare scrive mail con allegati curriculum e opera inedita. Un tempo costava molta fatica e denaro inviare un manoscritto a trenta case editrici. Oggi la stessa identica cosa si fa in tre quarti d’ora. Alda Merini diceva che il sottobosco letterario è terribile. Sicuramente aveva le sue ragioni per affermarlo. Ma oggi dove inizia e dove finisce il sottobosco? E perché si scrivono ad esempio ancora poesie e romanzi? Flaubert stesso ne “Le memorie di un pazzo” si chiedeva cosa lo tratteneva a scrivere nella sua stanza invece di godersi il mondo, la vita. Brecht scriveva che lo tratteneva alla scrivania l’orrore per l’imbianchino (perché Hitler da giovane era stato un aspirante pittore). In fondo sia i grandi geni che gli aspiranti sacrificano una buona parte della loro vita e di sé stessi per l’arte, vera o presunta. Ne vale davvero la pena? Peirce spiegava così quel che definiva abduzione (che non va confusa con un particolare tipo di sillogismo): 1) si scopre un fenomeno speciale A, insolito 2) si pensa che l’ipotesi B possa spiegare quel fenomeno 3) si ritiene a rigor di logica che l’ipotesi B sia vera. Ebbene, facendo un’abduzione, l’unico modo per spiegare che si scrive ancora è ritenere la scrittura in gran parte terapeutica, pur vivendo in un’epoca povera per l’arte. Non solo ma esistono scuole di psicoterapia come la psicosintesi che si fondano sulla scrittura. È vero: la scrittura può comunque portare insoddisfazione e disagio e come ogni scelta di vita ci sono pro e contro. Vittorio Sereni ne “Gli strumenti umani” scriveva:
“I versi”
Se ne scrivono ancora.
Si pensa ad essi mentendo
ai trepidi occhi che ti fanno gli auguri
l’ultima sera dell’anno.
Se ne scrivono solo in negativo
dentro un nero di anni
come pagando un fastidioso debito
che era vecchio di anni.
No, non era più felice l’esercizio.
Ridono alcuni: tu scrivevi per l’arte.
Nemmeno io volevo questo che volevo ben altro.
Si fanno versi per scrollare un peso
e passare al seguente. Ma c’è sempre
qualche peso di troppo, non c’è mai
alcun verso che basti
se domani tu stesso te ne scordi.
nov 012023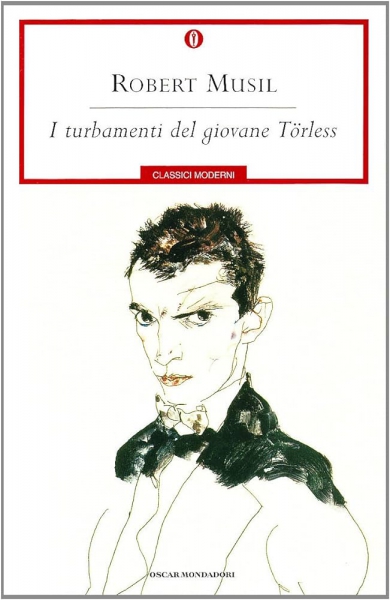
Omen nomen, nel nome un destino: Törless significa letteralmente "senza porta", perciò da intendersi qui come chiuso, introverso. Prima di tutto una curiosità: alcuni traducono il titolo di questa opera "I turbamenti del giovane Törless" e altri "I turbamenti dell'allievo Törless". In questo romanzo di esordio di Musil, in parte autobiografico e pubblicato nel 1906, vengono descritte le esperienze di un allievo sedicenne, proveniente dalla buona borghesia, in un esclusivo collegio militare austro-ungarico. È un romanzo sia di formazione che psicologico. Descrive minuziosamente la crisi esistenziale del ragazzo. Da una parte troviamo il contrasto tra intelletto e passione, mentre dall'altra troviamo la crescita personale e l'evoluzione del giovane. È un libro che tratta tutte le sfumature dell'animo di un ragazzo lontano da casa (può solo scrivere delle lettere ai suoi familiari), costretto a vivere in collegio, e al contempo tutte le sfaccettature di questa istituzione così malsana. L'autore parlò di questa opera come crudele e tenera allo stesso tempo. Inizialmente Törless prova molta nostalgia di casa e una grande monotonia per la vita del collegio. Da un lato c'è la rigida disciplina e dall'altro i soprusi e le esperienze al limite dei giovani cadetti, che hanno esperienze sessuali di varia natura, anche mercenarie e omosessuali. Potremmo oggi definire quelle angherie e umiliazioni con il termine nonnismo. Oggi si è sempre più diffuso il termine pansessuale, coniato dallo scrittore Mario Mieli, che si ispirò a sua volta al concetto freudiano di bambino come "perverso polimorfo". Ai tempi dei tempi, usando un linguaggio datato, avrebbero affermato che questi giovani fanno del sesso senza trasporto, cioè senza coinvolgimento emotivo né sentimentale. È l'età dell'esplosione ormonale. Secondo Kinsey non esisteva una netta contrapposizione tra eterosessuali e omosessuali, ma esisteva un continuum nella popolazione. Questo grande studioso della sessualità americana ideò una scala fatta di sette livelli. Agli estremi c'erano le persone totalmente eterosessuali e omosessuali. In mezzo stavano i bisessuali. C'erano anche gli asessuati. Ma c'erano altri gradi intermedi. Come in questo romanzo, in cui diversi ragazzi sono eterosessuali, che hanno esperienze omosessuali. Probabilmente però la verità è che a sedici anni si è certi di poco; alcuni non sono certi del proprio orientamento sessuale. Ai tempi del social network MySpace alcuni mettevano nel loro profilo "orientamento sessuale incerto". Ecco molti giovani di questo romanzo hanno l'orientamento sessuale incerto. Un tempo si diceva che la carne è debole. Tradotto in termini più attuali, potremmo affermare che tutti provano piacere se viene stimolata una loro zona erogena, indipendentemente da chi provoca questo turbamento. È anche vero che almeno in teoria dovremmo fare sesso con la persona di cui si è innamorati o con chi ci attrae veramente sessualmente. Resta da stabilire quanto si sia determinati e quanto sia una scelta di vita il proprio orientamento. L'argomento è controverso. Comunque sia, attraverso il sesso c'è in questo romanzo anche la sperimentazione e la ricerca di sé. Törless vive degli sbandamenti. Assiste agli abusi sessuali da parte di due suoi amici nei confronti di Basini, un allievo effeminato e unico veramente omosessuale, che questi due sadici hanno scoperto a rubare e ora ricattano, e di Bozena, una prostituta del villaggio vicino. Ancora una volta viene da chiedersi se siano i ragazzi malati o se sia l'istituzione malata. Viene da interrogarsi quanto questi ragazzi siano adulti in miniatura e quanto il collegio sia un modello in miniatura della società di quell'epoca. Per alcuni Musil evidenzia il declino inarrestabile della società Mitteleuropea. Va sottolineato poi che anche in chi viene dominato nel sadomasochismo c'è un rilascio di endorfine. C'è piacere anche nel dolore, cosa scabrosa e sconveniente a dirsi. Non solo ma una componente sadomasochista secondo Freud esiste in tutte le relazioni. Si pensi agli atti preliminari di mordicchiare, di stringere forte, di tenere la testa con forza. Anche se Törless non prende parte alle umiliazioni e non schiavizza Basini e Bozena, è in un certo qual modo complice psicologicamente. Potremmo anche affermare che è un voyeur. Nel migliore dei casi è una sorta di bystander, uno spettatore passivo, che non fa niente e non chiede aiuto. I due allievi sadici si ispirano al superomismo e all'esoterismo. Anche il protagonista fa sesso con Basini, però quest'ultimo è consenziente e si concede volentieri. Ma il sadismo, la crudeltà, il sesso, entrambi fini a se stessi, non ne fanno un romanzo erotico. Il sesso forse è solo un pretesto per affrontare ben altro. Di certo Musil ha voluto affrontare a 360 gradi la vita di un collegio militare e non ha escluso nulla, neanche l'argomento tabù per eccellenza, ovvero il sesso. La sessualità quindi non è concepita qui come finalizzata alla procreazione, né come dovere coniugale, né da un punto di vista ludico. Piuttosto si tratta di una iniziazione sessuale, di una scoperta di sé e del mondo. Nel protagonista si nota una lotta incessante tra le sue pulsioni sessuali, la sua parte più animalesca e la sua necessità di razionalizzare e trovare un ordine alle cose. L'autoritarismo e le gerarchia militare dell'epoca sono rappresentate magistralmente. Il collegio vorrebbe reprimere con le sue regole ferree. È una istituzione castrante, sessuofobica, opprimente. Finisce che, coercizione dopo coercizione, quasi tutti interiorizzano i codici del collegio o quantomeno tutti li accettano passivamente e con rassegnazione. La sessualità si può sfogare, reprimere o sublimare. Ma Törless è troppo giovane per utilizzare uno dei migliori meccanismi di difesa psichici: la sublimazione. Questo romanzo è un'eccezionale mistura di ambiguità sessuale, delinquenza giovanile, elucubrazioni filosofiche, smarrimenti esistenziali. Musil scandaglia l'abisso dell'animo umano. Si rivela un profondo conoscitore della natura umana, così enigmatica. Insomma Ulrich è l'uomo delle possibilità, che non vengono realizzate. Più che un uomo senza qualità, come hanno notato molti, ci sono delle qualità senza più l'uomo. Ulrich è un uomo fatto, non ha scusanti e manca come persona. Törless è un giovane alla ricerca di senso e ordine, anche in presenza di quello che in modo retrogrado un tempo chiamavano disordine morale e che adesso non scandalizza più nessuno. Törless è messo in crisi dalla sua sensualità, dal suo lato oscuro, dalla sua Ombra, per dirla alla Jung, e compie il suo tortuoso percorso di individuazione. Ulrich è l'uomo che potenzialmente potrebbe essere tutto a livello esistenziale. Törless è un giovane che prova di tutto, si forma e si salva all'ultimo, nonostante le asperità. Alcuni hanno visto in Törless un Ulrich ragazzo. Massimo Cacciari ha parlato del capolavoro "L'uomo senza qualità" come di un esperimento da parte di Musil. In fondo anche "I turbamenti del giovane Törless" è un esperimento. Inoltre Musil, nonostante alcuni sottili distinguo, era discepolo del filosofo Mach, che dava importanza all'esperienza, alle sensazioni, ai fatti. Mach era per il primato della scienza, pur riconoscendo a essa dei limiti conoscitivi. Non aveva perciò una fiducia smisurata nel progresso scientifico. Musil riporta queste problematiche gnoseologiche nel romanzo. Infine per ironia della sorte Törless viene espulso dal collegio e i due compagni aguzzini vengono lodati come allievi retti e esemplari. L'istituzione rivela la sua totale assurdità. Da leggere inoltre il discorso finale del protagonista.
Questo romanzo si occupa di adolescenza, che è una stagione, in cui avvengono grandi mutamenti. L'adolescente è sottoposto a varie pressioni, che agiscono spesso in senso opposto e contrario. Se da un lato ogni ragazzo è sottoposto ad una tempesta ormonale, dall'altro è anche vero che grazie allo sviluppo del pensiero ipotetico-deduttivo si innamora spesso delle idee. Mai come in questo periodo della vita si è al tempo stesso innamorati del sesso, del cosiddetto amore romantico e delle idee. Ma l'adolescente è in continua tensione proprio perché non riesce ancora a trovare un equilibrio tra pulsioni sessuali, sentimenti e idealismo. Oscilla continuamente tra istinto e razionalità. Se dal punto di vista dello sviluppo fisico l'adolescente è a tutti gli effetti un uomo, quindi in grado di procreare, dal punto di vista emotivo, affettivo e psichico è una crisalide.
Mai come in questi anni si presenta in famiglia il divario generazionale tra genitori e figli e le posizioni assunte dai genitori possono apparire talvolta ai figli assurde e inconciliabili con le proprie. Ciò è dovuto non solo al divario generazionale, alle differenti mentalità, all'assunzione di ruoli diversi, ma anche alla perentorietà delle affermazioni, alle certezze, all'ingenuità dei figli. Dall'altro lato della medaglia è anche vero che esistono dei genitori, che sono iperprotettivi ed enfatizzano le insidie del mondo esterno, che l'adolescente vuole esplorare sempre e comunque a tutti i costi.
L'adolescenza è la stagione maniaco-depressiva per eccellenza. Basta uscire con una ragazza per essere euforici, è sufficiente un innamoramento non corrisposto per essere depressi per mesi. L'adolescenza è un insieme di complessi, di ansie, di frustrazioni e di sentimenti, che non saranno mai più esperiti con la stessa intensità nel corso dell'intera esistenza. Negli anni successivi tutto si affievolirà. Non solo ma spesso le cose ritenute importanti in questo periodo non saranno più considerate tali nella giovinezza. Già dopo pochi anni nella maggioranza dei casi si assisterà ad un mutamento, se non proprio ad un ribaltamento, di prospettiva.
L'adolescente è colui che ha il caos dentro di sé. E' colui che non ha ancora fatto sufficientemente chiarezza su di sé. Però allo stesso tempo l'adolescente si interroga e cerca una propria identità. Molti adulti invece si negano questa possibilità. Considerano di avere ormai una identità acquisita e non interrogano più se stessi e il mondo. L'adolescente ricerca, ma una volta divenuto uomo conclude la ricerca e fonda la propria identità nella maggioranza dei casi su ciò che fa, su ciò che ha, sull'immagine e la considerazione che gli altri hanno di lui. La ricerca invece dovrebbe essere incessante nel corso di tutta la vita, anche se priva dell'entusiasmo giovanile.
Ma veniamo ora al rapporto del protagonista con la matematica.
In definitiva la matematica esiste per contare, per misurare e anche per dimostrare. Per i formalisti i numeri non sono altro che simboli. Ma la matematica può essere rivelatrice di qualcosa di più profondo, inerente l'esistenza. Nel romanzo di Musil a proposito dei numeri immaginari il protagonista dice: "Questa unità non esiste. Ogni numero, positivo o negativo che sia, elevato al quadrato dà una quantità positiva. Dunque non può esistere un numero reale che sia la radice quadrata di una quantità negativa". Törless, nonostante la sua timidezza, espone i suoi dubbi al professore di matematica, ma questo gli risponde così: “Nello stadio elementare, dove lei ancora si trova, è molto difficile dare la spiegazione giusta di molte cose che occorre toccare. Per fortuna pochissimi allievi se ne accorgono, ma se viene uno, come è venuto le oggi allora non si può far altro che dire: Caro giovane amico, devi credermi sulla parola; quando saprai di matematica dieci volte tanto di quel che sai ora, capirai; ma per adesso, credi!". Musil quindi pone l'accento sui limiti intrinseci dello scibile umano, sulle difficoltà espressive di ognuno.
Ma che cosa turba davvero Törless? Una prostituta disposta ad essere schiava, la crudeltà dei compagni del collegio o proprio i numeri immaginari? Che cosa fa vedere a Törless la realtà in due modi, cioè quello ordinario e quello che fa intuire "una vita segreta" delle cose? Forse sono davvero i numeri immaginari e non certe esperienze di vita? Non lo sapremo mai. Musil in fondo era sia un ingegnere che uno studioso di psicologia. Lo turbava di più il lato oscuro dell'animo umano oppure la filosofia della matematica, la metafisica dei numeri?
Forse Törless era turbato allo stesso modo da entrambe le cose. La tematica della matematica è ricorrente in Musil. Anche Ulrich è un matematico. Potremmo affermare, facendo una analogia tra matematica e realtà, che l'irrazionale erompe dal razionale, come la diagonale di un quadrato di 1 centimetro che rappresenta appunto un numero irrazionale deriva da due lati quantificabili con un numero intero e naturale. La realtà presenta caso o quantomeno disordine a cui molti esseri umani vogliono mettere ordine. Ci sono alcuni scienziati che cercano di predire le urgenze di un ospedale in un dato periodo oppure alcuni eventi nefasti come le bombe d'acqua, la caduta di un meteorite e i terremoti. Eppure non tutti gli esseri umani cercano la sintropia.
Ci sono anche artisti che godono dell'entropia e che vogliono aggiungere disordine al disordine. Scriveva Nietzsche che "bisogna avere un caos dentro di sé per partorire una stella danzante". Ci sono sempre stati nella storia dell'arte e della letteratura sia artisti organici che disorganici. Non sempre si è razionali. L'inconscio è una struttura portante della nostra psiche. L'irrazionale erompe dall'ordinarietà: lo sanno bene i baristi che talvolta si imbattono nel fine settimana in alcuni clienti sbronzi, che raccontano loro la storia della vita. Che mistero la vita! Quante generazioni! Ci passiamo il testimone. Facciamo da staffetta. Ci avvicendiamo, ci alterniamo sulla faccia della Terra. Chi va e chi viene. Di quanti istanti è fatta una vita? Per quanto tempo ancora saremo rimasti sulla scena? Le vite si sfiorano, si intrecciano, si combaciano, si compenetrano, si aggrovigliavano, si allontanano, si evitano. Non si può far altro che presumere. Non c'è formula che riassuma l'esistenza. Non c'è metafora calzante che la imprigioni. La vita è uno splendido garbuglio.
L'irrazionale emerge dal quotidiano, come un biglietto trovato in un libro preso a prestito in biblioteca o nel giubbotto appena ritirato dalla lavanderia. A volte ci chiediamo se alcuni piccoli dettagli siano davvero insignificanti o se siano degli indizi di qualcosa più grande come le coincidenze. Ma ritorniamo ai numeri. Lo stesso rapporto tra la misura di una circonferenza e il suo diametro dà come grandezza il pi greco, che è anche esso un numero irrazionale. In fondo non c'è da stupirsi perché lo stesso Galileo Galilei considerava la matematica il linguaggio della natura. Anche i fiocchi di neve e le frastagliature delle coste possono essere rappresentati con dei frattali. Dietro una apparente irregolarità si cela una regolarità, che può essere descritta da numeri. Forse le scienze non possono esistere senza formule matematiche. Tutto quindi, seguendo questi criteri, dovrebbe essere matematizzato. Concludendo, il giovane Törless, col suo rapporto ossessivo con i numeri, è l'opposto del giovane Holden, che si innamora del linguaggio e che si attacca ad esso. La verità è che abbiamo bisogno sia di numeri che di parole: la mente umana è un mirabile sistema alfanumerico, anche se molti se lo scordano, svalutando il linguaggio in questa società tecnologica.
ott 042023

Torno di nuovo su “Il maestro di Vigevano” di Mastronardi, a cui ho accennato più volte nei miei scritti, ma che non ho mai trattato pienamente. Innanzitutto questo romanzo è potente perché tocca le corde del cuore, entra nel profondo dell’animo. È una disamina accurata, oserei dire uno studio chirurgico delle convenzioni, delle regole, della mentalità piccolo-borghese, che il protagonista, per l’appunto un maestro di provincia, chiama “catrame”. La questione principale è che per togliere il catrame si finisce per togliere la pelle, dato che la mentalità piccolo-borghese è l’essenza stessa di certe persone, che si identificavano e che ancora oggi si identificano in essa, al punto che il discostarsi un minimo da essa è considerata una minaccia alla loro identità psicosociale.
Viene da chiedersi se il protagonista del libro sia un alter ego di Mastronardi, anche lui maestro, che fu un tipo alquanto singolare, un caratteriale e venne addirittura condannato perché aveva offeso un ferroviere su un treno, dandogli del “terrone”. La trama del romanzo è nota a molti perché è stata fatta una trasposizione cinematografica dal regista Elio Petri, mentre Alberto Sordi impersonava il maestro Mombelli. Comunque in poche righe, il maestro ha una moglie e un bambino piccolo. Vive a Vigevano, dove c’è il boom economico e molti si arricchiscono a fare scarpe. La moglie quando i due vanno in paese elenca al marito tutti quelli che, partendo dal niente, si sono arricchiti.
Il meccanismo psicologico è quello della deprivazione relativa: moglie e marito pensano che gli altri abbiano ingiustamente un benessere che loro non hanno e ritengono che questi arricchiti non abbiano nessuna qualità interiore o intellettiva superiore a loro. Il grande scrittore fa la distinzione tra “chi sa” e “chi guadagna” e non sempre le due cose corrispondono, soprattutto se si ha una formazione culturale umanistica. Alla fine la moglie lo convince a mettersi in proprio. Così i due osano, come se mettersi in proprio fosse solo questione di avere una certa propensione al rischio. Lui si licenzia e coi soldi della buonuscita apre un’attività. Ma parla troppo a una cena con gli ex colleghi. Viene registrato, mentre parla delle irregolarità che commette in azienda.
Insomma ha spifferato tutto in piazza. I tre soci vengono convocati dall’avvocato e l’ex maestro deve andare a Canossa e cospargersi il capo di cenere. Insomma è tutta colpa sua. Lui che faceva l’impiegato nella sua ditta ora è costretto a ritornare di nuovo a scuola. Sua moglie muore e mentre sta morendo confessa di averlo sempre tradito, che quello che considerava suo figlio è di un altro. Il figlio inoltre viene sorpreso a commettere atti osceni in luogo pubblico con un pederasta e viene anche denunciato per aver percosso un anziano. Tutto va a rotoli. Il decoro di quest’uomo viene distrutto, annientato, annichilito. La genialità di Mastronardi si vede non solo per come mette in scena la borghesia di quegli anni (il libro uscì nel 1962, ma è ancora attuale), ma anche per come vengono descritte le passeggiate del maestro, le sue sensazioni, la descrizione del fiume Ticino.
Però questo romanzo non è solo il resoconto di un tracollo morale ed economico, è anche la rappresentazione di un uomo, un piccolo intellettuale di provincia, che è troppo lucido e disincantato; forse il suo dramma è tale non solo per la sua sconfitta sociale ma anche per la presenza di una coscienza sempre attenta e vigile. La fine del romanzo è probabilmente un nuovo inizio, più che l’inizio della fine, poiché il maestro è pronto a risposarsi e a ricadere, a ripiombare di nuovo nel mondo piccolo-borghese. Insomma non c’è via di uscita, dato che chi è borghese, a meno che non venga arrestato, resta borghese per tutta la vita. Quel mondo chiuso e angusto, diremmo oggi in modo più moderno, è troppo rassicurante, è una comfort zone, una sicurezza, a cui pochi vogliono rinunciare. Un libro da leggere assolutamente. Un capolavoro, senza se e senza ma.
set 012023
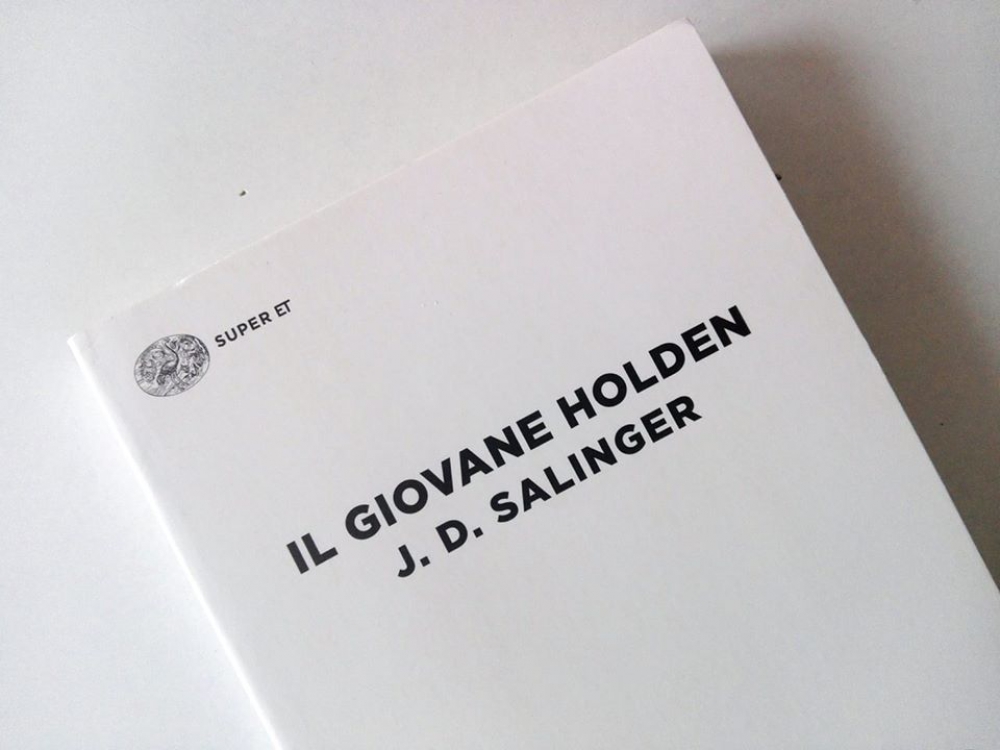
Quel lunatico e schivo di Salinger ha piazzato uno dei più grandi romanzi americani con “Il giovane Holden”. Di sé ha sempre fatto sapere poco al mondo. Ha sempre fatto vita ritirata ed appartata. E’ sicuramente il più schivo e riservato dei grandi scrittori americani del ‘900. Tempo fa su un settimanale vidi una sua foto, o meglio un suo mancato ritratto fotografico: infatti il fotografo era riuscito a riprendere la sua figura, ma Salinger era riuscito a tapparsi il volto con la mano. La foto quindi non permetteva una completa lettura del suo viso. Ma veniamo al romanzo. Il giovane Holden innanzitutto è innovativo per la continuità impressionante del gergo giovanile. Dall’inizio alla fine del romanzo Salinger utilizza sapientemente un linguaggio nuovo, che realizza uno scarto significativo con la tradizione letteraria americana. L’originalità di questo suo linguaggio è sbalorditiva, se si pensa che fu scritto negli anni ’50. Un’altra caratteristica saliente del libro è la sincerità allarmante del protagonista nei confronti di sé stesso e degli altri. Di solito chi scrive cerca sempre di dare una buona impressione ai lettori. Un’alta percentuale delle persone che scrivono infatti per dare un’ottima immagine di sé stessi agli altri cadono nel sentimentalismo, nella retorica, oppure in leziosismi e virtuosismi. Salinger invece mette in gioco tutto sé stesso. Si cala in Holden, suo alter ego, e scrive nello stile più essenziale possibile per arrivare al nocciolo della questione. Questa sua sincerità, questa incessante ricerca di un brandello di verità umana, che a tratti sconfina nel disincanto e nel cinismo, permette a Salinger di riportare alla luce quella parte di ognuno di noi, che prima di questo romanzo non era mai stata scandagliata a dovere. Salinger infatti riesce a mettere sulla pagina bianca tutte quelle piccole idee banali e superficiali, che vengono in mente a tutti; tutti quei pensieri brevi e sconnessi, che releghiamo nel subconscio. Ci sono ad esempio operazioni cognitive, come quelle per guidare una macchina, talmente automatiche e ripetitive, che dopo un minimo di esperienza non raggiungono più la soglia di coscienza. Salinger è riuscito a far venire fuori dalla sua testa queste piccole idee quotidiane, talvolta banali, qualche volta addirittura assurde. Ad esempio di fronte a un laghetto Holden si chiede dove vadano i cigni, quando il lago è gelato. A leggere questo libro si rimane stupefatti, se si è letto qualche libro di filosofia di tanto in tanto. Non c’era bisogno di quelli che Ricouer chiama “i maestri del sospetto” (ovvero Marx, Nietzsche, Freud) per dimostrare al mondo la fallacia della ragione umana e i limiti del razionalismo. Era sufficiente soltanto saper cogliere questi piccoli pensieri banali, automatici, quotidiani. Infine un altro aspetto fondamentale del libro è la messa a fuoco del disagio giovanile. Holden è il classico bravo ragazzo, che frequenta un collegio con regole ferree. E’ il classico ragazzo della borghesia americana. Ma non si trova a suo agio nei suoi panni. A scuola è svogliato. Non gli vanno i professori. Non gli vanno i suoi compagni di scuola. Non gli va bene nessuna delle cricche e delle comitive del suo collegio. Non trova un senso in quel che fa. E’ diffidente nei confronti degli altri. E’ insofferente verso le regole e i paletti imposti dal mondo dei grandi. E’ spietato verso il grigiore della quotidianità. Il rapporto del protagonista con gli altri è sempre problematico, conflittuale, ambivalente. Holden vuole ripagarli con la stessa moneta dell’indifferenza con cui pensa che gli altri lo paghino. La sua è una sensibilità offesa. Quando si ha questo disagio nei confronti degli altri e della società una persona può reagire in tre modi differenti: diventare asociale, misantropo o addirittura antisociale (è forse una coincidenza il fatto che l’assassino di Lennon aveva in tasca una copia di questo libro? Forse si identificava con Holden? Apprezzava forse la sua apparente anaffettività?). Per tutto il romanzo qualsiasi sentimento e qualsiasi tipo di affetto nei confronti delle persone a lui vicine è rimosso. Ma Holden non può rimuovere totalmente ogni emozione. Deve pure investire affettivamnte su qualcuno o su qualcosa. Ecco allora che si innamora del linguaggio. Schifato dal mondo esterno e perfino dai suoi schemi mentali si aggrappa ingenuamente alle parole. Così utilizza le sue parole per mentire. Infatti di sé stesso dice:” Io sono il più fenomenale bugiardo che abbiate mai incontrato in vita vostra”. Alle menzogne e alle falsità del mondo degli adulti quindi contrappone le sue menzogne ingenue, mai dannose per gli altri. Ad esempio quando incontra la madre di un suo compagno di scuola in treno mente spudoratamente, ma lo fa a fin di bene e per quieto vivere. Dice alla madre quello che vuole sentirsi dire di suo figlio. Holden dice alla madre che quel collegio è un’ottima scuola, anche se in realtà gli fa schifo: ma d’altra parte cosa dovrebbe dire a una madre, che paga una retta salata per mantenere suo figlio in collegio? Dice alla madre che suo figlio è un ragazzo sensibile, quando invece pensa che sia il più grande bastardo della scuola. Mente anche sulla sua vera identità, tant’è che, quando si presenta, usa il nome e il cognome del bidello della scuola, per non mettersi a raccontarle la sua vera storia. Ma d’altronde perché non dovrebbe mentire? La conversazione avviene in un contesto sociale, che i sociologi moderni definirebbero “un non-luogo”. E nel non-luogo di uno scompartimento di un treno si possono raccontare tutte le balle che si vogliono. Poi la madre del suo compagno di collegio è una bella donna e il dialogo tra i due è infarcito di luoghi comuni. Perché mai non dovrebbe mentire? Solo alla fine del romanzo Salinger si concilia con gli altri e con il mondo esterno. Infatti scrive: “Io, supergiù, so soltanto che sento un pò la mancanza di tutti quelli di cui ho parlato. Perfino del vecchio Stradlater e del vecchio Ackley, per esempio. Credo di sentire la mancanza perfino di quel maledetto Maurice. E’ buffo. Non raccontate mai niente a nessuno. Se lo fate, finisce che sentite la mancanza di tutti”. Il senso di questo libro di Salinger sta tutto nel titolo originale. Il titolo originale è “The catcher in the rye”, che si potrebbe tradurre “il pescatore nella segale”. Il titolo deriva da un’espressione modificata di una poesia di Robert Burns. La poesia in verità dice: “se scendi tra i campi di segale e ti viene incontro qualcuno”. Invece Holden crede che dica: “E ti prende al volo qualcuno”. E quando se ne accorge capisce anche il motivo per cui ha modificato questo verso della poesia. Lui infatti si è immaginato migliaia di ragazzi, che giocano in un immenso campo di segale. Ma questi ragazzi sono incoscienti ed ingenui, non tengono affatto conto che esiste un dirupo in cui possono cadere. Holden-Salinger scrive allora che la cosa che gli piacerebbe fare di più è quella di acchiapparli e di salvare coloro che inavvertitamente stanno per cadere nel dirupo. Fuor di metafora: il giovane Holden può ancora salvarsi e tramite le sue parole salvare altri adolescenti dalle brutture e dalle ipocrisie del mondo dei grandi. Quell’assurdità e quello squallore del mondo degli adulti se non vengono affrontati nell’adolescenza possono portare al gesto estremo più avanti, come il protagonista del racconto “Un giorno ideale per i pesci banana” dell’opera successiva di Salinger “I nove racconti”, che si spara un colpo alla tempia. Infatti lo scrittore americano nel giovane Holden è cinico nei confronti degli altri, perché il disagio deve affrontare brutalmente lo schifo. Invece ne “I nove racconti”, in cui prende in esame il mondo degli adulti, usa la pietà umana: oramai non può fare più niente per loro, le loro vite sono già compiute, le loro persone sono già gestalt finale. “Il giovane Holden” è stato terapeutico per lo scrittore americano. Salinger è riuscito a fare i conti con il proprio disagio. Ed è proprio per questo motivo che questo libro è stato letto da generazioni di giovani americani. E’ per questo motivo che Salinger è diventato una sorta di compagno di strada dei giovani americani e non solo. E se oggi pochi lo leggono, non sanno che cosa si perdono, perché questo libro diverte e fa riflettere.
lug 022023
_0_o.jpg)
Moravia, la noia e il desiderio:
Ci sono tre modi per combattere e vincere la noia: fare le stesse cose in modo diverso, fare cose nuove, cambiare il rapporto tra la propria coscienza e le cose. Cercare di analizzare questo terzo modo significa scandagliare l'insondabile. E' quello che Moravia fa nel suo romanzo-saggio: l'analisi dell'ontologia della noia. Come ha rilevato la critica Moravia scrive in "prima persona intellettuale": l'io narrante è lo stesso autore. Moravia inizia questo viaggio metafisico interminabile con quella che nell'epilogo definirà "un'ambizione insostenibile". Nel primo capitolo il protagonista confessa che si annoia sin dall'adolescenza. Addirittura una volta ha cercato di interpretare la storia universale sulla base della noia. La noia è dovuta ad una mancata conciliazione tra la coscienza e il desiderio. Flaiano diceva che per essere felici bisogna desiderare quello che si ha. Ma -ahimè- è cosa ardua, dato che raggiunto un obiettivo, posseduto un oggetto, il nostro desiderio si sposta e si proietta verso altre mete. Moravia vuole smontare questo meccanismo, cercare di carpirne le leggi. Vuole scoprire un modo per chiamarsi fuori da questo circolo vizioso. Moravia nel corso della narrazione ci dà molteplici definizioni della noia. Me le sono annotate: "la noia, per me, è propriamente una specie di insufficienza o inadeguatezza o scarsità nei confronti della realtà", "una malattia degli oggetti", "incapacità di uscire da me stesso", "malessere che mi ispirava quello che ho chiamato l'avvizzimento degli oggetti", "specie di nebbia nella quale il mio pensiero si smarrisce". Per analizzare la noia Moravia abbandona qualsiasi tipo di sovrastrutture e qualsiasi tipo di schemi precostituiti: niente Marx, niente Freud e nessun altro maestro di pensiero che sé stesso. Le sue considerazioni sono del tutto personali: dall'inizio alla fine del romanzo. Il pittore protagonista, dopo aver distrutto a coltellate un quadro, smette di dipingere. Fino ad allora dipingeva per cercare di instaurare un rapporto autentico con la realtà. Incontra Cecilia, la modella dell'anziano pittore Balestrieri, suo vicino di casa. Successivamente verrà a sapere che Balestrieri è morto, mentre stava facendo l'amore con Cecilia. Essendo un dongiovanni Balestrieri, il protagonista si chiede che cosa mai avesse Cecilia per aver fissato il desiderio nell'ultimo periodo della sua vita unicamente su di lei. Cecilia diventa quindi lo strumento per analizzare la noia. Il protagonista Dino ne diventa l'amante; però a questo punto scopre che non ha niente di speciale. Non sa baciare. Nel dialogo tra il protagonista e la ragazza regna l'incomunicabilità. Nelle conversazioni tra i due le risposte della ragazza sono sempre superficiali ed evasive: non lo so, uffa, non ti capisco, non ho niente da dire, non saprei, niente, etc etc (queste espressioni sono ricorrenti nelle sue risposte). Il protagonista si chiede se è lei ad essere noiosa o è lui che si annoia. Ma il viaggio metafisico continua. Cecilia ormai è il simbolo della realtà, tant'è che Moravia scrive "volevo ignorare e conoscere Cecilia, ossia la realtà". Il tentativo che compie il protagonista è quello di disfarsi totalmente della realtà. Cerca di farlo prima con ripetuti e ossessivi possessi fisici, pensando che questo possa portare alla fine al possesso mentale su Cecilia e di conseguenza sulla realtà. Ma nonostante i numerosi amplessi il protagonista si accorge che talvolta Cecilia è altrove, in certi momenti addirittura chiude gli occhi: si estranea, è distante. Allo stesso modo gli oggetti per quanto possono essere comprati ed essere posseduti (usati e logorati), rimarranno sempre per ogni uomo circondati da un alone di mistero e di impenetrabilità. A questo proposito mi vengono in mente i versi di una poesia breve di Auden: "Tavoli e sedie e sofà di casa/sanno cose di noi/ che i nostri amanti ignorano". Inoltre Borges a riguardo scrive: "Quante cose: atlanti, lime, soglie, coppe, chiodi; ci servono come taciti schiavi senza sguardo, stranamente segrete. Dureranno più in là del nostro oblio, non sapranno mai che ce ne siamo andati." Il possesso insomma ha i suoi limiti sia con gli oggetti che con le persone: è un vicolo senza uscita. Allora il protagonista per distruggere "l'autonomia e il mistero" di Cecilia (e anche della realtà) utilizza il moralismo, ossia giudicarla significa possederla e disfarsene. Allora indaga sui rapporti tra la ragazza e l'attore Luciani. La pedina, la spia. Ma qui il discorso si complica. Fino a quando Dino riteneva che Cecilia fosse innamorata di lui la relazione era scontata. Quando invece si accorge che la ragazza non lo ama, allora il desiderio di lei aumenta. Si comporta come se fosse un innamorato geloso. In un certo senso è geloso: la sua però non è una gelosia dovuta ad angoscia di separazione, ma è una gelosia determinata soltanto dal possesso esclusivo che credeva di avere nei confronti della ragazza. Deve ancora tentare altre strade, come quella della mercificazione (Cecilia diventa Danae…stessa mitologia de "La vita interiore"). Ma Cecilia non accetta la proposta di matrimonio né di instaurare un rapporto puramente mercenario. E' ancora una volta autonoma e lo dimostra andando a Ponza con l'altro suo amante Luciani. Il protagonista ha l'incidente in macchina. Dopo l'incidente ha la rinascita e trova il modo per chiamarsi fuori dal meccanismo del desiderio inconciliabile (dato che l'animo umano è insaziabile): ecco la contemplazione disinteressata dell'albero. Può così finalmente "amare in modo nuovo Cecilia" e questo vuol dire " ricominciare a dipingere".
Ma ora vorrei lasciare il romanzo di Moravia e fare delle considerazioni a largo raggio.
La presenza del desiderio è la dimostrazione che non siamo monadi isolate, che nessuno è un’entità a sé stante. Necessitiamo dell’alterità, dell’altro da noi. Ci sarà sempre una parte di noi, anche una minuscola regione subcosciente, che brama qualcosa che è altro da noi: oggetto o persona, talvolta ridotta a oggetto. Per non rendere ancora più equivoco il concetto di desiderio dovremmo attuare una netta distinzione tra questo e l’aspirazione (altrimenti finiremo in un ginepraio): aspirare all’uguaglianza, alla libertà, alla prosperità di tutti sono sentimenti più nobili e più alti dell’impulso che muove il semplice desiderio rivolto a un oggetto o a una persona. Se così non facessimo dovremmo trattare del legame tra desiderio e valore e ciò implicherebbe necessariamente valutare che un valore è difficilmente classificabile e che talvolta questo nasce da una problematica di carattere generale, talvolta è una norma o un codice morale. Finiremo inevitabilmente per trattare di soggettivismo e di relativismo di valori e non finiremo più. Diciamo piuttosto che concordiamo con chi ritiene che il valore sia “un fine desiderabile”, ma noi tratteremo solo di desideri superficiali e semplici, che hanno oggetti del desiderio definiti. E’ un’impresa ardua giungere a una fenomenologia del desiderio. Non mi risulta che qualche filosofo sia riuscito a dare una definizione esaustiva. Il desiderio infatti si confonde con la memoria. Memoria e desiderio attingono sia dal mondo sensibile che dall’immaginazione. Memoria, desiderio, immaginazione, realtà: si finisce quindi in un circolo vizioso della ragione. Ad intuito possiamo ritenere - semplificando un po’- che il desiderio si situi tra vedere e pensare, tra soggetto e oggetto, tra reale e immaginario, tra fatto e rappresentazione mentale, tra dimensione intrapsichica e dimensione intersoggettiva, tra assenza e possesso, tra essere e poter-essere. Etica e morale pongono dei limiti e dei freni al nostro desiderio. Ma non vorrei dilungarmi oltre riguardo alla genealogia della morale. Perfino i nostri stessi sogni risentono di una censura psichica, che sposta e condensa. I sogni non sempre hanno un contenuto manifesto, ma possono rivelare i nostri desideri repressi, trasformati dal lavoro onirico. Grazie a Nietzsche e a Freud abbiamo appreso qualche informazione utile su desiderio, morale e sogno. Per le religioni orientali l’uomo per eliminare la sofferenza deve eliminare il desiderio e annichilire l’io. Deve acquisire la consapevolezza che ciò che desidera è effimero, è pura illusione. Semplificando potremmo affermare che viene svalutato sia il soggetto che l’oggetto del desiderio. In Oriente il desiderio è considerato un fattore limitante per la libertà umana. Ma per noi occidentali è sinonimo di libertà. Noi occidentali lo consideriamo come inesauribile e ineludibile. Noi occidentali abbiamo anche cercato nel corso dei secoli di conciliarci con il desiderio. Gli stoici ad esempio cercarono di dominare le passioni. Flaiano sosteneva che bisognava desiderare ciò che si aveva. Ottimo aforisma, che però non contiene altro che un imperativo categorico irrealizzabile. Si desidera solo ciò che non si è mai avuto o ciò che si è avuto e si è perduto. L’orizzonte del desiderio comprende solo l’assenza e la perdita. Desiderare in fondo significa volere il possesso e/o la presenza di una determinata cosa o persona. Una volta raggiunto l’obiettivo nella maggioranza dei casi diminuisce (a volte addirittura scompare) il desiderio e subentra l’abitudine, la noia, l’incomunicabilità (se si tratta di una persona). E’ difficile rinnovare continuamente il desiderio verso lo stesso oggetto o la stessa persona. Il desiderio è dovuto molto spesso alla novità o ad una separazione non ancora elaborata. Probabilmente nasce da un impasto di realtà e immaginazione e tende a diminuire (e spesso a scomparire) quando il desiderante instaura una relazione con il proprio oggetto del desiderio. Esiste quindi una relazione di inversa proporzionalità tra desiderare ed avere quell’oggetto del desiderio. Una persona poi - una volta ottenuto ciò che desiderava- continua a desiderare ancora: non è mai paga. Un racconto sufi è un’ottima metafora del desiderio incessante dell’uomo. Narra di un mendicante, che chiede a un imperatore di riempire la sua ciotola. Ma l’impresa si rivela impossibile perché il mendicante aveva adibito a ciotola il teschio di un uomo. Infatti era impossibile riempire quel cranio perché voleva sempre di più. L’avere implica riflettere sui limiti del rapporto tra noi e l’oggetto posseduto. Il desiderare invece ci porta a meditare su uno dei maggiori problemi della filosofia: le nostre rappresentazioni mentali della realtà non sempre coincidono con la realtà stessa. In parole più povere a tutti può accadere di essere vittime di un desiderio non realistico o addirittura irrealizzabile. Il desiderare implica necessariamente anche ricercare una spiegazione della ragione per cui abbiamo scelto quel determinato oggetto del desiderio. Spesso si desidera ciò che è bello. Quindi noi abbiamo selezionato tra i tanti quell’oggetto del desiderio perché soddisfa certi canoni e criteri estetici individuali e/o collettivi. Ma potremmo anche aver scelto il nostro oggetto del desiderio perché ci è utile, ci dà piacere o provoca in noi uno stato di benessere interiore.
Direi quindi che nella maggior parte dei casi il desiderio cessa con il possesso. Il possesso è spesso la morte del desiderio. E questo non accade solo e soltanto con gli oggetti, che un tempo ambiti finiscono spesso per essere dimenticati in un angolo remoto della casa, ma anche in quel che chiamano amore. La donna desiderata una volta, diventata moglie non è più desiderabile quanto prima. L’eros diventa allora una formalità da sbrigare o talvolta un’esigenza fisiologica da soddisfare. Diventa solo una pulsione sessuale da completare per ripristinare l’equilibrio. L’abitudine soggioga allora la passione. E’ un problema che l’uomo si porta nell’animo dalla notte dei tempi quello del riuscire a conciliarsi con il proprio desiderio. E’ sempre accaduto che l’uomo cercasse di appropriarsi di più oggetti possibili per avidità e per vanità. In entrambi i casi però gli oggetti devono considerarsi come protesi mal riuscite del proprio ego o come tentativo goffo di rafforzarlo. Freud parlava di principio di realtà. Secondo il celebre psicanalista viennese nei soggetti maturi il principio di piacere deve sempre essere supervisionato dal principio di realtà. Ciò assicurerebbe dei limiti alle frustrazioni che potrebbero derivare nel prefiggersi degli obiettivi irraggiungibili per l’individuo. Nonostante il principio di realtà freudiano che esamina le nostre aspirazioni e le nostre mete, la noia di ciò che abbiamo e di ciò che possediamo è sempre in agguato. Il rapporto con gli stessi oggetti familiari ci annoia. Eppure abbiamo una contraddizione interna riguardo agli oggetti, ancora più accentuata da questa epoca consumistica: desideriamo gli oggetti, li andiamo a visionare nei negozi, ci facciamo prendere dall’istinto di acquisizione o da qualcosa del genere, li compriamo, ci sentiamo rassicurati perché avremo qualcosa di nuovo a cui dedicare attenzione per i prossimi giorni, facciamo in modo che gli oggetti occupino sempre più gli spazi vuoti della nostra casa, come se invece degli spazi vuoti della nostra abitazione potessero riempire gli spazi vuoti del nostro animo, il nostro senso di solitudine. Alcune persone hanno un bisogno compulsivo di fare shopping. A costo di lasciare debiti devono fare acquisti. Comprano libri che non leggeranno mai, dischi che non ascolteranno mai, oggetti che non hanno per loro nessuna utilità pratica né nessuna utilità. Eppure sono momentaneamente appagati. Il guaio è che il giorno dopo sono punto e daccapo. Come se non bastasse si è consumatori non solo perché compriamo continuamente secondo i nostri bisogni reali, i nostri desideri ed i dettami della pubblicità, ma anche perché i prodotti hanno vita breve e sono stati studiati per rompersi a breve termine. Si chiama obsolescenza programmata. Nel giro di poco tempo gli oggetti comprati si rompono e quindi siamo costretti a portare ad aggiustare o a ricomprare. Quanto dura uno stereo, un computer, un’automobile? Ogni quanto le portiamo ad aggiustare? Ogni quanto li ricompriamo perché non vanno più? I prodotti sono fatti perché si rompano nel giro di pochi anni, altrimenti tutto il sistema produttivo andrebbe in crisi. Se il problema di conciliarsi con il proprio desiderio è un problema antico per l’umanità, a mio avviso questa società lo ha aumentato esponenzialmente, dato che l’industria (avvalendosi del marketing e della pubblicità) cerca continuamente di creare nuovi bisogni. Viene allora da interrogarsi su quale significato dare alla parola bisogno perché secondo alcuni questa muta al mutare del contesto storico, sociale, civile, scientifico. Qualche decennio fa non era necessario il bagno nelle case, mentre oggi nessuno ne farebbe a meno e nessuno andrebbe ad evacuare quotidianamente nel campo vicino a casa. Oggi viene considerato necessario possedere un cellulare, quando fino a pochi anni tutti vivevano senza. Alcuni studiosi sostengono che si tratta in ogni caso di bisogni: prima i bisogni era fisici, oggi invece bisogna rilevare un aumento dei bisogni psicologici. A mio avviso invece il rischio della società odierna è quello di confondere i bisogni primari con le comodità ed i comfort. Marx parlava di creazione di falsi bisogni nella società capitalistica. La pubblicità cerca continuamente (e spesso ci riesce) di convertire le comodità in bisogni primari o quantomeno vuole che i comfort acquistino nell’ordine simbolico dei consumatori la stessa valenza dei bisogni primari. Con questo non voglio essere apocalittico, non voglio configurare scenari inquietanti; è sufficiente solo avere presente la netta linea di demarcazione tra bisogno e comodità. Anni fa effettuando un blind test i ricercatori scoprirono che per la maggior parte delle persone la Pepsi era più buona della Coca-Cola. Il dottor Montague scoprì, studiando l'attività cerebrale di 67 soggetti, che quando le persone vedevano ciò che bevevano allora ritenevano più buona la Coca-Cola. Quest'ultima era la più venduta e considerata la più buona perché nelle pubblicità aveva associato il proprio marchio ad immagini di felicità. Questo è uno degli esperimenti di neuromarketing più famosi. Ci sono già le suggestioni dei singoli individui che possono essere potenti. Immaginiamoci i condizionamenti dei mass media e la pressione esercitata dal conformismo! La merce comunque è sempre più una "astrazione". Si pensi a quanto valore aggiunto può dare un marchio, al di là del costo effettivo del prodotto. Si pensi a tanti vestiti, prodotti a basso costo nel terzo mondo, che poi diventano costosi perché i loro marchi sono famosi e ritenuti esclusivi. In definitiva abbiamo la crisi dell’oggetto, la crisi del soggetto e la crisi del rapporto tra oggetto e soggetto a causa di questo tipo di società. A questo riguardo è significativo un racconto di Moravia, intitolato “Palocco”. Un’infermiera a domicilio supplisce alle proprie carenze affettive idolatrando un cane di nome Palocco, che viene investito ed ucciso da una macchina. Da allora la donna considera Palocco una sorta di spirito guida, un’entità astratta con cui parlare quando è da sola a casa. In realtà Palocco non è altro che una proiezione psichica della donna, una parte di se stessa, che ad esempio le vieta di convincere il signor Gesualdo a comprarle una pelliccia ecologica, che ha sognato. In questo racconto scabro, scarno ed essenziale di Moravia viene rappresentata in modo efficace la dinamica del desiderio della protagonista in contrasto con il suo senso di solitudine e la sua crisi psicologica. Non c’è solo la crisi del rapporto tra soggetto ed oggetto, c’è anche la crisi del soggetto. La donna ingenuamente cerca di stringere un patto con il signor Gesualdo ed un suo amico per avere la pelliccia, ma dopo una discussione capisce che per averla deve umiliarsi di fronte a loro, deve fingere di essere un cane. Deve quindi snaturarsi per avere l’oggetto del proprio desiderio. Ma istintivamente -questione di un attimo- capisce che non può snaturarsi e fingere di essere un animale e scappa via. Moravia tramite un caso-limite, una situazione paradossale evidenzia una condizione sempre più frequente dell’essere umano in questo tipo di società, e cioè di chi si snatura a costo di perdere la propria identità per avere degli oggetti. Ma forse nel fondo della propria interiorità resta un residuo di ragionevolezza…
feb 102023
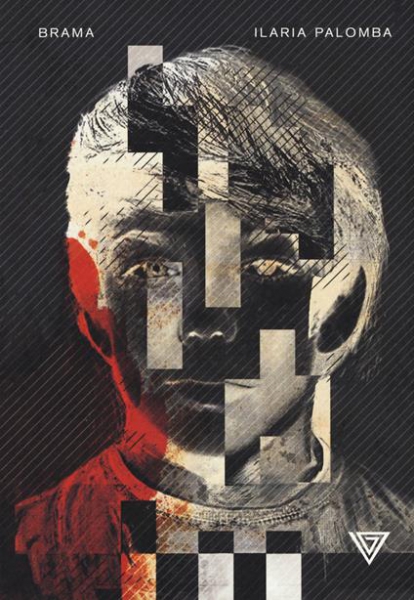
SINOSSI DELL’OPERA. Possedere l'altro, primeggiare, schivare le attenzioni di una madre morbosa, meritare il riconoscimento di un padre inarrivabile sono i desideri che animano Bianca, fragile trentenne, ricoverata più volte in psichiatria per i suoi vani tentativi di suicidio. L'incontro con il filosofo Carlo Brama, ambivalente oggetto di desiderio, rende maggiormente precario il suo stare al mondo e apre un viaggio a ritroso nell'infanzia e nell'adolescenza pugliese, frugando tra i segreti di una famiglia borghese piena di scheletri nell'armadio. L'amore non è una fiaba a lieto fine ma una radiografia della psiche, un legame tanto carnale quanto spirituale che, come in un rito, nel suo compiersi conduce al trascendimento della ragione. Tra Carlo e Bianca c'è un gioco crudele che diventa una condanna, una tessitura di destini, sacra e terribile, cui cercano entrambi di sfuggire.
L'autrice cita subito in esergo due concezioni della brama, secondo Alberto Savinio e Jung; la protagonista desidera "come la terra brama il cielo", ma poi citando "Il diario del seduttore" di Kierkegaard scrive che è "la paura il desiderio più grande, la natura dell'anima umana" e nel capitolo 30 i termini desiderio e brama sono intercambiabili: questo non significa assolutamente confusione o inesattezza, ma difficoltà a stabilire differenze ontologiche tra brama e desiderio per chiunque. La protagonista di questo bellissimo romanzo si alterna tra relazioni tormentate, autodistruzione, tentativi di suicidio sotto forma di "abbuffata di farmaci", cure psichiatriche conseguenti e rischio reale di essere "lobotomizzata da farmaci", che stabilizzano l'umore, annullano deliri e psicosi, ma allo stesso tempo appiattiscono la vita psichica. È vero però che nessun psicofarmaco per ora può annullare il desiderio o per dirla alla Palomba la brama. Il romanzo è scritto molto bene ed è comprensibile a tutti. La Giulio Perrone conferma ulteriormente con questo romanzo di pubblicare libri di elevata qualità. Quest'opera è senza ombra di dubbio frutto di grande talento e coraggio. È un'analisi psicologica incessante, arricchita da citazioni letterarie, psicologiche, filosofiche. Le rare volte in cui si descrive atti sessuali non c'è mai volgarità ma modernità. Il sesso poi non è mai estremo. Il sadomasochismo è soprattutto psicologico/esistenziale: come scrive magistralmente la Palomba è una "sfida a fottersi entrambi" da parte dei due amanti. Vengono anche descritte le dinamiche patologiche familiari. Bianca, la protagonista, si sente una pazza depressa e una figlia ingrata, ma interiormente prova un forte disagio, tant'è che si definisce la "somma di pezzi non assemblati". Carlo, il suo amante, non vuole solo il sesso o l'amore, ma soprattutto la mente; però anche la protagonista è considerata da chi la conosce bene una manipolatrice mentale. Bianca desidera incessantemente ma allo stesso modo esiste "in quanto desiderio di qualcuno": la sua è una via senza uscita, non si esce da questo circolo vizioso. L'instabilità psichica viene descritta in modo egregio nel capitolo 18, in cui le stesse sensazioni sembrano liquefarsi. Bianca insegue l'equilibrio, la stabilità, la normalità. Ma la normalità non esiste. Bion sosteneva che tutti gli esseri umani, anche i più normali, hanno dei nuclei psicotici, nonostante cerchino di inibirli. Ognuno ha delle zone di ombra e anche i cosiddetti folli hanno dei periodi di lucidità. I veri creativi integrano lucidità e follia. Inoltre una cosa filosoficamente molto interessante: la scrittrice per tutto il romanzo gioca su un discrimine, una dicotomia mai netta davvero: da una parte vorrebbe scrutare l’abisso e fermarsi sull’orlo del precipizio, dall'altra vorrebbe come dice lei stessa attraversarlo. Questo romanzo ben congegnato porta a molte riflessioni. Una è sul desiderio.
Oggi riceviamo molti più stimoli e molti più input di un tempo. Siamo quindi degli eterni insoddisfatti. Il consumismo e con esso i mass media stimolano il nostro desiderio incessantemente. Vorremmo avere tutto o quasi, vivere tutto o quasi. Aumentano però anche le frustrazioni. Spesso è questione di modelli inarrivabili, di un immaginario erotico mai pago. Basta leggere “Soggettività e denaro. Logica di un inganno” del filosofo Silvano Petrosino per capire meglio, per decifrare il mistero. Petrosino avverte, citando Lacan che il desiderio è spesso un fantasma più che un oggetto/soggetto vero e proprio. Quando il desiderio si concretizza e l’oggetto/soggetto diventa nostro strumento di piacere ecco allora che non riusciamo a goderne pienamente o desideriamo un altro oggetto/soggetto. Come ricorda Petrosino noi per amare ed essere amati cerchiamo di fare in modo che la persona desiderata ci desideri, per amare bisogna rispecchiarsi nell’altra persona e questa si deve rispecchiare in noi. Insomma l’amore è un incontro di desideri. È soprattutto questo che ci dice la Palomba. È difficile trovare in amore il giusto mezzo. Il sesso non sempre è vissuto da tutti in modo egosintonico.
Un'altra considerazione sorge spontanea sulla nostra grande capacità a cadere sempre nei soliti errori, ad autosabotarci. Freud dal punto di vista psichico parlava di coazione a ripetere. Secondo la Treccani la coazione a ripetere è una “tendenza incoercibile, del tutto inconscia, a porsi in situazioni penose o dolorose, senza rendersi conto di averle attivamente determinate, né del fatto che si tratta della ripetizione di vecchie esperienze”. Per Freud la coazione a ripetere era un grande rovello. Era chiaro che non era governata dal principio di piacere e così Freud aveva teorizzato che fosse causata da Thanatos. Alcuni sono come degli automi che ripetono le solite azioni in un loop infinito. Un tempo si diceva che fosse l’istinto. Oggi questo termine per gli esseri umani risulta inappropriato e si usa invece il termine “pulsione”. Ma non c’è solo questo. Molti, quasi tutti, sono determinati dalle cosiddette dinamiche psicologiche. Da un lato utilizziamo le solite griglie interpretative e siamo rassicurati quando ci troviamo di fronte i soliti script. Quasi tutti si tende a ripetere i soliti schemi di comportamento; siamo soggetti a pensare gli stessi pensieri, a visualizzare le stesse immagini, ad avere gli stessi desideri, a compiere le stesse identiche azioni. Insomma siamo in preda a degli automatismi. È la classica forza dell’abitudine? La casistica delle dinamiche psicologiche è infinita. Ma cosa sono in fondo queste dinamiche psicologiche? La definizione più semplice, quasi tautologica, ma anche più calzante è che sono le spiegazioni psicologiche più plausibili che diamo a dei comportamenti osservati. La scrittrice ha scritto un romanzo impareggiabile sulle dinamiche psicologiche. Oltre alla dipendenza fisica da una sostanza a esempio esiste una dipendenza psicologica. Ci sono inoltre relazioni sentimentali che sono davvero tossiche e che sono determinate da una dipendenza affettiva. Il problema cruciale spesso non è spezzare la catena, ovvero il legame con quella persona, ma annullare o rendere innocua la dinamica psicologica che porta ad instaurare sempre lo stesso tipo di relazione tossica. Ci sono molte persone che si legano da sole sempre alla stessa catena. Non è una questione di logica. A livello razionale si può imparare dagli errori, ma a livello psicologico c’è spesso qualcosa di più forte di noi, che ci porta a ripeterli. Tutto questo lo scrive benissimo la Palomba. Ognuno ha i suoi tarli, le sue debolezze, le sue catene, ma solo pochi riescono ad esserne consapevoli. Spesso tutto ciò è inconscio per chi lo vive. Noi vediamo sempre le catene altrui, ma molto raramente riusciamo a vedere le nostre. Ci sono tante forme di dipendenza. Non a caso per la cura di molti disturbi psicologici si sta diffondendo la schema therapy. In ambito sentimentale la stragrande maggioranza delle persone ha un archetipo definito, dei gusti definiti che portano a scegliere spesso la stessa tipologia di partner. Si usa dire che chi si somiglia si piglia. Ma non c’è una regola certa. A volte si possono scegliere persone complementari, mentre a volte si attraggono le persone totalmente opposte, completamente agli antipodi. Ma questo accade in diversi contesti. Sapere poi perché siamo esseri così abitudinari è difficile a dirlo. Perché i nostri comportamenti sono incasellati sempre in pochi pattern, in poche categorie? Perché fanno parte della nostra identità e della nostra personalità di base che è sempre così stabilita e predeterminata? Siamo davvero degli esseri così prevedibili? È ciò che un lettore si domanda dopo aver letto questo bel libro. In fondo siamo ciò che pensiamo e siamo ciò che facciamo e inoltre facciamo sempre ciò che pensiamo? I nostri desideri agiscono per noi? Siamo agiti dalle nostre subpersonalità? Siamo come automi già programmati con schemi sia innati che appresi? Gli studiosi della mente cercano di dare risposte, ma c’è poco di certo. Tutti concordano nel dire che il cervello umano è “schematico” per adattarsi meglio all’ambiente, per essere coerenti con noi stessi (dato che siamo ricercatori di coerenza e stabilità), per mettere ordine al disordine, per interpretare più efficacemente il mondo. Tutti siamo soggetti a schemi cognitivi, costituiti da modelli e rappresentazioni mentali, da convinzioni radicate nell’animo. Il problema è che alcuni hanno degli schemi “disfunzionali” e finiscono per imbattersi sempre nelle solite situazioni, nei soliti episodi. Bianca, la protagonista del romanzo, è in un certo qual modo disfunzionale in amore. È però anche vero che quando ci imbattiamo in una situazione viene attivata la memoria e in essa vengono cercate delle reazioni e dei comportamenti a situazioni simili che abbiamo già vissuto. È molto difficile cambiare, comportarsi in modo completamente nuovo ed originale. Alcune domande sorgono spontanee. In che modo viene generato un modello di comportamento? Fino a che età si può cambiare schemi di comportamento? Una persona poi può cambiare i suoi schemi di comportamento senza snaturarsi totalmente? Una cosa è certa: molte persone sono molto conservatrici, hanno così paura del nuovo, dell’ignoto, del cambiamento, che preferiscono stare malissimo pur di rimanere tali e quali. Una persona, come si suol dire, è inutile che viaggi per il mondo e cambi mille città diverse se porta con sé nel cuore e nella mente il suo vecchio paese, con le sue esperienze spiacevoli. Volenti o nolenti i nostri schemi di comportamento sono delle generalizzazioni che ci permettono di interagire con gli altri nel modo che a noi sembra più efficace e più veritiero possibile. Il problema principale, croce e delizia al tempo stesso, è che la nostra esperienza è sempre troppo limitata per fare delle inferenze efficaci per il futuro. La scrittrice infine ci fa domandare come potremmo Imparare a non farsi del male, a volersi bene. Sartre a tal proposito sosteneva: "È vero che non sei responsabile di quello che sei, ma sei responsabile di quello che fai di ciò che sei.”
.
gen 032023 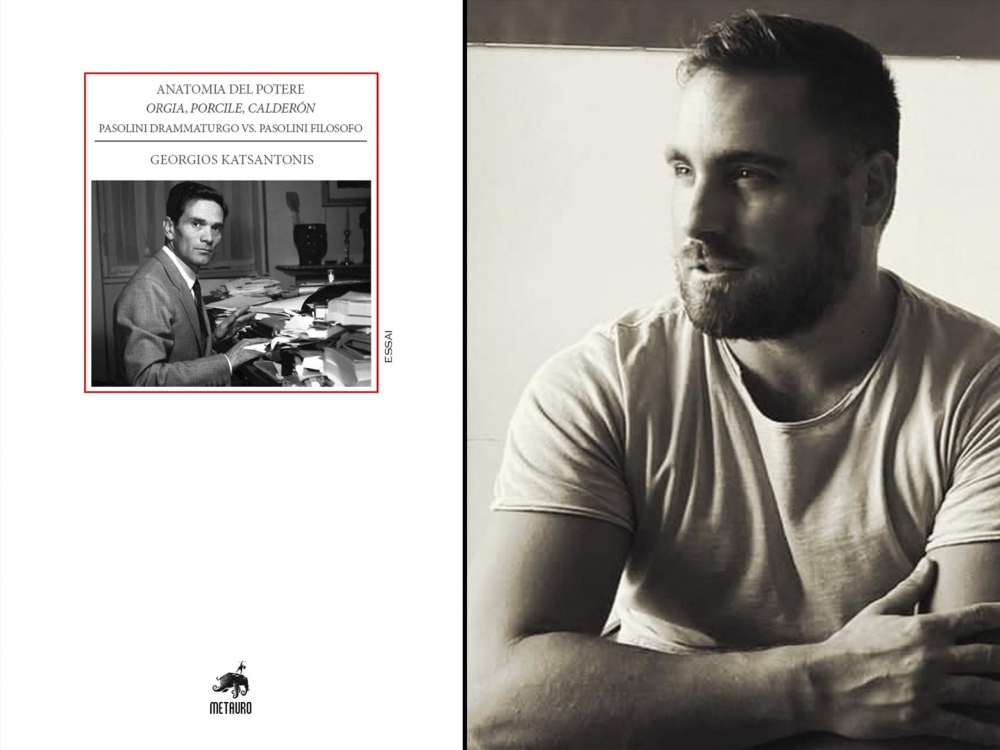
Georgios Katsantonis, nato a Patrasso nel 1987, è studioso di teatro e letteratura.Si è laureato in Studi Teatrali presso l’Università degli Studi di Patrasso (Grecia) portando a termine un percorso completamente strutturato sulla drammaturgia europea, antica, moderna e contemporanea. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Letterature e Filologie Moderne con lode presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha conseguito il Master in Letteratura, Scrittura e Critica teatrale presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Questo libro ha vinto la XXXVII del premio Pier Paolo Pasolini come tesi di dottorato. Tra le motivazioni si parla di un'opera contrassegnata da un "notevole spessore culturale", in grado di fare accostamenti non comuni, di collegare le opere di Pasolini al pensiero di Deleuze sul masochismo, alle riflessioni sul potere di Foucault e di Spinoza, alla concezione degli animali di Derrida.
L'analisi condotta studia i seguenti temi: 1) il corpo in preda al desiderio sadomasochistico (Orgia ), 2) la zooerastia (Porcile ), 3) il corpo recluso tra scissione e visionarietà (Calderón ).
Ma allo stesso tempo c'è anche un'ulteriore analisi: l’erotizzazione del fascismo (Orgia), la fine della polis (Porcile), la società intesa come un mondo concentrazionario, come il Lager (Calderón). L'autore riesce a scorgere un "fil rouge" nelle opere pasoliniane Orgia, Porcile, Calderón. Il saggio è un'eccellente analisi interdisciplinare e comparata in grado di cogliere nessi originali senza mai forzare troppo la mano. Katsantonis è in grado di fare collegamenti mai rilevati con pertinenza, acutezza, rigore filologico, senso critico assolutamente fuori del comune. Originalissima l'idea di non trattare del potere istituzionale come hanno fatto Weber, Parsons, Machiavelli, Pareto, etc etc. Piuttosto il potere è analizzato anche da un punto di vista antropologico e psicosessuale. È studiato, per dirla alla Foucault, sia il micropotere (le dinamiche psicologiche per esempio) che il macropotere; inoltre l'autore molto intelligentemente fa capire che per Pasolini l'immaginario collettivo è già omologato totalmente. Un'altra caratteristica innovativa del saggio è che altri hanno descritto il masochismo morale freudiano o il masochismo politico (come Bruno Moroncini) in Pasolini, ma Katsantonis come nessun altro riesce a scrivere del sadomaschismo pasoliniano come filosofia, come estetismo, infine come vera ragione di vita. Suo cugino Nico Naldini aveva scritto in “Come non ci si difende dai ricordi”: “Da tempo Pasolini aveva adottato il sadomasochismo anche con rituali feticistici: le corde per farsi legare e così immobilizzato in una sorta di scena sacrificale farsi percuotere fino allo svenimento. Non ne aveva mai fatto mistero, sia nelle ultime poesie, sia in quelle giovanili dove si era raffigurato come Cristo-giovinetta nel martirio della Croce”.
L'opera è densa, ma mai troppo concettosa; è un lavoro accademico, ma trascende lo specialismo; inoltre non è mai oracolare ed è provvisto di chiarezza espositiva. Il libro è suddiviso in tre capitoli. Nel primo viene accostata Orgia di Pasolini con La filosofia del boudoir di Sade. Il boudoir è un luogo situato tra il soggiorno e la camera da letto, per intenderci. Viene analizzato il corpo come vittima e la corporeità come assoggettata al potere; vengono considerate la dicotomia dolore/piacere, il passaggio dal culto religioso al culto feticista, la donna seduttrice in Sade, la questione femminile nelle opere pasoliniane. Viene messo in evidenza che per Sade la vera schiavitù è l'accettazione della morale. Per quanto riguarda la questione femminile per Pasolini le donne erano "vittime e marionette" nelle mani del sistema, ma a livello autoriale probabilmente trascendeva i suoi limiti come uomo, che amava solo la madre e vedeva nelle altre donne delle rivali troppo emancipate, che gli rubavano i ragazzi di vita: forse nell'intimità Pasolini, come ebbe a dire Dacia Maraini, era moralista con tutti tranne che con sé stesso. Il capitalismo viene considerato da Pasolini come nuova religione. Viene citata anche l'ideologia del consumismo, il cosiddetto edonismo neo-laico. Per Pasolini "il sadomaso è soppressione di ogni limite", andare oltre i propri limiti, cercare di non porseli. Questo saggio ha una grande forza dialettica ed è in grado di far riflettere qualsiasi lettore, anche quello meno creativo. Se forse c'è un discrimine tra sadomaso come patologia e trasgressivo gioco di ruolo nell'ambito della normalità è la conoscenza dei propri limiti e non superarli. Per Pasolini invece il sadomasochismo forse era una via per il martirio. Non a caso il titolo della tesi di dottorato era "Drammaturgia del corpo patetico" pasoliniano. Viene da chiedersi se è lecita la libertà di opprimere o di essere schiavi. Il sadomasochismo per Pasolini era l'unica valvola di sfogo, l'unico modo di avere piacere in questa società. Katsantonis ottimamente evidenzia la distinzione tra godimento e piacere, sottolineando il sadomasochismo pasoliniano come impasto di Eros e Thanatos. Per Pasolini soffrire significava uscire da sé per poi ritrovarsi. L'autore dà per scontato naturalmente che sia Pasolini che Sade sono dei nichilisti attivi, cioè vogliono distruggere la morale comune e la borghesia perché poi qualcuno in futuro ricrei una nuova società. Il sadomasochismo pasoliniano, come evidenziato nel saggio, è espressione della volontà di potenza neo-capitalistica. Pasolini vorrebbe andare contro, ma anche lui deve comunque adattarsi alla società. Se per Karl Kraus "le perversioni sono metafore dell'amore" nelle opere di Pasolini il sadomasochismo è al contempo metafora e metonimia del fascismo.
Le pagine di questo bel libro generano molti dubbi e questo è naturalmente un merito del saggista. Forse uno dei limiti intrinseci di Sade e Pasolini è stato quello di aver dato sfogo a tutte le loro fantasie, di aver detto l'indicibile, di aver rappresentato l'impresentabile, ma a forza di eccessi si sono discostati troppo dalla realtà umana, in cui invece i sadomasochisti comuni si pongono delle restrizioni per disgusto, per morale, per dolore. In una delle lettere Sade alla moglie scriveva: «Sì, sono un libertino, lo riconosco: ho concepito tutto ciò che si può concepire in questo ambito, ma non ho certamente fatto tutto ciò che ho concepito e non lo farò certamente mai. Sono un libertino, ma non sono un criminale né un assassino». Un ottimo saggio come questo, bello corposo ed esauriente, porta a fare delle riflessioni e suscita molti interrogativi.
In Pasolini e in Sade il sadomaso è anaffettivo, non è mai in funzione dell'amare e dell'essere amati, del soddisfare o dell'essere soddisfatti. Inoltre in Pasolini e in Sade non viene mai pronunciato alcun "i can't" dagli schiavi, come di fatto in pratica avviene. Viene da chiedersi se si può davvero liberarsi della morale come in Pasolini e in Sade oppure se restano sempre dei residui atavici, magari sotto forma di sensi di colpa. Ma bisogna ricordare anche che il sadomasochismo pasoliniano scaturisce dalle limitazioni delle rappresentazioni del sesso all'epoca. Come scriveva Pasolini in "Le belle bandiere": "Io cerco di creare un linguaggio che metta in crisi l'uomo medio, nei suoi rapporti con il linguaggio dei mass media, per esempio".
Nel secondo capitolo viene studiata Porcile. Vengono messi in relazione il nazifascismo e il nuovo capitalismo. Non è un caso che i vecchi ex nazisti nel dopoguerra in America vennero messi ai vertici dei servizi segreti. Viene descritto il carattere di alterità del protagonista Julian. Spinoza discute con Julian della sua Etica, ma alla fine il filosofo abiura la sua opera perché ha prodotto come umanista il padre del protagonista e come tecnocrate il suo socio. Spinoza ammette che la Ragione è sempre ragione del più forte. L'autore sottolinea che per Pasolini la società capitalistica è un macello per uomini e animali. La domanda che sorge spontanea è quale sia il porcile vero? Quello di Julian o quello della società là fuori? Vengono citati anche Derrida, Deleuzee, Guatari, Artaud e il suo corpo senza organi. Nel terzo capitolo vengono paragonati il Calderón di Pasolini, La vita è sogno di Calderón de la Barca, Un sogno di Strindberg. Vengono analizzate la prima Rosaria e l'incesto, la Rosaria prostituta, quella sottoproletaria, quella medioborghese, infine quella prigioniera di un lager. La protagonista è succube del Potere: "obbedisce senza essere obbediente" in un ribellismo confuso ed è al contempo un "vaso semivuoto da riempire con il Bene borghese". Compare anche Enrique, studente sessantottino, che chiede asilo a casa dei borghesi. Ancora l'autore rimarca che tra il corpo e il potere c'è di mezzo un immaginario omologato. Viene da chiedere se ci sia un confine netto tra sogno e realtà. Non solo ma viene descritto "il concentrazionamento del mondo". L'autore dimostra tutta la sua cultura citando l'istituzione totale di Goffman, autore conosciuto dai sociologi in Italia più per il suo rituale dell'interazione e per la perdita di faccia. Bisogna ricordare però che anche nel 1960 Bruno Bettellheim nel Prezzo della vita aveva paragonato la società capitalistica a un sistema totalitario e nel 1964 Paul Goodman in La gioventù assurda aveva paragonato la civiltà dei suoi tempi a una corsa dei topi in una stanza chiusa. Ma perché Pasolini vedeva nel neo-capitalismo un inferno terreno? Una coscienza politica non era possibile perché la televisione aveva imposto l'ideologia del consumo. Ciò che preoccupava Pasolini non era il centralismo dello stato né le istituzioni repressive ma il neolaicismo imperante e il nuovo edonismo propinato dai mass media. Aveva già capito che la televisione era un agente di socializzazione, capace di influenzare con i suoi messaggi le idee delle persone e dunque era anche la causa primaria dell'omologazione, grazie a cui il potere produceva una standardizzazione dell'immaginario. I giovani di borgata avevano iniziato a vestirsi, a comportarsi e a pensare come "i figli di papà": non era più possibile distinguere un proletario da un borghese oppure un comunista da un fascista. Questo era frutto della "mutazione antropologica", termine preso a prestito dalla biologia. La mutazione genetica in biologia è determinata prima dalla variazione e quindi dalla fissazione di alcuni caratteri. Nel caso della "mutazione antropologica" la variazione delle mode e degli stili di vita era decisa nei consigli di amministrazione delle reti televisive e poi fissata con i messaggi subliminali della pubblicità. Pasolini sapeva perfettamente che i codici imposti dalla televisione diventavano subito comportamenti collettivi. La sottocultura di massa diventava interclassista. Tutti aspiravano agli stessi status symbol. Non si trattava più di appagare semplicemente dei desideri. Il nuovo uomo di massa doveva soddisfare dei falsi bisogni. I disvalori del consumismo nel giro di pochi anni impoveriranno l'Italia. Già allora stavano scomparendo le tradizioni di un tempo. Già allora non esistevano più le classi sociali. Tutti ormai erano diventati piccolo-borghesi. Infine è creativo davvero l'accostamento in Pasolini, Calderón de la Barca e Strindberg nel ritenere la nascita una colpa. Dopo questo eccellente saggio viene da chiedersi se Pasolini, che considerava il potere come dominatore del corpo e della sessualità sia datato, se forse aveva ragione Marcuse con la sua desublimazione repressiva: il potere che concede libertà sessuale per ridurre le probabilità di critica e rivoluzione. Quindi in definitiva un saggio da leggere assolutamente. Una lettura critica di questo lavoro è doverosa per pasoliniani e profani, insomma per tutti.
ott 182022

Enrico Brizzi (1974) è uno scrittore bolognese, amante della montagna, delle camminate e della natura. Si è laureato al Dams. Con questo romanzo si è fatto conoscere dal grande pubblico, ma l'autore non ha deluso mai neanche nei libri successivi, nonostante siano meno famosi. Ho letto altri libri e sono stati sempre piacevoli. Leggendo questo libro ci si può far trasportare dalla fantasia e ci può sembrare di camminare sotto i portici bolognesi insieme allo scrittore, ma questo romanzo è anche un tuffo al cuore per chi ha vissuto gli anni Novanta e vuole ricordarli. Oppure quest'opera è anche un modo per far conoscere ai giovanissimi come vivevano e i miti in cui credevano i loro genitori della generazione X.
Trama:
"Jack Frusciante è uscito dal gruppo" è un romanzo generazionale, pubblicato nel 1994. Innanzitutto il titolo è dovuto al fatto che Frusciante dei Red Hot Chili Peppers lasciò il gruppo. Il romanzo non è ideologico e sessuale come "Porci con le ali". Non è trasgressivo come "Altri libertini" di Tondelli, anche se Enrico Brizzi riconosce nello scrittore di Correggio un maestro. Pur avendo anche come punto di riferimento "Il giovane Holden" non è presente in questo romanzo il tour de force del gergo giovanile presente nell'opera di Salinger. Il protagonista Alex è un diciassettenne che frequenta un liceo classico bolognese e si innamora di Adelaide, che però non lo ricambia, anche se tra di loro nasce una tenera amicizia. La ragazza in questione è troppo presa dall'ansia di futuro, dovrebbe andare a studiare in America, non vuole impegnarsi, vuole essere libera e allo stesso tempo non vuole illudere nessuno. Mentre Alex è alle prese con la sua prima delusione sentimentale, si suicida un suo amico, più benestante di lui, più svogliato negli studi e più nichilista. Il suo amico era pieno di ragazze e di amici, era un assiduo frequentatore di discoteche, ma al suo funerale ci sono poche persone perché quel popolo della notte, quegli amici della fauna notturna non lo hanno accompagnato per l'ultimo viaggio e questa è una constatazione di fatto molto amara per il protagonista, che vuole dirci che il sesso facile e il divertimento sfrenato non sono sinonimi di amore e amicizia veri. Il romanzo è colmo di citazioni postmoderne, molto spesso ludiche. Non voglio spoilerare ulteriormente.
Recensione:
Si tratta di uno dei libri più divertenti e spassosi degli anni Novanta in Italia. Brizzi irrompe nel mondo della narrativa con freschezza, originalità, talento. Di solito gli scrittori italiani si perdono nelle descrizioni ossessive o nelle narrazioni minuziose: Brizzi giovanissimo riesce a dosare sapientemente, con maestria, narrazione e descrizione. Pensate che il libro ha venduto più di un milione di copie e persino Umberto Eco lo ha trattato in una sua Bustina di Minerva. Prima di acquistarlo avevo sentito parlare Brizzi al Maurizio Costanzo Show e mi aveva incuriosito. È sicuramente stato molto furbo, intelligente e capace Brizzi ad aver trasformato una cocente delusione amorosa in un libro. Tuttavia il romanzo, anche se mischia cultura bassa e cultura alta, non è commerciale o quantomeno non è stato scritto con l'intento di farne un best seller. Forse l'autore voleva solo scrivere un libro non noioso. Comunque sia, Brizzi ha avuto il merito di scrivere un libro che meglio di molti altri rappresenta la generazione X italiana. Molto azzeccata la scelta di mettere in copertina una bicicletta scassata, come a voler rappresentare una storia giovanile qualsiasi tra persone comuni. In parte mi ricorda anche il film Ovosodo, seppur ci siano delle differenze e nessuno abbia copiato da nessuno. Brizzi colpisce per il suo modo delicato e ironico di raccontare una vicenda adolescenziale agrodolce, ma colpisce anche per le sue sentenze e il fatto di non guardare in faccia nessuno: così scrive a proposito di Adelaide che sono le albechiare che ti fregano e a proposito del cattolicesimo scrive che sono le persone che si mettono in prima fila in chiesa a rovinare la religione cristiana, attaccando quindi frontalmente il perbenismo e la vuota apparenza. Insomma un libro non pretenzioso ma ben scritto, che merita il successo che ha avuto. Un libro quindi da leggere a tutti i costi. È in definitiva un romanzo che punta sulla leggerezza, ma che fa anche riflettere.
ott 182022

(Nella foto Pisa)
Ottiero Ottieri (1924-2002) è stato scrittore, poeta, sociologo e dirigente della Olivetti. È stato un autore importante. Non a caso fu un autore Einaudi. Anche Walter Pedullà nella sua monumentale "Storia della letteratura italiana" tratta Ottieri a più riprese. Il suo romanzo "Donnarumma all'assalto" fu un caso letterario, che trattava della disoccupazione meridionale in contrasto con le rigorose selezioni del personale delle industrie del Nord. Quel romanzo era autobiografico perché Ottieri lavorò alla Olivetti di Pozzuoli. Se da un lato la Olivetti era un'impresa all'avanguardia, dove trovavano impiego i migliori intellettuali e dove nessun dirigente guadagnava più di cinque volte degli operai, dall'altro anche questa azienda non poteva assumere tutti, doveva selezionare e quindi discriminare in un certo qual modo, escludere, compiendo delle ingiustizie umane e sociali. Ma Ottieri riuscì anche a rappresentare le contraddizioni intrinseche dell'alta borghesia, classe sociale a cui lui stesso apparteneva, ad esempio con il racconto lungo "I divini mondani".
Trama
"L'infermiera di Pisa" è un poemetto eccellente, in cui Ottieri tratta del suo ricovero a Pisa perché era maniaco-depressivo. Quando fu scoperta questa patologia Kraepelin la definì psicosi. In realtà oggi è classificato come un semplice disturbo dell'umore e basta appunto uno stabilizzatore dell'umore, assunto quotidianamente, per curare efficacemente i pazienti. Il poeta andò così in cura dallo psichiatra Cassano, dopo essere stato per diverso tempo curato da un analista junghiano inutilmente in Svizzera. Per la cronaca Cassano era uno dei migliori studiosi della depressione ed era uno psichiatra organico, esperto di psicofarmaci. In quest'opera viene narrata l'infatuazione per una infermiera pisana, ma vengono anche descritti gli sbalzi d'umore, gli stati mentali di Ottieri tra citazioni colte, erotismo, invettive, resistenze psicologiche alla cura. Da una parte abbiamo l'amore per l'infermiera e dall'altra abbiamo la neurochimica. Sullo sfondo c'è Pisa con i suoi lungarni, la sua vita di provincia, l'università, le sue scuole di eccellenza. In questo libro vengono perciò trattati in modo esemplare sia l'innamoramento non corrisposto che la sofferenza psichica.
Recensione:
È un libro che consiglio spassionatamente di leggere per chi vuole diventare poeta, ma anche per chi ha molte titubanze a curarsi psichicamente, ad andare da uno specialista. A livello stilistico il poeta si rivela straripante, un vero e proprio fiume in piena, descrive minuziosamente tutto e tutti del suo soggiorno pisano. È un libro che ricorda il grande psichiatra Cassano ma non solo. Ottieri si dimostra un grande poeta, un autore da leggere e da gustare. Dimostra la sua bravura ed è una bravura che non annoia, che non incute soggezione, ma desta continuo interesse, spinge a riflettere. Nella poesia di Ottieri talento e cultura si uniscono armoniosamente, nonostante le sue tare psicologiche, i suoi fantasmi mentali, l'alcolismo e la dipendenza dal sesso. Ottieri non fu creativo grazie ai suoi difetti e ai suoi eccessi, ma nonostante questi. Quello che più stupisce è l'unicità della sua voce inconfondibile, che non fa il verso a nessuno e non somiglia a nessuno. In un mondo sempre meno rappresentabile e in cui sono poche le opere poetiche che ci stupiscono, ebbene questo poemetto spicca ancora oggi a distanza d'anni per la sua originalità, la sua genuinità, miscelate con sapienza da uno degli autori più singolari e versatili del Novecento italiano.
set 062022

Ho un modo di recensire particolare, nel senso che trasgredisco la regola d’oro del recensore, formulata sia da Giovanni Raboni in “La poesia che si fa” che da Massimo Onofri in “Recensire. Istruzioni per l’uso”.
Tengo a sottolineare che sono due libri molto importanti per iniziare a recensire, ma secondo questi due grandi letterati ad artista non di deve aggiungere artista (secondo un adagio degli antichi latini), ovvero un recensore deve essere sottotono, deve mantenere un profilo basso e nel testo deve vigere l’understatement.
Io ritengo piuttosto che una recensione debba spiegare tutto, essere esaustiva o quantomeno cercare di essere esauriente.
Forse così si rischia di strabordare. Nel primo caso invece si rischia di fare un compitino striminzito.
E poi a mio modesto avviso per capire cosa voleva dire un poeta bisogna un poco immedesimarsi nel poeta in questione ed essere di volta in volta un poco artisti anche noi miseri recensori. Ma è solo questione di opinioni. So benissimo che Onofri e Raboni sono delle autorità in materia e io sono un bastian contrario. Ma passiamo ad altro. Alcune volte mi arrivano dei documenti pdf da recensire via mail oppure dei libri a casa.
Sgombro il campo da ogni equivoco: non esiste assolutamente l’obbligo di recensire nessuno. Alcuni ritengono che tutto sia loro dovuto. Anche se mi arriva un ottimo libro non è mio dovere recensirlo: sia ben chiaro. Io non sono pagato a cottimo. È una bella pretesa! Alcuni sono anche molto sbrigativi e si scordano le belle maniere, ma questo fa parte della personalità egoriferita di alcuni autori.
Personalmente io non cerco lo scambio di favori. Non scrivo più poesie o presunte tali dal 2018. Quindi nessun do ut des! Non cerco recensioni incrociate. Tutto questo mi consente una maggiore obiettività e indipendenza, non scrivendo più poesie.
Alcuni potrebbero criticarmi per il fatto che scrivo recensioni in cui esprimo un giudizio positivo sul libro. Ma è solo una parte della verità. Diciamo piuttosto che io non voglio stroncare nessuno e quindi non pubblico mai stroncature.

Perché non stronco? Semplicemente perché onestamente non mi va. Inoltre ritengo che si debba avere una certa autorità per farla e io ne sono sprovvisto. Non solo ma esiste una regola non scritta secondo cui si stronca solo i big. So bene anche che ogni autore si sente padre della sua opera. Penso che una stroncatura sia più che un atto di lesa maestà (di cui mi importa poco) un vero colpo al cuore, una piccola ferita. Diciamocelo francamente: non voglio far rimanere male nessuno. Di conseguenza alcuni pensano che io sia facile di gusti o che tratti tutti i libri con bonaria indulgenza. Nella maggioranza dei casi io recensisco invece libri di qualità, ma questa è solo la parte emersa dell’iceberg: nessuno sa i libri e i documenti via mail che mi hanno inviato e che non ho recensito. Al momento mi sono anche imposto di recensire solo libri pubblicati e non autopubblicati, libri cartacei e non ebook (altrimenti non ce la farei a recensire tutto). Preferisco quindi non recensire che recensire negativamente. Non solo ma Giovanna Rosadini, direttrice di Atelier poesia, fa una scrematura di opere prima di inviarmi le cose da recensire.
È comunque vero che preferisco evidenziare i punti di forza di un’opera invece che i punti deboli. Ritengo in questo modo di spronare, di incoraggiare l’autore. Ma recensire è un diritto e non un dovere. Inoltre rivendico l’orgoglio di recensire. Tutti vogliono diventare scrittori o poeti, vogliono la fama, la gloria postuma. Il recensore invece è relegato ai margini della vita letteraria, eppure i libri vanno obbligatoriamente recensiti, altrimenti li leggerebbero in molti meno e non ci sarebbe alcun passaparola tra i lettori. Anzi forse è il caso di dire che al mondo d’oggi ci sono troppi poeti effettivi, aspiranti, sedicenti e davvero pochi recensori. Sempre a mio modesto avviso un recensore non deve essere obbligatoriamente un critico letterario e aver letto migliaia di libri come vorrebbe Valerio Magrelli. Un recensore deve solo avere un minimo di sensibilità, un minimo di comprensione del testo e sapere un minimo la lingua italiana. Questi sono i prerequisiti fondamentali. Aggiungo anche che se ogni lettore diventasse un recensore nel suo blog personale o sui profili social ne guadagnerebbe il lettore suddetto che eserciterebbe il suo senso critico e ne guadagnerebbe la letteratura che diventerebbe un grande oggetto di attenzione, un argomento di tendenza, di dibattito e non più un fenomeno marginale. Se ci fossero più lettori-recensori certo ci sarebbe qualcuno di essi che rientrerebbe nella categoria degli odiatori, ma la letteratura sarebbe più rizomatica, meno stagnante, insomma più viva. Infine va detto che anche se a nessun recensore spetta la gloria postuma a differenza dei poeti qualcosa possono guadagnare se lo vogliono. Qualche agenzia letteraria i recensori li può pagare; ci sono autori disposti a pagare recensori. Infine recensire libri può essere un primo passo per fare il saggista, il giornalista culturale o il web content editor (coloro che a pagamento riempiono di contenuti i siti web). Non solo ma c’è anche chi si inventa un’attività redditizia recensendo libri su Instagram, anche se ci riescono solo i giovani e non i letterati attempati. Nel peggiore dei casi arrivano gratis dei libri a casa, anche se le ore passate a leggere il libro e a recensire non vengono pagate.
lug 272022
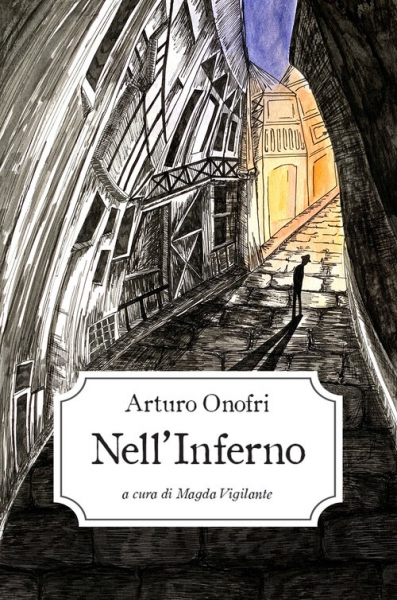
Questi tre racconti, editi in un volume dalla Pandilettere, di Arturo Onofri, poeta metafisico e scrittore (1885-1928) rappresentano a mio modesto avviso delle autentiche rivelazioni. Non lo scrivo per essere celebrativo perché Onofri è un letterato memorabile, che ha in modo inequivocabile segnato il '900 per l'originalità e la qualità della sua scrittura. Dell'importanza di Onofri ne è la controprova che una esperta italianista come Magda Vigilante ha dedicato una prefazione di quaranta pagine, facendo una disamina accurata dei racconti. Cercherò quindi di fare una breve rassegna di questo libro, spoilerando il meno possibile per non togliere istinto di acquisizione e gusto della lettura. Farò delle considerazioni di carattere personale, senza parlare della sua vita, del suo apprendistato, delle sue frequentazioni e delle sue collaborazioni con le riviste letterarie. Il primo racconto si intitola "Il pollice esercitato" (che sta a significare il talento coltivato) e tratta il tema della creazione artistica e della ispirazione con tutte le difficoltà del caso (la creta non è mai molle, indipendentemente dal fatto che si cerchi la mimesi, la trasfigurazione, la creazione ex novo). Come ci ricorda la Vigilante le idee in questione non sono quelle dell'Iperuranio, ma sono spiritelli maligni. Forse il poeta vuole suggerirci che la vera creatività spetta alle donne oppure solo a madre natura: forse solo loro hanno la vera capacità di generare. Le stesse idee sono signore algide e scostanti. Ho letto recentemente che le idee veramente innovative e originali scaturirebbero in modo casuale secondo i neuroscienziati e che addirittura la loro frequenza potrebbe essere descritta dalla distribuzione statistica di Poisson: semplificando ogni idea sarebbe un evento raro e fortuito nelle menti più creative. Ecco quindi la fatica di Sisifo della creazione artistica. Insomma Onofri aveva anticipato i tempi. Il secondo intitolato "I due" mette in scena sia il tema del doppio che quello psicologico del falso Sé (più che dell'Ombra junghiana a mio modesto avviso). Alla fine viene da chiedersi chi sia il personaggio autentico, se la figura in carne e ossa oppure il sembiante. Uno è il Sé autentico e l'altro è la maschera sociale, colui che rispetta codici e convenzioni borghesi. Il terzo intitolato "Inferno" esamina il perturbante in senso freudiano. Il protagonista prova allo stesso tempo repulsione e attrazione verso la donna, descritta inizialmente come orrida. Il lettore viene spiazzato più volte con alcuni straniamenti, con alcuni colpi di scena. Perché una scena sia effettivamente perturbante per Freud deve essere ambivalente emotivamente, deve essere familiare ed estranea al contempo. Onofri si dimostra un artista enigmatico, simbolista, decadente, esoterico (non a caso studiò l'antroposofia steineriana) in questi tre racconti, a cui lasciamo libera interpretazione agli acquirenti del volume; in questa sede ho voluto solo dare delle indicazioni di massima. D'altronde l'arte si caratterizza per la sua polisemia e ambiguità. Ognuno quindi può dargli il suo significato. Posso solo affermare che Onofri nei suoi racconti accosta elevazione spirituale e spavento, grazia e solitudine, levità ed angoscia, orfismo e scissione, purezza e terribilità. Sulla scena si affaccia prepotente il mistero, l'irrazionale sotto la forma di ossessione, di paura. Senza mai cadere nell'intimismo c'è una propensione innata alla penetrazione psicologica. Sono ineludibili lo sgomento e la sorpresa dei protagonisti, che sono tra la veglia e il sonno, quasi in uno stato di reverie e hanno delle apparizioni sconvolgenti. Onofri dà forma al materiale informe dell'onirico. Getta un ponte tra conscio e inconscio, trovando archetipi senza scandagliare oscenamente i segreti recessi dell'anima. Lavora di cesello e l'oscuro non è mai incoerente né incongruo. La sua prosa -per quanto subisce echi, risonanze, influssi- è suggestiva e mai suggestionata da nessun altro autore. Centrali sono le visioni e le analogie di Onofri. Non imita né prende a prestito alcunché. Piuttosto si rifà sporadicamente ed episodicamente alla tradizione. Per dirla alla Peirce il poeta era mosso da autentico amore per la conoscenza, era all'instancabile ricerca della verità. Non è forse un caso che amò diverse dottrine, ma non divenne mai dottrinario? E ora veniamo all'inghippo: quella di Onofri è una prosa poetica? E ancora si può cercare un discrimine tra poesia e prosa poetica?

Voglio sgomberare il campo da ogni possibile fraintendimento: è impossibile a mio avviso fare una distinzione oggettiva tra poesie in versi e prose poetiche. Di distinzioni se ne possono fare ma sono solo soggettive e a mio avviso stucchevoli. Mi auguro che non lo si faccia per faziosità o per partito preso. È sempre arduo stabilire una relazione tra prosa e poesia oppure una linea di confine. C'è chi sostiene che non vi sia più una grande differenza tra i due generi e che per vendere più copie molti poeti farebbero meglio a non andare a capo. Ricordo a tutti che condannare la prosa poetica può voler dire giudicare negativamente i capolavori di Pagliarani e Bertolucci. Perché condannare un certo ibridismo? Per quale motivo? Inoltre ricordatevi che per i puristi del verso scrivere in versi liberi significa andare a capo arbitrariamente ed è considerato alla stessa stregua dello scrivere in prosa. Il verso libero è il lasciapassare e allo stesso tempo la diretta conseguenza della prosa poetica. È meglio non mettere steccati e paletti. Nel secondo Novecento non l'hanno fatto. A mio avviso è lecito scrivere in ogni modo. È sempre meglio non fare restrizioni di nessuna sorta e permettere ogni tipo di libertà. Preferisco per quel che mi riguarda essere onnicomprensivo e inclusivo ai massimi livelli. Un poeta può dimostrare la propria versatilità e scrivere in ogni modo: Onofri ne è stato l'esempio lampante e ha dimostrato tutta la sua versatilità. Un poeta deve avere sempre la massima libertà espressiva. Di conseguenza può utilizzare qualsiasi registro espressivo, che deve essere considerato comunque espressione artistica. Può anche adottare il pluristilismo. La poesia in versi liberi può essere a mio avviso poesia come, anche la prosa poetica può essere allo stesso tempo poesia. Tutto il resto è polemica sterile fatta per amor della polemica. Personalmente non cerco ossessivamente come fanno taluni una linea di demarcazione tra poesia e non poesia. Cerco solo di distinguere solo ciò che mi emoziona da ciò che non lo fa, ciò che mi fa pensare da ciò che non lo fa. I tre racconti di Onofri mi hanno colpito favorevolmente, mi hanno emozionato. Una cosa che contraddistingue la sua scrittura è il fatto che, nonostante le innumerevoli variazioni della lingua italiana dagli anni di stesura a oggi, essa sia ancora comprensibile e chiara senza l'ausilio di alcuna nota: ciò dimostra la capacità comunicativa dell'Onofri. Quella del poeta romano è a ogni modo una prosa lirica, è quella che un tempo veniva chiamata prosa d'arte. Per tutte queste ragioni il volume meriterebbe di essere letto.
lug 232022

"Il mondo di ieri" di Stefan Zweig, scrittore austriaco ebreo di successo negli anni '20 del Novecento, è un'autobiografia illuminante, che fa piena luce sia sulla sua vita che sulla sua epoca. Il libro è caratterizzato da riflessioni e ricordi, intesi in senso guicciardiniano. Il libro fu scritto tra il 1939 ed il 1941 in Brasile, dove l'autore si era rifugiato. Si possono rintracciare aforismi, massime, avvertimenti, però a differenza del segretario fiorentino, Zweig non si impegna nella scrittura breve, non è discontinuo né frammentario, anzi è un accumulatore seriale di aneddoti e ricordi, pur tuttavia sempre racchiusi in una forma organica, lineare e razionale. L'opera si legge tutta di un fiato. Lo scrittore riesce sempre a ravvivare e ridestare l'interesse nel lettore, non perdendosi mai in intellettualismi e senza scadere mai in digressioni prolisse. Zweig fa un affresco memorabile dell'impero austro-ungarico e della sua caduta; lo fa a pieno diritto, visto e considerato che è stato un rappresentante di alta levatura della cultura mitteleuropea. In Europa fu un autore molto letto. Zweig inizia col descrivere la sua infanzia a Vienna. Definisce la scuola una galera, a causa della disciplina ferrea vittoriana che determinava molti "complessi di inferiorità". In quella Vienna la massima aspirazione delle famiglie borghesi non era che i loro figli si arricchissero ulteriormente ma che diventassero dottori. Molti bambini e adolescenti volevano diventare artisti. Allo stesso modo l'educazione era molto rigida e impostata. I doveri avevano la priorità assoluta sui diritti. I ragazzi avevano come modelli dei maestri di pensiero, prima di tutto rispettabili. La sessualità era un tabù. Era un'attività da non mettere in mostra e un argomento di cui non parlare. L'erotismo in quella società sessuofobica era tutto nascosto e adulterato o almeno mistificato. Ma allo stesso tempo per un meccanismo di compensazione quella era in Austria anche l'epoca della sicurezza. Era la Felix Austria. Era la Belle Époque. Era la società del liberalismo e del progresso, delle "magnifiche sorti e progressive". Zweig proveniva da famiglia agiata ed ebbe la fortuna sia di poter andare all'università che di scegliere la facoltà, cose non affatto scontate a quei tempi. Scelse filosofia, ebbe modo anche di pubblicare le prime poesie e di conoscere Herzl, fondatore del sionismo. Poi il 28 giugno 1914 Princip, uno studente serbo, assassinò l'erede al trono asburgico. Come scrive Zweig erano stati 40 anni di pace e poi era sopraggiunta all'improvviso la guerra. Molto fuoco covava sotto la cenere. L'equilibrio in Europa era precario. C'erano molte tensioni di varia natura (economica, politica, sociale, ideologica). Iniziarono gli sconvolgimenti, gli eccidi, gli orrori. Come ci racconta Zweig i soldati al fronte morivano, mentre gli altoborghesi imboscati se la spassavano in patria. I superpatrioti ce l'avevano con lui che era pacifista. Ma lo scrittore era impegnato lo stesso perché aveva la coscienza e l'esatta percezione di quanto fosse importante il parere e la presa di posizione di un letterato o di un artista a quei tempi, mentre come sottolinea molto lucidamente nella seconda guerra mondiale gli intellettuali erano ormai fuorigioco e ininfluenti. Finita l'università si trasferisce a Parigi. Zweig descrive con nostalgia la capitale francese, una città cosmopolita per eccellenza, e scrive che sulla Senna ognuno si sentiva a casa propria. Racconta anche i suoi viaggi, che lui definisce "pellegrinaggi". Un artista, per essere tale, deve avere frequentazioni con giganti intellettuali e lui ebbe molti incontri con geni come Rilke, Harden, Richard Strauss, Herzl, Romain Rolland, Pirandello, Freud, Dalì. Riconobbe nella Svizzera un modello per tutti per la civiltà e l'accoglienza, dato che in terra elvetica trovavano rifugio tutti i perseguitati. Allo stesso modo ci descrive gli Stati Uniti come il paese in cui ci sono più libertà ma anche più opportunità, visto che in pochi giorni gli offrono ben cinque impieghi. Inoltre descrive il periodo londinese, che va dal 1934 al 1940.
altmann-zweigandrothinostendin1936(cropped)1_0_o.jpg)
Zweig dagli anni '20 era uno scrittore noto al grande pubblico. I suoi libri vendevano molto. Aveva ottime entrature nell'alta società, anche se tutto ciò non lo interessava granché. Conosceva tutti gli scrittori, gli editori, i direttori di riviste che contavano in Europa. Eppure fece naufragio perché si suicidò in Brasile insieme alla moglie. Nonostante il suo successo personale aveva vissuto anche troppo orrore per la guerra, la crisi dell'Austria, che non aveva più fabbriche, era povera e la cui banca nazionale era senza più oro, tutti segni di una miseria inenarrabile e della fine di un'epoca felice. Ma non c'è solo questo: Zweig aveva assistito anche all'ascesa di quel folle di Hitler. Gliene avevano parlato già all'epoca in cui istitgava all'odio i bavaresi nelle birrerie. Aveva avuto modo di constatare la follia di Hitler, che aveva saputo approfittarsi della difficile situazione in cui versava la Germania in quegli anni, obbligata a pagare una indennità di guerra incredibile. Hitler si approfittò di una Germania umiliata e colse la palla al balzo, coniugando necrofilia, imitazione del fascismo, antisemitismo, anticomunismo, sadismo e crudeltà infinita. Zweig era un intellettuale così lucido che si era accorto del pericolo. Cosí come probabilmente forse si era accorto della "banalità del male" del popolo tedesco. Date queste premesse la fine di Zweig era quasi scontata.
lug 082022
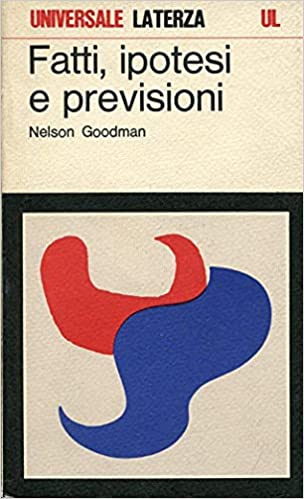
Riporto testualmente dal sito www.platon.it: “Paradosso di Goodman (o degli “smeraldi blerdi”): data una certa proprietà contraddistinta da una variazione dopo una certa data (l’essere blerde, ossia verde fino a una certa data, quindi blu), per quante osservazioni io faccia relative a oggetti che sembrano godere della stessa proprietà senza variazione (p.e. smeraldi verdi), non posso mai escludere che questi stessi oggetti godano della proprietà con variazione (siano smeraldi blerdi); in particolare, aumentando i casi confermativi, aumenterebbero sempre nello stesso modo sia la probabilità di registrare la proprietà senza variazione (smeraldi verdi), sia la probabilità di registrare la proprietà con variazione (smeraldi blerdi)”.
N. B: la stessa cosa si può dire del vlu.

E ora ecco le mie considerazioni:
Secondo il paradosso di Goodman dobbiamo considerare un nuovo predicato: il vlu. Mettiamo di applicare questo predicato a uno smeraldo. Uno smeraldo vlu è uno smeraldo, che fino al tempo t è verde e dopo il tempo t diviene blu. Mettiamo che alcuni individui credano che gli smeraldi dopo il 2030 diventeranno blu. Mettiamo che io non creda a questa loro affermazione. Allora io posso formulare due ipotesi opposte per ciò che accadrà dopo il 2030: “tutti gli smeraldi restano verdi” oppure “tutti gli smeraldi sono vlu”. Tutte e due le ipotesi sono possibili, quindi nessuna è meglio dell’altra. Da un certo punto di vista potremmo affermare che si equivalgano. Il problema che ne consegue è che se le due ipotesi si equivalgono anche il verde e il vlu si equivalgono. Quindi io potrei adoprare il vlu ogni volta che voglio. Il linguaggio finirebbe per diventare vlu. Voi vi chiederete: perché mai gli smeraldi, che sono tutti verdi e che sono sempre stati verdi, dovrebbero cambiare colore? Mettiamo per assurdo che dopo il 2030 cambi la struttura del mondo fisico, oppure cambi il nostro sistema nervoso (e quindi anche le nostre percezioni e i nostri stati mentali) oppure che lo smeraldo per qualsiasi motivo emetta un’altra lunghezza d’onda. Comunque sia…. noi - secondo il filosofo Goodman - possiamo fare due previsioni. Come mai noi consideriamo più probabile (più “proiettabile”) l’ipotesi che tutti gli smeraldi siano verdi piuttosto che l’ipotesi che tutti gli smeraldi siano vlu? Ora io farò delle semplici osservazioni da uomo comune e non da filosofo (perché naturalmente non sono filosofo). Io so che per gli smeraldi l’essere verde è una proprietà, che considero permanente di quell’oggetto. Se uno smeraldo cambia colore - potrei anche affermare - che non posso più considerarlo uno smeraldo, piuttosto un nuovo oggetto. Un nuovo oggetto, che avrà bisogno di un altro nome. In modo molto semplice: Goodman dà un nuovo nome al colore in base ai cambiamenti nel tempo, mentre si dovrebbe dare solo un nuovo nome all’oggetto. Poniamo il seguente principio: quando la proprietà (ritenuta prima permanente e inalterabile) di un oggetto viene modificata non bisogna etichettare in modo nuovo il predicato che descrive la proprietà di quell’oggetto in base ai possibili cambiamenti nel tempo, ma bisogna considerare che quell’oggetto sia un nuovo oggetto e necessiti di un nuovo nome. Il paradosso di Goodman, se seguissimo questo principio, esisterebbe ancora? Resterebbe comunque una domanda: perché dobbiamo utilizzare per forza questo principio? Ma veniamo di restare nella realtà e di non fare astrazioni campate per aria. L’acqua a 0 gradi oppure al di sotto diventa ghiaccio, mentre invece in condizioni normali (alla pressione di 1 atmosfera) vaporizza alla temperatura di 100 gradi. Sappiamo che ciò dipende dallo stato fisico della materia. Sappiamo quindi che lo stato fisico della materia (e quindi anche dell’acqua) può cambiare. Nella realtà io non utilizzo predicati come acqua-ghiaccio o come acqua-vapore per indicare l’acqua che è diventata ghiaccio o per indicare l’acqua che è diventata vapore. Non utilizzo aggettivi- definiamoli- “deciduali”. Altrimenti sarei costretto ogni volta per l’acqua ad utilizzare un aggettivo (predicato) come acqua-ghiaccio-vapore perché c’è la possibilità che l’acqua a certe condizioni possa diventare ghiaccio e ad altre condizioni possa diventare vapore. Noi invece sappiamo che lo stato fisico dell’acqua cambia, ma non utilizziamo un linguaggio “deciduale” (come le foglie. Mi riferisco all’esempio di Piattelli Palmarini) per definire lo stato fisico dell’acqua. Semplicemente cambiamo nome all’oggetto quando la proprietà di quell’oggetto non è permanente, costante. Facciamo un altro esempio. Consideriamo l’animale dal colore più mutevole (e diciamo più “deciduale”) del mondo: il camaleonte. Che cosa caratterizza il camaleonte? Potremmo dire: gli occhi grandi, la lingua che si può ritirare in qualsiasi momento, il fatto di cambiare colore in base all’ambiente. Queste sono le caratteristiche ritenute costanti di quest’animale. Per le nostre menti le proprietà permanenti di un oggetto o di un soggetto sono le proprietà, che caratterizzano quell’oggetto. Qualcuno potrebbe chiedere il perché. Non lo so. Io so solo che quelle proprietà ritenute costanti lo distinguono dagli altri oggetti. Ma il problema è che se io mi imbattessi in un animale, che ha tutte le caratteristiche fisiche di un camaleonte e non cambia più il colore in base al colore dell’ambiente, non potrei più considerarlo un camaleonte. Semplicemente: sarebbe un altro animale. Se la proprietà ritenuta permanente di un oggetto cambia allora cambia anche l’oggetto (o il soggetto) e perciò cambia anche la definizione di quell’oggetto. Se quell’oggetto è diventato un altro oggetto è chiaro che ha bisogno di un nuovo nome, di nuovi predicati, di una nuova definizione. Se facciamo in questo modo (e nella realtà facciamo in questo modo) il paradosso di Goodman diventa più semplice. Ci sono sempre due ipotesi: 1) quell’oggetto (lo smeraldo) subirà una trasformazione (oppure la realtà oppure il soggetto conoscente) e diventerà (oppure verrà considerato dal soggetto) un altro oggetto. 2) quell’oggetto (lo smeraldo) non subirà trasformazioni e resterà lo stesso. E’ un problema di semplice convenzionalismo linguistico? Quello che Goodman chiama “trinceramento” è soprattutto un fatto derivante dalle convenzioni linguistiche? Il problema che si pone è: perché non possiamo utilizzare predicati “deciduali” e un linguaggio “deciduale”? Perché il verde va sempre preferito al vlu? Se io ammetto il vlu, cioè ammetto un aggettivo “deciduale” allora ammetto che qualsiasi predicato possa essere “deciduale”. Permetto quindi che tutto il linguaggio possa essere “deciduale”. Ma un linguaggio “deciduale” non è una semplice foglia, che cade per terra. E’ l’intera conoscenza umana, che cade nel nulla. Alcuni sostengono che il paradosso di Goodman sia una riformulazione più elaborata del vecchio problema di Hume sull’induzione. Secondo Hume gli uomini facevano delle inferenze in virtù di “uso e abitudine”. Potremmo oggi parlare di innatismo e di intersoggettività. Ma è lo stesso. Detto in parole povere: data una mole di osservazioni io ho bisogno di individuare delle proprietà costanti dagli oggetti per poi successivamente classificarli e definirli. I problemi sembrerebbero quindi due: come io giungo all’inferenza e come passo dall’inferenza alla classificazione. In questo senso in filosofia dal “tacchino induttivista” di Russell oggi sono passati al “tacchino anti-induttivista” di Goodman. Ma non c’è solo questo. Il tacchino di Goodman è anche un tacchino anti-classificatorio. Io ragiono come l’uomo della strada, anzi sono l’uomo della strada. Allora mi chiedo molto semplicemente una cosa. Se io ammetto il vlu posso anche dare un nome a ogni singolo oggetto? Se io ammetto il vlu tutto è possibile nel linguaggio. Il linguaggio diventa eracliteo. Ogni elemento del linguaggio potrà variare in base al fattore tempo o in base a qualsiasi altro fattore. Alcuni studiosi hanno pensato che il paradosso di Goodman dipendesse esclusivamente dal tempo, ma a mio avviso non è così. Il fattore tempo è solo un pretesto. Comunque se accettassimo tutti universalmente il concetto di vlu non ci sarebbero più limiti. Finiremo quindi per dare un nome anche ad ogni singola sedia o ogni nostro stato mentale. Sorge spontanea una domanda: perché io ogni sedia la chiamo sedia e non scelgo un nome specifico per ogni singola sedia? Ora mi posso chiedere: perché classifico gli oggetti? Probabilmente ho bisogno di classificare gli oggetti per i limiti della memoria umana, per economia di tempo e di risorse cognitive, per non avere rappresentazioni mentali offuscate, per vivere la vita e non per passare tutta la vita a nominare oggetti. Se io ammettessi che qualsiasi proprietà di un oggetto ( o soggetto) possa essere definita in base ai cambiamenti passati, attuali futuri (o possibili) francamente passerei tutta la vita immobile nel letto soltanto a definire sempre tutti i miei umori e i miei stati mentali. Non ci può essere una corrispondenza totale tra linguaggio e realtà. Per motivi di tempo e di risparmio di energia abbiamo sempre bisogno di etichettare, catalogare, generalizzare. Ma perché ho parlato di tacchino anti-classificatorio di Goodman? Prendiamo ad esempio il noto paradosso del mentitore. Epimenide di Creta sostiene che “tutti i cretesi sono bugiardi”. Essendo cretese Epimenide è bugiardo e sta dicendo il falso. Oppure Epimenide sta dicendo il vero, ma essendo anch’egli cretese l’affermazione è falsa perché allora non tutti i cretesi sono bugiardi. Nel celebre paradosso del mentitore il soggetto contraddice se stesso o il predicato. Ma perché? Perché in fondo predica se stesso. Nel paradosso di Goodman non è il soggetto a “mentire” (diciamo così). E’ piuttosto il predicato a mentire. Ci sono infatti due alternative: 1) se una proprietà costante degli smeraldi è di essere verde non potranno mai essere blu. Quindi in questo caso è il concetto di vlu che si autocontraddice. 2) se lo smeraldo, che viene definito come tale in base alla proprietà costante dell’essere verde, diventa blu non è uno smeraldo. Quindi in questo caso il predicato sembra contraddire il soggetto della proposizione. Il predicato quindi annulla la proprietà interna del soggetto.
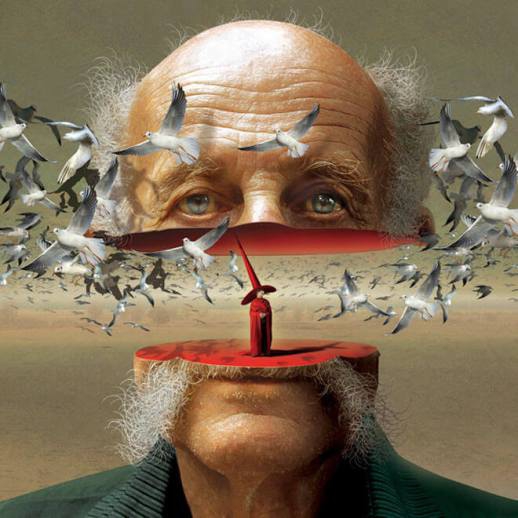
Fino ad oggi il colore dello smeraldo ha sempre denotato lo smeraldo e lo smeraldo è sempre stato definito anche in base al colore. Ma cosa posso fare se gli smeraldi diventano blu dopo il 2030? Posso ridefinire il soggetto della proposizione successivamente e dare un nuovo nome al nuovo tipo di smeraldo. La domanda allora è: posso considerare un nuovo tipo di smeraldo (che non è più verde) e considerarlo un altro oggetto e dargli un altro nome. Sì. Io posso. L’umanità può. Può incessantemente costruire logicamente e verbalmente in modo nuovo la realtà. Perché quindi devo preferire il “vlu” (che porta all’anarchia linguistica) quando posso costruire in modo logico e verbale nuovi oggetti mentali? E poi posso considerare sempre in modo probabilistico le proprietà ritenute costanti degli oggetti o dei soggetti. Se l’umanità accettasse (e quindi estendesse) il vlu a tutte le proprietà e a tutti gli oggetti non ci sarebbe più alcuna classe. Non ci sarebbero nemmeno più gli insiemi in matematica. Russell definiva gli stessi numeri delle “proprietà di classi”. Alcuni studiosi sostengono che ci sia una certa parentela tra il paradosso di Goodman e il paradosso del corvo di Hempel. Secondo quest’ultimo paradosso le cose non nere confermano il fatto che tutti i corvi siano neri. E’ esclusivamente un problema di induzione. In fin dei conti questo paradosso filosofico ci insegna a chiederci: perché facciamo inferenze soltanto sui corvi e non sulle cose che non sono corvi? Alcuni filosofi hanno ragionevolmente pensato che sia dovuto al fatto che l’insieme dei corvi è molto inferiore rispetto all’insieme dei non-corvi. Inoltre mi chiedo molto semplicemente a proposito di questo paradosso: perché le cose non nere devono per forza confermare il fatto che tutti i corvi sono neri? Quello che voglio dire è che alla fin fine non dovremmo chiederci solo perché facciamo inferenze nel dominio di quell’oggetto di indagine, ma anche perché ogni volta che facciamo un’inferenza non cambiamo oggetto di indagine. E’ una domanda scontata. Ma a mio avviso è una domanda scontata anche chiederci perché osserviamo solo corvi quando vogliamo confermare l’ipotesi “tutti i corvi sono neri”. Vlu in fin dei conti significa semplicemente “prima verde e dopo un periodo stabilito blu”. Potrei sostenere semplicemente che il paradosso di Goodman porta a una situazione indecidibile perché gli aggettivi in qualsiasi lingua umana non sono caratterizzati da un istante t (che determina il cambiamento di questo o quello oggetto). Si può però dire che un oggetto è mutevole. L’aggettivo “mutevole” indica genericamente che quell’oggetto può subire dei cambiamenti o delle trasformazioni nel tempo. Mutevole però indica una qualità dell’oggetto. Ci dice che genericamente quell’oggetto cambia sempre. Il vlu invece ci dice che quell’oggetto dopo un certo istante t da verde diventerà blu. Ci dà due informazioni precise. Nessuna lingua umana contempla un aggettivo, che sia predittivo ed esatto. Inoltre un unico aggettivo ci dà due informazioni: quell’oggetto fino ad un certo istante t sarà verde e poi diventerà blu. Pensiamo per un attimo a quanti concetti e a quante relazioni ci vogliono per definire il vlu. Ci vuole il concetto di cambiamento, il concetto di colore, la definizione di verde, la definizione di blu, il concetto di tempo, l’avverbio di tempo “prima”, l’avverbio di tempo “dopo”, la conoscenza dell’istante t, la relazione tra il colore verde e l’avverbio di tempo “prima”, la relazione tra il colore blu e l’avverbio di tempo “dopo”. L’aggettivo “mutevole” invece richiede solo due concetti: il cambiamento e la forma. Potremmo quindi ritenere che nell’aggettivo vlu ci sia un eccesso di senso, un surplus di informazioni. Gli aggettivi qualificativi di solito sono più vaghi. Almeno nella lingua italiana ci forniscono la qualità di un oggetto o di un soggetto. Niente altro. Se si vuole fare una frase di senso compiuto comprendendo anche il tempo - è banale dirlo - utilizziamo gli avverbi di tempo e non gli aggettivi. Il vlu è un concentrato di concetti. Nasce da un paradosso linguistico perché almeno nella lingua italiana è un aggettivo (il vlu), che comprende anche due avverbi di tempo e altre cose. Allora bisogna chiedersi perché utilizziamo gli avverbi di tempo e non il vlu? Facciamo così, parliamo così. Probabilmente per economizzare le nostre risorse cognitive. Probabilmente se dovessimo estendere il vlu a ogni qualità e a ogni colore e a ogni trasformazione la nostra memoria a breve termine andrebbe a fottersi. E’ così in italiano, ma è così anche in tutte le altre lingue. Non solo ma se io ammetto il vlu ammetto anche il ble. Infatti dopo che quell’istante t l’oggetto che prima era verde ora è blu, ma io devo anche presupporre che in futuro possa ridiventare verde e quindi devo ammettere anche il ble (il blu che dopo un istante t diventerà verde). Se io accetto il ble accetto anche il giasso (il giallo che prima era giallo e dopo un certo istante è diventato rosso). E così all’infinito. Ma per economia delle risorse cognitive umane nessuno si sogna di utilizzare aggettivi, che tengano conto di tutti i cambiamenti della realtà e di tutti gli istanti esatti in cui avvengono questi mutamenti. Il problema di Goodman è quindi solo di natura semantica? Assolutamente no. Se io accetto il vlu accetto non solo le proposizioni scaturite dal paradosso del mentitore (del tipo: “questa frase non è vera”), ma sono costretto ad accettare anche proposizioni come “questa proposizione è vera-falsa” oppure proposizioni come “questa proposizione è vera-falsa-priva di significato” oppure come “questa proposizione è bella-brutta”. Perché restino in piedi le classi e le classi delle classi bisogna estromettere dalle classi delle proposizioni quelle derivanti da concetti come quello di vlu. Alcuni studiosi potrebbero parlare di gerarchie linguistiche tra predicato e soggetto, altri di metalinguaggio. Russell sosteneva che paradossi come la sua antinomia e il paradosso del mentitore fossero determinati da quella che definiva una circolarità viziosa. Può darsi che anche il paradosso di Goodman dipenda da una circolarità viziosa. Non lo so con certezza. Per i filosofi medievali non esistevano questi paradossi e non esistevano quindi tutte le implicazioni annesse e connesse. Loro le consideravano senza significato. Comunque sia nel paradosso di Goodman è presente il fattore tempo (quell’istante t in cui avviene il mutamento della qualità dell’oggetto). Ma potremmo anche cambiare e considerare il fattore spazio: ad esempio un oggetto che in casa mia è verde e fuori dalla mia casa è blu. Anche in questo caso abbiamo il famigerato vlu. Anche in questo caso compaiono due ipotesi: il verde e il vlu. Ecco perché sostengo che il fattore tempo è solo un pretesto. Nell’induzione le osservazioni possono dipendere dal tempo, ma anche dallo spazio. Visto che possiamo ipotizzare e fare qualsiasi cosa nel mondo filosofico di Goodman allora possiamo pensare che le osservazioni (e l’induzione) possono dipendere da infiniti elementi. L’importante è che ci sia il cambiamento della proprietà dell’oggetto di indagine. Ci vuole questo per fare il paradosso di Goodman e per farne altre varianti. Il paradosso di Goodman si basa sull’ipotesi riguardo alla proprietà (ritenuta costante) di un oggetto. E non riguarda solo il fatto in sé (l’osservazione), ma riguarda anche come siamo fatti noi esseri umani (come percepiamo, interpretiamo e nominiamo il mondo là fuori). Il paradosso di Goodman ci dice che prima della formulazione di quell’ipotesi abbiamo osservato la realtà, abbiamo fatto delle inferenze, abbiamo individuato delle proprietà costanti di un oggetto, abbiamo fatto una classificazione successiva, abbiamo nominato e definito l’oggetto. Dopo aver fatto queste cose ora possiamo fare un’ipotesi. Dopo l’istante t se gli smeraldi saranno vlu noi faremo le nostre osservazioni, faremmo delle nuove inferenza (osserveremo mille smeraldi vlu e concluderemo che tutti gli smeraldi sono vlu), individueremo delle proprietà costanti di un oggetto, faremo una nuova classificazione (in cui per forza di cosa gli smeraldi saranno tali se sono blu). Comunque da che cosa è composto dal punto di vista epistemologico il paradosso di Goodman? Da due ipotesi. Da un lato abbiamo un’ipotesi (quella del verde), che è dovuta all’induzione e alla verificazione (e anche alla convenzione linguistica, alla credenza, alla probabilità, alla rappresentazione mentale, alla classificazione, al concetto di tipo). Dall’altro abbiamo l’ipotesi del vlu che a primo acchito sembrerebbe dipendere dalla falsificazione. Dal punto di vista epistemologico la falsificazione va preferita alla verificazione, perché sappiamo che esiste quella che viene chiamata un’asimmetria logica tra verificazione e falsificazione. Il problema però è che il vlu del paradosso di Goodman non rischia di falsificare solo il verde e il blu, ma anche le nostre invarianze linguistiche. Uno scienziato potrebbe formulare qualsiasi tipo di ipotesi, anche quelle più improbabili e addirittura quelle ritenute impossibili. Potrebbe ipotizzare che nel 2030 il verde diventerà blu, nel 2040 il blu diventerà rosso, nel 2050 il giallo diventerà viola, nel 2060 il bianco diventerà nero. Potrebbe anche ipotizzare che il verde tra due minuti diventerà blu e dopo due minuti diventerà grigio e dopo ancora due minuti diventerà rosso e dopo due minuti ancora sarà nero. La stessa cosa non vale solo per le ipotesi formulate in base al fattore tempo, ma in base ad altri fattori (ad esempio il fattore spazio). Per dirla in modo generico - se noi non accettiamo delle invarianze nell’induzione, delle invarianze nella categorizzazione e delle invarianze linguistiche - finiamo per essere sommersi da infiniti vlu e da infiniti ble (il blu che dopo un istante t diventerà verde. E se accettiamo il vlu dobbiamo accettare il suo complementare ble). Nella realtà noi cerchiamo di fare economia anche nel campo delle ipotesi. Consideriamo solo le ipotesi ritenute più probabili e non tutte quelle possibili (altrimenti ci sarebbe un proliferare di ipotesi). Ma riflettiamo sulla frase “tutti gli smeraldi sono verdi”. Dire che “uno smeraldo è verde” almeno in questo mondo fino a oggi è una tautologia in fin dei conti. Si può considerare come tale. Prima chiamo l’oggetto A (lo smeraldo) quell’oggetto che ha come proprietà B (l’essere verde) e poi dico che quell’oggetto A ha come proprietà B. Quando dico uno smeraldo è verde dico questo. Qual è il problema? Il problema è che l’ipotesi del vlu può falsificare quella tautologia. Dopo quell’istante t se l’ipotesi che si verificherà sarà quella del vlu allora potremmo dire che uno smeraldo non è più uno smeraldo. Ora io posso fare tre cose per risolvere questo problema: posso ridefinire tutti gli smeraldi in base al fatto che siano tutti blu, posso dare un nuovo nome agli smeraldi (e considerarli dei nuovi oggetti) oppure posso definire gli smeraldi in base ad altre proprietà (ritenute) costanti, non considerando più quindi il colore degli smeraldi. Posso quindi chiamarli ancora smeraldi e non nominare più il loro colore perché potrebbe cambiare da un momento all’altro. Posso chiamarli ancora smeraldi e dire che un tempo erano verdi e ora sono blu senza utilizzare il vlu. Sono possibili tutte le soluzioni. Sono le soluzioni più efficaci e più economiche. Perché dovrei utilizzare il vlu? Visto e considerato che sono a conoscenza che questi cambiamenti non avvengono che raramente (lo so dall’esperienza) posso anche cambiare il nome allo smeraldo e chiamarlo in altro modo. Posso fare in diversi modi senza utilizzare il vlu. Inoltre prima ho scritto che il vlu sembrerebbe falsificare il verde. Ma se analizziamo bene la questione dal punto di vista linguistico potrebbe essere così, ma non dal punto di vista metodologico. Dopo il 2030 gli smeraldi potrebbero diventare verdi o vlu. Io però dopo il 2030 ho bisogno dell’induzione (come prima del 2030) per constatare se gli smeraldi siano verdi o vlu. Posso trovare che molti smeraldi siano vlu, ma mi basta un solo smeraldo verde per constatare che nessuna delle due ipotesi è valida (smeraldi tutti verdi e smeraldi tutti vlu). Posso anche trovare che molti smeraldi siano verdi, ma mi basta un solo smeraldo vlu per constatare che nessuna delle due ipotesi è valida. Ho bisogno dell’induzione quindi anche dopo il 2030. Inoltre il principio di falsificazione di Popper può smentire tutte e due le ipotesi. Tutti gli smeraldi potrebbero essere vlu tranne uno che è rimasto verde oppure tranne uno che è diventato verde (tranne uno che è ble). Tutti gli smeraldi potrebbero restare verdi tranne uno che è sempre stato blu (e non ce ne siamo accorti) oppure tranne uno che è diventato blu e che prima era anch’esso verde (quindi vlu). Io non sarò mai certo che tutti gli smeraldi siano verdi o vlu dopo il 2030. Il vlu quindi dal punto di vista epistemologico non è migliore del verde. Visto e considerato che gli esseri umani hanno delle convinzioni radicate e hanno anche una certa resistenza al cambiamento perché adottare il vlu anche a livello linguistico e logico (se il vlu a livello metodologico non è migliore di come noi nominiamo i colori in questo mondo fino ad oggi?). Possiamo anche cambiare regole, ma le nuove regole non migliorano assolutamente niente.

Piattelli Palmarini ci ricorda che il filosofo Donald Davinson ha complicato ulteriormente le cose, immaginandosi degli smerazi. Gli smerazi vengono definiti come degli smeraldi che dopo un certo istante t diventeranno topazi. Piattelli Palmarini scrive di immaginarsi le implicazioni di affermazioni come “tutti gli smerazi sono vlu”. Il fatto qui si complica anche perché i topazi possono avere molte colorazioni. In questo caso può cambiare sia il soggetto che il predicato della proposizione. Ci sono molte ipotesi concorrenti dell’ipotesi “tutti gli smerazi sono vlu”. Tutte ugualmente valide dal punto di vista logico. C’è l’ipotesi “tutti gli smeraldi sono verdi”, “tutti gli smeraldi sono vlu”, etc etc. Ci sono anche le ipotesi che gli smerazi saranno di molte altre colorazioni, ma non vlu. La stessa frase “tutti gli smerazi sono vlu” a sua volta è composta dall’ipotesi (o informazione) “tutti gli smeraldi dopo l’anno 2030 diventeranno topazi” e “tutti i topazi dopo il 2030 diventeranno vlu”. Prima del 2030 potremmo considerare gli smeraldi dei semplici smeraldi oppure degli smerazi. “Tutti gli smerazi sono blu” significa che queste gemme prima erano smeraldi verdi e dopo il 2030 sono diventati topazi blu. Potremmo anche affermare che “tutti gli “smerazianti sono vlugi”. Per smerazianti posso intendere gli smeraldi che dopo il 2030 diventano topazi e dopo il 2040 diventano diamanti. Per vlugi posso intendere che il verde dopo il 2030 diventerà blu e dopo il 2040 diventerà grigio. E potrei continuare all’infinito. Ma la memoria a breve termine degli individui ha dei limiti ben noti. Apparentemente queste sono frasi semplici, ma rischiano di racchiudere troppe informazioni e/o troppe ipotesi per la nostra mente. Perché quindi non utilizzare il vlu invece del verde? Semplicemente per i limiti della mente umana. Continuando a complicare le cose potrei anche formare un unico predicato che contiene tutte le trasformazioni da un oggetto all’altro e potrei anche formare un aggettivo che contiene tutte i cambiamenti possibili e impossibili di una proprietà del predicato. La frase sarebbe assolutamente semplice dal punto di vista sintattico, ma il soggetto sarebbe costituito da migliaia di mezze parole e così anche il predicato. La domanda che si pone è: perché non utilizziamo una frase con un soggetto lunghissimo e un predicato lunghissimo per fare delle ipotesi o per trasmetterci delle informazioni? Perché invece quando facciamo ipotesi utilizziamo un linguaggio fatto di parole corte? La nostra mente procede in questo modo, perché la nostra memoria ha dei limiti. Ho fatto una ricerca singolare. Ho guardato quale era la parola più lunga del vocabolario italiano. E’ una parola impronunciabile e ha 29 lettere. Per me non è pronunciabile e penso anche per molti altri. Più dell’80% delle parole italiane sono formate da un minimo di tre lettere a un massimo di venti lettere. Qualcuno potrebbe farmi l’esempio dell’inui (la lingua parlata dagli eschimesi). Ma anche in questa lingua ci sono parole molto lunghe rispetto all’italiano, ma non sono composte da centinaia di sillabe. E invece se accettivamo il vlu non esisterebbero più limiti di lunghezza delle parole. Immaginiamoci ora parole formate da migliaia di lettere composte da sillabe di altre parole. Diventerebbe insostenibile la situazione. Non solo perché dovremmo ricordarci parole lunghissime, ma perché dovremmo utilizzare due vocabolari. In fondo noi (esseri umani del 2021) per definire il vlu abbiamo bisogno sia della parola verde che della parole blu. Avremmo quindi bisogno di una lingua madre con cui creare successivamente il vlu, il ble, etc etc. La domanda che mi chiedo è: il vlu presuppone sempre l’esistenza di una lingua preesistente? Se così fosse perché io devo utilizzare una seconda lingua che mi dà più problemi quando posso utilizzare una lingua da me ritenuta più semplice o più adeguata? Il vlu, lo smerazio, lo smeranziante sono parole composte, che mi ricordano di tutti i cambiamenti e di tutte le trasformazioni del soggetto e del predicato. Noi esseri umani abbiamo bisogno di queste parole composte se vogliamo utilizzare il vlu, lo smerazio, lo smeraziante. Un uomo che parla il vluese non esiste. Nella sua vita ha trovato oggetti che erano verdi e lui gli ha dato un nome a quel colore. Nella sua vita ha trovato oggetti che erano blu e gli ha dato un nome. Può forse definire un colore in base ai cambiamenti che questo colore ha nel tempo? Dare un nome a un colore significa porre un’invarianza linguistica. Nessuno può esimersi da questo. Il vlu quindi presuppone due invarianze linguistiche (il blu e il verde). Il colore vlu può esistere solo se esiste un linguaggio con il blu e il verde. Qualcuno potrebbe sostenere che gli uomini che parlano la lingua del vlu non hanno bisogno di parole composte. Ma non è così. Chiamiamo X la proprietà di un oggetto, che subisce dei cambiamenti. Chiamiamo Y un soggetto, che subisce delle trasformazioni. Potrei formulare l’ipotesi “tutti gli X sono Y” e tutto ciò sembrerebbe molto semplice a livello linguistico. Ma dovrei ricordarmi mentalmente tutti i cambiamenti di X e tutti i cambiamenti di Y. La memoria sarebbe sempre sovraccarica e ingolfata. In ogni caso non si va da nessuna parte con parole composte da migliaia di mezze parole e non si va da nessuna parte con una proposizione sintatticamente semplice, che contiene implicitamente centinaia di informazioni o ipotesi. In ogni caso dobbiamo ricordarci che la nostra memoria a breve termine ha dei limiti. Perché dovremmo preferire il verde al vlu? Anche per il semplice motivo che dovremmo cercare di stabilire sempre una corrispondenza tra percezione e linguaggio. Alcuni esperimenti in psicologia hanno dimostrato che alcune tinte di colori sono innominabili per qualsiasi essere umano. Quindi una corrispondenza totale non può esserci. Ma una certa corrispondenza c’è. Per la psicologia la percezione è il modo con cui organizziamo le sensazioni, gli stimoli esterni del mondo. Quando noi cerchiamo di individuare a livello percettivo la forma degli oggetti per esempio lo facciamo anche tramite delle inferenze inconsce. La percezione è data da questa interazione continua tra organismo ed ambiente. La nostra mente alcune volte convalida, altre corregge. Secondo la psicologia l’uomo ha bisogno delle costanze percettive, anche perché sono necessarie per adattarsi in qualsiasi ambiente. Faccio un esempio banale. Una tribù di indigeni sa che nei campi ci sono due tipi di serpenti perfettamente uguali nella forma, ma che hanno colore diverso. I serpenti verdi sono velenosissimi. I serpenti marroni sono innocui. Salvarsi o non salvarsi la vita dipende quindi dalla percezione del colore ed è scontato dirlo (ma è bene dirlo) dalla costanza percettiva del colore. Il verde è una invarianza linguistica, determinata da una costanza percettiva. Possiamo dire che il verde è in corrispondenza con il nostro modo di percepire i colori. Per adattarsi all’ambiente l’essere umano ha bisogno di costanze percettive e di conseguenza anche di costanze linguistiche. Che senso avrebbe avere il linguaggio sfasato rispetto alla percezione? Mettiamo che un indigeno ipotizzi che un serpente velenosissimo possa essere vlu invece che verde. A questo punto ammette qualsiasi possibilità. Ammette anche che possa essere vlugio (cioè essere verde fino all’istante X, quindi diventare blu e dopo l’istante Y diventare grigio). E così via. Diventerebbe una sorta di serpente-camaleonte nella sua testa e ciò genererebbe un eccesso di ansia e di apprensione, che lo condurrebbe all’immobilismo. Mettiamo che gli indigeni per sopravvivere debbano andare a caccia e ci rendiamo conto che questo modo di concepire la realtà sarebbe inconcepibile!!! Goodman sostenne che non si poteva risolvere il suo paradosso utilizzando la nozione di adattamento. Da un certo punto di vista è vero: quali sono le cose che mi permettono di creare queste costanze percettive se non la pratica e l’esperienza? Però bisogna anche ammettere che queste costanze percettive a loro volta ci permettono di adattarci al mondo a differenza del modo di percepire-nominare la realtà in vlu o in vlugio. Goodman ci insegna che esistono l’io e il mondo e che non sapremo mai dove finisca l’io ed inizi il mondo e dove finisca il mondo e inizi l’io. Il paradosso di Goodman ci insegna che c’è una base di partenza di noi esseri umani e che noi agiamo partendo sempre da lì. Non possiamo fare altrimenti. Ma la nozione di adattamento ci aiuta a capire come le nostre basi di partenza si accordano o meno al mondo. Se al posto degli smeraldi utilizziamo i serpenti velenosi ci accorgiamo che non solo noi preferiamo il verde piuttosto che il vlu in base alle nostre basi di partenza innate, ma anche in base alla nostra interazione continua con il mondo. Ma non c’è solo questo. Se io ammetto il vlu - serpenti o non serpenti, smeraldi o non smerald i- ammetto anche qualsiasi tipo di ipotesi possibile e impossibile. Noi scegliamo quindi le ipotesi più probabili? Se le intendiamo come ipotesi più probabili dal punto di vista soggettivo, allora senza ombra di dubbio. Sappiamo però che se accettiamo il vlu rischiamo di passare tutta la vita a formulare ipotesi. Una selezione delle ipotesi quindi ci vuole. Buona o cattiva che sia. Se tutta l’umanità fosse in preda all’immobilismo si estinguerebbe la razza umana. Che cosa ci permette di creare costanze percettive? Hanno ragione gli innatisti o gli empiristi? In questo caso non ci interessa. Molto probabilmente individuare delle costanze percettive dipende prima di tutto dalla nostra struttura cerebrale. Ma la cosa più importante è che le costanze percettive abbiano una funzione adattiva dell’essere umano all’ambiente. Di solito esiste una “discreta” corrispondenza tra percezione e linguaggio. Non deve esserci una corrispondenza totale tra percezione e linguaggio, ma non deve esserci nemmeno nessuna corrispondenza. Perché? Perché siamo fatti così. Tra percezione e linguaggio c’è una corrispondenza non totale e non può essere altrimenti per noi esseri umani. Allora perché adoprare il vlu quando non risponderebbe a queste esigenze primarie di sopravvivenza? Perché dovremmo avere un linguaggio sfasato rispetto alla percezione? Il paradosso di Goodman sembrerebbe farci capire che fare in un modo o fare in un altro è uguale. Ma se cerchiamo di estendere il concetto di vlu a ogni possibile ipotesi (trasformazione o cambiamento) ci accorgiamo che la mente umana preferisce il verde al vlu a causa dei limiti della propria memoria a breve termine. Per noi esseri umani il verde e il vlu possono essere ipotesi ugualmente valide dal punto di vista logico, ma non possiamo considerarle ugualmente valide da un punto di vista linguistico. Abbiamo i nostri limiti. Questo naturalmente non vuol dire che l’evoluzione della specie umana non continui e non ci siano in futuro altri uomini che preferiranno il vlu. Questo naturalmente non vuol dire che nell’universo non ci siano extraterrestri più evoluti rispetto a noi, che utilizzino il linguaggio del vlu. Con queste mie osservazioni non penso assolutamente di aver risolto il paradosso di Goodman. Sono abbastanza fesso, ma non fino a questo punto. Con queste mie osservazioni ho voluto solo precisare alcune cose. Per esempio alcuni formulano il paradosso di Goodman prendendo come esempio una tribù di indigeni, che parla il vluese. A mio avviso nessun essere umano fino ad oggi ha parlato e può parlare il vluese a causa di certi limiti mentali di noi esseri umani. Dovrebbero piuttosto parlare di esseri superiori alieni, che parlano il vluese. E ora vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale. L’epistemologia in Inghilterra e in America viene intesa come lo studio della conoscenza umana, mentre in Italia viene considerata come metodologia della ricerca scientifica. Il paradosso di Goodman ci dimostra che per una seria analisi della metodologia della ricerca scientifica gli scienziati e i filosofi della scienza devono occuparsi seriamente anche dell’analisi del linguaggio. E’ questo che il paradosso di Goodman ci invita a fare. Su questo paradosso, che riguarda la scienza e anche il linguaggio, sono stati versati fiumi di inchiostro. Nessuno lo ha risolto e non è detto che qualcuno in futuro possa risolverlo (e sono passati decine di anni). Con questo suo paradosso Goodman sferrò un attacco decisivo al neopositivismo logico del circolo di Vienna. La metodologia scientifica sembrava basarsi fino ad allora sul principio di causalità, sull’induzione, sul principio di verificazione. A distruggere il determinismo e il causalismo filosofico (secondo cui ogni cosa era allo stesso tempo causa ed effetto di qualche altra cosa) ci pensò Heisenberg. Quello che ci interessa sapere a riguardo è che con il suo principio di indeterminazione dimostrò che non si poteva stabilire contemporaneamente la posizione e la quantità di moto di una particella. Ma non c’era solo questo. Le scoperte di Heisenberg avevano anche altre implicazioni. Per esempio si poteva dedurre che un osservatore (uno strumento scientifico oppure uno studioso di scienze umane) interagiva con l’oggetto di indagine e quindi in un certo qual modo interferiva. Dopo il principio di indeterminazione di Heisenberg crollò la certezza di stabilire con esattezza delle relazioni lineari di dipendenza tra due eventi. I filosofi invece che criticarono in modo serrato l’induzione e il principio di verificazione furono soprattutto Popper e Goodman. Quest’ultimo molto probabilmente ideò questo celebre paradosso per attaccare l’induzione ed invece finì per mettere in crisi l’intera epistemologia. Il paradosso di Goodman è una sorta di violazione del principio di non contraddizione della proposizione. Se io ritengo che possa esistere una cosa che allo stesso tempo è e non è allora violo il principio di non contraddizione. Goodman scatena un putiferio con un solo aggettivo: il vlu. Il vlu è ciò che è verde e dopo un certo periodo di tempo potrebbe diventare blu. Ecco allora che gli smeraldi fino ad allora considerati da noi tutti verdi finiscono per essere e non essere. Il verde è una qualità costante dello smeraldo. Ma se il verde diventa vlu gli smeraldi per il linguaggio umano sono e non sono allo stesso tempo, almeno fino a quando non ci decidiamo di cambiare nome agli smeraldi oppure fino a quando non decidiamo di definirli in base ad altre qualità. Visto e considerato che trattare questo paradosso è molto complesso fino ad ora ho cercato di essere più chiaro possibile. Potremmo essere più filosofici e affermare che il vlu è un elemento metalinguistico della proposizione “tutti gli smeraldi sono vlu”. E se ci pensiamo questo potrebbe anche essere un modo per approcciare il problema. “Tutti gli smeraldi sono vlu” significa che “tutti gli smeraldi sono verdi fino al 2030, ma dopo il 2030 saranno tutti verdi”. E poi avete notato una cosa? Il verbo. Quando utilizziamo il vlu condensiamo due ipotesi e mettiamo il verbo “sono”. In realtà gli smeraldi sono blu e dopo il 2030 saranno verdi se è vera questa ipotesi. In realtà gli smeraldi vlu sono e saranno allo stesso tempo. Il vlu implica che gli smeraldi “sono e saranno”. Potrei quindi sostenere che in ogni lingua umana esiste almeno un passato, un presente e un futuro. Noi esseri umani abbiamo bisogno in ambito linguistico di distinguere tra passato, presente e futuro. Siamo fatti così. Se io ammetto il vlu ammetto anche la confusione temporale. Noi esseri umani non possiamo permettercelo. Potremmo anche pensare che quel vlu non sia che metalinguaggio condensato.

E ora una riflessione di carattere più generale. Kuhn aveva parlato già di “sfondo fornito dai paradigmi” quando descriveva la “scienza normale”, che cercava di risolvere i rompicapi. Popper aveva controbattuto sostenendo che si doveva disfarsi del “mito dello sfondo” e che lo sfondo poteva venire superato di volta in volta. Goodman con il suo celebre paradosso è riuscito a mettere in crisi non solo lo sfondo determinato dai paradigmi. E’ riuscito a mettere in crisi anche lo sfondo fornito dal linguaggio comune (qualsiasi tipo di linguaggio), dagli schemi mentali umani, dalle credenze e dalle costanze umane: lo sfondo fornito dal nostro modo di esperire e concepire la realtà. Molto probabilmente ci vorrebbe un essere di un altro pianeta per superare questo paradosso: un altro essere con un altro sfondo che riesca a vincere questo nichilismo degli sfondi. Il paradosso di Goodman non mette in crisi una “nicchia” culturale o scientifica. Mette in crisi tutto lo sfondo della conoscenza umana. Ci fa capire che gli esseri umani non possono uscire dai limiti e dalle possibilità del loro linguaggio. Forse l’unico tentativo per arrestare provvisoriamente questo paradosso è attaccarsi al caro vecchio nominalismo. Prendere per buono il fatto che possiamo individuare delle proprietà degli oggetti e ritenerle costanti. Qualcuno potrebbe chiedermi: come fanno gli esseri umani a rilevare queste proprietà? Oppure potrebbe chiedermi: ma per una tribù di indigeni il vlu non potrebbe essere considerato una proprietà costante di un oggetto? Allora io risponderei: non mi importa come gli esseri umani rilevano le proprietà e se una proprietà è più o meno semplice da rilevare di un’altra. E aggiungerei: mi importa il fatto che gli uomini individuino delle proprietà, che ritengono costanti. A questo punto sorge una domanda: su quali basi gli uomini ritengono costanti delle proprietà? E’ questo che in fondo ci domanda il paradosso di Goodman. Molto probabilmente lo fanno tramite l’induzione. Ma per tentare di arrestare provvisoriamente il paradosso di Goodman mi può bastare anche dimostrare che tutti gli esseri umani hanno bisogno dell’induzione, delle costanze linguistiche, di classificare oggetti in base a delle proprietà ritenute costanti. A mio avviso nessun uomo può parlare il vluese per tutta la vita e instaurare una corrispondenza tra linguaggio e realtà parlando il vluese. Non può farlo perché il vlu non definisce la proprietà (ritenuta) costante di un oggetto. Almeno per gli uomini di quest’epoca. Tra migliaia di anni non lo so. E ora concludo…..perché quindi non dobbiamo accettare il vlu? Perché sarebbe il nichilismo del linguaggio (è quello che più mi interessa) almeno per noi esseri umani del 2021. Ma è possibile combattere il nichilismo del linguaggio soltanto tramite il linguaggio? Molto probabilmente è impossibile. Goodman che era uno dei più grandi filosofi del ‘900 creò questo paradosso, ma è morto senza risolverlo. Fino ad oggi nessuno lo ha risolto.
giu 262022
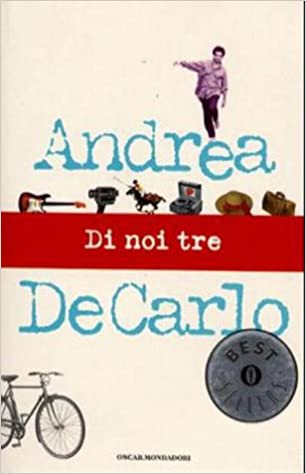
Vi consiglio di leggere due romanzi sulla giovinezza. Il primo è "Di noi tre" di Andrea De Carlo, che ha una trama avvincente e che si legge tutto di un fiato. L'io narrante è Livio, ma i protagonisti sono tre: Livio, Misia, Marco. Il primo ha appena discusso la tesi in storia antica e ha polemizzato con la commissione di laurea. La stessa sera incontra Misia. Livio rimane colpito da questa ragazza bionda nel marasma di una cantina (dove si balla) perché emana "una luce speciale", "un'aria luminosa", "una naturalezza leggera". Per arrivare a conoscerla si intromette addirittura nella lite tra lei e il suo ragazzo, subendo l'aggressione del tipo. Poi Livio inizia a frequentare assiduamente Marco, che lo vuole coinvolgere in uno dei suoi tanti progetti strampalati: fare un film senza alcun tipo di finanziamento. I due devono perciò trovare attori non protagonisti, organizzare la troupe, scrivere la sceneggiatura, decidere la scenografia, gli interni e gli esterni. Livio presenta Misia a Marco e la coinvolge nel film. A questo punto Livio avverte che tra Misia e Marco è nata un'intesa. Della sofferenza causata da questa delusione sentimentale non c'è traccia nel libro. Livio è come se rimuovesse questa frustrazione. Comunque quest'ultimo diventa un pittore affermato grazie all'interessamento di Misia, che riesce a organizzare una mostra dei suoi quadri. Anche il film ha successo e porta alla ribalta Marco come regista e Misia come attrice. Marco addirittura diventa quasi un mito, prigioniero del suo stesso personaggio. Rifiuta la mondanità, detesta l'ambiente dello spettacolo, rifiuta lavori. Non voglio però raccontare tutta la trama. Dirò solo che i colpi di scena si susseguono tra Barcellona, Londra, Buenos Aires. A mio avviso le tematiche di questo romanzo sono due: 1) l'amicizia tra i tre che riesce anche a destare dal torpore esistenziale Livio, il quale alla fine riesce a dominare i propri sbalzi di umore (muovendosi rasoterra, così basso che non ha nessun posto dove cadere...De Carlo cita questo verso di Bob Dylan). 2) la critica nei confronti della società moderna in cui tutti si vendono: chi vende il corpo, chi l'intelletto, chi la dignità. Tuttavia le scelte di vita di tutti i protagonisti sono antitetiche a questa legge di mercato.
A mio avviso questo è un libro da leggere. Sono a conoscenza naturalmente che molti critici letterari storcono il naso ogni volta che si parla di un libro di Andrea De Carlo perché le sue opere vengono considerate troppo commerciali. De Carlo infatti è uno dei pochi che riesce a vendere senza essere un letterato e neanche un personaggio televisivo. Probabilmente alcuni invidiano allo scrittore la prolificità. Secondo me questo è il suo romanzo migliore. Riguardo a De Carlo sono dell'idea che avessero ragione Italo Calvino, che fu il suo talent scout, e Carlo Bo, che lo criticò positivamente.
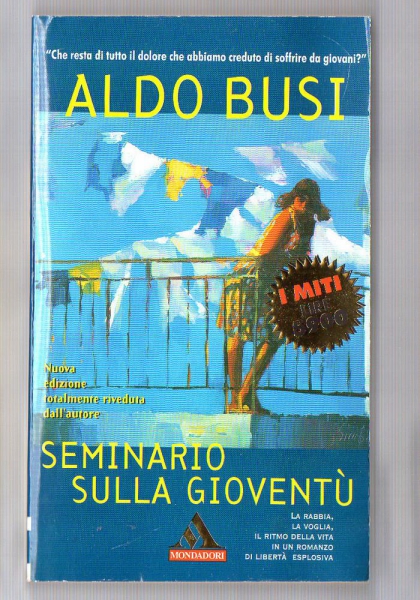
Il secondo romanzo è "Seminario sulla gioventù" di Aldo Busi. La frase che mi ha colpito di più di questo capolavoro è l'incipit del libro: "Che resta di tutto il dolore che abbiamo creduto di soffrire da giovani? Niente, neppure una reminiscenza". Il tempo e la maturità rimarginano ferite ritenute allora letali. Ma il vero fulcro del romanzo è lo stesso Busi, che ci mette dentro il corpo, l'animo, la rabbia, la disperazione, il cinismo, l'ironia disincantata. Tra un susseguirsi di mestieri per mantenersi, tra una ricaduta del trigemino e un incontro furtivo, Busi ci spiega tutti i meccanismi di quello che lui chiama "sessualterrorismo". Come scrive Busi uno fa tanta fatica "per sfuggire allo scemo del villaggio e al genio, e si ritrova giullare di una fighetta turistica". Il protagonista infatti per riuscire a barcamenarsi, pur essendo omosessuale, si fa mantenere da Arlette, sopportando a stento le sue amiche con le loro vanità, narcisismi e frivolezze. Il protagonista in un crescendo di insofferenza nei confronti del perbenismo si vendica dei suoi amanti, borghesi dalla reputazione immacolata, con ricatti e stoccate. Il protagonista esamina a fondo l'emarginazione che subisce dalla società e analizza i vizi segreti di coloro che sono insospettabili, pur avendo una doppia vita. Un'altra felice intuizione di Busi è la seguente: "le vere personalità sono quelle inventate: non c'è grandezza dove non c'è violenza". Come a dire che Busi è diventato un grande scrittore perché ha dovuto sopportare e accettare persone e mestieri, che se avesse avuto la possibilità di scegliere avrebbe rifiutato categoricamente.
Alcuni potrebbero chiedersi perché leggere questi due romanzi. A mio avviso servono a far riflettere in questo mondo dove tutti vanno di corsa e dove le menti non fanno altro che immagazzinare dati. Questi due romanzi fanno riflettere: fanno riflettere sulla giovinezza. Penso proprio che potrebbero essere definiti due romanzi generazionali. Non solo ma non sono mai noiosi. Non sono certo pretenziosi e non sono assolutamente due metaromanzi, genere in voga tra gli intellettuali. Inoltre Cioran scrisse: "quello che so a sessanta anni lo sapevo altrettanto a venti. Quaranta anni di un lungo, superfluo lavoro di verifica...". Ebbene a mio modesto avviso tutti abbiamo bisogno di fare questo "superfluo lavoro di verifica", anche se potrebbe sembrare paradossale di primo acchito. Talvolta non c'è niente di così necessario delle cose apparentemente superflue.
giu 262022

Ritengo sia interessante paragonare “La nausea” di Sartre a un suo racconto, pubblicato un anno dopo, intitolato “Il muro”. Ne “La nausea” il protagonista Roquentin, dopo aver viaggiato per il mondo, si trova in una cittadina a fare ricerche storiche su un personaggio minore del Settecento. Queste ricerche lo portano spesso alla Biblioteca dove conosce l’autodidatta, che si erudisce leggendo per ordine alfabetico gli autori. L’autodidatta è una figura importante del romanzo perché il suo atteggiamento nei confronti dell’umanità è agli antipodi di quello del protagonista. L’autodidatta dichiara di essere socialista e di amare l’umanità. Pur tuttavia gli ideali non trovano corrispondenza nella vita dell’uomo, che viene addirittura scoperto a molestare un ragazzo in biblioteca. Roquentin ha viaggiato per tutto il mondo. Ma se è vero che per Sartre alla nausea si può contrapporre solo l’avventura, è altrettanto vero che il protagonista guardandosi indietro si rende conto di aver avuto solo storie e non avventure. Da quattro anni si è lasciato con Anny, la sua donna, che nel frattempo è diventata un'obesa depressa. Anny non gli interessa più, così come non gli interessano più le sue ricerche storiche. Mentre scrive questo capolavoro, Sartre ha in mente la sua filosofia dell’ “uomo solo”. Ma quest’opera, strutturata come un romanzo poliziesco, è anche un feroce attacco alla borghesia. La nausea causa nel protagonista l’estraneità degli oggetti, la percezione distorte delle cose e della propria immagine. Non riesce nemmeno a conciliarsi con l’immagine che gli rimanda lo specchio: un uomo addirittura estraneo a sé stesso. A mio avviso la nausea è dovuta principalmente alla illogicità dell’esistenza. Per dirla in termini esistenzialisti è determinata dal riconoscimento della “deiezione”, cioè dal fatto dell’essere gettati nel mondo senza saperne il motivo. Non solo, ma Sartre in questo suo capolavoro registra fedelmente lo scarto tra la richiesta chiarificatrice e classificatrice della logica umana e l'aspetto frammentario e dispersivo della realtà. Roquentin è sospeso tra solipsismo e scetticismo. Ma non ha certezze né riguardo al proprio modo di essere né riguardo al mondo esterno. Sartre svela sia la fallibilità della conoscenza interiore che la limitatezza e la pochezza dell'agire umano. Il rapporto tra protagonista ed esperienza non è però solo quello del divenire temporale, ma è anche quello della negazione di ogni forma di relazione tra simili. Mi viene in mente l'esistenzialismo positivo di E.Paci, filosofo oggi ormai dimenticato. Per Paci non è possibile essere soltanto idealisti (cioè prendere in esame solo "il pensiero per il pensiero") né soltanto esistenzialisti (cioè considerare solo "l'esistenza per l'esistenza") né avere soltanto dei presupposti etici (cioè considerare solo "il valore per i valori"). Bisogna invece attuare una sintesi tra queste tre sfere dell'universo umano. Sartre per tutto il romanzo analizza solo il pensiero e l'esistenza: è invece totalmente assente qualsiasi fondamento etico, che possa risollevare Roquentin. Il protagonista de “La nausea” non ha un’ideale per vivere. Questa sarà poi l’unica ancora di salvezza secondo Sartre, che infatti successivamente scriverà in un suo saggio: “l’uomo è costantemente fuori di sé; solo progettandosi e perdendosi fuori di sé egli fa esistere l’uomo e, d’altra parte, solo perseguendo fini trascendenti”.

Ma nel suo racconto “Il muro” Sartre fa sfoggio di un umorismo tragico, che era totalmente assente nel suo primo capolavoro. Qui il protagonista è un anarchico spagnolo, condannato a morte per le sue idee. Viene messo in una cella con altri due condannati e deve passare la notte più lunga della sua vita: all’alba lo fucileranno. La luce entra da alcuni spiragli e da piccola apertura sul soffitto, da cui si può intuire uno squarcio di cielo. Ma il cielo non comunica né simboleggia niente. Ha la morte nell’anima, ma non ha paura di soffrire. Gli altri sono sempre l’inferno e la compassione lo disgusta. Oramai è preparato a morire perché passare tutta la notte ad aspettare la morte significa “vivere venti volte l’esecuzione”. Nonostante questo il protagonista ritiene che morire sia la cosa meno naturale del mondo. Non ha nemmeno più ideali. Dell’anarchia e della liberazione della Spagna non gli interessa più niente. Al mattino però gli danno un’opportunità: deve scegliere se essere fucilato o dire dov’è il suo amico Gris. Il protagonista sa che Gris si è nascosto in casa dei suoi cugini, ma nonostante questo preferisce morire. E prima di morire ha una trovata comica. Vuole gabbare i soldati, dicendo che Gris si trova al cimitero. Vuole immaginarsi la scena di quegli uomini in uniforme che corrono tra le tombe.

Ma Gris ha abbandonato la casa dei cugini e si è rifugiato davvero al cimitero. Il protagonista ha salva la vita. Mi viene naturale paragonare la notte insonne che passa il protagonista de “La nausea” in un albergo di commessi viaggiatori a questa notte terribile, che passa il protagonista de “Il muro”. E’ questa la chiave di volta per capire il rovesciamento di prospettiva che Sartre attua in questo breve racconto. Ne “La nausea” il grande scrittore fa un’analisi minuziosa dei paradossi dell’esistenza, scrive una fenomenologia del disagio interiore. Il protagonista tuttavia ha libertà di scelta e d’azione. Ne “Il muro” invece si trova di fronte al paradosso dei paradossi della vita: la morte che nullifica ogni scelta e ogni malessere interiore. Il filosofo Adorno a proposito dell’esistenzialismo scrisse che la scelta alla fin fine era tra crepare o crepare. E se per K. Jaspers l’uomo di fronte alla morte si può aggrappare alla fede, molto più difficoltoso è il rapporto con la finitezza e la precarietà dell’esistenza per un esistenzialista ateo come Sartre. Ma viene in soccorso la trovata comica e il protagonista si salva, ridendo dell’assurdità dell’esistenza e della morte. Sartre ne "Il muro" dà scacco matto alla nausea e alla morte.
giu 232022
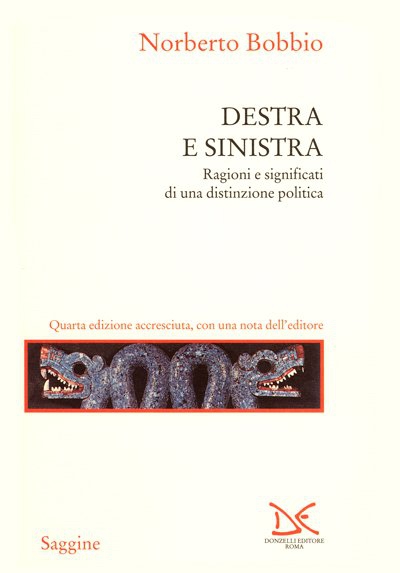
Dopo tre quarti d'ora a parlare di politica io e Lele concludiamo così:
"è tutto un darselo a intendere."
Secondo recenti studi esiste ancora la cosiddetta "eredità politica". I genitori fanno proselitismo, educano, formano, influenzano. I figli li imitano. Questo accade 6/7 volte su dieci. Oppure i figli in piccola parte vogliono "uccidere" il padre, si contrappongono, perché c'è un rapporto conflittuale, un complesso edipico da risolvere, come successe nel '68. Plausibile l'ipotesi di Adorno sulla personalità autoritaria. Secondo Adorno il fascismo era determinato da una educazione rigida, repressiva, autoritaria. Si tenga però presente che l'avalutatività delle scienze umane è un'utopia e che allora molta sociologia, molta psicologia contenevano in sé la teoria implicita che chi era progressista era sano psichicamente oltre che nel giusto. Tutto ciò era in buona parte giustificato perché gli studiosi progressisti in gran parte erano memori degli orrori del nazifascismo, ma ancora non conoscevano a dovere quelli dei regimi comunisti. Le loro conclusioni non corrispondevano totalmente al vero, se si ragiona a rigore di logica e se si conosce un minimo la natura umana. È presumibile che anche dittatori e persone comuni comuniste possano avere o possano avere avuto aspetti patologici correlati significativamente alla loro ideologia. Come scrive Andreoli di ogni scelta politica si potrebbe dare una "lettura psicoanalitica". C'è anche la questione dell'età. Secondo un celebre aforisma di Pitigrilli "si nasce incendiari e si finisce pompieri". C'è anche chi vota non in modo affettivo/emotivo ma in modo razionale, facendo un'analisi costi/benefici. Sono quelli che votano chi difende i loro interessi. In modo opposto ci sono ricchi che votano il partito comunista anche per eliminare o ridurre il loro senso di colpa di essere privilegiati.

Secondo le scienze umane l'ideologia sarebbe definita come "un complesso di credenze, opinioni e valori che orientano un determinato gruppo sociale o un individuo; tale insieme di credenze, inoltre, è condiviso all’interno di un gruppo e ne sostiene le azioni" (Carraro e Bortolotti, 2020, p. 337). Ma recentemente è nata la psicologia politica, ovvero lo studio delle variabili psicologiche che decidono l'orientamento politico. Secondo alcuni studi l'orientamento politico è "predeterminato geneticamente", addirittura sarebbero individuati i geni del conservatorismo o del progressismo. Io sono rimasto agli studi degli psicologi nelle carceri che per esempio hanno evidenziato quanto i brigatisti rossi spaziassero dal delirio di onnipotenza alla mania di persecuzione, croce e delizia di quella che loro consideravano una sorta di guerra tra guardie e ladri.

Bobbio ha scritto il long seller "Destra e sinistra" che ha venduto centinaia di migliaia di copie ed è stato tradotto in tutto il mondo. Per Bobbio "destra" e "sinistra" erano "reciprocamente esclusivi e congiuntivamente esaustivi". Il libro è ancora attuale, sebbene sia stato pubblicato nel 1994. Bobbio era uno dei più grandi filosofi italiani, molto acuto e altrettanto rigoroso. Non le mandava a dire. Scrisse che il fascismo era dovuto anche alla compromissione del popolo italiano, che non era esclusivamente colpa di Mussolini e dei gerarchi: ebbe il coraggio di dire e scrivere che anche la popolazione italiana, sebbene avesse l'attenuante dell'ignoranza a quei tempi, aveva avuto un'ubriacatura ideologica, si era fatta lusingare, sedurre, incantare, ipnotizzare dai fascisti della prima ora, diventando essa stessa fascista, ed era in un certo qual modo responsabile del fascismo. Bobbio considerava certamente la propaganda del partito fascista, ma chiamava gli italiani a un esame di coscienza collettivo. Bobbio sapeva che il fascismo era stato, per così dire, "nazionalizzazione delle masse". Il filosofo sapeva esattamente come era avvenuta l'ascesa di Mussolini. Anche per via della dittatura e della violenza esercitata comunque furono pochissimi gli italiani a non aver pagato il pedaggio al fascismo. Bobbio evidenziò anche i meriti della Resistenza d'altra parte. Per chiarire il giudizio di Bobbio sulla compromissione degli italiani durante il regime basta citare il titolo di un suo saggio sulla memoria e i valori della Resistenza: "eravamo ridiventati uomini". Insomma fu sempre attento ad analizzare con obiettività luci e ombre degli italiani e dell'Italia. Quindi per l'autorevolezza, la competenza, l'onestà intellettuale, il rigore morale quando venne pubblicato questo volume, filosoficamente accurato ma leggibilissimo, molti pendevano dalle labbra di Bobbio, volevano ascoltarne le interviste, si recavano ad acquistare il libro. Ma davvero come scrive Bobbio sinistra è uguaglianza, emancipazione, bisogno e destra è diseguaglianza, tradizione, merito? Per alcuni queste categorie sono desuete, non hanno più modo di esistere, come cantava Gaber. Personalmente penso che oggi molti tifino un orientamento politico, un partito politico come si fa con una squadra di calcio, senza avere idee precise o valori di riferimento stabili e certi. Non hanno molti la preparazione adeguata, le conoscenze teoriche. Non sono aggiornati. Non seguono la politica. D'altronde il discorso è complesso. Tutti hanno il diritto/dovere di votare. Calvino lo mise in evidenza con "La giornata di uno scrutatore". Il voto per tutti è uno dei valori fondanti della nostra democrazia. Continuo però a pensare che ci sia gente che si tira la zappa sui piedi. Comunque molti votano cosa hanno votato i loro genitori (se esiste il partito ancora o se c'è un minimo di continuità), intrattenendo spesso un rapporto di natura clientelare con gli uomini di quel partito. Chiamatele pure conoscenze, pubbliche relazioni, conoscenze utili, amicizie interessate. È insomma anche un do ut des. Pochi si acculturano e si documentano per la politica. Hanno anche ragione. Anche io sono tra questi. Nessuno sta dietro alla politica come accadeva negli anni '70. Non dico che esista il voto di scambio, ma quasi. Di solito ci sono i referenti politici, che io per esempio non ho. In Italia come dichiarò l'allora ministro del lavoro Poletti per trovare un lavoro sono importanti esperienza e curriculum, ma più di tutto le relazioni sociali: per Poletti era più importante andare a giocare a calcetto con gli amici o a cena con ex compagni di scuola che andare all'ufficio di collocamento (visto che fino a pochi anni fa solo il 4% dei disoccupati trovava lavoro grazie a esso). Fortini scriveva: "...Gli oppressi/ sono oppressi e tranquilli, gli oppressori tranquilli/ parlano nei telefoni, l’odio è cortese, io stesso/ credo di non sapere più di chi è la colpa". Se un tempo in chiave marxista gli oppressi erano i proletari e gli oppressori i capitalisti e gli imperialisti oggi si dovrebbe parlare di gruppi dominatori e gruppi dominati, di categorie avvantaggiate e di categorie svantaggiate. Oggi il mondo non è più wasp comunque. In realtà il discorso è sfumato e complesso. Come scrive Bailey lo status di persona svantaggiata è multidimensionale. Non esiste più la categoria unica sulla base del capitale. Ci sono varie dimensioni come il genere, l'età, l'etnia, il grado di istruzione, lo stato di salute, l'orientamento sessuale. Ma in Italia almeno esistono anche stereotipi e conseguenti discriminazioni sulla base dell'appartenenza politica. Gli italiani, pur essendo disinformati ed essendosi disaffezionati alla politica, si odiano ancora in base alle categorie politiche; chi è di destra odia le cosiddette zecche, chi è di sinistra odia i fascisti. Ancora oggi non c'è una riappacificazione, una conciliazione tra le due parti. Ci sono sempre almeno due fazioni, c'è una logica della contrapposizione. Ci sono sempre nella popolazione la suddivisione tra Don Camillo e Peppone, tra guelfi e ghibellini. Siamo un popolo emotivo, litigioso. Si vien sempre chiamati a stare da una parte, bisogna sempre sapere da che parte stare in Italia. Nessuno si può esimere. Il voto in teoria è segreto, però dimmi chi voti: così si potrebbe riassumere tutto. Si può diventare falchi o colombe. Si può essere galline azzannate da volpi. Si può far la fine delle volpi, che dopo aver azzannato le galline, venivano uccise e qui da noi in Toscana a chi le uccideva gli venivano regalate le uova delle galline. Il potere come al solito divide e governa. In Toscana per esempio esiste una tradizione rossa dovuta alla fondazione del partito comunista a Livorno, alle tante case del popolo un tempo, alla diffusione di circoli Arci oggi, alle tante cooperative rosse. In Toscana un semplice liberale apartitico può essere penalizzato. In Veneto lo è altrettanto un comunista. Gli italiani discriminano, ghettizzano, emarginano, danno amicizia e amore, includono o escludono, favoriscono oppure ostracizzano, offrono opportunità socioeconomiche oppure non le danno in base al colore politico, eppure al governo vige la logica del consociativismo e della spartizione. Tutto è già deciso. Il saggio di Bobbio è in bella vista nella mia libreria, lo tengo sempre a portata di mano. Adriano Sofri in "Altri hotel" scriveva che era in disaccordo con le equazioni di Bobbio sinistra=uguaglianza e destra=libertà. Anche Vittorio Foa proponeva che se la destra significava liberalismo la vera libertà invece stava a sinistra. Bobbio naturalmente vedeva distante, ma non aveva la sfera di cristallo.

Su una cosa aveva totalmente ragione: la destra si basava allora su un concetto dell'antropologia tradizionale, ovvero gli uomini non sono uguali e bisogna valorizzare la diversità. Personaggi come Almirante volevano esaltare le differenze individuali. Dagli anni '90 in poi all'egemonia culturale della sinistra opponevano l'egemonia mediatica berlusconiana. Oggi la destra è populista e parla di identità. La sinistra vuole la fluidità. Oggi la sinistra ha il merito maggiore di difendere i diritti civili e forse non riesce a difendere a dovere i precari. La destra un tempo, come sostiene Bobbio, era inegualitaria, prendendo come riferimento Nietzsche. Bisogna leggere anche "La sinistra nell'era del karaoke" di Bobbio, Bosetti, Vattimo. Quest'ultimo scriveva a riguardo: "Credo di vedere delle spiegazioni di questo conservatorismo della sinistra italiana: essa, o almeno una gran parte di essa, si è liberata lentamente, negli ultimi decenni, del mito della rivoluzione e ha scoperto relativamente da poco il valore che hanno le regole del gioco. Questo spiega in termini non puramente denigratori perché oggi la sinistra sembra più arroccata in difesa della Costituzione" (pp.21-22). Forse essere di sinistra significa oggi come ieri difendere le minoranze e sentirsi una minoranza, che è o si sente élite. Come dice Nanni Moretti in "Caro diario": "Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io, anche in una società più decente di questa, mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Ma non nel senso di quei film dove c'è un uomo e una donna che si odiano, si sbranano su un'isola deserta perché il regista non crede nelle persone. Io credo nelle persone. Però non credo nella maggioranza delle persone. Mi sa che mi troverò sempre d'accordo e a mio agio con una minoranza...".
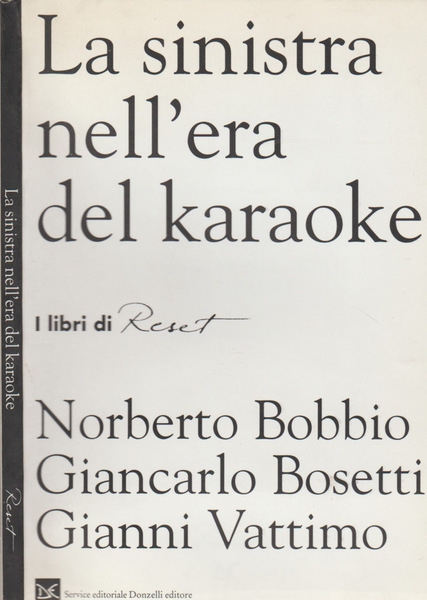
E la destra invece? E adesso come è da questo punto di vista la destra? Oggi i punti programmatici dei partiti sembrano assomigliarsi tutti. Qualcuno dice che la sinistra non esiste più e la destra è troppo camaleontica. Poi oggi si registra il primato dell'economia sulla politica. Che cosa conta la politica italiana così provinciale in un mondo dominato dal nuovo neocolonialismo delle lobby economiche e delle multinazionali? Nessuno vuole più fare la rivoluzione. Chi potrebbe farla è pur sempre "uno svantaggiato integrato". Gli esclusi non hanno forza né voce in capitolo. Ma esiste più il senso di appartenenza? Oppure non esistendo più le classi non esiste più la coscienza di classe e non esistendo più le ideologie non esiste più l'amore per la politica? Talvolta ho la vaga sensazione che chi dice che sinistra e destra non esistono più non vuole schierarsi, non vuole dichiararsi oppure addirittura vuole mistificare la realtà. Il saggio di Bobbio ha avuto a mio avviso il merito, piccolo o grande che sia stato, di innalzare la discussione politica, di far volare alti gli italiani, in un Paese allora sclerotizzato sulla distinzione netta tra berlusconiani e antiberlusconiani, al punto da regredire politicamente, mantenere lo status quo per anni, non evolvere, arenandosi nelle secche e non facendo le riforme. Ma anche qui il consociativismo alla fine aveva la meglio: i politici progressisti facevano accordi sottobanco, pubblicavano libri con le case editrici del nemico, andavano a fare ospitate nelle reti Mediaset, sempre prezzolati. Per molti intellettuali progressisti duri e puri Berlusconi era un imprenditore illuminato perché permetteva loro di essere pubblicati o di scrivere sui suoi giornali. Nel frattempo Berlusconi si impossessava di buona parte del Paese e decine di migliaia di persone erano suoi dipendenti. Sicuramente il saggio di Bobbio va letto comunque, anche per essere contro e per dissentire. È un saggio tascabile, colto, penetrante, divulgativo e chiaro. Bobbio fa delle pregevoli argomentazioni e solleva interrogativi validi ancora oggi. Ecco perché ha avuto meritatamente questo successo inaudito, forse impensabile. È ancora molto attuale a mio avviso, ma anche se fosse datato avrebbe il merito di ricordarci come eravamo, come pensavamo, su quali problemi ci accapigliavamo quasi trenta anni fa. In ogni caso va letto.
giu 222022
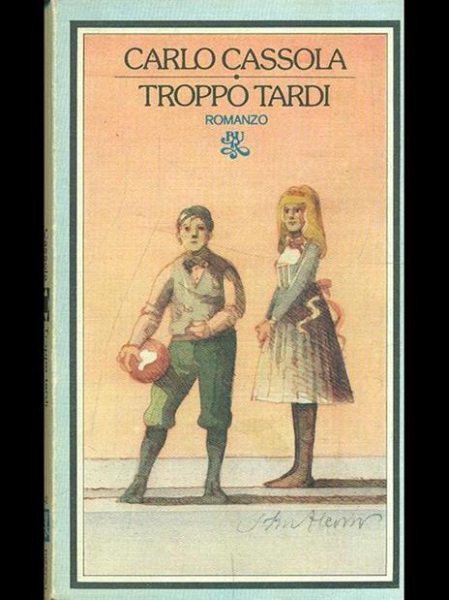
È ormai caduto nel dimenticatoio Carlo Cassola, che ha vinto a suo tempo premi letterari importanti come lo Strega e il Bagutta. Non rientra ormai nei canoni letterari. Gli italianisti a stento lo citano. Il suo nome e i suoi romanzi sono caduti nell'oblio. Eppure negli anni '60 e' 70 aveva una grande popolarità e un vasto consenso. Le sue opere avevano avuto notevole risonanza nel pubblico. Come scrive Cassola non è esatta l'equazione successo=demerito, ancora in voga oggi e utilizzata da tanti critici letterari. Qualcuno però, soprattutto in Toscana, lo ricorda ancora Cassola. Recentemente la tratta ferroviaria Cecina-Saline, di cui aveva scritto in "Ferrovia locale" è assurta alla cronaca per delle iniziative culturali in memoria dello scrittore, che era nato a Roma ma toscano d'adozione, tanto è vero che aveva ambientato molti romanzi nell'entroterra pisano. Nel 2020 l'università Cattolica ha istituito un premio di laurea in memoria di Cassola. La biblioteca comunale degli Intronati di Siena ha allestito una mostra bibliografica in suo ricordo.
I letterati non sono mai stati benevoli con lui. Alcuni critici hanno visto nella sua narrativa il ritorno al grado zero della scrittura. Altri però hanno evidenziato l'influsso delle epifanie di Joyce. Cassola è stato uno scrittore coerente stilisticamente e politicamente. I suoi libri erano letteratura ma erano anche best seller. La neoavanguardia lo accusò di essere la Liala del '63, ma lui con stile ed educazione andava a braccetto con Sanguineti. Pasolini lo criticò perché i suoi libri erano un ritorno al realismo. Nei suoi romanzi non ci sono le tematiche comuni a tanta narrativa in auge all'epoca: la nevrosi, l'alienazione, l'incomunicabilità, l'inettitudine. Erano tutti argomenti, considerati di primaria importanza per gli artisti. Lui si astiene da tanta intellettualità. Nel Novecento letterario il mondo e anche la psiche sono costituiti da frammenti eterogenei e la verità umana si trova solo nel dettaglio. La verità si fa puntiforme. I romanzi del ’900 sono i segni di una crisi profonda. Cito tra tutti “L’uomo senza qualità” di Musil, “Oblomov” di Goncarov, “Auto da fé” di Canetti, “La cognizione del dolore” di Gadda, “La coscienza di Zeno” di Svevo. Ma di esempi se ne potrebbero fare altri.

(Nella foto Carlo Cassola)
Cassola invece privilegia il grigiore dell'esistenza, le vite comuni, connotate dall'insensatezza. Il poeta Carlo Bordini diceva che c'era della narratività nella sua poesia e della poesia nella sua narrativa. Anche in Cassola in fondo troviamo una commistione di generi. Non c'è una prosa lirica, una prosa poetica, ma la poesia della quotidianità. Spesso sono narrati fattarelli insignificanti di personaggi umili e dimessi con un lessico comune. La trama è scarna, mai avvincente, mai ricca di colpi di scena. I grandi eventi, la storia stanno molto spesso sullo sfondo. Eppure si percepisce la lunga mano sapiente di Cassola che orchestra e dirige tutto fin nei minimi dettagli: un grande narratore acuto e consapevole. Nessuna traccia comunque di quella che oggi chiameremo realtà aumentata o iperrealismo. L'acme della vita sta nei vagiti, negli orgasmi, nei rantoli. Ma nessuno sa con certezza quali sono gli istanti decisivi, i momenti topici del percorso. È anche questo che vuole dirci lo scrittore, che rimuove l'inconscio e non cerca mai di fare la rivoluzione: in vita sua ha già fatto la Resistenza e questo è più che sufficiente. Quindi non è mai stato velleitario né demagogo.
"Troppo tardi" è ambientato a Roma ai tempi del fascismo. Tratta di due fratelli adolescenti, Anna e Giorgio, abbandonati dal padre. I due hanno un rapporto ambivalente come si usa tra fratelli. La madre ha una mentalità comune, tiene molto al decoro piccolo-borghese. Vivono in una appartamento in affitto nel quartiere Prati. I due vengono mandati a scuola, ma Anna decide di interrompere gli studi di stenografia perché è svogliata. Non sa quello che vuole. Alcuni giorni si veste per passare inosservata, altri giorni si veste in modo vistoso per attirare l'attenzione. Il romanzo per la maggior parte è essenziale e dialogico. Nelle conversazioni tra ragazze si parla di questioni amorose, di confidenze. Anna è irrequieta, vorrebbe vivere "cento vite". Ma deve stare attenta perché basta accettare un invito in macchina da un medico per rischiare seriamente di venire abusata. Il dottore infatti la porta in campagna in un luogo appartato, ma lei riesce a opporsi efficacemente. Giorgio fa le sue congetture sulle ragazze. Cerca di trovare differenze di costume tra quelle che lavorano e quelle che studiano, pensa che le ragazze delle grandi città siano tutte poco serie: insomma pensieri e pregiudizi ricorrenti nei ragazzi di ogni generazione. Cassola si fa sfuggire un commento, un'osservazione amara, mette in bocca ai suoi personaggi una sentenza inoppugnabile: nella vita è solo questione di soldi, coi soldi si può essere generosi o farsi perdonare tutto. Su tutto prevale la cupidigia, il culto del denaro e un’etica del lavoro, che se analizzata risulta riprofevole. La trilogia di Mastronardi ad esempio (“Il maestro di Vigevano”, “Il calzolaio di Vigevano”, “il meridionale di Vigevano”) è eloquente a riguardo, illustra chiaramente la grettezza e l’arrivismo della borghesia votata esclusivamente al profitto. Ma quelli descritti da Cassola erano anche i tempi in cui una ragazza se usciva la sera e fumava le sigarette destava scalpore e scandalo nei perbenisti. C'era una ristrettezza di vedute all'epoca. Poco era consentito e molto era tabù. Anna si sposa incautamente e frettolosamente con un avvocato di mezza età di Recanati, che ha conosciuto a una festa. Eppure prima aveva conosciuto Ferruccio, amico di suo fratello, con cui c'era stata un'amicizia affettuosa senza intimità. L'unica affinità elettiva tra Anna e il suo marito era che entrambi si annoiavano a quella festa. Il suo fratello si sposa senza pensarci troppo con l'incoscienza della gioventù. Si può affermare che come i protagonisti di "Delitto e castigo" di Dostoevskij e di "I sotterranei del Vaticano" di Gide compiono l'omicidio assurdo allo stesso modo in questo romanzo i due fratelli compiono un gesto assurdo sposandosi entrambi in modo avventato. Ma la guerra inizia a trasformare le vite dei protagonisti. Il marito di Anna va in guerra e di lui per diverso tempo non si hanno più notizie. Anna e Ferruccio diventano amanti. Ferruccio si mette a fare il giornalista. Giorgio perde l'impiego perché scoperto in combutta coi repubblichini. A tratti il romanzo diventa concettuale, soprattutto quando Ferruccio, amante di Anna, decide che vuole fare lo scrittore, decide di spendere gran parte del suo stipendio in libri ed allora vengono fatte delle riflessioni intellettuali sui romanzi del Novecento. La digressione però non annoia. Il marito di Anna ritorna e chiede la separazione. Ferruccio poi capisce di non amare più Anna perché si invaghisce di una ragazza molto più giovane. Cassola si dimostra maestro a rivelare le contraddizioni dell'animo, ormai insanabili dei suoi personaggi. In fondo se i lettori dell'epoca si appassionavano per le vicissitudini narrate nei suoi libri qualche motivazione più che plausibile c'era, ovvero il fatto di essere letteratura di consumo di alta qualità per quei tempi. Infine come nel romanzo "L'antagonista", che Cassola considerava la sua miglior opera, anche qui c'è un duello a distanza tra due maschi, che si contendono una donna.

(Nella foto Davide Morelli con l'amico di infanzia Emanuele Morelli dopo tre birre)
Ricapitolando e facendo una breve sintesi dei romanzi italiani sul nazifascismo e sulla seconda guerra mondiale abbiamo:
"Uomini e no" di Vittorini: la Resistenza a Milano e la rappresaglia dei tedeschi
"La storia" della Morante: romanzo corale, crudo, ambientato a Roma, criticato anche per la descrizione della crudezza della Resistenza
"Il giardino dei Finzi Contini" di Bassani : la condizione degli ebrei a Ferrara
"Se questo è un uomo" di Primo Levi: il lager
"Cristo si è fermato a Eboli" di Carlo Levi: il confino
"Il sentiero dei nidi di ragno" di Calvino: la Resistenza vista con gli occhi di un bambino
"Il partigiano Johnny" di Fenoglio: la presa di Alba e la Resistenza nelle Langhe
"Lessico famigliare" della Ginzburg: l'attività antifascista e gli intellettuali antifascisti
"La polvere sull'erba" di Bevilacqua: il triangolo rosso in Emilia
"Il sergente nella neve" di Mario Rigoni Stern: la ritirata in Russia
"La ragazza di Bube" di Cassola: ex partigiano che uccide il figlio di un carabiniere
"Il clandestino" di Mario Tobino: la lotta partigiana in Versilia
"L'ombra delle colline" di Arpino: l'uccisione di un tedesco da parte di un bambino
"L'Agnese va a morire" di Renata Viganò: la staffetta partigiana
"La casa in collina" di Pavese: la fuga e il rifugio dai bombardamenti nazisti
"Troppo tardi" di Cassola: la storia di un fratello, di una sorella e dei suoi due amori ai tempi del fascismo e della guerra.
giu 222022

Questo libro della scrittrice canadese, premio Nobel per la letteratura nel 2013, è una raccolta di 9 racconti. C'è del vitalismo più o meno disperato nei racconti della Munro, che ha un tipo di scrittura che riesce ad aderire alla vita. Coincide, corrisponde perfettamente senza espedienti e infingimenti. Riesce a coinvolgere il lettore con la sua scrittura. Riesce a parlare con il cuore in mano. Uno dei maggior pregi nei testi è l'immediatezza, la scorrevolezza. La scrittrice ha uno sguardo profondo e partecipe sulla condizione umana, è una indagatrice della natura umana. Il suo stile è asciutto e impeccabile. Ogni suo racconto è un microcosmo. Nel primo Johanna riceve delle false lettere d'amore, ingannata da due ragazzine. Va a comprare un abito da sposa e la negoziante è soddisfatta di averglielo venduto perché così per quel giorno ha giustificato la sua esistenza. Tutto ciò fa pensare alla romana di Moravia secondo cui ognuno è ciò che fa. La commerciante aveva trovato la sua ragion d'essere, il suo motivo di esistere in una cittadina, che rappresenta qualsiasi mondo concentrazionario. Questa frase della Munro è già di per sé molto azzeccata e appropriata perché in America è davvero così: nella società utilitaristica, pragmatica, tutti devono avere un ruolo ben preciso, disegnato (altrimenti si finisce per essere come nella poesia disperata "College all'angolo della via" di Kenneth Patchen, in cui il protagonista non è mai stato niente, nemmeno soldato). È un dramma in America non fare niente, non occuparsi di niente. La Munro lo esprime molto bene in una sola frase, messa in bocca a una negoziante in crisi con scarsa clientela. Nel racconto "Ponte galleggiante" Jinny, donna sposata e malata di tumore, riesce a ravvivare l'esistenza baciando un ragazzo. In "Conforto" Nina ha una doppia vita e si divide tra il marito padrone e l'amante. Ma forse il racconto che rende meglio l'intensità, il dolore e la drammaticità della vita è "The Bear Came Over the Mountain", in cui viene descritta la relazione tra un marito ed una moglie, che sta perdendo la ragione. Viene insomma trattato il tema della demenza senile. E la domande che sorgono spontanee sono che cosa resta della persona dopo l'insorgenza della malattia e cosa resta conseguentemente dell'amore tra i due. Questo racconto ha avuto una trasposizione cinematografica: Away from Her (Lontano da lei), diretto da Sarah Polley. La Munro sembra un fiume in piena. I suoi testi non sembrano pensati e ripensati, corretti e modificati. Sembrano tutti pubblicati alla prima o al massimo alla seconda stesura. Se sono stati modificati molto probabilmente ha tolto e non aggiunto perché in questi racconti si tratta di levare più che di battere. Non bisogna guardare quindi alla forma mentis dell'autore. D'altronde in un romanzo o in una raccolta di racconti non bisogna cercare le congetture filosofiche, le digressioni pseudo-psicanalitiche o le descrizioni di paesaggi o città. Tutto ciò annoia a lungo termine. Bisogna cercare invece chi riesce a raggiungere la vita o quantomeno si sforza di farlo.

La Munro riesce a descrivere gli eventi, a riportare casomai le conversazioni e a narrare gli stati d'animo nel modo più realistico possibile. Allo stesso tempo dimostra di avere una invidiabile capacità introspettiva. Molti romanzi, anche dei capolavori, se li paragono ai racconti della Munro, mi sembrano artefatti. La scrittrice canadese forse era così vitale ed esuberante con la penna perché nella realtà la vita sfuggiva di mano. Forse è questo il motivo: nella realtà non era assolutamente padrona della sua vita, che forse sembrava seguire logiche e automatismi inspiegabili. D'altronde tutto questo è comprensibile perché il vitalismo è sempre stato contrapposto al meccanicismo. La Munro è intellettuale, lucida e sobria. Il suo vitalismo non è fittizio ma è sempre autentico. Non c'è niente di posticcio. Un'altra cosa che mi piace della Munro è che non si è messa a studiare la vita in modo calcolatore e a tavolino ma sembra perfettamente che si sia messa a narrare in modo occasionale. Sembra che abbia vissuto le sue peripezie e ogni tanto abbia fatto una pausa tra una fatica e un'altra per annotarla sul suo taccuino. La scrittrice ci racconta la vita quotidiana con i suoi drammi ed allo stesso tempo non crea altre realtà: è testimone Impareggiabile delle sua epoca, restituisce senza sconti e senza finzioni la cruda verità umana. Dramma dopo dramma purtroppo l'esistenza diventata tragedia. La vita sembra scorrere tranquilla fino all'evento irreparabile, al guasto irreversibile. È questo forse il messaggio. La Munro riesce a narrarlo magistralmente nelle più svariate sfaccettature. Riesce a fornirci una visione altra della vita, che erompe dal contingente. Tutto questo non è poco. Anzi è merce rara in un libro di narrativa.
I romanzi per molti hanno una sovrastruttura intellettuale e un intreccio che i racconti non avranno mai. Per molti i romanzi comprendono una maggiore cura nel descrivere ambienti e personaggi, soprattutto nel delineare la psicologia dei personaggi. Ogni racconto della Munro invece è un romanzo in miniatura. Lo scrittore Aldo Busi spesso ha dichiarato che in Italia esistono molti poeti, molti scrittori di racconti ma pochi sono i veri romanzieri. Molti artisti secondo Busi sarebbero dei romanzieri mancati. Il romanzo, facendo queste considerazioni, sarebbe quindi più complesso di una raccolta di racconti: più complesso da scrivere, da leggere, da analizzare, da recensire. Necessiterebbe di una sovrastruttura e di una architettura. Ma poi ne siamo così sicuri? Ad esempio "Casa d'altri" di Silvio D'Arzo (pseudonimo) che cosa è esattamente? Un racconto lungo? Un romanzo breve? Un ibrido particolarissimo? Una eccezione che conferma le regole suddette? Ai letterati e ai critici letterari l'ardua sentenza. Ma perché disprezzare il racconto? Perché considerarlo un genere minore? Non suscita forse emozioni? Non fa scaturire riflessioni e pensieri? Una raccolta di racconti fantastici non può trattare di universi paralleli come un romanzo di fantascienza? Una raccolta di racconti non può forse essere un'opera aperta? Non può essere un'opera di avanguardia? Non può trattare tematiche importanti? Non può far vedere le cose da una prospettiva insolita? Non ci vuole forse anche una certa abilità nello scrivere racconti? Inoltre c'è anche chi sostiene che il romanzo non abbia più un senso. Già le avanguardie avevano decretato la morte del romanzo. Secondo Milan Kundera la morte del romanzo è già avvenuta e nessuno ne è rimasto colpito o scandalizzato. Il romanzo secondo il famoso scrittore rappresenta la complessità del mondo e dell'esistenza; i mass media che invece dominano il pianeta tendono a dare una visione univoca e ipersemplificata della vita. In buona parte dei casi il racconto probabilmente è una storia breve. Uno dei maestri indiscussi del racconto nel novecento è R. Carver. Naturalmente i racconti fantastici di Borges sono esemplari. Ma sono particolari: anzi, oserei dire unici nel loro genere. Sono però da leggere anche i racconti di S.Beckett e di Salinger ("I nove racconti"). Parlo sempre di autori del Novecento. In Italia invece i grandi scrittori di racconti sono a mio parere Dino Buzzati ("I sessanta racconti), Cesare Pavese ("Feria d'agosto", "Fallimenti"), Silvio D'Arzo ("L'aria della sera e altri racconti"), Giorgio Manganelli ("Centuria"), Del Giudice ("Il museo di Reims"), Italo Calvino ("Ultimo viene il corvo"), Antonio Delfini ("Il ricordo della Basca"), Tommaso Landolfi. Comunque questi sono gli autori che bisogna leggere e con cui bisogna fare i conti se si vuole iniziare a scrivere o solo a capire qualcosa di racconti. Discorso a parte merita Silvio D'Arzo, molto stimato dalla critica letteraria e anche da Montale, che in vita pubblicò solo tre libri senza alcuna gloria e fu un anonimo professore. Morì a soli trentadue anni. Altro discorso a parte anche per un altro irregolare delle patrie lettere: Antonio Delfini, che riuscì a passare alla storia anche come poeta irriverente e al di fuori della retorica e degli stilemi del tempo. Con il suo capolavoro "Poesie della fine del mondo, del prima e del dopo" riuscì nell'impresa di scrivere un anticanzoniere. La donna un tempo amata non era più idealizzata e neanche mitizzata, come avevano fatto per secoli in poesia e nella letteratura. Fino a pochi anni fa esisteva il premio Antonio Delfini che era dedicato alla poesia. Oggi non ho più notizie di questo premio, un tempo prestigioso. Comunque sembrerebbe che con il passare degli anni di questo singolare personaggio anticonformista sia rimasto più il poeta che lo scrittore. La Munro sicuramente va letta assieme a questi scrittori sopracitati. Purtroppo però il Nobel alla Munro, che è una delle migliori scrittrici del mondo di racconti brevi, non ha determinato una ripresa della lettura e quindi un aumento di vendite di raccolte di racconti in Italia. Purtroppo qui in Italia il genere dei racconti è considerato frutto di un'arte minore. Un pregiudizio che porta anche le case editrici a pubblicare poche raccolte di racconti, di solito solo di autori già affermati. Questa è un'amara constatazione di fatto, è pura realtà, non certo un'opinione.
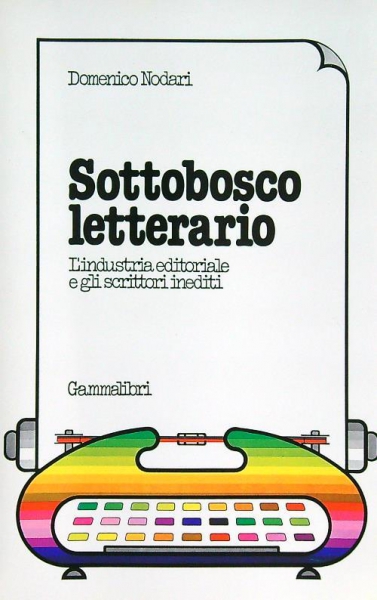


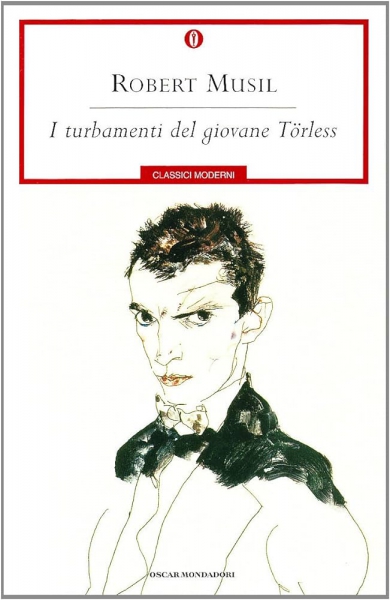

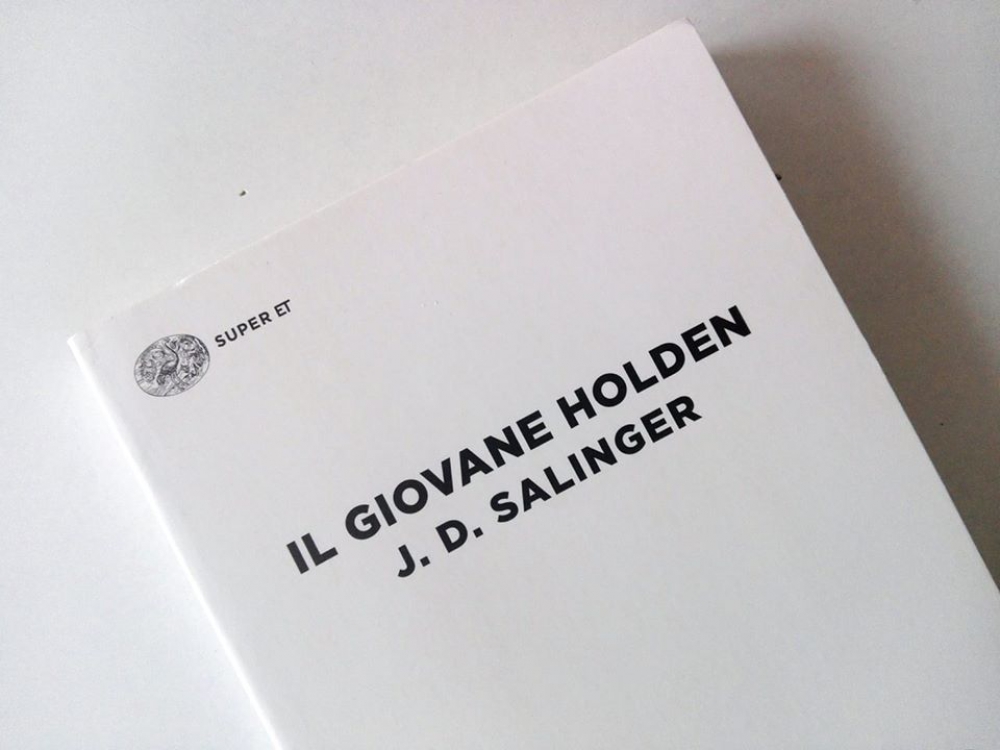
_0_o.jpg)
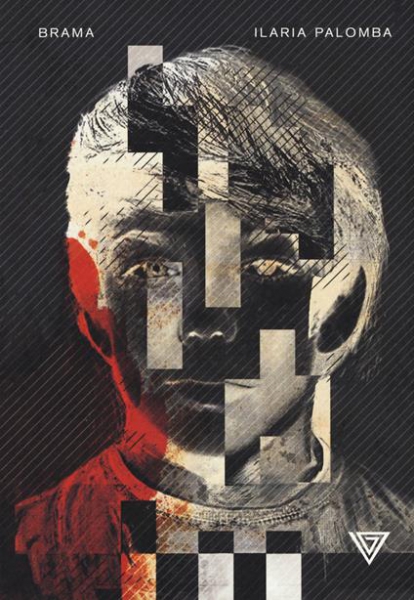
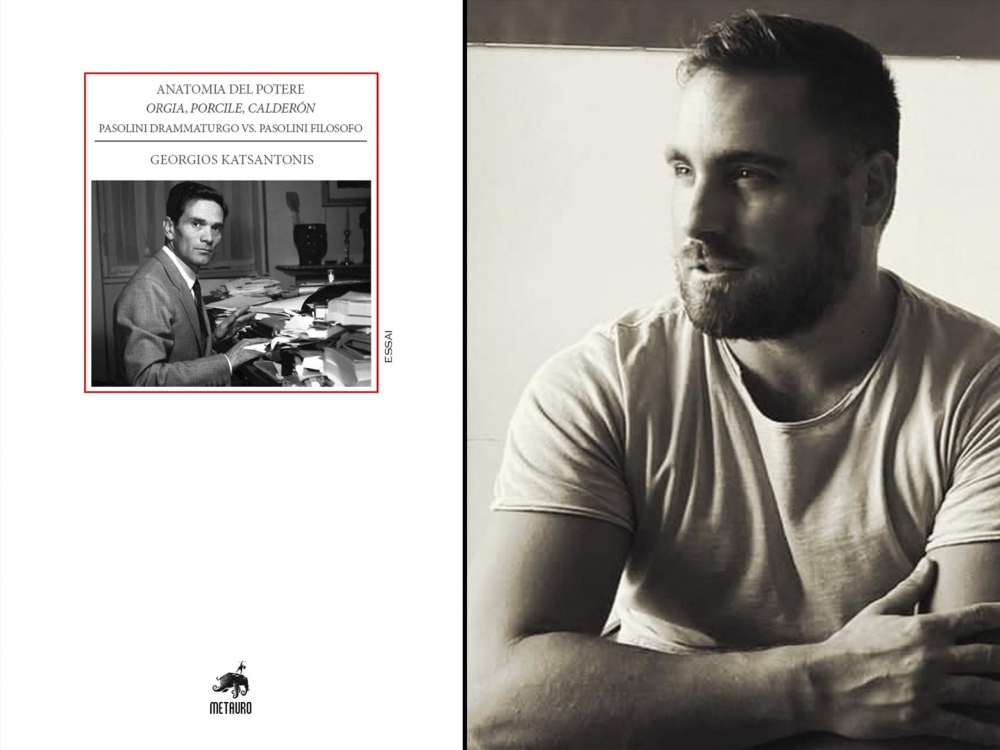




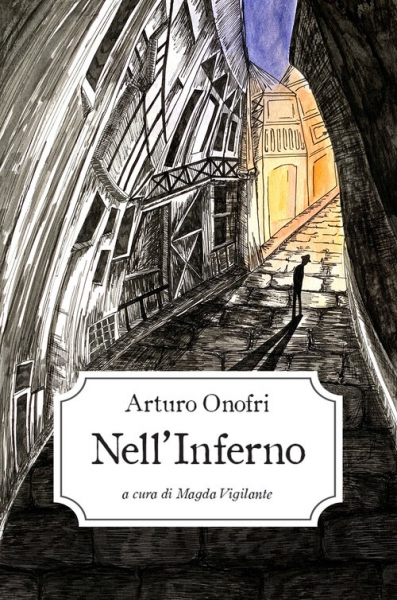


altmann-zweigandrothinostendin1936(cropped)1_0_o.jpg)