
Nella categoria: HOME | Letteratura e... altro
• Introduzione
• I giochi
• Soluzioni
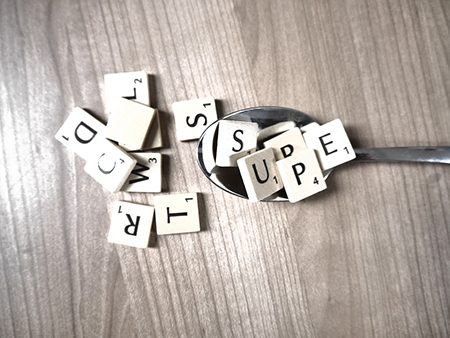
Un po' di tempo fa capitava di vedere in televisione delle trasmissioni dove il gioco proposto non era uno dei quiz attuali, fatti di domande che rasentano l'assurdo e dove la posta in palio sono molti soldi, ma dove si giocava a formare delle parole con delle lettere estratte a sorte, in un tempo prestabilito. Questo gioco era Paroliamo. Ma i giochi di parole (o con le parole) non sono nati nel nostro secolo e tanto meno con l'avvento della televisione. Infatti si è cominciato a giocare con le parole probabilmente subito dopo che l'uomo ha familiarizzato efficacemente con il linguaggio. Si narra che questo tipo di giochi veniva fatto dopo un lauto pasto, dove i commensali si sfidavano a vicenda al ritmo di indovinelli abbastanza primitivi. Dagli indovinelli rudimentali si è passati a degli enigmi più raffinati, ma che venivano utilizzati solo dai personaggi più potenti (stregoni, oracoli, indovini), i quali producevano testi così ambigui che riuscivano a coprire i diversi casi del destino che si sarebbero potuti verificare. I giochi di parole appassionavano anche i personaggi più potenti: il re Salomone si dilettava negli enigmi posti dalla regina di Saba, risolvendoli tutti.
L'enigma più conosciuto è senz'altro quello che la Sfinge - animale con testa di donna, ali di aquila, corpo di leone e coda di drago - propose a Edipo:
"Qual è quell'animale che al mattino cammina con quattro zampe, a mezzogiorno con due e alla sera con tre?"
Il giovane re vide soccombere la sfinge quando risolse l'enigma. Ma la sfinge non è la sola creatura che muore per gli enigmi: un caso eclatante è quanto si narra riguardo ad Omero. L'autore dei più importanti poemi della Grecia antica sembra sia morto di collera per non aver saputo risolvere un indovinello che gli era stato posto da alcuni pescatori: il poeta cieco chiese cosa stessero facendo e loro risposero:
"Quel che abbiamo preso lo lasciamo, quel che non abbiamo preso lo teniamo"
Il famoso favolista greco Esopo invece, proponeva domande del tipo:
"Ditemi quale cosa ognuno desidera raggiungere, ma se viene data immediatamente nessuno la vuole?"
I Romani, da parte loro, possedettero i Libri Sibillini, scritti profetici redatti in forma enigmatica, dei quali ormai rimangono pochi frammenti. Greci e Romani condividevano l'usanza di dare un bicchiere a colui che rispondeva ad un quesito: pieno di vino in caso di risposta corretta, di aceto in caso contrario.
Quasi istintivamente viene associata al Medioevo l'idea di periodo buio del sapere, in realtà esso ne è stato sia conservatore che seme di ulteriore sviluppo. Infatti basta ricordare il minuzioso lavoro svolto dai monaci che, ricopiando manoscritti altrimenti destinati all'oblio, hanno permesso, ancora oggi, di leggere i testi degli autori dell'antichità. In questo periodo le autorità ecclesiastiche cercavano di convincere il popolo che vi fosse davvero un arcano legame fra le parole del clero e i fatti che pretendevano di spiegare. Così, proprio nel Medioevo, si scoprono dei legami fra singole parole ed espressioni piene di significato religioso, per far credere alle persone meno istruite che coloro che mostravano di conoscere i segreti di questi legami fossero come dotati di poteri eccezionali.
La nascita dell'Italiano pare risalire ad un indovinello dell'VIII o IX secolo d.C. L'indovinello potrebbe essere il seguente: Boves se pareba, alba pratalia araba et albo versorio teneba et negro semen seminaba. La traduzione è la seguente:
| Boves se pareba | Spingeva innanzi i buoi (le dita della mano) |
| alba pratalia araba | arava prati bianchi (fogli di carta pergamena) |
| et albo versorio teneba | e teneva un bianco aratro (una piuma d'oca, per scrivere) |
| et negro semen seminaba | e seminava un nero seme (l'inchiostro) |
Anche Carlo Magno corrispondeva coi suoi cortigiani più affezionati con una vera sfida intellettuale scandita da indovinelli spesso basati su fatti e personaggi noti solo agli interessati.
Con un salto di qualche secolo incontriamo Leonardo da Vinci il quale coniugò con successo scrittura e disegno diventando un precursore del rebus, già noto, però, agli antichi Egizi sotto forme differenti. Con Giulio Cesare Croce - autore di "Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno" - gli enigmi ricompaiono di diritto come sfide rivolte a tutti e senza alcuna intenzione di ingannare i meno istruiti i quali, anzi, sembrano dar del filo da torcere a re e regine coi loro arguti indovinelli. Passato il Medioevo, gli indovinelli iniziano ad avere doppi sensi sempre più audaci, mascherati da una soluzione innocente.
Nasce la sciarada e si viene sempre più affermando l'idea che l'Enigmistica necessiti di regole precise pena la produzione di giochi banali o, all'opposto, eccessivamente difficili. Così, siamo al XX secolo, scompaiono gradualmente i giochi che non rispettano le regole che gli enigmisti cominciano a darsi. Compare il cruciverba che si diffonde rapidamente e ben presto diventa nella mente di molti il simbolo stesso dell'Enigmistica; in realtà esso è un figlio considerato degenere.
Per un letterato la scelta della parola più adatta al contesto, quella più ricca di significato per rappresentare al meglio la situazione narrata o descritta è una difficoltà con cui si deve scontrare quotidianamente. Le parole però nascondono oltre che i vari significati posseduti, anche una "caratteristica speciale" che è data proprio dalle lettere con cui sono composte: a seconda di come vengono combinate le lettere per formare una parola, si possono ottenere interessanti risultati. Quando una parola è composta dalle stesse lettere di un'altra, poste in un ordine diverso, allora si dice che l'una è l'anagramma dell'altra e viceversa. Alcuni esempi:
cielo = liceo
teatro = attore
cretino = incerto
calendario = locandiera
Come dice Stefano Bartezzaghi, "attraverso l'anagramma si può praticare una metamorfosi all'interno di una singola parola: ogni volta le lettere sono le stesse, cambia solo la disposizione e da una quantità limitata di elementi (le lettere) si può dar vita a molti oggetti diversi, secondo l'algebra delle permutazioni". Ovviamente questo gioco può essere esteso a più parole o a frasi intere. Molti si divertono a trovare gli anagrammi del proprio nome e cognome, oppure di quello di personaggi famosi:
Platone = talpone = Lepanto =
polenta = pentola
Roma = amor = mora = orma = Omar = armo
l'arte della ceramica = le Terme di Caracalla
bibliotecario = beato coi libri
Carol Voitila = l'alto vicario
A noi hanno insegnato a scrivere partendo da sinistra e andando verso destra. In altre culture, invece, la scrittura va da destra verso sinistra (gli ebrei e gli arabi scrivono così) e in altre ancora si scrive verticalmente. Nell'antichità, addirittura, la scrittura seguiva l'andamento dei buoi durante l'aratura di un campo: arrivati al margine della pagina seguendo, ad esempio, la direzione da sinistra verso destra, si scriveva tornando "indietro", e cioè da destra verso sinistra. Ci può venir voglia, allora, di leggere le parole al contrario, partendo da destra; che cosa succede? Quando si legge una parola al contrario, nella maggior parte dei casi quello che si ottiene è una parola senza senso: questo è un problema dell'italiano, dove quasi tutte le parole cominciano per consonante e finiscono per vocale e quindi una parola che comincia per vocale e finisce per consonante difficilmente avrà un senso.
Esistono però dei casi notevoli di scrittura
rovesciata: la lettura da destra verso sinistra di una parola produce
un'altra parola di senso compiuto, come nel caso di OSSA che diventa
ASSO. Un altro caso interessante è il fatto di considerare
la parola OSSO, al posto di ossa. Cosa succede se la parole viene
letta in senso contrario? La parola rimane invariata e si ottiene
di nuovo OSSO.
In enigmistica questi due casi di lettura rovesciata della parola
vengono chiamati in due maniere differenti: il primo caso è
il bifronte; il secondo è il palindromo. Sembra che gli enigmisti
siano pignoli a chiamare due cose praticamente uguali con un nome
diverso, ma in realtà la distinzione di nomenclatura è
giustificata dal fatto che un palindromo è una parola sola,
mentre un bifronte è una coppia di parole; inoltre si dice
che una parola è (o non è) un palindromo e che una
parola ha (o non ha) un bifronte. Alcuni esempi:
non (palindromo)
ossesso (palindromo)
ingegni (palindromo)
avara/arava (bifronte)
essere/eresse (bifronte)
Anche in questo caso in enigmistica esistono frasi e testi che possono essere letti al rovescio, ad esempio ai lati d'Italia oppure ora per poi io preparo. L'esempio più importante e anche il più straordinario, però, è una frase latina: Sator Arepo tenet opera rotas, in voga nel Medioevo. La sua traduzione è la seguente:
| SATOR | Il seminatore, cioè Dio |
| AREPO | sul suo carro (Arepo, di origine celtica, significa carro) |
| TENET | dirige |
| OPERA | con perizia |
| ROTAS | le ruote, cioè le orbite dei corpi celesti |
Quello che c'è di straordinario in queste cinque parole è che possono costituire un quadrato magico, nel quale l'intera frase si può leggere partendo o dalla lettera posta in alto a sinistra, oppure dalla lettera posta in basso a destra, prendendo una qualsiasi direzione (verticale o orizzontale).
| S | A | T | O | R |
| A | R | E | P | O |
| T | E | N | E | T |
| O | P | E | R | A |
| R | O | T | A | S |
Il quadrato magico è un gioco enigmistico e può essere considerato il progenitore del cruciverba. Come già detto nell'introduzione storica, il cruciverba si è rapidamente diffuso ed è diventato un simbolo inconfutabile dell'enigmistica (intere riviste sono dedicate esclusivamente a lui, con tutte le varianti possibili). Ma perché il cruciverba ha avuto così tanto successo? Senz'altro è un gioco che possono fare tutti, senza essere espertissimi di enigmistica, inoltre permette di essere risolto senza seguire un particolare percorso ideato dall'autore, contrariamente ai giochi classici (indovinelli, enigmi, sciarade e simili) che hanno un percorso obbligato, talvolta pure difficile, quindi poco adatto ad intrattenere chi desidera semplicemente rilassarsi un po'.
Nella lingua si possono trovare legami molto stretti tra parole, in quanto sono costituite praticamente quasi dalle stesse lettere poste nel medesimo ordine, ma dal punto di vista del significato, queste non hanno niente a che vedere l'una con l'altra. Stiamo parlando dei falsi alterati. Questo gioco si fa soprattutto con i bambini quando frequentano le prime classi della scuola elementare, dove l'insegnante li avverte che quando si scrive o si parla sono sempre in agguato gli errori. Ecco alcuni esempi:
burro -> burrone (falso accrescitivo)
matto -> mattone (falso accrescitivo)
vago -> vagone (falso accrescitivo)
matto -> mattino (falso diminutivo)
tacco -> tacchino (falso diminutivo)
paglia -> pagliaccio (falso peggiorativo)
foca -> focaccia (falso peggiorativo)
Uno scrittore dovrebbe sapere che le parole possono nascondere altre interessanti caratteristiche. In letteratura, specialmente in poesia, molti autori si prendono delle licenze poetiche creando parole come pié (sta per piede), amor (sta per amore) ecc. Ebbene le parole si possono distruggere, spezzare e riattaccare insieme in maniera diversa. In enigmistica il gioco che fa al caso nostro è la sciarada che, scelta una parola, la divide in due o più tronconi, per trovare altre due (o più) parole di senso compiuto. Ecco alcuni esempi:
muti/lato = mutilato
tram/poli = trampoli
con/tanti = contanti
Quando si fa una sciarada bisogna stare attenti
a dove dividere la parola, in maniera tale da ottenere sì
parole di senso compiuto, ma che non hanno attinenza con la parola
di origine: ad esempio la coppia piano/forte forma pianoforte, ma
questa non è una sciarada in quanto le tre parole hanno attinenza
tra di loro (in generale funzionano così tutti i nomi composti).
Anche stesse etimologie non sono considerate valide: ad esempio
equi/libri = equilibri non è una sciarada perché nella
parola equi c'è l'idea di equità, che sta alla base
della parola equilibri.
La sciarada è uno dei giochi dell'enigmistica più
antichi e da essa derivano tutti gli altri giochi che spezzano e
ricompongono le parole come lo scarto, la zeppa, l'incastro, il
lucchetto e tanti altri.
Fin qui abbiamo parlato di giochi che possono essere fatti esclusivamente con le singole parole o al massimo con una frase. Vediamo adesso come le potenzialità della letteratura entrano a far parte dei giochi enigmistici. Prendendo una qualsiasi rivista di enigmistica, i giochi come la sciarada (e tutti i suoi derivati), l'anagramma ecc. sono rappresentati attraverso un componimento poetico di pochi versi, dove spesso compare anche la rima. In questi testi sono presenti le parole che determinano la soluzione del gioco e vengono indicate con delle incognite al posto delle lettere. Un esempio:
Sciarada (4/5 = 9)
Alla governante di Artù piacciono i cartoni animati
"Vi prego, non arrabbiatevi,
xxxx,
se oggi la reggia non è linda e yyyyy.
Il mio dovere era di pulire
Ma ho visto tutto il dì "La Xxxxyyyyy"".
Dal punto di vista letterario, tralasciando il significato del gioco, il poemetto è sgradevole per il fatto che compaiono le incognite. Possiamo allora costruire dei testi dove non compaiono le indicazioni delle parole, utilizzando delle parole che celino vari significati, tra tutti le parole della soluzione. Vediamo come si coniugano perfettamente strutture letterarie con i giochi enigmistici. Consideriamo il seguente testo:
La bambina ha tardiva dentizione
Si mangia le parole e le trattiene
fra i labbri; ma il suo dire non è privo
di senso e un po' sospesi sol ci tiene;
credo che stia mettendo un incisivo.
(Odisseo)
È facile riconoscere questo componimento come una poesia di una sola strofe. Precisamente si tratta di una quartina di versi endecasillabi, con una rima alternata (ABAB). Siamo sicuri che si tratti di un gioco enigmistico? Sì, è un gioco. Non è una sciarada come nell'esempio precedente, ma è un indovinello. Un tempo si diceva: "Indovina, indovinello.... " e si andava sul sicuro: quello che si stava per pronunciare era un indovinello. Invece questo testo ha ben poco dell'indovinello. Per fortuna le riviste del settore scrivono esplicitamente che si tratta di questo gioco.
Nell'indovinello è presente una certa sfida tra l'autore ed il solutore, una sfida che si fa sempre più marcata, finché non si tratta più di un indovinello, ma di un vero e proprio enigma. Sia l'enigma che l'indovinello sono interrogazioni espresse in un linguaggio allusivo (o perché vago, o perché ambiguo o allegorico), a cui l'interlocutore deve saper rispondere sciogliendo l'allusione. Sono enigmi i componimenti che si trovano soprattutto nella mitologia, nella religione, nel genere tragico: l'enigma più famoso è senz'altro la domanda della Sfinge che alle porte di Tebe poneva a chi volesse entrare nella città; mentre sono indovinelli i testi che troviamo nella cultura popolare e nel folklore.
Sempre citando Stefano Bartezzaghi: "gli indovinelli che vengono fatti oggi nell'ambito dell'enigmistica contemporanea sono molto differenti da quelli antichi. Si distinguono dagli enigmi perché gli indovinelli hanno un tono spiritoso e sono racchiusi in una quartina o in una sestina. Gli enigmi sono invece poesie un po' più lunghe e di tono lirico o comunque stilisticamente sostenuto: l'enigma utilizza le possibilità espressive della poesia e i suoi fini"; un esempio:
Fuga
Addio, monti sorgenti dall'acque,
ombre azzurre emergenti
dai piani sconfinati
dorsali imponenti, massicci
sporgenti sugli abissi,
addio, alti zampilli ricadenti
sulle gole profonde.
La crudeltà e l'avidità
degli uomini
ci cacciano lontano,
uomini armati hanno sconvolto
l'ordine della nostra vita.
E noi fuggiamo, tenendo il respiro,
con un brivido freddo nel sangue,
sentendoci morire
con un'acuta fitta che ci tortura,
ingoiando l'amaro
senza parole.
E dunque addio, famiglia sperata,
inermi creature da proteggere
che nessuno potrà abbracciare,
che non vivrete mai su questa terra.
Vi estinguerete pian piano,
candide fantasie solo sognate
e sommerse fra le chimere,
lontane visioni, illusioni
di isole.
(Maria Fagnani Failla)
Come si vede il punto di partenza di questo enigma
è la frase del Manzoni. Una volta che si è stabilito
ciò, ci si chiede che cosa la scelta può rappresentare
in modo enigmistico. Qui l'autrice ha pensato alle balene ed ha
fatto un enigma proprio sulle balene. Infatti è una bella
analogia quella tra monti e balene e su di essa gioca tutta la prima
strofe: i monti sono in mezzo a piani sconfinati proprio come le
balene che stanno in mezzo ai mari; sia i monti, sia le balene hanno
dorsali imponenti e si sporgono su abissi (che possono essere senza
ombra di dubbio i crepacci delle montagne in un caso e le profondità
marine nell'altro). Gli zampilli fanno ricordare le sorgenti di
alta montagna e gli spruzzi in aria delle balene quando respirano.
Nella seconda strofe cambia la scena e si presentano delle persone
in fuga, come nei Promessi Sposi dove Lucia deve fuggire per andare
a rifugiarsi presso la Monaca di Monza. In questa strofe le balene
sono considerate come prede, ovvero sono animali cacciati. Nell'espressione
acuta fitta c'è tutto il senso atroce e drammatico della
caccia: in primo luogo essa è un forte dolore, in secondo
luogo rappresenta l'arpione dall'acuta punta che si conficca nelle
balene.
Nella terza strofe si passa alla seconda persona plurale e il tema
dominante è di nuovo l'addio: un addio dovuto, stavolta,
all'estinzione che minaccia la famiglia (nel senso tassonomico)
delle balene. Le creature che nessuno potrà abbracciare non
sono bambini destinati a non nascere, ma cetacei un po' troppo voluminosi
per essere stretti fra le braccia; e se non vivranno mai su questa
terra è perché le balene sono creature marine. Nel
finale le balene che rischiano di estinguersi, sono poi viste in
lontananza con gli occhi del sogno e della fantasia: sono bianche,
come in Moby Dick, e sembrano quasi il miraggio di un'isola.
A conclusione di questo articolo, propongo le soluzioni degli enigmi presenti in questo testo.
La risposta all'enigma della sfinge è l'uomo: quando nasce (al mattino) cammina carponi e quindi ha quattro zampe; quando è giovane (di giorno) cammina eretto e quindi ha due gambe; quando è vecchio (la sera) cammina con tre gambe, perché la terza è il bastone a cui si appoggia.
Omero si è lasciato morire perché non ha saputo rispondere ai pescatori. La risposta a questo enigma è i pidocchi: i pescatori si stavano spidocchiando e quelli che prendevano li buttavano via, mentre dovevano tenersi addosso quelli che non riuscivano a prendere.
Ad Esopo bisogna invece rispondere con la vecchiaia: una persona non vede l'ora di diventare adulto, ma se si cresce in fretta si ha il rimpianto della giovinezza.
La sciarada qui presentata ha questa soluzione: sire/netta = Sirenetta.
L'indovinello di Odisseo non parla certamente di una bambina che sta mettendo i primi denti: mangiarsi le parole è chiaramente una metafora, così come lo è la parola labbri; mentre sotto sospesi e incisivo ci deve essere un inghippo. La soluzione dell'indovinello è la parentesi: essa contiene una frase che non è priva di significato, ma lascia in sospeso gli ascoltatori e contribuisce per inciso al senso complessivo di quel che viene detto.
Bibliografia:
1. Federico Curcio, Giocare
con le parole in DEV n.78, Ponsacco, Gruppo Editoriale Infomedia,
2000.
2. Stefano Bartezzaghi, Lezioni di enigmistica, Torino,
Einaudi, 2001.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG