
Nella categoria: HOME | Letteratura e... altro
Quale rappresentazione di sé e del proprio “lavoro” lo scrittore offre nella sua opera? Quale il rapporto con il denaro? E quale la rappresentazione del lavoro manuale?
A queste domande le considerazioni che seguono intendono rispondere, partendo dall’analisi di testi prevalentemente poetici di Alfieri, Foscolo e Leopardi.

Nelle poesie di Alfieri e Foscolo lo scrivere è visto non come un’attività derivante da una libera scelta del soggetto, ma come un surrogato dell’azione, l’unica possibilità, in tempi iniqui e rei, per chi desideri lasciare traccia di sé, meritare fama. Nel sonetto CLXXXVI Alfieri prospetta per l’intellettuale, dunque per sé, la sola possibilità di liberare la patria oppressa con la “penna”, poiché il “brando” gli è precluso:
uom cui nel petto irresistibil ferve / Vera di gloria alta divina brama; / Nato in una contrada ove ad un sol si serve, / Come acquistar mai puossi eterna fama? / Dal volgo pria dell’alme a lui conserve / Si spicca, e poggia a libertà che il chiama, / Atterrandosi a l’ire e le proterve / Voglie del Sir, che la viltà sol ama. / Ma poi convinto, che impossibil fora / Patria trovar per chi senz’essa è nato, / Benché lungi, al suo nido ei pensa ognora. / Liberarlo col brando non gli è dato: / Con penna dunque in un se stesso onora / E a’ suoi conoscer fa lor servo stato
Foscolo, nel suo autoritratto, si dichiara “spesso di man prode”, e solo “talor di lingua”, anche se nel sonetto XII escluderà ogni alternativa, dichiarando “a chi altamente oprar non è concesso / Fama tentino almen libere carte”.
Anche Leopardi, il cui stile di vita si distacca nettamente da quello dei due precedenti autori, ribadisce il carattere compensatorio della scelta della scrittura, infatti:
… se il soggetto principale delle lettere è la vita umana, il primo intento della filosofia l’ordinare le nostre azioni; non è dubbio che l’operare è tanto più degno e nobile del meditare e dello scrivere, quanto più è nobile il fine che il mezzo e quanto le cose e i soggetti importano più che le parole e i ragionamenti. Anzi niun ingegno è creato dalla natura agli studi; né l’uomo nasce a scrivere, ma solo a fare. Perciò veggiamo che i più degli scrittori eccellenti, e massime de’ poeti illustri, di questa medesima età; come a cagion d’esempio, Vittorio Alfieri; furono da principio inclinati straordinariamente alle azioni; alle quali, ripugnando i tempio, e forse anche impediti dalla fortuna propria, si volsero a scrivere cose grandi…
[Il Parini, ovvero della gloria, in Operette morali]
Addirittura, secondo Leopardi, la scelta dello studio e dell’attività intellettuale:
… non è secondo natura degli uomini, non si può seguire senza pregiudizio del corpo, né senza moltiplicare in diversi modi l’infelicità naturale del proprio animo…
La scelta della scrittura sembra determinare, comunque, in tutti e tre gli autori una netta contrapposizione rispetto alla società: nelle loro poesie Alfieri e Foscolo raffigurano se stessi “in fuga” dal “secol”, e, poiché questo è vile e reo, la fuga acquista il significato di una condanna morale. Anche nei Canti leopardiani emerge la consapevolezza della diversità rispetto agli altri, diversità che è però prevalentemente segnalata dall’essere il poeta in uno spazio delimitato, chiuso o rialzato (la finestra, il balcone/verone) rispetto allo spazio degli altri: al poeta non resta che mirare/guardare – gli è preclusa la possibilità di “essere mirato” (cfr. Passero solitario). Che anche questa dislocazione non sia priva di valenze morali è evidente: quella del poeta è comunque una posizione privilegiata – anche se, forse, dolorosamente – e, in quanto tale, permette una visione dall’alto, come in modo esemplare suggerisce l’immagine del passero solitario.
I tre scrittori, pur nella diversità del temperamento e delle rispettive situazioni sociali e politiche, spiegano la loro scelta: è la realtà opprimente che, non consentendo ad animi grandi l’azione, lo costringe alla scrittura, alla ricerca intellettuale. Sembrerebbe profilarsi una precisa gerarchia in cui il primo posto spetta all’azione, alla prassi, tanto che chi se ne distoglie per la ricerca e la scrittura deve, in certo modo, giustificarsi. Nonostante questo (o proprio per questo?) la scelta assume una dimensione eroica e determina una “diversità” rispetto a quanti, invece, continuano a dedicare tempo ed energie prevalentemente all’azione.
La coscienza di una radicale diversità rispetto alla società e di una sofferta emarginazione è particolarmente lucida in Leopardi, che sembra precorrere i tempi, anticipando tematiche che saranno proprie del decadentismo. Ma la collocazione storica e culturale non giustifica tale accostamento: si tratta, in realtà, di una problematica dalle radici diverse e più antiche, se già Platone aveva contestato ai poeti l’utilità della loro esistenza all’interno della città, tanto da prospettare l’esclusione dalla sua Repubblica dei poeti tragici ed epici (PLATONE, Repubblica, libro X).
Il quadro si complica ulteriormente se ad un generico riconoscimento di un proprio ruolo o funzione all’interno della società si accompagna la richiesta-necessità di un riconoscimento monetario. Alfieri può rivendicare la propria estraneità al sistema, addirittura cedendo alla sorella i propri beni – conservandone però quanto gli è necessario per vivere – e dunque proclamando la propria non assimilabilità ed eccezionale libertà:
…mie sostanze intere / Furate a me, me di più Fama ricco / Facciano, e in un mie voci ognor più vere. / Così due volte dal mio Aver mi spicco, / E la mia libertà con me sol pere / Nel fango i vili intanto al suo conficco”.
[I versi sono tratti sal sonetto LXXVI; “sostanze due volte furate” : il poeta è costretto, per avere l’esenzione dagli obblighi verso il Re di Sardegna e libertà di movimento, a cedere i beni alla sorella; una “seconda volta” i suoi beni gli furono sottratti temporaneamente, agli inizi della Rivoluzione francese]
Può in tal modo giungere a consigliare ai “…grandi ingegni che per ingiustizia di fortuna si trovano ad essere nati poveri … a desistere dall’impresa dello scrivere, e a cercare altri mezzi per campare” (V. ALFIERI, Del Principe e delle lettere, II, 1°).
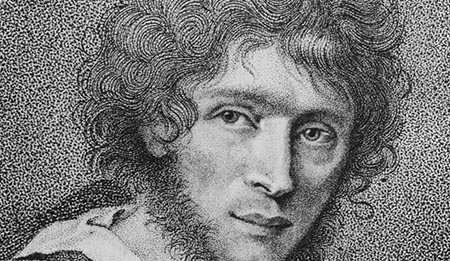
Più sfumata, anche per la diversa situazione personale, la posizione – teorica – di Foscolo che, ad esempio, apprezza l’esistenza in Inghilterra di un mercato librario, ma che, nella rappresentazione letteraria, continua a fornire l’immagine mistificante dell’intellettuale libero e soprattutto estraneo alle dinamiche sociali e alle necessità economiche. La lettera alla sorella del 4 ottobre 1823 (Lettera alla sorella Rubinia Molena da Londra, 4 ottobre 1823, in Epistolario, Firenze, Le Monnier, 1854, III, pp. 350-56), invece, testimonia, in maniera inequivocabile, le frustrazioni e le difficoltà di un uomo di lettere “cavallo generoso da corsa” costretto a procurarsi il necessario per vivere, “destinato a tirar barche” con il lavoro - sottopagato – intellettuale.
Anche il nobile Leopardi è alla ricerca di possibilità di guadagno, dichiara il proprio desiderio di un impiego retribuito, ma rifiuta le scarse offerte – compresa quella di una cattedra universitaria – adducendo pretesti vari:
… in quella materia io sono … un asino: e mettermi a fare uno studio fondato, per impararne quanto bisogna per insegnarla altrui, Dio sa quando mi sarà possibile con questa salute … L’altra difficoltà è quella della provvisione … quattro luigi al mese … al bisogno sono troppo poco: con meno di cinque luigi, io non sono potuto vivere in nessun luogo. E Parma alla fine è città capitale…
[Lettera a F. Maestri del 6 febbraio 1829]
Si lega, però, con un contratto di lavoro ad un editore, lo Stella di Milano, pur lamentadone il costo in fatica e in qualità (Lettera a Monaldo leopardi del 3 luglio 1622; lettera a F. Targioni Tozzetti, del 5 dicembre 1831). Impartisce anche lezioni private e, se al padre - che evidentemente esprime la sua disapprovazione – dichiara che “non vi è nulla di vile” (Lettera a Monaldo Leopardi del 10 ottobre 1825), al fratello Carlo, in una lettera scritta quello stesso giorno, confessa: “… quelle lezioni che mi sventrano la giornata mi annoiano terribilmente” (Lettera a Carlo Leopardi del 10 ottobre 1825).
Il mancato riconoscimento sociale e, perché no, monetario, allo scrittore è imputato da Leopardi al fatto che non viene riconosciuto alla scrittura lo status di lavoro: non si attribuisce infatti allo scrittore il possesso di abilità specifiche né l’impiego di tempo e fatica (Cfr. il Parini, ovvero della gloria, in particolare il cap. II). Se “… tutte le altre [facoltà] danno pane, molte di loro … onore anche durante la vita”, la poesia e la filosofia “le sommità dell’umano spirito, le più nobili e le più difficili cui possa applicarsi l’ingegno umano” non possono portare altro che “gloria e soltanto dopo la morte… Chi s’annunzia per medico, per legista, per matematico, per geometra, per idraulico, per filologo, per antiquario, per linguista, per perito anche in una sola lingua; il pittore eziandio e lo scultore e l’architeto, il musico … tutti questi son ricevuti nella società con piacere … Chi s’annunzia solo per poeta o per filosofo … non trova chi faccia caso di lui… La ragione si è che tutti credono essere filosofi, ed aver quanto si richiede a esser poeti, sol che volessero metterlo in opera…” (Zibaldone, 8 settembre 1823).
Proprio nell’ottica di una moderna valutazione della scrittura come lavoro è possibile leggere i versi 15/22 di A Silvia, in cui – è un caso? - le “libere carte” di Foscolo si trasformano in “sudate carte”. I versi:
Io gli studi leggiadri
Talor lasciando e le sudate carte,
Ove il tempo mio primo
E di me si spendea la miglior parte,
D’in su i veroni del paterno ostello
Porgea l’orecchio al suon della tua voce,
Ed alla man veloce
Che percorrea la faticosa tela.
testimoniano due operazioni da parte dell’autore, contrapposte e complementari: da un lato l’alleggerimento e la nobilitazione del lavoro manuale che può entrare, così, nella rappresentazione lirica (la stessa operazione di “alleggerimento” è ravvisabile nelle figure di lavoratori presenti in Il Sabato del villaggio); dall’altro, il riconoscimento al lavoro intellettuale dello status, appunto, di lavoro; riconoscimento attuato attribuendogli caratteristiche “fisiche”. Infatti il “sudore” che impregna le carte del poeta consente di vedere il lavoro intellettuale come “fatica” che però è abilmente spostata, tramite la metonimia, dal soggetto “lavorante” (che il “sudore” renderebbe troppo simile al lavoratore manuale) al “frutto” del lavoro, le carte; il lavoro, invece, effettivamente manuale e fisico di Silvia è “alleggerito”: oggetto dell’ascolto sono il “suono della … voce” e la “man veloce” (da notare il ritorno della metonimia); dal fatto che è la “tela” ad essere deformata dai segni della fatica. La correzione di “percotea” in “percorrea”, perciò, oltre alla memoria degli amati versi virgiliani (Eneide, VII, v. 14 “arguto tenuis percurrens pectine tela”) (Cfr. nota 21-22 al testo di A Silvia in Segre-Martignoni, Testi nella storia, vol. 3°, p. 603) può essere stata motivata anche dall’esigenza di rendere “leggera” l’operazione della tessitura, venendo completamente a mancare in “percorrea” l’idea dello sforzo e della fatica implicita in “percoteva”.

Il confronto con il linguaggio di Petrarca di cui la poesia – come gli interi Canti - è tramata, conferma lo spostamento semantico nelle due direzioni. Da un lato l’aggettivo “faticoso” riacquista in Leopardi un significato concreto e pregnante, mentre in Petrarca l’aggettivo – come il corrispondente sostantivo “fatica” – era usato per lo più in senso figurato. Dall’altro Leopardi utilizza il verbo “sudare” che ricorre una sola volta nel Canzoniere e descrive l’attività del dio Vulcano (il dio fabbro ed artigiano); infine l’espressione “ove il tempo mio primo / E di me si spendea la miglior parte” ha precisi riscontri in Petrarca (Cfr. sonetto CCXI: “così spendo ‘l mio tempo lacrimando”; sonetto CCCLIV: “Pentito e tristo de’ miei sì spesi anni, / Che spender si dovean in miglior uso”). Nel Canzoniere il verbo “spendere” ricorre 5 volte e in 4 occorrenze, come nei versi di Leopardi, ha per oggetto il tempo (gli anni, la notte, ecc.). Ma se in Petrarca il tempo è speso nell’inseguimento di un amore terreno, è, dunque, in un’ottica cristiana, sprecato, in Leopardi il tempo è speso nella scrittura: resta da vedere se è, anche in questo caso, sprecato.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG