
GIOSUE’ CARDUCCI
Il ricordo di Bologna
di Reno Bromuro
«Surge nel chiaro inverno la fosca
turrita Bologna,
e il colle sopra bianco di neve ride.
È l'ora soave che il sol morituro
saluta
le torri e l'tempio, divo Petronio, tuo»
Nella categoria: HOME | TOURismi letterari
• Biografia
• L'opera "Nella piazza di San Petronio"
• Testimonianze
• Critica
• Il luogo: Bologna
 Giosuè
Carducci nacque a Valdicastello una
frazione di Pietrasanta (Lucca), il 27 luglio
del 1835 da Michele, che esercitava la professione di
medico, e Ildegonda Celli, figlia di un orafo fiorentino.
Giosuè
Carducci nacque a Valdicastello una
frazione di Pietrasanta (Lucca), il 27 luglio
del 1835 da Michele, che esercitava la professione di
medico, e Ildegonda Celli, figlia di un orafo fiorentino.
Trascorse nella cittadina lucchese soli i primissimi anni della sua infanzia,
perché nel 1838 fu costretto a seguire il padre prima a Castagneto
poi a Laiatico. Ma Michele, nel 1849, con il ritorno del granduca di Toscana,
Leopoldo II, nella provincia, si sentiva isolato per
le sue idee mazziniane e quindi si trasferì a Firenze. E qui Giosuè
frequentò i primi studi presso la Scuola dei Padri
Scolopi di San Giovannino fino al 1852. Tra tutti gli insegnanti
fu attratto da Eugenio Barsanti e Geremia Barsotti
che gli trasmise l'amore per Orazio e Fantoni.
Ma già in precedenza egli aveva avuto benefici della biblioteca
paterna dei classici Omero, Virgilio,
Ovidio, oltre al poeta di Venosa, e
Alfieri, Leopardi, Foscolo
ma non disdegnando Giovanni Berchet, mostrava avversione
per il Manzoni. Nello stesso anno nacque "l'Accademia
dei Filomusi" di cui cofondatori furono Nencioni
e Gargani. È padre Barsotti nel 1853, a consigliargli
un concorso per un posto gratuito di convittore presso la "Regia
Scuola Normale di Pisa" che poi vinse. Il tipo di insegnamento
antiquato, lo colpisce in senso negativo ma nonostante ciò a soli
vent'anni si laurea in filosofia e filologia con una tesi sul poema cavalleresco.
È dell'anno seguente, il primo incarico operativo, è professore
di retorica presso una scuola di San Miniato al Tedesco (Pisa).
Proprio in quest'ambiente nacque il gruppo degli "Amici
Pedanti" che vide tra le sue fila i già citati
Nencioni e Gargani ma anche il Chiarini
e che rivendicava la virtus e vis classica contro i sentimentalismi
della seconda generazione romantica.
Sono anni travagliati e dolorosi quelli che seguono. Pubblicò presso
il Ristori di San Miniato le Rime.
Il 4 novembre del 1857 il fratello Dante si toglie la
vita, si dice, dopo un violento litigio col padre e il 15 agosto muore
suo padre Michele per malattia improvvisa. La sua condotta
si fa alquanto sospetta, tanto che deve cambiare ambiente e pur avendo
vinto nel 1857 la cattedra di greco al Ginnasio di Arezzo,
le sue idee repubblicano-giacobine e l'ateismo, dissuasero le autorità
toscane a non assegnargliela. Allora visse dai proventi di lezioni private
e dalle "cento lire toscane per tomo"
che gli derivavano dalla direzione della collana "Diamante"
presso l'editore Barbèra. Dopo tanto patire, un
evento felice rasserena l'animo rinfrancandolo, infatti, il 7 marzo del
1859 si sposa con la cugina Elvira Menicucci, il loro
amore era sbocciato molti anni prima. Adesso si apre una nuova stagione
nella vita di Giosuè, è nominato professore di latino e
greco nel liceo di Pistoia. Ma è nel 1860 che
compie il miglioramento ed è nominato dal Ministro
della Pubblica Istruzione, Terenzio Mamiami,
professore di eloquenza, poi letteratura italiana, all'Università
di Bologna, aveva compiuto appena venticinque anni.
 Respira
l'aria pura dello studio bolognese e legge oltre Mazzini,
scrittori e poeti come Hugo, Goethe,
Von Platen, Shelly, Tierry,
Bérenger, Barbier, Quinet,
Michelet, Taine, Blanc.
Nel 1863 pubblica le Stanze, l'Orfeo,
le Rime di Angelo Ambrogini (il Poliziano)
e due anni dopo pubblica l'inno "A Satana"
che suscitò un vespaio di polemiche. L'inno forgiato dall'innato
anticlericalismo carducciano, contrapponeva la cultura illumunistica,
della rivoluzione, del progresso scientifico al Sillabo di
Pio XI.
Respira
l'aria pura dello studio bolognese e legge oltre Mazzini,
scrittori e poeti come Hugo, Goethe,
Von Platen, Shelly, Tierry,
Bérenger, Barbier, Quinet,
Michelet, Taine, Blanc.
Nel 1863 pubblica le Stanze, l'Orfeo,
le Rime di Angelo Ambrogini (il Poliziano)
e due anni dopo pubblica l'inno "A Satana"
che suscitò un vespaio di polemiche. L'inno forgiato dall'innato
anticlericalismo carducciano, contrapponeva la cultura illumunistica,
della rivoluzione, del progresso scientifico al Sillabo di
Pio XI.
Il nuovo Ministro della Pubblica Istruzione Broglio,
di ispirazione manzoniana, nel 1868 lo trasferisce d'ufficio, all'Università
di Napoli, ma egli non si piega al provvedimento che sa tanto di epurazione
ideologica. Ha scagliato e continua a scagliare infatti, numerosi strali
contro la mediocrità della classe politica italiana che non aveva
saputo conseguire un unità completa e che aveva inibito ed emarginato,
nella persona del re, Giuseppe Garibaldi. In quello stesso
anno pubblica a Pistoia la raccolta Levia gravia
e ripubblica un anno dopo l'Inno a Satana approfittando
della concomitanza col Concilio Ecumenico. Le
sue idee avverse alla politica governativa gli valsero la sospensione
dell'attività e dello stipendio per tre mesi.
 Il 1870 si apre e si conclude con avvenimenti funesti che lo colpiscono
nell'intimo. Infatti il 3 febbraio, gli muore la madre e 9 novembre il
figlioletto Dante di travaso celebrale.
Il 1870 si apre e si conclude con avvenimenti funesti che lo colpiscono
nell'intimo. Infatti il 3 febbraio, gli muore la madre e 9 novembre il
figlioletto Dante di travaso celebrale.
Da quest'avvenimento luttuoso, nasce la struggente "elegia"
Pianto antico. Ma chiusa quest'infelice parentesi
si apre per Giosuè una stagione di amori e di muse ispiratrici:
l'affascinate Carolina Cristofori Piva è la Lina
delle Primavere elleniche o la Lidia
in altri passi, Adele Bergamini, Dafne Gargiolli
è Lalage e la indimenticata Annie
Vivanti.
Nel 1899 fa ristampare presso Zanichelli, Rime
e ritmi e pubblica il commento, presso il Sansoni,
alle Rime del Petrarca, che aveva composto con
l'ausilio di Severino Ferrari. Contemporaneamente la
paralisi gli preclude l'uso della mano destra.
Nel 1905 escono per i tipi della Zanichelli, "Poesia"
una raccolta scelta di opere. E l'anno successivo riceve in Bologna,
dall'ambasciatore di Svezia, il "Premio
Nobel per la Letteratura", morirà un anno dopo,
nella notte fra il 15 e il 16 febbraio a Bologna, per broncopolmonite.
Le sue spoglie giacciono nella Certosa di Bologna.
OPERA
NELLA PIAZZA DI SAN PTERONIO
L'atto di nascita della basilica di San Petronio
risale ad un decreto del 1388, ma i lavori iniziano dopo due anni. Il
26 febbraio 1390 il Comune incarica della costruzione Antonio
di Vincenzo un muratore cui si deve anche il progetto del Palazzo
della Mercanzia e il 7 giugno è posata la prima pietra.
Il progetto è di una grande basilica gotica. La costruzione della
chiesa inizia dalla facciata prospiciente la piazza principale per annunciare
subito la presenza del grande tempio. Ma i lavori procedono lentamente,per
secoli. Solo nel 1393 sono costruite le due prime cappelle per parte,
e nel 1479 si cominciano le ultime.
Quanto alle volte gotiche della navata centrale, sono costruite dal 1646
al 1658, Girolamo Rainaldi, proprio in piena età
barocca.
Rimane irrisolto il problema della facciata, che è abbellita dal
basamento marmoreo di Antonio di Vincenzo, su cui sono
stati costruiti il portale maggiore di Jacopo della Quercia
e i due portali minori. Il rivestimento completo della parete, iniziato
nel 1538 su disegno di Domenico da Varignana, si arena
tra molte polemiche.
Architetti famosissimi si sono occupati della facciata. Ci sono disegni
e progetti di Baldassarre Peruzzi, Giacomo Ranuzzi,
Jacopo Barozzi da Vignola, Giulio Romano,
Domenico Tibaldi, Francesco Morandi detto il
Terribilia, Andrea Palladio, Alberto
Alberti. Eppure dopo secoli è ancora incompiuto.
La grande Basilica di San Petronio solo dal 1929, a seguito dei Patti
Lateranensi, la proprietà è trasferita alla
Diocesi. Anche per questo motivo la chiesa,
mai compiuta del tutto, è consacrata solo nel 1954 dal cardinale
Lercaro.
 La
basilica di San Petronio richiama più volte l'attenzione di Giosuè
Carducci, che le dedicò la lirica:
La
basilica di San Petronio richiama più volte l'attenzione di Giosuè
Carducci, che le dedicò la lirica:
NELLA PIAZZA DI SAN PETRONIO
Surge nel chiaro inverno la fosca turrita Bologna,
e il colle sopra bianco di neve ride.
È l'ora soave che il sol morituro saluta
le torri e 'l tempio, divo Petronio, tuo;
le torri i cui merli tant'ala di secolo lambe,
e del solenne tempio la solitaria cima.
Il cielo in freddo fulgore adamàntino brilla;
e l'aër come velo d'argento giace
su 'l fòro, lieve sfumando a torno le moli
che levò cupe il braccio clipeato de gli avi.
Su gli alti fastigi s'indugia il sole guardando
con un sorriso languido di vïola,
che ne la bigia pietra nel fosco vermiglio mattone
par che risvegli l'anima de i secoli,
e un desio mesto pe 'l rigido aëre sveglia
di rossi maggi, di calde aulenti sere,
quando le donne gentili danzavano in piazza
e co' i re vinti i consoli tornavano.
Tale la musa ride fuggente al verso in cui trema
un desiderio vano de la bellezza antica.
L'evoluzione della poesia di Carducci
coincide di solito con l'arco delle sue esperienze umane e culturali.
Ai versi di Juvenilia, improntati a un intransigente
classicismo, e a quelli di Levia Gravia, dove
è già una maggiore consapevolezza artistica, segue la fase
giambica, culminata con la violenta reazione del poeta alle delusioni
politiche rispecchiata in Giambi ed Epodi, cui
già è un'anticipazione nell'Inno a Satana,
un componimento in cui Satana è celebrato come la personificazione
del libero pensiero. Così Carducci, approda ai momenti maggiori
della sua lirica. Nella raccolta, le Odi barbare,
si accostano nuovi temi a quelli precedenti, «come il mito della
romanità, il senso religioso di una misteriosa presenza superiore
(Canto di marzo, La madre) e infine i versi in cui a
una realtà precisa e solare si affianca il mistero e l'imponderabile
che a questa realtà è sempre congiunto (Mors, Nevicata,
Alla stazione in una mattina d'autunno)».
In questi capolavori Carducci, «avversario dei facili sentimentalismi
del secondo romanticismo in nome di una concezione sana e concreta della
vita, si ricollega al primo romanticismo, la cui aspirazione realistica
egli solleva in una sfera epica». C'è anzi un momento
decadentismo la cui esigenza di perfezione formale e la esotica nostalgia
dell'Ellade sono paragonate a identici atteggiamenti dei poeti francesi.
Ma già nelle ultime Odi barbare si esaurisce
la migliore ispirazione carducciana e prevalgono l'evocazione erudita,
il paesaggio oleografico, l'eloquenza deteriore.
Che Carducci fosse rimasto affascinato dalla Basilica di San Petronio
e avesse di questa architettura una grande ammirazione lo svelano i versi:
«le torri i cui merli tant'ala di secolo lambe,
e del solenne tempio la solitaria cima.
Il cielo in freddo fulgore adamàntino brilla;
e l'aër come velo d'argento giace
su 'l fòro, lieve sfumando a torno le moli
che levò cupe il braccio clipeato de gli avi»
ma lo stesso stato d'animo del poeta si ritrova anche in
altre liriche, ed è il medesimo interesse per l'amore che precede
l'ammirazione per la regina.
L'immagine, con quella luce che insieme evidenzia, la bellezza architettonica
e il brillio del cielo che inargenta l’aria, sembra unirlo alla
Basilica che gli infonde la sua notevole forza, che celebra la grandezza
dell’arte e dell'amore, senza nulla nascondere, nella stesura del
verso, l'intrinseco e quotidiano sviluppo di questo sentimento; mettendo
in risalto la sua grande perizia letteraria, una evidente capacità
di rivivere dall'interno il tema, facendone vibrare le più profonde
risonanze, pur senza scoprire intrusioni autobiografiche e senza cadute
nel patetico.
Forse per questo motivo, questa lirica, dopo aver attraversato il Novecento,
giunge fino a noi viva e coinvolgente, forte del costante bisogno di conoscere
e sapere di noi posteri, contando sull'immutabilità del sentimento
e della vita stessa, nella sua totalità.
 Giosuè
Carducci giunge a Bologna il 10 novembre
1860 e il suo insegnamento all'Università coincide con l'Unità
d'Italia. Ha 25 anni, come già anticipato, ed è
stato nominato professore di letteratura italiana. Il ministro Mamiani,dopo
aver letto un suo libretto di Rime, lo ha trovato
a Pistoia, dove insegna greco al liceo.
Giosuè
Carducci giunge a Bologna il 10 novembre
1860 e il suo insegnamento all'Università coincide con l'Unità
d'Italia. Ha 25 anni, come già anticipato, ed è
stato nominato professore di letteratura italiana. Il ministro Mamiani,dopo
aver letto un suo libretto di Rime, lo ha trovato
a Pistoia, dove insegna greco al liceo.
I fatti si sono sviluppati in questo modo: al momento della proclamata
annessione al Regno d'Italia, la Facoltà di Lettere
e Filosofia di Bologna conta sei cattedre, tra loro, quella
di letteratura italiana e latina tenuta da un sacerdote, monsignor Gaetano
Golfieri, il quale si rifiuta di prestare giuramento di fedeltà
al Re d'Italia. Al suo posto si pensa di chiamare Giovanni
Prati, che non vuole saperne adducendo impedimenti familiari
e la cattedra, quindi è offerta a Carducci.
Si tratta chiaramente di un compito gravoso. Lo Studio di
Bologna, da centro europeo di cultura quale era stato per
tanti secoli, si è ridotto nella prima metà dell'Ottocento
ad una povera Università provinciale. Nel 1859 conta appena trecento
iscritti, di cui nessuno alla Facoltà di Lettere. La cattedra di
letteratura italiana è poi considerata a Bologna, come nel resto
del paese, la più rappresentativa del nuovo carattere nazionale
delle Università dell'Italia unita. Giosuè Carducci è
consapevole della gravità della missione che gli è stata
affidata, ma gli esordi della sua carriera accademica sono difficili.
Dopo la prolusione tenuta dinanzi a un folto pubblico di curiosi, quasi
più nessuno va a sentirlo. Le sue lezioni sono seguite da pochi
uditori. Ma la fama della sua eloquenza e del suo insegnamento accresce
ben presto il numero dei giovani iscritti alla facoltà di Lettere,
e la piccola, modesta aula, basta appena a contenere la folla degli ascoltatori
tra i quali, spesso, con grande fastidio di Carducci, si insinua qualche
curioso ammiratore. La presenza di questi estranei lo porta a rilevare
che in quella stanza si va per studiare e non in cerca di impressioni
sull'uomo celebre.
Egli ha una concezione altissima del dovere e nei suoi 43 anni di insegnamento
non ripete mai la stessa lezione. Pretende che tutti gli alunni fossero
assidui alle lezioni e al lavoro, e una volta l’anno ogni alunno
deve affrontare il momento della restituzione e della correzione delle
tesine. Si tratta di un piccolo studio, di una breve monografia su un
tema liberamente scelto, con la quale lo studente deve dare saggio della
sua preparazione, del suo orientamento critico e anche della sua capacità
di scrivere e ragionare. Se sia riuscito nel suo intento, dopo l'avvenuta
Unità, ha bisogno che lo testimoniano i nomi noti di molti suoi
allievi: Giovanni Pascoli, Renato Serra,
Manara Valgimigli, Guido Mazzoni, Severino
Ferrari, Giovanni Federzoni, Giuseppe
Albini, Albano Sorbelli, ... e tanti altri.
Durante il suo soggiorno a Bologna il compone molti versi dedicati alla
città. In particolare si ricordano tre poesie incluse nelle Odi
Barbare: Fuori alla Certosa di Bologna,
Le Due Torri, Nella Piazza di San Petronio.
Ci siamo occupati della terza Ode.
 Mi
sono soffermato a Bologna in tre occasioni, la prima per incontrare un
amico pittore, Ottavio Predieri, il quale sentendomi
parlare di Carducci con tanto calore, mi porta a pranzare in un ristorante
di fronte alle Due Torri; poi mi fa visitare
la Basilica e mi narra del Santo
che ritorna sotto le Due Torri ogni anno, il 4 ottobre, giorno in cui
si festeggia San Petronio.
Mi
sono soffermato a Bologna in tre occasioni, la prima per incontrare un
amico pittore, Ottavio Predieri, il quale sentendomi
parlare di Carducci con tanto calore, mi porta a pranzare in un ristorante
di fronte alle Due Torri; poi mi fa visitare
la Basilica e mi narra del Santo
che ritorna sotto le Due Torri ogni anno, il 4 ottobre, giorno in cui
si festeggia San Petronio.
«La statua che torna sotto le Due Torri, uno spettacolo in Piazza
Maggiore, due mostre, concerti e fuochi d'artificio: è con un programma
denso di manifestazioni che il Comune e la Curia intendono celebrare in
questo giorno, riservato a San Petronio, il Patrono della nostra città».
Nel 1981 avendo la finale e la premiazione delle «Talentiate
a Camugnano», per il 7-8-9 ottobre, giunsi con una
settimana di anticipo per vivere quanto Ottavio mi aveva raccontato.
Anche oggi, le celebrazioni iniziano il 3 ottobre, alle 17, con l'inaugurazione
della mostra «La basilica incompiuta. Progetti antichi per la
facciata di San Petronio». L'esposizione, allestita al Museo
Civico Medievale di via Manzoni 4, presenta ventiquattro
progetti per il completamento della facciata della basilica, elaborati
tra il Sedicesimo e Diciassettesimo secolo da artisti di gran fama, non
solo bolognesi e l’esposizione è aperta fino al 6 gennaio,
tutti i giorni dalle 10 alle 18.
Il 4 ottobre alle 12,30 si tiene la cerimonia di ricollocazione dell'antica
statua di San Petronio in piazza di Porta
Ravegnana, alla presenza del sindaco, del cardinale e del
presidente della Camera. Dal 1871, infatti, la statua del Santo è
collocata nella Cappella di San Rocco all'interno
della Basilica di San Petronio. La statua, opera
del Brunelli, è situata su un basamento, del tutto
uguale a quello originario, nella zona riservata ai pedoni che è
stata appositamente creata tra la fine di Via Rizzoli
e Piazza di Porta Ravegnana.
Nel pomeriggio la festa prosegue, alle 15,30 in Piazza Maggiore con il
concerto della banda, alle 17, nella Basilica di San Petronio, il cardinale
presiede la Santa Messa seguita dalla processione e dalla benedizione
con le reliquie di San Petronio e alle 19, sempre in Piazza Maggiore,
si tiene un altro concerto.
La piazza continua ad animarsi con uno spettacolo teatrale che ha inizio
alle 20, rappresentando: «La favola dell'Homo riscoperta ne'
famosi proverbi bolognesi». Sono otto bellissime incisioni
del Mitelli ispirate ai proverbi più noti, queste
sono le colonne portanti dello spettacolo. L’azioni scenica, ispirate
a ciascun proverbio, prende vita sotto gli occhi del pubblico, coinvolgendo
tutta Piazza Maggiore, il centro cittadino per eccellenza e palcoscenico
naturale della vita urbana. Nella successione di dieci quadri: attori,
danzatori, musicisti, cantanti e molti altri artisti, animano la Piazza
con performance di grande effetto spettacolare.
Un mese più tardi, dal 24 novembre al 24 febbraio, è allestita,
al Salone del Podestà la mostra «San
Petronio e Bologna. Il volto di una storia», promossa dal Comune
e dall'Istituto Veritas Splendor - Centro Studi per la cultura popolare.
L'esposizione mostra attraverso opere d'arte e documenti quanto la figura
del Patrono sia stata, come punto di riferimento religioso, sociale e
civile a un tempo, fulcro di aggregazione e di forza e anche fonte feconda
di una creatività che si è espressa in grandi opere di pittura,
scultura, stampa, lasciando un'impronta nei segni, nei gesti, nelle consuetudini
della vita e della cultura cittadina.
Bibliografia
A. Momigliano, Introduzione ai poeti, Roma, 1946;
U. Bosco, La poesia di Giosuè Carducci, Napoli, 1947
; B. Croce, Giosuè Carducci. Studio critico, Bari, 1953;
G. Getto, Carducci e Pascoli, Bologna, 1957;
L. Russo, Carducci senza retorica, Bari, 1957;
F. Flora, Poesia e prosa di Giosuè Carducci, Pisa, 1959;
G. Santangelo, Carducci, Palermo, 1960;
M. Biagini, Il poeta della terza Italia, Milano, 1961;
N. Sapegno, Storia del Carducci, in Ritratto di Manzoni e altri saggi,
Bari, 1961;
W. Binni, Carducci e altri saggi, Torino, 1967;
G. Spadolini, Fra Carducci e Garibaldi, Roma, 1983;
Marzia Faietti, Massimo Medica, La Basilica incompiuta - Progetti antichi
per la facciata di San Petronio, Ferrara, Edisai, 2001;
Rolando Dondarini, Carlo De Angelis, Atlante storico di Bologna, vol.
III, Bologna 1997, p. 36;
M. VALGIMIGLI, in G. CARDUCCI, Rime e ritmi, cit., p. 143.; L. BANFI,
in G. CARDUCCI, Rime e ritmi, a cura di L. Banfi, Mursia, Milano, 1987,
p. 100.
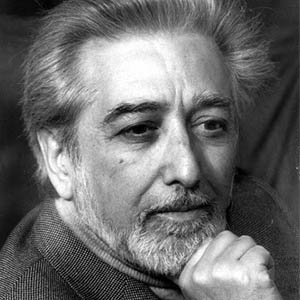
Reno Bromuro è nato a Paduli, in Campania, nel 1937. E' stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale. Nel 1957, a Napoli, ha fondato il Centro Sperimentale per un Teatro neorealista. Ha fondato nel 1973 (di fatto) l'A.I.A. Associazione Internazionale Artisti "Poesie della Vita", e, come critico letterario, ha recensito molti poeti italiani e stranieri. Si è spento nel 2009, qualche anno dopo averci dato l'opportunità di collaborare con lui. Noi di Letteratour lo ricordiamo con affetto qui.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG