
di Reno Bromuro
"Né più mai toccherò
le sacre sponde
ove il mio corpo fanciulletto giacque
Zacinto mia, che te specchi nell'onde
del greco mar, da cui vergine nacque
Venere, e fea quell'isole feconde
col suo primo sorriso…"
Nella categoria: HOME | TOURismi letterari
• Biografia
• L'opera: A Zacinto
• Critica
• Il luogo
• Bibliografia
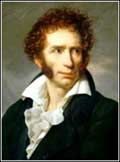 Niccolò
Ugo Foscolo nacque a Zante (Zacinto),
isoletta del mare Ionio dal medico veneziano Andrea e
dalla greca Diamantina Spathis, il 6 febbraio 1778. Ha
ricevuto la sua prima educazione a Spalato dove il padre è stato
nominato direttore di quell'ospedale, frequenta gli studi nel seminario,
ma alunno ribelle, ne è scacciato. In seguito alla morte del padre,
avvenuta nel 1788, la vedova torna a Zante con i figli, dove si stabilisce
in una catapecchia le cui finestre non avevano vetri. Ugo, che ha definitivamente
rinunciato al suo primo nome, prende a frequentare caffè e circoli
letterari tra cui quello della contessa Isabella Teotochi,
amica di Pindemonte, che lo inizia capricciosamente ai
segreti dell'amore e che gli è amante per cinque giorni, ma amica
per tutta la vita. In quel periodo d’inquieta maturazione, il giovane
poeta non sogna soltanto le Muse e le donne, ma si proclama rivoluzionario
accostandosi alle idee di Robespierre, Rousseau
e di Alfieri. Contemporaneamente frequenta saltuariamente
l'Università di Padova dove i consigli
del Cesarotti gli rivelano per primi la cupa teatraggine
dell'Ossian e dello Young.
Maggiore di sei figli, Ugo sente la responsabilità della “paternità
fanciulla”. A diciannove anni scrive la sua prima tragedia,
"Tieste" che, dopo nove rappresentazioni
consecutive a clamor di pubblico, è consacrato autore di successo.
Niccolò
Ugo Foscolo nacque a Zante (Zacinto),
isoletta del mare Ionio dal medico veneziano Andrea e
dalla greca Diamantina Spathis, il 6 febbraio 1778. Ha
ricevuto la sua prima educazione a Spalato dove il padre è stato
nominato direttore di quell'ospedale, frequenta gli studi nel seminario,
ma alunno ribelle, ne è scacciato. In seguito alla morte del padre,
avvenuta nel 1788, la vedova torna a Zante con i figli, dove si stabilisce
in una catapecchia le cui finestre non avevano vetri. Ugo, che ha definitivamente
rinunciato al suo primo nome, prende a frequentare caffè e circoli
letterari tra cui quello della contessa Isabella Teotochi,
amica di Pindemonte, che lo inizia capricciosamente ai
segreti dell'amore e che gli è amante per cinque giorni, ma amica
per tutta la vita. In quel periodo d’inquieta maturazione, il giovane
poeta non sogna soltanto le Muse e le donne, ma si proclama rivoluzionario
accostandosi alle idee di Robespierre, Rousseau
e di Alfieri. Contemporaneamente frequenta saltuariamente
l'Università di Padova dove i consigli
del Cesarotti gli rivelano per primi la cupa teatraggine
dell'Ossian e dello Young.
Maggiore di sei figli, Ugo sente la responsabilità della “paternità
fanciulla”. A diciannove anni scrive la sua prima tragedia,
"Tieste" che, dopo nove rappresentazioni
consecutive a clamor di pubblico, è consacrato autore di successo.
 Contemporaneamente,comincia
il suo percorso politico all'insegna del giacobinismo, nel momento in
cui Napoleone inizia ad esportare in Europa
le idee della rivoluzione francese. Sempre nel 1797, in onore al popolo
di Reggio Emilia che per primo ha accettato
le idee rivoluzionarie, scrive l'ode "A Bonaparte liberatore"
che gli procurerà i primi fastidi politici, tanto che deve fuggire
a Milano all'indomani del trattato di Campoformio.
Da quell'evento nasce la diffidenza, che lo accompagnerà poi per
tutta la vita, verso la politica di Bonaparte.
Contemporaneamente,comincia
il suo percorso politico all'insegna del giacobinismo, nel momento in
cui Napoleone inizia ad esportare in Europa
le idee della rivoluzione francese. Sempre nel 1797, in onore al popolo
di Reggio Emilia che per primo ha accettato
le idee rivoluzionarie, scrive l'ode "A Bonaparte liberatore"
che gli procurerà i primi fastidi politici, tanto che deve fuggire
a Milano all'indomani del trattato di Campoformio.
Da quell'evento nasce la diffidenza, che lo accompagnerà poi per
tutta la vita, verso la politica di Bonaparte.
Abolito il governo della Serenissima, a Venezia
si fonda una municipalità provvisoria, Foscolo
crede suo dovere ritornare nella sua patria di elezione, ricoprendo incarichi
di governo, ma trovandosi spesso a protestare contro gli "ipocriti
della libertà" tra cui mette lo stesso Alfieri.
Venezia è ceduta all'Austria
e Foscolo raggiunge Milano, dove diviene redattore
del "Monitore italiano" e stringe
amicizia con Vincenzo Monti, che ha conosciuto a Bologna.
Nell'aprile di quell'anno 1798 il "Monitore" è soppresso
e Foscolo perseguitato dalla polizia anche per aver fondato immediatamente
l'"Italico", che il governo lascia vivere soltanto
pochi mesi. Il bisogno economico lo porta nuovamente a Bologna,
con un misero impiego, dove affida all'editore Marsigli
una prima versione de "Le ultime lettere di Jacopo Ortis",
poi completata dall'editore stesso, che ricorre al mediocre redattore
Angelo Sassoli, per affrettarne l'uscita.
 Sono
gli anni di un’intensa maturazione personale e letteraria: del 1800
è l'ode "A Luigia Pallavicini caduta da cavallo",
del 1802 l'ode "All'amica risanata"
e le "Poesie",che comprendono le due
odi più dodici sonetti, tra cui i famosissimi "Alla
sera", "A Zacinto",
"In morte del fratello Giovanni".
All'attività letteraria affianca l'impegno di combattente: al seguito
del generale Macdonald è alla Trebbia;
nel giugno del 1799, con le milizie cisalpine e francesi, è a Firenze,
dove conosce il Niccolini; poi è a Genova,
Nizza e di nuovo a Milano.
In questi anni continua a dedicarsi all'Ortis, un libro-chiave, specchio
di un'intera generazione, e che è più volte stampato e modificato
nel corso degli anni.
Sono
gli anni di un’intensa maturazione personale e letteraria: del 1800
è l'ode "A Luigia Pallavicini caduta da cavallo",
del 1802 l'ode "All'amica risanata"
e le "Poesie",che comprendono le due
odi più dodici sonetti, tra cui i famosissimi "Alla
sera", "A Zacinto",
"In morte del fratello Giovanni".
All'attività letteraria affianca l'impegno di combattente: al seguito
del generale Macdonald è alla Trebbia;
nel giugno del 1799, con le milizie cisalpine e francesi, è a Firenze,
dove conosce il Niccolini; poi è a Genova,
Nizza e di nuovo a Milano.
In questi anni continua a dedicarsi all'Ortis, un libro-chiave, specchio
di un'intera generazione, e che è più volte stampato e modificato
nel corso degli anni.
Dal 1804 al 1806, è in Francia al seguito dell'armata che sta progettando
l'invasione dell'Inghilterra; inizia a tradurre "Il viaggio
sentimentale" di Sterne. Nel 1807
vedono la luce i "Sepolcri"; nell'anno
successivo ottiene la Cattedra di Eloquenza all'Università
di Pavia, ma la cattedra è presto soppressa per motivi
politici. Nel 1809 rappresenta l'"Aiace"
alla Scala, tragedia che è definita dalle
autorità: antinapoleonica. A Foscolo non resta che ricominciare
la sua carriera di perseguitato politico nell'impero Napoleonico che ha
tradito i suoi ideali. Nel 1812 scrive il suo ultimo capolavoro "Le
Grazie", e segue le alterne vicende dell'impero fino
a Waterloo. L'Austria, ottenuto il Lombardo-Veneto,
chiede agli ex ufficiali napoleonici il giuramento di fedeltà,
Foscolo si rifiuta di prestarlo e abbandona per sempre l'Italia, rifugiandosi
prima in Svizzera e poi in Inghilterra.
 Comincia
così il periodo più difficile della sua vita, nel corso
del quale riscrive "Le ultime lettere di Jacopo Ortis"
e vari saggi di letteratura italiana per riviste inglesi, unico modo,
insieme ad alcune lezioni private di Italiano, per contrastare le avversità
economiche che gli costano persino l'arresto per debiti, nel 1824. La
morte lo colse il 10 settembre 1827, nei pressi di Londra,
a Turnham Green ed è sepolto nel cimitero
di Chiswick, da dove nel 1871, i resti sono trasportati
a Firenze in Santa Croce.
Comincia
così il periodo più difficile della sua vita, nel corso
del quale riscrive "Le ultime lettere di Jacopo Ortis"
e vari saggi di letteratura italiana per riviste inglesi, unico modo,
insieme ad alcune lezioni private di Italiano, per contrastare le avversità
economiche che gli costano persino l'arresto per debiti, nel 1824. La
morte lo colse il 10 settembre 1827, nei pressi di Londra,
a Turnham Green ed è sepolto nel cimitero
di Chiswick, da dove nel 1871, i resti sono trasportati
a Firenze in Santa Croce.
Pensare che vent’anni prima aveva scritto:
"Tu non altro che il canto avrai del figlio,
o materna mia terra; a noi prescrisse
il fato illacrimata sepoltura".
 Il
Poeta rievoca la sua Patria, indugiando tra i ricordi
del mito, poi china il capo con infinita tristezza pensando che, a differenza
di Ulisse, egli non trova sepoltura nella terra che lo vide nascere. Fa
parte dei dodici sonetti cui i più famosi sono: In
morte del fratello Giovanni, A Zacinto,
Alla Sera. Il primo parla del suicidio del fratello
e dell'importanza delle tombe. Il terzo parla della sera, che simile alla
morte dà un senso di pace. Il secondo, "A Zacinto", parla
della Patria lontana, poiché lui è in esilio e ricorda Ulisse,
che rappresenta l'uomo esule lontano dalla Patria, in sintesi è
la figura dell'eroe romantico; in quest'ultimo sonetto si parla già
dell'importanza del Sepolcro, della tomba illacrimata che se
lontana dalla Patria non è confortata dal pianto dei parenti.
Il
Poeta rievoca la sua Patria, indugiando tra i ricordi
del mito, poi china il capo con infinita tristezza pensando che, a differenza
di Ulisse, egli non trova sepoltura nella terra che lo vide nascere. Fa
parte dei dodici sonetti cui i più famosi sono: In
morte del fratello Giovanni, A Zacinto,
Alla Sera. Il primo parla del suicidio del fratello
e dell'importanza delle tombe. Il terzo parla della sera, che simile alla
morte dà un senso di pace. Il secondo, "A Zacinto", parla
della Patria lontana, poiché lui è in esilio e ricorda Ulisse,
che rappresenta l'uomo esule lontano dalla Patria, in sintesi è
la figura dell'eroe romantico; in quest'ultimo sonetto si parla già
dell'importanza del Sepolcro, della tomba illacrimata che se
lontana dalla Patria non è confortata dal pianto dei parenti.
Il sonetto è dedicato all’isola in cui il poeta è
nato e il tema principale è quindi la lontananza dalla patria.
Ed è attraverso immagini classiche che Foscolo inneggia alla sua
isola esprimendo di poterle dedicare solo il proprio canto dal momento
che l’esilio gli ha prescritto un’illacrimata sepoltura in
terra straniera dove nessuno potrà piangere sulla sua tomba. Da
questo sonetto emerge l’immagine del Foscolo che, sentendosi sradicato
da una società in cui non si riconosce, ama rappresentarsi miticamente
come un’esule, un estraneo al mondo, condannato alla sconfitta,
alla infelicità e ad un perenne vagabondare.
L'estetica, o meglio, la poetica di Foscolo nei sonetti,
è rintracciabile nella metodologia implicita dei suoi scritti di
critica letteraria. Egli accetta “come punto di partenza la
nozione tradizionale che l'arte imita la natura, ma ne trae personali
sviluppi. Tutte le arti di immaginazione nascono dal bisogno di creare
oggetti di contemplazione che abbelliscono la triste realtà e rendono
varia la monotonia della vita. Perciò l'imitazione artistica della
natura non è una semplice copia, ma idealizzazione della realtà:
il genio non si limita a cogliere il Vero, ma crea l'Ideale”.
Nell'opera d'Arte Vero e Ideale devono fondersi in maniera perfetta. Solo
quando un artista nel suo quotidiano conflitto tra creatività e
razionalità è in equilibrio si ha l'opera d'arte "maggiore".
Il motivo teorico è la coscienza dei diritti dell'immaginazione
creativa di fronte alla storia; il motivo psicologico sta nel sentimento
dell'arte come rifugio e consolazione dalle noie e dai dolori della vita.
Nel mondo ideale creato dall'arte si riflette quella "Universale
secreta armonia" che esiste nel mondo reale.
Questa concezione dell'Arte è molto lontana dall'idea dei romantici
italiani, e in particolare in Manzoni, ricorda le concezioni
dei romantici stranieri che vedono nella poesia il mezzo per sfuggire
ai limiti e ai contrasti della realtà per immergersi in una sfera
di armonia e di serenità, al quale Foscolo non
attribuisce tanto un significato metafisico-religioso, come i romantici,
quanto un significato etico.
La Poesia è considerata come lo strumento migliore per esprimere
queste illusioni. Nei “Sepolcri”
l'illusione è l'elemento come centro di affetti familiari, simbolo
di una corrispondenza d'amore che lega gli uomini attraverso il tempo;
illusione della vittoria della vita sulla morte, sopravvivenza delle tradizioni
civili di un popolo nella storia. Il mito della bellezza serenatrice,
come bellezza eterna e incorruttibile e per i mortali è alternativa
all'angoscia di vivere e dà la possibilità di raggiungere
un superiore equilibrio. Il mito della poesia è il mezzo per tramandare
alla generazioni successive i più grandi valori della civiltà
umana. Poesia eternatrice dei valori più alti, che oltre a sfidare
la morte, sfida anche il tempo.
Il sonetto di cui parliamo, inizia con una triplice negazione, che è
una constatazione amara della perdita della sua patria, e termina con
la sentenza definitiva del suo esilio e della sua illacrimata sepoltura
in terra straniera. Tra questi due poli negativi è racchiusa, attraverso
l'incatenamento di immagini la rappresentazione nostalgica e meravigliosa
del mondo ideale dell'infanzia del poeta e la trasfigurazione mitica della
propria esperienza dell'esilio che avviene attraverso all'analogia fra
la sua figura è quella di Ulisse. Ulisse, "bello
di fama e di sventura" rappresenta l'immagine del poeta, anch'egli
esule magnanimo avversato dal destino e dagli uomini, ma rappresenta soprattutto
il nuovo concetto dell'eroe romantico, grande per la forza e la dignità
con cui sopporta le ingiurie della sventura: l'esito dell'esilio però,
sarà diverso. “Foscolo a differenza di Ulisse sarà
sepolto in terra straniera e nessuno verserà delle lacrime sulla
sua tomba. Altre immagini mitiche sono presente nei versi, quella di Omero
che rappresenta la poesia eterna dell'eroismo e dei valori più
alti e Venere, nata secondo il mito dalla spuma del mare, simbolo della
natura fecondatrice, della bellezza e dell'armonia, che con il suo sorriso
ha reso fertile e rigogliosa la patria del poeta”.
Il ritmo del sonetto è dato dal sovrapposti di più piani:
le rime, la struttura metrica degli endecasillabi, la non coincidenza
tra enunciati e versi, la particolare struttura sintattica che vede sei
proposizioni relative concatenate che collegano tra loro, come in una
continuità inesauribile, le immagini scaturite dal ricordo infantile
del poeta.
Linguaggio e sintassi della tradizione aulica, complesso nella costruzione
e ricco di latinismi e termini letterari. Esempi di latinismi: vergine
per giovane, diverso, che vaga di qua e di là. Oppure letterario:
onde, illacrimata inclito, ove ecc…
L'esilio lo angoscia profondamente e da questa situazione egli si risolleva
attenuando l'esigenza politica. Tuttavia, la riflessione autocritica è
fatta nell'ambito della mera soggettività, con l'intenzione di
rinunciare a quegli ideali o per lo meno alla loro realizzazione nel breve
periodo. Il sonetto non solo chiude un capitolo dell'impegno politico
del Poeta,ma non lascia spazio a una possibile ripresa, più realista
e disincantata, di quell'impegno. La delusione viene avvertita in maniera
traumatica nella produzione letteraria successiva ai sonetti. In poche
parole sul piano tematico, Foscolo non ha fatto altro che ripetersi.
 L'isola
di Zante è molto grande e se la si vuole
girare tutta bisogna sapersi organizzare. Per questo motivo pensammo di
organizzarci come se dovessimo fare un’escursione, in modo tale
di poter vedere più posti nello stesso giorno, percorrendo la stessa
strada. Visitare tutta l'isola è ovviamente impossibile, e noi
non avevamo molto tempo a disposizione, ma volevamo lo stesso avere la
possibilità di non perderci i posti più belli...
L'isola
di Zante è molto grande e se la si vuole
girare tutta bisogna sapersi organizzare. Per questo motivo pensammo di
organizzarci come se dovessimo fare un’escursione, in modo tale
di poter vedere più posti nello stesso giorno, percorrendo la stessa
strada. Visitare tutta l'isola è ovviamente impossibile, e noi
non avevamo molto tempo a disposizione, ma volevamo lo stesso avere la
possibilità di non perderci i posti più belli...
Partimmo la mattina molto presto e iniziammo dal Porto Vromi,
in attesa della barca che ci avrebbe portato sulla spiaggia del Navajo,
la più bella dell'isola per il biancore della sua sabbia e l'azzurro
delle sue acque. Dio, ce l’ho ancora negli occhi quei colori! Di
solito si rimane sull’isola non più di un'ora e mezza, il
tempo per approfittare di fare colazione in uno dei caratteristici bar
e a mezzogiorno pranzare nei ristorantini di Anafonitria, dove approfittammo
di andare a visitare il Monastero. Nel pomeriggio
avanzato andammo ad ammirare il Navajo dall'alto e aspettammo il tramonto.
Lungo la strada che porta al bel vedere, ammirammo l'ulivo più
grande di Zante. Le strade non erano ancora tutte asfaltate per cui raggiungere
quei posti fu molto semplice, ma faticoso.
Il giorno successivo, sempre partendo la mattina presto, trascorremmo
l'intera giornata a Porto Limniona, senza dubbio
uno dei posti più belli e caratteristici dell'isola. Nel pomeriggio
ci fermammo a Kampi, e godemmo del bellissimo
panorama, meravigliati divedere una grande croce, alta dieci metri, messa
lì in cima, in ricordo degli italiani che furono scaraventati dal
pendio della montagna, in tempo di guerra. Il tramonto è tanto
bello da far mancare il fiato.
Il giorno dopo, dal porto di Kerì, è
facemmo una meravigliosa gita in barca. C’erano dei pescatori che
organizzavano questa escursione, quindi non dovemmo far altro che munirci
di una buona crema protettiva e partire. Visitammo le grotte di Kerì
e sbarcammo sull'isolotto di Marathonisi, altra
perla di quest’isola incantevole. Di solito la permanenza a Marathonisi
durò l’intero pomeriggio, i pescatori ci consigliarono, seppure
fosse solo maggio, di affittare un ombrellone, fare il rifornimento d’acqua
e cibo perché l'isola è deserta.
 Nel
terzo giorno di permanenza sull’isola, partimmo dal porticciolo
di Skinari per andare e vedere le famose “Grotte Azzurre”
che si trovavano sulla punta nord dell'isola. Bellezza più…
affascinante non videro più i miei occhi, anche se a prima vista
mi ritrovai a Capri per pochi secondi, fino
a quando non mi resi conto che la “Grotta azzurra” ha diverse
caratteristiche e altro colore più argenteo, mentre queste di Skinari
sono di un azzurro intenso e terso come il cielo primaverile del mezzogiorno
d’Italia. La caratteristica azzurra del mare riesce a colorare di
celeste qualsiasi cosa vi si immerga. Ecco perché, illanguidita
e con lo sguardo nel vuoto, Valentie mi sussurrò
all’orecchio: “ora sei tutto azzurro, mio principe!”;
e guardando la foto che scattò la mia maglietta non era più
bianca ma azzurra di un azzurro!… Finita la gita alle grotte, prima
di pranzo, raggiungemmo la spiaggia di Makris Gialos.
Nel pomeriggio, proseguimmo per Xighia, dove
rimanemmo per un tempo interminabile a guardare quel mare misto ad acqua
sulfurea. Ci promettemmo di ritornarci in luglio perché bagnarsi
in quelle acque sicuramente sarebbe stato un toccasana per la pelle, ma...
Valentina se ne andò, volò come una colomba e a Zante ci
ritornai solo dopo dieci anni. Intanto c’era stato il terremoto,
Zante era stata quasi completamente rasa al suolo. Quando giunsi la trovai
completamente ricostruita ad immagine e somiglianza di quella che era
la vecchia cittadina adottando però norme antisismiche molto severe.
Nel
terzo giorno di permanenza sull’isola, partimmo dal porticciolo
di Skinari per andare e vedere le famose “Grotte Azzurre”
che si trovavano sulla punta nord dell'isola. Bellezza più…
affascinante non videro più i miei occhi, anche se a prima vista
mi ritrovai a Capri per pochi secondi, fino
a quando non mi resi conto che la “Grotta azzurra” ha diverse
caratteristiche e altro colore più argenteo, mentre queste di Skinari
sono di un azzurro intenso e terso come il cielo primaverile del mezzogiorno
d’Italia. La caratteristica azzurra del mare riesce a colorare di
celeste qualsiasi cosa vi si immerga. Ecco perché, illanguidita
e con lo sguardo nel vuoto, Valentie mi sussurrò
all’orecchio: “ora sei tutto azzurro, mio principe!”;
e guardando la foto che scattò la mia maglietta non era più
bianca ma azzurra di un azzurro!… Finita la gita alle grotte, prima
di pranzo, raggiungemmo la spiaggia di Makris Gialos.
Nel pomeriggio, proseguimmo per Xighia, dove
rimanemmo per un tempo interminabile a guardare quel mare misto ad acqua
sulfurea. Ci promettemmo di ritornarci in luglio perché bagnarsi
in quelle acque sicuramente sarebbe stato un toccasana per la pelle, ma...
Valentina se ne andò, volò come una colomba e a Zante ci
ritornai solo dopo dieci anni. Intanto c’era stato il terremoto,
Zante era stata quasi completamente rasa al suolo. Quando giunsi la trovai
completamente ricostruita ad immagine e somiglianza di quella che era
la vecchia cittadina adottando però norme antisismiche molto severe.
 La
città di Zante la sera è diventata
molto romantica e carina! Passeggiare sotto i portici del lungo mare,
sul molo o nelle piazzette è riposante e culturalmente elevato.
Sostare in Piazza Solomos, che si trova di fronte
al porto ed è la piazza più grande della città e
come passare la serata sulla Scalinata di Trinità de’
Monti a Roma, senza il mare. Al
centro c'è la statua di Dionisio Solomos
il poeta greco che ha scritto l'inno nazionale. Sempre a piedi, camminando
lentamente giunsi in Piazza San Marco, e visitai
la Chiesa omonima, piccola ma molto suggestiva ed è l'unica Chiesa
cattolica di Zante.
La
città di Zante la sera è diventata
molto romantica e carina! Passeggiare sotto i portici del lungo mare,
sul molo o nelle piazzette è riposante e culturalmente elevato.
Sostare in Piazza Solomos, che si trova di fronte
al porto ed è la piazza più grande della città e
come passare la serata sulla Scalinata di Trinità de’
Monti a Roma, senza il mare. Al
centro c'è la statua di Dionisio Solomos
il poeta greco che ha scritto l'inno nazionale. Sempre a piedi, camminando
lentamente giunsi in Piazza San Marco, e visitai
la Chiesa omonima, piccola ma molto suggestiva ed è l'unica Chiesa
cattolica di Zante.
F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, Napoli,
1870;
A. Momigliano, Gusto neoclassico e poesia neoclassica, in “Leonardo”,
1941;
C. F. Goffis, Studi foscoliani, Firenze, 1942;
G. De Robertis, Saggi, Firenze, 1944;
R. Ramat, Itinerario ritmico foscoliano, Città di Castello, 1946;
P. Bigongiari, Il senso della lirica italiana, Firenze, 1952
; G. De Robertis, Foscolo, Sterne e Didimo, Firenze, 1952;
A. Vallone, Linee della poesia foscoliana, Firenze, 1957;
C. F. Goffis, Nuovi studi foscoliani, Firenze, 1958;
W. Binni, Foscolo e la critica, Firenze, 1963;
M. Fubini, Ortis e Didimo, Milano, 1963.
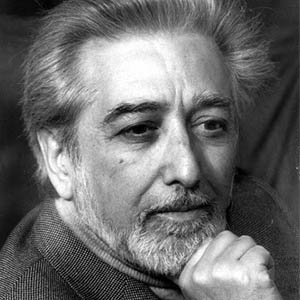
Reno Bromuro è nato a Paduli, in Campania, nel 1937. E' stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale. Nel 1957, a Napoli, ha fondato il Centro Sperimentale per un Teatro neorealista. Ha fondato nel 1973 (di fatto) l'A.I.A. Associazione Internazionale Artisti "Poesie della Vita", e, come critico letterario, ha recensito molti poeti italiani e stranieri. Si è spento nel 2009, qualche anno dopo averci dato l'opportunità di collaborare con lui. Noi di Letteratour lo ricordiamo con affetto qui.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG