
di Reno Bromuro
Nella categoria: HOME | TOURismi letterari
• Biografia
• I Promessi sposi
• La genesi del romanzo
• Storicità dei personaggi
• L'umorismo
"Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno… "
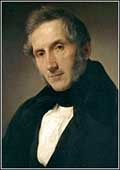 Alessandro
Manzoni, uno dei più grandi scrittori non solo del Diciannovesimo
secolo, ma della letteratura europea, nasce a Milano il 7
marzo 1785, dal conte Pietro, un benestante
proprietario terriero originario di Barzio in
Valsassina, e da Giulia Beccaria
figlia di Cesare Beccaria, il celebre illuminista autore
dell'opera Dei delitti e delle pene, contro
la tortura e la pena di morte.
Alessandro
Manzoni, uno dei più grandi scrittori non solo del Diciannovesimo
secolo, ma della letteratura europea, nasce a Milano il 7
marzo 1785, dal conte Pietro, un benestante
proprietario terriero originario di Barzio in
Valsassina, e da Giulia Beccaria
figlia di Cesare Beccaria, il celebre illuminista autore
dell'opera Dei delitti e delle pene, contro
la tortura e la pena di morte.
Quando Giulia sposa Pietro Manzoni ha vent'anni e lui quarantasei, due
più del suocero. È un matrimonio combinato, al quale la
giovane acconsente malvolentieri e che subisce con insofferenza. Così
quando nasce Alessandro, i soliti pettegoli danno per certo che la paternità
del bambino sia da attribuirsi a Giovanni Verri. Pietro
Manzoni, però, riconosce il figlio e lo affida ad una balia, dal
carattere dolce e allegro, che abita alla cascina Costa, tra Malgrate
e Mozzate, nei dintorni di Lecco.
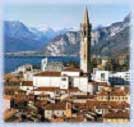 L'interno dell'abitato di Malgrate é
ancora quello che ha visto crescere il piccolo Alessandro: primitivo,
con la case addossate costruite alla vecchia maniera ed i sottoportici
oscuri persi nella ragnatela di vicoli stretti, pavimentati con porfido
posato alla romana;
L'interno dell'abitato di Malgrate é
ancora quello che ha visto crescere il piccolo Alessandro: primitivo,
con la case addossate costruite alla vecchia maniera ed i sottoportici
oscuri persi nella ragnatela di vicoli stretti, pavimentati con porfido
posato alla romana;
Secondo la legge Alessandro resta con il padre. A sei anni entra nel collegio
dei padri Somaschi, prima a Merate
e poi, nel 1796, a Lugano. Qui conosce padre
Carlo Felice Soave autore fra l'altro di Novelle
morali per l'infanzia, un uomo rigido ma di grande prestigio e dirittura
morale, l'unico tra i suoi insegnanti che ricorderà con stima.
Due anni dopo eccolo a Milano, nel collegio
dei Nobili, gestito dai Barnabiti: dieci anni in tutto, durante i quali
riceve una buona educazione classica, a giudicare da come traduce Virgilio
e Orazio. Esce dalla scuola esasperato e ribelle, forse
anche amareggiato dalla sua situazione familiare, ma gratificato da alcune
amicizie che dureranno tutta la vita, come quella di Ermes Visconti.
I genitori si interessano poco di lui; già dal 1792 Giulia Beccaria,
che nel frattempo, aveva conosciuto il nobile e ricco Carlo Imbonati,
col quale si stabilisce prima a Londra e poi
a Parigi, dove è accolta favorevolmente
anche grazie alla fama del padre, finché nel 1805 il nobile muore
improvvisamente lasciandola erede di una cospicua fortuna.
 L'adolescente
Alessandro, è, in sostanza, abbandonato dalla madre, ed ha scarsi
contatti umani con il padre, che in lui vede l'immagine del suo fallimento
matrimoniale e di una donna che non era stato capace di amare e conquistare,
anche a causa di un carattere irresoluto e incline a una spiritualità
umana e religiosa di maniere fatta di apparenze più che di sostanza.
L'adolescente
Alessandro, è, in sostanza, abbandonato dalla madre, ed ha scarsi
contatti umani con il padre, che in lui vede l'immagine del suo fallimento
matrimoniale e di una donna che non era stato capace di amare e conquistare,
anche a causa di un carattere irresoluto e incline a una spiritualità
umana e religiosa di maniere fatta di apparenze più che di sostanza.
 Ama
il teatro, va a giocare al Ridotto della Scala,
conosce il poeta Vincenzo Monti che gli sembra un'immagine
autorevole da imitare, ammira le idee che diffonde Napoleone
in tutta Europa, anche se il personaggio lo lascia perplesso. La vocazione
poetica del sedicenne Manzoni si manifesta con un sonetto autobiografico,
un Autoritratto, in cui si presenta: "Capel
bruno; alta fronte; occhio loquace..." e poi, per quanto riguarda
il carattere, ammette di essere "Duro di modi, ma di cor gentile",
anche se confessa, alla fine, di essere un po' confuso circa il giudizio
da dare di se stesso, "Poco noto ad altrui, poco a me stesso.
/ Gli uomini e gli anni mi diran chi sono". Ma non è
altro che un adolescente in cerca della propria identità; ecco
perché il sonetto riecheggia lo stile di Vittorio Alfieri
che, per i giovani del tempo, è un idolo di cui si ammira la generosità,
l'insofferenza per ogni forma di ipocrisia, il carattere ribelle, l'incarnazione
del genio incompreso, in lotta contro ogni forma di mediocrità.
Ama
il teatro, va a giocare al Ridotto della Scala,
conosce il poeta Vincenzo Monti che gli sembra un'immagine
autorevole da imitare, ammira le idee che diffonde Napoleone
in tutta Europa, anche se il personaggio lo lascia perplesso. La vocazione
poetica del sedicenne Manzoni si manifesta con un sonetto autobiografico,
un Autoritratto, in cui si presenta: "Capel
bruno; alta fronte; occhio loquace..." e poi, per quanto riguarda
il carattere, ammette di essere "Duro di modi, ma di cor gentile",
anche se confessa, alla fine, di essere un po' confuso circa il giudizio
da dare di se stesso, "Poco noto ad altrui, poco a me stesso.
/ Gli uomini e gli anni mi diran chi sono". Ma non è
altro che un adolescente in cerca della propria identità; ecco
perché il sonetto riecheggia lo stile di Vittorio Alfieri
che, per i giovani del tempo, è un idolo di cui si ammira la generosità,
l'insofferenza per ogni forma di ipocrisia, il carattere ribelle, l'incarnazione
del genio incompreso, in lotta contro ogni forma di mediocrità.
In questi anni, incoraggiato dai consensi e dall'amicizia di poeti come
Ugo Foscolo ed Ermes Visconti scrive
l'ode Qual su le Cinzie cime, in cui si sente
l'influsso della poesia del Parini e del Foscolo,
l'idillio Adda, una sorta di invito al Monti
perché sia suo ospite nella villa paterna del Caleotto,
sul lago di Como, e i quattro Sermoni,
in cui, alla maniera di Orazio, elabora una satira sferzante
contro il malcostume del tempo.
I promessi sposi è un
romanzo storico e rappresenta il primo esempio di questo
genere in Italia. Il modello è il romanziere inglese Walter
Scott, da cui Manzoni si discosta affidando alla storia un ruolo
più centrale, creando situazioni e personaggi totalmente verosimili,
ben inseriti nel contesto storico che l'autore ricostruisce rigorosamente
su testi e documenti. La struttura dell'intero romanzo è basata
su una finzione: Manzoni immagina, infatti, di aver trovato un manoscritto
risalente al 1600 in cui un anonimo afferma di aver ascoltato la storia
direttamente da Renzo.
Il romanzo racconta la vicenda di Renzo e Lucia che giunti
nell'imminenza delle nozze, vedono il loro matrimonio impedito dalla prepotenza
del corrotto, don Rodrigo. La viltà di don
Abbondio consente al malvagio di mandare a buon fine il suo proposito.
Le umili vicende dei due promessi si intrecciano con quelle più
grandi della guerra dei Trent'anni e dei suoi riflessi in
Italia, la calata dei Lanzichenecchi
e la conseguente pestilenza del 1630. La vicenda si conclude finalmente
col matrimonio celebrato proprio da don Abbondio.
 L'azione
ha inizio sul lago di Como e si svolge, evolvendosi,
tra Monza, Lecco,
Milano ed altri luoghi della Brianza.
L'azione
ha inizio sul lago di Como e si svolge, evolvendosi,
tra Monza, Lecco,
Milano ed altri luoghi della Brianza.
E' incantevole come la narrativa manzoniana riesca a far partecipe il
lettore della vicenda e fargli vedere i luoghi dove si svolge, la storia
narrata. Abbiamo visto che siamo sulle alture del lago di Como, Don Abbondio
sale affannosamente l'erta via sterrata quando alla sommità, da
dove si può ammirare tutta la bellezza del panorama, incontra "due
figuri" (il Griso e il Nibbio)
che gli impongono: "questo matrimonio non sa da fare".
Siamo tra il Quindicesimo e il Sedicesimo
secolo, la seta comincia a diffondersi in Lombardia,
e viene introdotta anche a Como. Si tratta all'inizio
di una produzione marginale, ma già verso la fine del Cinquecento
e poi nel corso del Seicento le prime fasi del ciclo della produzione
serica si affermano in tutto il territorio rurale, provocando anche massicce
trasformazioni nel paesaggio agrario.
E' un sistema di imprese in grado di garantire lavorazioni e prodotti
qualificati e tali da soddisfare ogni esigenza. Scorrendo queste pagine
avete la certezza di trovarvi, appunto, in un sito turistico-culturale.
"Quel ramo del lago di Como, che
volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti…"
L'origine del Lago di Como, come quella di molti laghi subalpini italiani,
è glaciale.
Abitato fin dall'epoca preistorica, il Lago di Como
ha sempre avuto una grande importanza come via di comunicazione tra le
regioni del Nord e la Pianura Padana.
Dopo i Galli vi si stabilirono i Romani,
che ne fecero un punto strategico aprendo sulla sponda occidentale la
via che collega il "Larius" con la Rezia.
In seguito, con la dominazione longobarda, questa strada, che porta ancor
oggi il nome "Regina", è riaperta
e riadattata dalla regina Teodolinda, data l'importanza
strategica del lago, che permette di raggiungere i passi del Maloja
e dello Spluga, la zona è stata soggetta
per secoli ad invasioni e dominazioni. Il primo paese che s'incontra aggirando
il lago, è situato proprio sulle sponde del ramo comasco del Lario;
il comune è formato da due nuclei distinti di Urio
e di Carate Lario, uniti dal 1927 come amministrazione.
Urio, è ricca di ville residenziali, è situata in bella
posizione panoramica su un pendio rivolto al lago. Un tempo vi sorgeva
un imponente castello, i cui resti sono stati incorporati nella villa
ottocentesca,attualmente sede del Centro Internazionale di
Studi dell'Opus Dei. Carate Lario, in posizione meno panoramica,
non è stata molto toccata dalla urbanizzazione e presenta una struttura
particolare con vicoli a scalinate e vecchie case. Le origini di entrambi
i centri sono molto antiche; nella zona sono state ritrovate tombe galliche
e resti della civiltà romana.
Camminando in cerchio intorno al lago incontriamo Cernobbio
paese di antiche origini, che dopo varie vicissitudini riesce ad ottenere
nel Tredicesimo secolo privilegi e statuti propri. Ha poi un periodo di
decadenza nel Sedicesimo secolo con l'invasione e il saccheggio da parte
degli Spagnoli. Nel secolo scorso è già
un luogo di villeggiatura molto conosciuto. Famosa per le sue ville e
i suoi alberghi, Cernobbio è anche un importante centro industriale.
Qui è nato uno dei primi stabilimenti a carattere industriale per
la lavorazione della seta. Passando per Moltrasio, non si può rinunciare
di visitare "Villa Passalacqua", detta
anche Palazzo di Moltrasio, le mura delle cantine
sono parte del monastero degli Umiliati. La prima parte
della villa è costruita dalla famiglia Odescalchi,
poi ceduta al conte Andrea Passalacqua, che affida i
lavori di ampliamento all'architetto Felice Soave. Tra
gli affreschi, tutti di fattura geniale, c'è una Madonna
con Bambino attribuita ad Andrea Appiani.
Ricordiamo anche che qui Vincenzo Bellini compose
La Straniera e parte de La Sonnambula.
Accanto alla villa, la chiesetta romanica di Sant'Agata
che fu adibita a lazzaretto durante la peste del Seicento. Di cui parla
Manzoni ne I Promessi sposi, ha un campanile con decorazioni ad archetti,
bifore e trifore. E poi uno allacciato all'altro s'incontrano: Laglio
e Torreggia, Brienno,
Argeno, Colonno,
Sala Comacina, Tremezo
seguiti da altri paesi lungo il cerchio che circonda il Lago.
Da Como, Manzoni, fa addentrare i personaggi
verso Lecco e dopo aver descritto l'ambiente,
le mansioni, e i lavori sui vari tipi di culture illustra, come viene
calcolato il salario del lavorante agricolo, come ed in quale casa egli
vive con la sua famiglia, per conoscere così tutti gli stratagemmi
che lo avrebbero aiutato a sbarcare il lunario. Il salario quello in danaro
veniva calcolato sulle duemilacinquecento ore annue obbligatorie, così
come recita lo Statuto del Patto Agrario e la
paga è corrisposta alla seconda domenica di ogni mese. A San
Martino, l'11 Novembre, data convenzionale in agricoltura per
l'inizio e la fine di ogni contratto agricolo, il datore di lavoro tira
le somme e provvede al conguaglio: dalla quota annuale vengono detratti
l'affitto della casa, gli acconti anticipati e, per chi ne ha fatto richiesta,
il supplemento di salario in natura, ovvero l'equivalente in danaro per
le ore perse per malattia e permessi.
Il salario in natura fissato dal patto colonico, riferito a salariati
compresi fra i 18 e i 65 anni, è di due quintali di frumento, cinque
di granturco, due di riso, trecentosessanta cinque litri di latte e poi
di trenta quintali di legna verde e cinque quintali di legna secca.
L'Autore ci descrive il sistema chiamato "Divisione e
compartecipazione", ancora oggi praticato, specialmente
nelle regioni meridionali.
 La
divisione, come dice chiaramente la parola, riguarda la spartizione del
raccolto. Per prima si divide il mais. L'ampia area dell'aia è
ravvivata dal giallo dorato del granturco frazionato in mucchi quanti
sono i compartecipanti.
La
divisione, come dice chiaramente la parola, riguarda la spartizione del
raccolto. Per prima si divide il mais. L'ampia area dell'aia è
ravvivata dal giallo dorato del granturco frazionato in mucchi quanti
sono i compartecipanti.
I mezzadri abitano in case fatiscenti, si vedono ancora nei cascinali
abbandonati, poi nei paesi di campagna esistono ancora degli agglomerati
rurali non ancora restaurati dai quali è possibile, avendo una
parvenza architettonica, datare l'epoca della edificazione ma, queste
case non hanno nulla a che vedere con quelle abitate dalla maggioranza
dei salariati. Questi caseggiati annessi o nelle vicinanze della corte
padronale, sono un ammasso informe di grossi sassi e mattoni tenuti insieme
da chissà quale impasto, sono tozze costruzioni a due piani di
epoca inconfondibile; in apparenza sembrano solide, ma solamente perché
hanno i muri perimetrali dello spessore di ottanta centimetri.
Il piano inferiore ha il pavimento in terra battuta e si trova sotto il
livello stradale, per evitarne l'allagamento è protetto dalle piogge
torrenziali da un piccolo argine posto all'inizio del declivio che conduce
alla porta d'ingresso. In caso di emergenza si provvede a rinforzare il
piccolo argine con un cordone di letame di stalla, grasso ed impermeabile.
 L'entrata,
brutta e sproporzionata è chiusa da un uscio enorme, fatto di tavole
chiodate sovrapposte e gira cigolante su grossi cardini aprendosi all'interno.
L'entrata,
brutta e sproporzionata è chiusa da un uscio enorme, fatto di tavole
chiodate sovrapposte e gira cigolante su grossi cardini aprendosi all'interno.
Il piano superiore, come il tetto, è sostenuto da grosse travi
sghembe; come area è la copia del piano terra con la sola variante
del pavimento che è in tavolato di legno grezzo. Gli annessi, ovvero
il pollaio, il porcile, si trovano di fronte o di fianco alle abitazioni,
mentre il servizio igienico, dove esiste e comune per tutti, è
collocato poco distante; di norma si tratta di una rudimentale costruzione
di circa un metro quadro, chiusa da una porta di legno, con due mattoni
posti di fianco ad un buco sul pozzo nero.
L'acqua per l'uso domestico arriva nelle abitazioni, tramite un canale
formato da tronchi d'albero svuotati, in questo territorio, poi, di acqua
ce n'è in abbondanza. I muri sono imbiancati a calce, perché
funge anche da disinfettante, che viene applicata con la pompa; da contratto
deve essere applicata una volta l'anno a spese del padrone ma, salvo eccezioni,
precipita nell'oblio.
In posizione privilegiata, sulla parete più ampia, troneggia il
ritratto dei vecchi antenati e l'altarino, con immagini sacre, le candele
e l'ulivo benedetto e la boccetta dell'acqua lustrale. A destra dell'ingresso
due bracci a muro con ganci sostengono due secchi di rame per la scorta
d'acqua e, su un pannello, sono appese le tazze a manico lungo per attingerla.
Di fianco un supporto alto un metro e settanta sostiene il catino per
le abluzioni quotidiane mentre per terra è riposto tutto l'occorrente
per lavare i piatti. In un angolo nascosto, un grosso paiolo raccoglie
gli avanzi e le scorie vegetali per nutrire il maiale, perché nulla
deve andare perduto.
Manzoni ha scritto il Fermo e
Lucia dal 1821 al 1823, contemporaneamente alle Odi
e all'Adelchi. Appena terminato comincia a riscriverlo,
in quel processo di revisione creativa che dà, poi vita a I
Promessi Sposi.
Lo scopo di questa revisione è di dare maggiore coerenza ed equilibrio
al romanzo, che in questa prima versione tende agli effetti forti ed alla
presa sul pubblico meno colto.
La riscrittura viene accompagnata da frequenti dialoghi del Manzoni con
gli amici Fauriel e Visconti. Lo scrittore
elimina le digressioni sulla lingua e la storia del processo ai due untori,
toglie un lungo passo storico che introduce la figura di Federigo
Borromeo e dà un tono meno orripilante alla scena della
morte di Don Rodrigo. Ma la sostanziale differenza tra
il Fermo e Lucia ed i Promessi Sposi si nota a proposito
dei personaggi di Gertrude e dell'Innominato.
L'edizione definitiva, che è pubblicata col titolo "I
Promessi Sposi" nel 1827, si presenta in tre tomi.
A questo punto sorge più urgente alla coscienza letteraria del
Manzoni il problema della lingua. Il linguaggio usato per l'edizione del
romanzo del 1827 gli sembra poco conforme a quel dialetto toscano che
egli ritiene dovesse essere la base di un buon italiano letterario.
 Manzoni
vuol rappresentare nel romanzo la lotta fra bene e male, perciò
i personaggi appartengono ai due diversi schieramenti di coloro che agiscono
positivamente o negativamente nella storia.
Manzoni
vuol rappresentare nel romanzo la lotta fra bene e male, perciò
i personaggi appartengono ai due diversi schieramenti di coloro che agiscono
positivamente o negativamente nella storia.
Alcuni hanno una loro matrice storica come la monaca di Monza
o il cardinale Federigo Borromeo, altri, come Renzo
e Lucia, sono stati creati dalla penna del Manzoni e
hanno soltanto una costruzione letteraria verosimile.
Manzoni, "nel discorso assume come tesi che il romanzo storico
sia un genere ibrido e quindi di scarso valore letterario, i Promessi
Sposi è un romanzo storico in accordo con tutti i principi accolti
per questo genere". Storico è lo sfondo nel quale l'azione
si svolge e storici sono gli avvenimenti descritti, come la carestia,
la guerra, l'epidemia di peste.
Sembra che Padre Cristoforo è una di quelle figure
di uomini impavidi e di religiosi eroici che incarnano l'idea manzoniana
di personaggio positivo e benefico. Nato nella famiglia di un mercante,
il suo nome originario era Lodovico. Il padre, ch'era
divenuto ricco grazie ai suoi affari, ma che si vergognava delle sue origini
plebee, aveva voluto che frequentasse le scuole più adatte ad un
giovane nobile e lo aveva educato come un aristocratico; e perciò
si può identificare con un certo Picenardi da Cremona,
mentre sicuramente storica è la figura di Antonio Ferrer,
gran cancelliere sotto il governo di Don Ponzalo Fernandez;
è astuto e, per calmare le acque, fa abbassare artificiosamente
il prezzo del pane ad una somma iniqua, non corrispondente al prezzo del
grano; come pure reale è il personaggio di Federigo Borromeo:
carattere fermo, inflessibile nel fare il ben e,
attento a compiere quanto è possibile per soccorrere i poveri.
Sappiamo da Manzoni che egli è il fondatore della Biblioteca
Ambrosiana, che fa costruire ospizi ed ospedali, che scrive
molti libri di dottrina, anche se in certi argomenti è soggetto
alle convinzioni superstiziose in cui cadono molti suoi contemporanei,
come le idee sulla stregoneria e sugli untori. Nell'Innominato
si adombra Bernardino Visconti
e,
attento a compiere quanto è possibile per soccorrere i poveri.
Sappiamo da Manzoni che egli è il fondatore della Biblioteca
Ambrosiana, che fa costruire ospizi ed ospedali, che scrive
molti libri di dottrina, anche se in certi argomenti è soggetto
alle convinzioni superstiziose in cui cadono molti suoi contemporanei,
come le idee sulla stregoneria e sugli untori. Nell'Innominato
si adombra Bernardino Visconti  e
la monaca di Monza, Gertrude, è pure una figura
reale, Virginia di Leyva. Gertrude ha il solo difetto
di avere un carattere debole, di essere influenzabile e soggetta alle
passioni. Firma avventatamente il documento che deve precedere di un mese
l'esame della vocazione, poi, tornata a casa, si scontra con la freddezza
dei genitori, che vogliono convincerla a tutti i costi a restare in convento
e per questo cercano di renderle sgradevole il soggiorno domestico. E
lei si aggira per anni per il chiostro (che vediamo qui a destra).
e
la monaca di Monza, Gertrude, è pure una figura
reale, Virginia di Leyva. Gertrude ha il solo difetto
di avere un carattere debole, di essere influenzabile e soggetta alle
passioni. Firma avventatamente il documento che deve precedere di un mese
l'esame della vocazione, poi, tornata a casa, si scontra con la freddezza
dei genitori, che vogliono convincerla a tutti i costi a restare in convento
e per questo cercano di renderle sgradevole il soggiorno domestico. E
lei si aggira per anni per il chiostro (che vediamo qui a destra).
Personaggi di invenzione sono invece i protagonisti, Renzo Tramaglino,
giovane contadino rimasto orfano dei genitori, all'apertura del romanzo
è sul punto di sposare Lucia che, con la futura
suocera Agnese, è ormai tutta la sua famiglia.
Rappresentante di quella gente umile e sincera che Manzoni predilige,
egli è dotato di un innato senso di giustizia ed è, allo
stesso tempo, un uomo di grande moralità. Ha però un temperamento
impulsivo, che lo porta ad essere preda di furie violente, le quali spaventano
le due donne, ma non approdano a risultati concreti. Lucia è il
personaggio che incarna l'ideale di Manzoni. Semplice, pura, gentile,
la sua innocenza fa sì che a volte non si renda conto dei pericoli
che corre. Forte di una fede ferma e incrollabile, si affida completamente
a Dio, e questo suo abbandono alla volontà divina la rende sempre
meno attiva e rumorosa degli altri personaggi del romanzo, che per ottenere
i loro scopi gridano e si arrovellano; e molti personaggi di contorno
come Agnese, Don Abbondio, Perpetua,
Don Rodrigo, il Griso, il Nibbio
e gli altri.
Il sorriso del lettore è originato innanzi tutto dal contrasto fra l'io narrante e certe posizioni dell'anonimo creato da Manzoni, che è espressione di una cultura secentesca cui lo scrittore nega ogni valore come cultura reale. Ma, oltre che in quest'artificio narrativo, l'umorismo del Manzoni si esprime in tutta la gamma d'atteggiamenti che può dettare ad un uomo credente ma disincantato la visione di un mondo che spesso coltiva valori non veri e che egli intende demistificare con l'acutezza dell'intelligenza. Il suo sarcasmo colpisce i personaggi d'autorità, come Don Gonzalo, Ambrogio Spinola e il Conte zio e si esprime, anche linguisticamente, nell'ironia che caratterizza l'episodio in cui compare Antonio Ferrer, con un uso del linguaggio - lo spagnolo misto all'italiano - dal quale risultano effetti di comico realismo. E' un umorismo che si trasforma in satira tagliente quando si parla di Donna Prassede, descritta come una donna chiusa in un bigottismo che è la trista parodia del cattolicesimo. Ci sono, poi, i personaggi ai quali lo scrittore guarda con un sorriso di comprensione, come il sarto letterato, che vorrebbe esprimere in una frase al Borromeo la propria cultura e la propria ammirazione, e non riesce, e continua a dispiacersene. A queste figure, buffe senza essere patetiche, lo scrittore è vicino e la sua distaccata ironia si smorza, per trasformarsi in divertita partecipazione.
Bibliografia
Alessandro Manzoni "I promessi sposi" - Edizione Collezione
Salani
Giorgio Petrocchi, da "La tecnica manzoniana del dialogo"
Natalino Sapegno da "Ritratto di Manzoni e altri saggi"
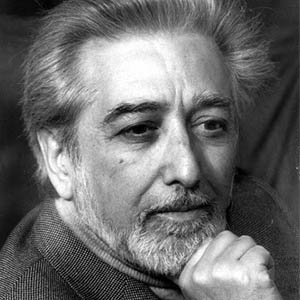
Reno Bromuro è nato a Paduli, in Campania, nel 1937. E' stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale. Nel 1957, a Napoli, ha fondato il Centro Sperimentale per un Teatro neorealista. Ha fondato nel 1973 (di fatto) l'A.I.A. Associazione Internazionale Artisti "Poesie della Vita", e, come critico letterario, ha recensito molti poeti italiani e stranieri. Si è spento nel 2009, qualche anno dopo averci dato l'opportunità di collaborare con lui. Noi di Letteratour lo ricordiamo con affetto qui.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG