
di Reno Bromuro
"la vita è lunga e questo dannato tempo non cammina"
Nella categoria: HOME | TOURismi letterari
• Biografia
• L'opera Lorenzaccio
• La storia
• La messinscena
• Critica: Lorenzaccio, ovvero il
disagio e l'utopia politica
• Palazzi di Firenze
 "La
vita è lunga e questo dannato tempo non cammina" così
ripeteva spesso il poeta Alfred de Musset nato a Parigi
l'11 dicembre 1810 da una famiglia dove ognuno ha la passione per le lettere
e le arti. Alfred rappresenta l'urgenza e le febbri di un artista nel
secolo Romantico
per antonomasia. Si consacra all'arte: alla sua arte, con dedizione assoluta,
sempre ispirato dalle donne e dall'amore; e nondimeno,ha vissuto da artista
romantico,all'insegna di bacco,tabacco e Venere... Nell'esperienza artistica
si interessa anche agli scacchi, ai quali si vota con competenza e poesia.
Suo fratello Paul lo rammenta come "uomo parossisticamente
inquieto", ama soprattutto il Cavallo, nel suo eloquio "cleval"
e non "cavalier", al quale intitola nel 1849 un autografo dal
titolo La Régence.
"La
vita è lunga e questo dannato tempo non cammina" così
ripeteva spesso il poeta Alfred de Musset nato a Parigi
l'11 dicembre 1810 da una famiglia dove ognuno ha la passione per le lettere
e le arti. Alfred rappresenta l'urgenza e le febbri di un artista nel
secolo Romantico
per antonomasia. Si consacra all'arte: alla sua arte, con dedizione assoluta,
sempre ispirato dalle donne e dall'amore; e nondimeno,ha vissuto da artista
romantico,all'insegna di bacco,tabacco e Venere... Nell'esperienza artistica
si interessa anche agli scacchi, ai quali si vota con competenza e poesia.
Suo fratello Paul lo rammenta come "uomo parossisticamente
inquieto", ama soprattutto il Cavallo, nel suo eloquio "cleval"
e non "cavalier", al quale intitola nel 1849 un autografo dal
titolo La Régence.
Giovanissimo frequentatore dei cenacoli di V. Hugo e
di Ch. Nodier, esponente del romanticismo più
tenero e intelligente, nel 1833, vive per due anni una sublime storia
d'amore con George Sand; nel 1852, è ammesso all'Académie
Française.
La tisi e l'assenzio contrassegnano gli ultimi due anni della sua esistenza
e dal 1855 al 1857, ogni giorno si reca alla Régence, intento in
partite sostenute con sigarette e assenzio. Tuttavia, Alfred de Musset
è stato un degno accolito del regno di Caissa,
come dimostra una sua partita col Maestro italiano Serafino Dubois,
ma, vino, tabacco e Venere avevano già minato il suo corpo che
si abbandona alla morte nella notte dal 1° al 2 maggio 1857 nella
sua casa di Parigi.
Nel suo "Piccolo trattato di poesia francese"
afferma che "Senza l'esattezza dell'espressione, non vi è
poesia".
 Musset,
come tutti gli autori del suo tempo si muove verso il teatro che procura
celebrità e soldi; e scrive dei drammi con il fratello Paul. Ma
il dramma la "Ricevuta del diavolo"
è tolto dal cartellone a causa delle agitazioni rivoluzionarie
di luglio 1830. Il secondo pezzo, una commedia, dal titolo
"La notte Veneziana" creata lo stesso
anno è un fallimento totale. A questo punto rinuncia al palcoscenico,
ma non alla scrittura teatrale che eserciterà liberamente, senza
preoccuparsi delle costrizioni del palcoscenico e lo stile alla moda.
Nel 1832, pubblica il volume Spettacolo in una poltrona,nel
1833, i Capricci di Marianne. Sta seguendo la
pubblicazione di questo lavoro che Buloz, il direttore
potente del Periodico dei Due Mondi lo arruola.
Durante gli anni che seguiranno, è, lui quello pubblicherà
più testi dell'autore.
Musset,
come tutti gli autori del suo tempo si muove verso il teatro che procura
celebrità e soldi; e scrive dei drammi con il fratello Paul. Ma
il dramma la "Ricevuta del diavolo"
è tolto dal cartellone a causa delle agitazioni rivoluzionarie
di luglio 1830. Il secondo pezzo, una commedia, dal titolo
"La notte Veneziana" creata lo stesso
anno è un fallimento totale. A questo punto rinuncia al palcoscenico,
ma non alla scrittura teatrale che eserciterà liberamente, senza
preoccuparsi delle costrizioni del palcoscenico e lo stile alla moda.
Nel 1832, pubblica il volume Spettacolo in una poltrona,nel
1833, i Capricci di Marianne. Sta seguendo la
pubblicazione di questo lavoro che Buloz, il direttore
potente del Periodico dei Due Mondi lo arruola.
Durante gli anni che seguiranno, è, lui quello pubblicherà
più testi dell'autore.
Dopo un viaggio a Venezia nel 1834; Musset si
ammala seriamente e sopporterà allucinazioni e crisi di pazzia.
Il rapporto intenso con George Sand raggiunge quella
maturità che riesce ad allontanare dalla vista i difetti dell'uno
e quelli dell'altra, per una nuova riconciliazione che dovrebbe essere
eterna, invece dopo solo un anno naufragherà ancora.
 È
durante questo periodo che scrive Fantasio ed
Uno non burla con l'amore, pezzi che offrono
una mistura di fantasia leggera e cinismo che non celano una disperazione
profonda. Dalla rottura con la Sand, nel 1834, nascerà un capolavoro
ineguagliabile inclassificabile, mostruoso, diamante del romanticismo
francese: il dramma teatrale Lorenzaccio e Il
Candeliere, un'autobiografia con la narrazione di La
confessione di un bambino del secolo, che analizza il dolore
singolare che lo colpisce in modo molto lucido: la noia per vivere o il
"dolore del secolo" che afferma provenga dalle ragioni
storiche e dalle speranze deluse dalla generazione intera, in special
modo, quella del suo secolo.
È
durante questo periodo che scrive Fantasio ed
Uno non burla con l'amore, pezzi che offrono
una mistura di fantasia leggera e cinismo che non celano una disperazione
profonda. Dalla rottura con la Sand, nel 1834, nascerà un capolavoro
ineguagliabile inclassificabile, mostruoso, diamante del romanticismo
francese: il dramma teatrale Lorenzaccio e Il
Candeliere, un'autobiografia con la narrazione di La
confessione di un bambino del secolo, che analizza il dolore
singolare che lo colpisce in modo molto lucido: la noia per vivere o il
"dolore del secolo" che afferma provenga dalle ragioni
storiche e dalle speranze deluse dalla generazione intera, in special
modo, quella del suo secolo.
Ma poco a poco, incapace di superare questa crisi esistenziale, Musset,
definitivamente a 28 anni già avrà dato il meglio di sé:
il ritmo con cui scrive, è lo stesso che manifesta la qualità
di produzione.
Un evento inaspettato, però, viene ad illuminare gli ultimi dieci
anni della sua vita: nel 1847, la Commédie française
lo nomina accademico di Francia, dopo il grande
successo del dramma, i Capricci di Marianne
che è un vero trionfo. È una sorpresa per tutto il mondo
culturale francese, allora Musset capisce che scrivere per il teatro non
è stato un gioco e di nuovo in Francia che l'autore non aveva fatto
cosa così eccellente. Di tutte le sue opere, però, Lorenzaccio
è un'eccezione, che riempie le sale dei teatri, e i produttori
lo investono di ordinazioni per nuovi testi. Oramai è ammalato
e scoraggiato, nonostante un'ufficiale duplice onorificenza: la Legione
d'onore nel 1845 e l'iscrizione all'Accademia francese e la nomina a bibliotecario
del ministero dell'istruzione pubblica che lui pensa di
ricevere l'anno seguente e, anche, se il suo teatro è riconosciuto,
si ritira nella solitudine.
Lorenzaccio del
1834, è un dramma storico tratto da un canovaccio di George
Sand. Musset partecipa attivamente alla formazione di un nuovo
gusto scenico.
Lorenzaccio è un progetto autodistruttivo, che poi è quello
della sua vita. Il piacere è anche il punto di partenza dell'annientamento
dei personaggi, e fondamento di una scelta esistenziale.
Lorenzaccio uccide Filippo Strozzi, compagno d'orge e
tiranno di Firenze, trovando nel regicidio una
giustificazione assurda della propria inanità. Rolla assorbe in
un nero flacone di veleno, con l'ultimo filtro amoroso, la morte che segna
la dilapidazione della fortuna e dei sentimenti, nel piacere. La vita
dei personaggi di Musset è seducente ed effimera. Svincolato da
impegni morali e politici, prigioniero delle sue scelte esistenziali,
si esprime emotivamente nel linguaggio letterario attinto a Marivaux,
oppure a Byron, che, con Don Juan,
è una delle figure che più condizionano la sua fantasia.
Lorenzino De' Medici detto
Lorenzaccio, visse dal 1513 al 1548.
Posto sotto la tutela di Clemente VII, dopo la morte
del padre, con un folle gesto decapita alcune statue antiche della corte.
E' bandito dal papa e si rifugia a Firenze,
presso suo cugino Alessandro, che in seguito assassina,
con l'aiuto di un servitore, per liberare Firenze dall'oppressione e dalla
tirannide.
La mancanza di organizzazione, però, gli chiude la via del successo,
lasciando a Cosimo la possibilità di impadronirsi
del potere. Lorenzino è costretto a fuggire a
Venezia, poi in Turchia,
a Parigi e infine ancora a Venezia,
dove è ucciso dai sicari di Cosimo.
 Nel
1896 è Sarah Bernhardt che mette in scena, per
la prima volta, questo dramma storico, ricco di intrecci, per la parabola
esistenziale di Lorenzino de' Medici, il quale nel 1537
uccide il cugino Alessandro. Il giovane de' Medici, proprio
per questo suo delitto, diventa "Lorenzaccio",
ed è la disperata e vana utopia del giovane solitario che, per
la libertà collettiva, vorrebbe opporre la violenza del singolo
a quella del potere. Però la sua vicenda, è, come tante
altre, legate ai movimenti utopici che si susseguono numerosi nel corso
dei secoli, il cui esito è vanificato dalla impreparazione e dalla
mancanza di un pensiero comune a coloro che pure si dichiarano pronti
al sacrificio supremo pur di riacquistare la libertà: con la conseguenza
di un ritorno al potere assoluto, seppure sotto altra veste, ma con pari
se non più giustificata violenza. Lorenzaccio è
una parabola, che si dipana nei meandri tortuosi della Storia e in quelli
non meno complessi dei sentimenti in uno dei capolavori del teatro romantico.
Fino allora le censure, quella monarchica di Luigi Filippo,
poi quella imperiale di Napoleone III, ne avevano rifiutato
il visto.
Nel
1896 è Sarah Bernhardt che mette in scena, per
la prima volta, questo dramma storico, ricco di intrecci, per la parabola
esistenziale di Lorenzino de' Medici, il quale nel 1537
uccide il cugino Alessandro. Il giovane de' Medici, proprio
per questo suo delitto, diventa "Lorenzaccio",
ed è la disperata e vana utopia del giovane solitario che, per
la libertà collettiva, vorrebbe opporre la violenza del singolo
a quella del potere. Però la sua vicenda, è, come tante
altre, legate ai movimenti utopici che si susseguono numerosi nel corso
dei secoli, il cui esito è vanificato dalla impreparazione e dalla
mancanza di un pensiero comune a coloro che pure si dichiarano pronti
al sacrificio supremo pur di riacquistare la libertà: con la conseguenza
di un ritorno al potere assoluto, seppure sotto altra veste, ma con pari
se non più giustificata violenza. Lorenzaccio è
una parabola, che si dipana nei meandri tortuosi della Storia e in quelli
non meno complessi dei sentimenti in uno dei capolavori del teatro romantico.
Fino allora le censure, quella monarchica di Luigi Filippo,
poi quella imperiale di Napoleone III, ne avevano rifiutato
il visto.
Nel 1986, dopo circa un secolo, Carmelo Bene, notata
la mancanza di naturalezza e di sincerità espressiva, le difficoltà
degli attori nell'eseguire azioni "reali" e "credibili",
problemi osservati da molti maestri del primo teatro di regia mette in
scena "Lorenzaccio" per far vedere in pratica la teoria
che enuncia la mancanza di naturalezza espressiva dell'attore.
Da tenere presente che la nozione corpo-mente si sviluppa principalmente
negli ambiti della rieducazione psicofisica, soprattutto con la Bioenergetica.
A questo proposito si veda il contributo comparativo di D. Boadella
- J. Liss, La psicoterapia del corpo. Le nuove frontiere
tra corpo e mente, Roma, Astrolabio, 1986.
Carmelo Bene con la messinscena del "Lorenzaccio"
ha voluto attirare la polarità del giovane attore e del pretentende
attore, e mostrare loro come questa polarità corpo/mente porta
con sé un'altra questione, che si evidenzia nella ricerca teatrale:
la possibilità per l'attore di essere naturale sulla scena, di
essere totalmente presente nelle proprie azioni, di essere sincero e credibile.
Stanislavskij, invece, costatando l'irrigidimento che
subisce l'interprete nel ripetere la parte e la mancanza di verità
dell'attore nel momento in cui finge d'essere un personaggio durante ogni
replica, si avvia verso la ricerca di uno stato d'animo creativo e di
una verità interiore che possa supportare l'attore durante la recitazione.
 Carmelo
Bene, con il "Lorenzaccio" ha affermato la
sua teoria, dimostrando che quest'ordine di problemi è reso evidente
da una situazione tipica dell'attore: eseguire, durante le repliche, con
la medesima spontaneità della prima volta, azioni e gesti predeterminati
e conosciuti da tempo.
Carmelo
Bene, con il "Lorenzaccio" ha affermato la
sua teoria, dimostrando che quest'ordine di problemi è reso evidente
da una situazione tipica dell'attore: eseguire, durante le repliche, con
la medesima spontaneità della prima volta, azioni e gesti predeterminati
e conosciuti da tempo.
Grotowski sottolinea, invece, che: "Se un attore
vuole esprimere, allora è diviso: c'è una parte che vuole
e una che esprime, una parte che ordina e una che esegue gli ordini".
In questa scissione interna all'attore, inoltre, la volontà di
controllare se stessi, non fa che acuire la generale mancanza di integrità
psicofisica; e propone un esempio di questa condizione: "Si verifica
spesso che l'attore controlli la sua voce ascoltando se stesso, e quindi
esegua male i suoi esercizi. Questo blocca l'organicità del processo
e può cagionare una serie di tensioni muscolari che, a loro volta,
impediscono la corretta emissione della voce […]. Si stabilisce
così un circolo vizioso: volendo usare correttamente la voce, l'attore
ascolta se stesso; ma ascoltandosi si blocca e quindi gli diventa impossibile
emettere la voce in maniera corretta"
 Vi
sono anche esperienze teatrali, però, che mettono in luce la medesima
problematica seguendo un percorso negativo, nel senso di un iter inverso
che non mira al superamento della separazione tra corpo e mente, bensì
alla denuncia dell'impossibilità di un'integrazione psicofisica
cosciente dell'agire umano. Le idee e il lavoro scenico di Carmelo
Bene, per esempio, sono incentrati su questo principio: "l'atto
e l'azione sono due fasi logicamente distinte dell'agire umano. L'azione
è il progetto, ossia il concetto dell'atto ad esso preesistente,
mentre l'atto è l'esito corporeo da cui l'azione, in quanto progetto,
è estromessa; se alla coscienza del soggetto appartiene l'azione
(il progetto), così non è per l'atto, esito dell'azione
di cui il soggetto ha conoscenza soltanto al di fuori del suo compiersi,
ossia a posteriori".
Vi
sono anche esperienze teatrali, però, che mettono in luce la medesima
problematica seguendo un percorso negativo, nel senso di un iter inverso
che non mira al superamento della separazione tra corpo e mente, bensì
alla denuncia dell'impossibilità di un'integrazione psicofisica
cosciente dell'agire umano. Le idee e il lavoro scenico di Carmelo
Bene, per esempio, sono incentrati su questo principio: "l'atto
e l'azione sono due fasi logicamente distinte dell'agire umano. L'azione
è il progetto, ossia il concetto dell'atto ad esso preesistente,
mentre l'atto è l'esito corporeo da cui l'azione, in quanto progetto,
è estromessa; se alla coscienza del soggetto appartiene l'azione
(il progetto), così non è per l'atto, esito dell'azione
di cui il soggetto ha conoscenza soltanto al di fuori del suo compiersi,
ossia a posteriori".
Attraverso questo genere di percorsi analitici, e mediante continui riscontri
empirici, la ricerca teatrale del Novecento giunge all'individuazione
di un problema essenziale per un teatro che si vuole proporre come un'arte
del presente e dell'espressione sincera e reale.
Carmelo Bene è stato rappresentato dalla sua voce inconfondibile
e ci ha fatto riascoltare con emozione alcune delle sue memorabili interpretazioni,
la registrazione video dello spettacolo "Lorenzaccio,
al di là di de Musset e Benedetto Varchi", che
l'artista aveva cominciato a montare insieme a Mauro Contini
e che oggi è stata completata a cura della fondazione "L'Immemoriale
di Carmelo Bene". La prima visione del Lorenzaccio
è la prova concreta della continuazione della vita delle opere
di Carmelo Bene: entrambe queste operazioni, non fanno ancora parte di
un lascito ma del suo stesso diretto impegno di lavoro.
Maurizio Scaparro, nel riproporre oggi Lorenzaccio,
ha inteso sottolineare la straordinaria attualità di un racconto
drammatico al cui centro c'è una generazione di giovani alle prese
con aspirazioni, ideologie, tensioni e infelicità così tremendamente
presenti, che fa una generazione prigioniera della propria individualità,
spesso esposta ai pericoli di scelte estreme e violente.
CRITICA
LORENZACCIO OVVERO IL DISAGIO E L'UTOPIA POLITICA
Lorenzaccio è considerato il Capolavoro
teatrale del Diciannovesimo secolo, questo dramma squisitamente
"shakespeariano" è ricco di un'analisi psicologica, di
un'attenta ricostruzione storica e di un'arte precisa del chiaro-scuro,
è ispirata alla cospirazione repubblicana contro suo cugino Alessandro.
Cosa muove Lorenzo al tirannicidio? La passione politica,
il disagio, prettamente giovanile, fatto di rabbia impotente, di noia,
di contestazione totale e forse d'incertezza.
 Lorenzaccio,
affascinante capolavoro poco frequentato del romantico Alfred De Musset
e portato in scena, la prima volta, da Sarah Bernhardt
nel 1896, è la storia di un uomo incapace di vivere in modo calmo
la propria esistenza.
Lorenzaccio,
affascinante capolavoro poco frequentato del romantico Alfred De Musset
e portato in scena, la prima volta, da Sarah Bernhardt
nel 1896, è la storia di un uomo incapace di vivere in modo calmo
la propria esistenza.
Disadattato perché sognatore, illuso ribelle, libero e solo, come
spesso sono gli anti-eroi: non vincitore, certo, perché Lorenzino
de' Medici soffre della insostenibile libertà concessagli, del
vuoto di ideali, di valori, che lo circonda in una Firenze
al declino. Uno sconfitto che sembra diventare eroe nel momento in cui
sceglie di combattere il potere crudele e corrotto del despota Alessandro.
Sotto quest'aspetto Lorenzaccio diviene quasi un simbolo, quanto mai contemporaneo,
di una "generazione sfortunata", privata
com'è di valori concreti, che vive con estrema fatica una fase
continua di transizione tra l'inglobamento in una società menzognera
e la fuga come unica via di salvezza, non va trascurato l'aspetto fortemente
politico, ed incredibilmente attuale, del testo.
De Musset pur ricreando una Firenze cinquecentesca,
avverte le contraddizioni ed il fallimento della Rivoluzione
Francese: censurato dalla Restaurazione,
scomodo per il potere e per il contro-potere, il dramma disvela trame
fitte che anticipano gli elementi umani, caratteriali dell'esistenzialismo,
della contestazione sessantottina, la dissolutezza dell'uomo di potere.
E il fragoroso rumore di sogni infranti di una gioventù abituata
a convivere con il nulla, appare chiaro che il fatto di portare oggi sulle
scene il Lorenzaccio, può dar spunto ad una riflessione
diversa, a domande che abbracciano questioni squisitamente etiche. Cosa
è che risulta così affascinante, tanto da risultare inquietante,
di questa parabola del potere?
Con la contestazione giovanile del Sessantotto,
la rivolta scende in strada, negli anni di piombo l'utopia si fa lotta
armata, poi gli ardori si spengono. Al mondo mistico dei figli dei fiori
si contrappone l'energia rampante degli yuppie: ma ai giovani non rimangono
troppe scelte.
In Mercuzio e Benvolio, come in Romeo,
è sempre una sottile linea di assurda violenza a segnare queste
fragili esistenze. In Amleto l'inquietudine della vendetta
si fa omicidio. Lorenzo è diverso, da Mercuzio e Benvoglio del
Giulietta e Romeo, perché riesce a coinvogliare la sua emotività
nella Politica, ritrovando la forza ed il coraggio di una scelta. L'assassinio
politico. Con quale animo giudicare questa azione? La violenza omicida
può dunque avere una giustificazione etica e morale? Il popolo
distratto, sfruttato, resta muto, lontano dalla Politica; e Lorenzo, nel
suo disincantato cinismo, lo sa bene.
Firenze, fondata
dai Romani nel Primo secolo avanti Cristo, raggiunge
i più alti vertici di civiltà tra l'Undicesimo e il Quindicesimo
secolo, come libero Comune, in equilibrio tra
l'autorità degli Imperatori e quella dei Papi,
superando il disagio delle lotte interne tra Guelfi e
Ghibellini. Nel Quindicesimo secolo passa sotto la Signoria
dei Medici, che in seguito divengono Granduchi di Toscana.
E' questo il periodo di massimo splendore della città, nelle arti
e nella cultura, in politica e in economia. Al Granducato dei Medici succede,
nel Diciottesimo secolo, quello dei Lorena, fino a quando,
nel 1860, la Toscana entra a far parte del Regno d'Italia,
di cui è capitale dal 1865 al 1871.
 Firenze
conserva un eccezionale patrimonio artistico, gloriosa testimonianza della
sua secolare civiltà. Qui sono vissuti Cimabue
e Giotto, padri della pittura italiana; Arnolfo
e Andrea Pisano, rinnovatori dell'architettura e della
scultura; Brunelleschi, Donatello e
Masaccio, iniziatori del Rinascimento; Ghiberti
e i Della Robbia; Filippo Lippi e l'Angelico;
il Botticelli e Paolo Uccello, i geni
universali di Leonardo e di Michelangelo.
Firenze
conserva un eccezionale patrimonio artistico, gloriosa testimonianza della
sua secolare civiltà. Qui sono vissuti Cimabue
e Giotto, padri della pittura italiana; Arnolfo
e Andrea Pisano, rinnovatori dell'architettura e della
scultura; Brunelleschi, Donatello e
Masaccio, iniziatori del Rinascimento; Ghiberti
e i Della Robbia; Filippo Lippi e l'Angelico;
il Botticelli e Paolo Uccello, i geni
universali di Leonardo e di Michelangelo.
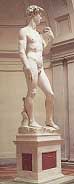 Le
loro opere, con quelle di molte altre generazioni d'artisti, fino ai maestri
del nostro secolo, sono raccolte nei numerosi musei della città.
A Firenze, con Dante, nasce la lingua italiana; con Petrarca
e con Boccaccio si affermano gli studi letterari; con
l'Umanesimo è rinnovata la filosofia
e valorizzata la cultura classica; con Machiavelli nasce
la moderna scienza politica, con Guicciardini la prosa
storica e con Galileo si afferma la moderna scienza sperimentale.
Fin dai tempi di Carlomagno Firenze è sede universitaria
ed oggi comprende decine d'istituti specializzati e un centro di cultura
per stranieri. All'intensa attività della città in questo
settore contribuiscono Accademie e scuole
d'Arte, Istituti scientifici e
centri di cultura.
Le
loro opere, con quelle di molte altre generazioni d'artisti, fino ai maestri
del nostro secolo, sono raccolte nei numerosi musei della città.
A Firenze, con Dante, nasce la lingua italiana; con Petrarca
e con Boccaccio si affermano gli studi letterari; con
l'Umanesimo è rinnovata la filosofia
e valorizzata la cultura classica; con Machiavelli nasce
la moderna scienza politica, con Guicciardini la prosa
storica e con Galileo si afferma la moderna scienza sperimentale.
Fin dai tempi di Carlomagno Firenze è sede universitaria
ed oggi comprende decine d'istituti specializzati e un centro di cultura
per stranieri. All'intensa attività della città in questo
settore contribuiscono Accademie e scuole
d'Arte, Istituti scientifici e
centri di cultura.
Il primo tipo di palazzo edificato in Firenze è quello fortificato,
pensato più per la difesa che come luogo di residenza privata,
austero sia nell'aspetto esterno sia negli arredi e decorazioni interne,
come Palazzo Davanzati. Si passa quindi, con
il mutamento della situazione politica, che si è stabilizzata con
l'avvento della dinastia medicea, a residenze il cui aspetto esteriore,
ma soprattutto quello degli interni, diviene sinonimo di potenza, ricchezza
e prestigio. E' così che sono concepiti Palazzo Antinori
o Palazzo Strozzi, dove sembra ancora di sentire
in sottofondo l'eco dei versi allegri e festosi dei poeti rinascimentali
e di Lorenzo Il Magnifico.
 Palazzo
della Condotta e della Mercanzia, si estende da Piazza
della Signoria a Piazza Santa Maria.
Questo splendido edificio, monumento nazionale, costruito sopra i resti
di un antico teatro romano, nasce dall'unione di due importanti palazzi,
quello della Condotta e quello della Mercanzia, e si trova nella maestosa
Piazza della Signoria, proprio a fianco del
Palazzo Vecchio, dimora e luogo di lavoro della
famiglia Medici, oggi sede del Comune di Firenze.
Palazzo
della Condotta e della Mercanzia, si estende da Piazza
della Signoria a Piazza Santa Maria.
Questo splendido edificio, monumento nazionale, costruito sopra i resti
di un antico teatro romano, nasce dall'unione di due importanti palazzi,
quello della Condotta e quello della Mercanzia, e si trova nella maestosa
Piazza della Signoria, proprio a fianco del
Palazzo Vecchio, dimora e luogo di lavoro della
famiglia Medici, oggi sede del Comune di Firenze.
E' stato sede dal 1337 dell'Ufficio della Condotta degli Stipendiati.
Cessato l'Ufficio militare per la caduta della Repubblica, la residenza
degli Ufficiali della Condotta fu occupata da quello della Gabella
dei Contratti.
Accanto al palazzo della Condotta si trova un altro edificio di dimensioni
più ridotte, che diverrà il Palazzo della Mercanzia,
così chiamato per aver ospitato l'Università
dei Mercanti e il così detto Ufficio
della Mercanzia, nato per tutelare i cittadini e il Comune
delle Arti. A gestire e rappresentare tale ufficio sarebbero
stati eletti i rappresentanti di Ciascuna delle Arti fiorentine, proprio
per ospitare al meglio le due istituzioni, il Comune decide di far ampliare
l'edificio.
A lavorare al progetto sono incaricati architetti e artisti la cui fama
è rimasta viva: Francesco Rinuccini, Iacopo
di Gherardino Gianni, Francesco da Orvieto,
Ciardo di Donato. La parte inferiore dell'edificio è
stata ultimata nel 1362; quella superiore è restata incompiuta
per molto tempo, fino a che Cosimo I, nel 1540, non si
adopera per concludere i lavori e portare il palazzo alle dimensioni che
possiamo vedere oggi. Nonostante nel corso degli anni abbia più
volte corso il rischio di essere demolito o comunque deturpato per lasciare
spazio a nuove istituzioni quali la Direzione Generale del
Registro e il Dipartimento Generale delle Poste,
il palazzo ha mantenuto immutato il suo aspetto ospitando molteplici uffici:
l'Ispettorato di San Giovanni, l'Ufficio
centrale del Genio Civile, la Direzione Generale
del Contenzioso finanziario, l'Ufficio d'esazione
per le rendite demaniali.
Palazzo Medici Riccardi è il più
tipico esempio di palazzo civile rinascimentale. E' stato costruito secondo
un austero disegno di Michelozzo per Cosimo il
Vecchio, nel 1444. Residenza dei Medici per cento anni è
stato poi acquistato dalla famiglia Riccardi e oggi è
sede della Prefettura e dell'Amministrazione
provinciale.
All'interno si trovano un elegante cortile, un piccolo giardino all'italiana
e la celebre Cappella affrescata da Benozzo Gozzoli nel
1459, che rappresenta La Cavalcata dei Magi.
Palazzo Pitti è il più grandioso
dei palazzi fiorentini: s'innalza su una superficie di oltre tre ettari
alle pendici della collina di Boboli. E' stato
costruito per il banchiere Luca Pitti su progetto attribuito
a Brunelleschi, verso la metà del Quindicesimo
secolo. La vastità dell'edificio dimostra la determinazione a rivaleggiare
con la famiglia dei Medici. Il fallimento del banchiere provocò
la sospensione dei lavori che furono ripresi un secolo dopo quando proprio
i Medici comprano il palazzo per farne la loro residenza. Del 1560 sono
il grandioso cortile e le due ali laterali, progettate da Bartolomeo
Ammannati. Con Cosimo II dei Medici, nel 1621,
iniziano i lavori per l'ingrandimento del prospetto e per la sistemazione
della piazza, eseguiti su progetto di Giulio e Alfonso
Parigi. Passato ai Lorena, l'edificio si arricchisce
dei due rondò, terminati da Paoletti e Poccianti
nella prima metà dell'Ottocento insieme alla palazzina della Meridiana.
Attualmente hanno sede nel palazzo e nel retrostante Giardino
di Boboli alcuni tra i più importanti musei fiorentini:
la Galleria Palatina, al primo piano; il Museo
degli Argenti, al pian terreno e al mezzanino; la Galleria
d'Arte Moderna, all'ultimo piano. Dislocato nella Palazzina
del Cavaliere sul versante alto del giardino è il
Museo delle Porcellane, mentre nella Palazzina
della Meridiana si trova la Galleria del Costume.
Palazzo Rucellai è stato costruito tra
il 1455 e il 1458 da Bernardo Rossellino, su progetto
di Leon Battista Alberti, per conto di Giovanni
Rucellai. E' uno degli edifici rinascimentali di Firenze più
riccamente decorati. Attualmente ospita il Museo Alinari,
dedicato alla storia della fotografia. Primo in Italia, è attualmente
l'unica istituzione nazionale dedita esclusivamente alle mostre fotografiche.
Palazzo Strozzi è il capolavoro dell'architettura
rinascimentale, ed è situato in via de' Tornabuoni,
è stato iniziato da Benedetto da Maiano nel 1489,
su ordine di Filippo Strozzi il Vecchio, e continuato
dal Rosselli e dal Cronaca fino al Sedicesimo
secolo. Il magnifico cornicione sotto il quale corrono due piani di bifore
divisi da cornici dentellate è del Cronaca. A pianterreno i portali
sono affiancati da finestre rettangolari. Aggiunge monumentalità
all'insieme il rivestimento esterno a bugne.
BIO-BIBLIOGRAFIA
J. Liss, La psicoterapia del corpo. Le nuove frontiere tra corpo e mente,
Roma, Astrolabio, 1986.
Stanislavskij, La mia vita nell'arte, Torina, Einaudi, 1963, p. 362
E. Barba - N. Savarese, L'arte segreta dell'attore. Un dizionario di antropologia
teatrale, Lecce, Argo, 1996, p. 18
Jerzy Grotowski, Per un teatro povero, Roma, Bulzoni, 1970, p. 187.
Jacques Copeau, L'educazione dell'attore (1920),
V. Mejerchol'd, L'attore del futuro, in L'Ottobre teatrale 1918/1939,
Milano, Feltrinelli, 1977.
Carmelo Bene, Lorenzaccio, in Carmelo Bene, Opere, Milano, Bompiani, 1995
E. Jaques-Dalcroze, Il ritmo, la musica e l'educazione, Torino, ERI, 1986,
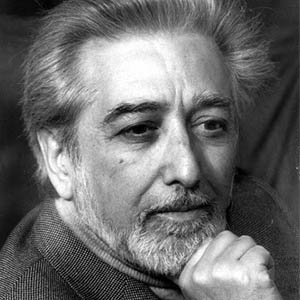
Reno Bromuro è nato a Paduli, in Campania, nel 1937. E' stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale. Nel 1957, a Napoli, ha fondato il Centro Sperimentale per un Teatro neorealista. Ha fondato nel 1973 (di fatto) l'A.I.A. Associazione Internazionale Artisti "Poesie della Vita", e, come critico letterario, ha recensito molti poeti italiani e stranieri. Si è spento nel 2009, qualche anno dopo averci dato l'opportunità di collaborare con lui. Noi di Letteratour lo ricordiamo con affetto qui.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG