
di Reno Bromuro
Nella categoria: HOME | TOURismi letterari
"Una sola cosa è triste, cari miei; aver capito il giuoco! Dico il giuoco di questo demoniaccio beffardo che ciascuno di noi ha dentro e che si spassa a rappresentarci di fuori, come realtà, ciò che poco dopo egli stesso ci scopre come una nostra illusione. Bisogna vivere, cioè illudersi".
BIOGRAFIA
 Luigi
Pirandello nacque ad Agrigento il 10
giugno 1867 da Stefano e da Caterina Ricci Gramitto.
Il padre è di origine ligure, la madre siciliana.
Luigi
Pirandello nacque ad Agrigento il 10
giugno 1867 da Stefano e da Caterina Ricci Gramitto.
Il padre è di origine ligure, la madre siciliana.
Sono molto importanti, per Luigi, gli anni dell'infanzia e della giovinezza,
non solo per le prime esperienze culturali e per l'affiorare degli interessi
per la letteratura e la poesia, ma anche per le esperienze umane e sociali
compiute nei decenni di confusione politica e morale che seguono all'unità
d'Italia. I primi versi che titola "Mal giocondo",
sono del 1885 e rappresentano la pienezza di una giovanile ed inquieta
amarezza di diciottenne. Inizia gli studi universitari alla Facoltà
di Lettere di Palermo per passare a quella di Roma,
dove ha fra i maestri Ernesto Monaci, uno dei più
grandi filologi del tempo. Per suggerimento del Monaci, va a studiare
a Bonn, dove si ferma due anni; si laurea nel
1891, discutendo una tesi sulla parlata agrigentina "Voci
e suoni del dialetto di Girgenti". A Bonn ha insigni
maestri: dal Bucheler, all'Usener, al
Forster; ma ha modo di avere contatti con le più
appassionanti esperienze della cultura contemporanea. Tornato a Roma
tenta di inserirsi nella vivace società letteraria che in quello
scorcio di secolo illustra la capitale. Domina D'Annunzio; ma lui non è sedotto dalle suggestioni del dannunzianesimo, anche
se ne risente qualche influenza, come nelle Elegie renane,
pubblicate nel 1895. È decisivo l'incontro con Luigi Capuana,
il teorico e maestro del verismo italiano. A contatto con Capuana, scopre
e definisce la propria vocazione di narratore; avvicinandosi alla grand'esperienza
del verismo.
Scrive il suo primo romanzo nel 1893 dal titolo "L'esclusa"
e nel 1894 pubblica il primo volume di racconti "Amori
senza amore". Nello stesso anno sposa Antonietta
Portulano, una bella e ricca compaesana. Le prove dure e amare
erano in agguato per i due coniugi: nel 1897 un grave dissesto economico
li costringe a trasferirsi a Roma, dove Luigi
insegna letteratura italiana all'Istituto Superiore di Magistero.
ma lui non è sedotto dalle suggestioni del dannunzianesimo, anche
se ne risente qualche influenza, come nelle Elegie renane,
pubblicate nel 1895. È decisivo l'incontro con Luigi Capuana,
il teorico e maestro del verismo italiano. A contatto con Capuana, scopre
e definisce la propria vocazione di narratore; avvicinandosi alla grand'esperienza
del verismo.
Scrive il suo primo romanzo nel 1893 dal titolo "L'esclusa"
e nel 1894 pubblica il primo volume di racconti "Amori
senza amore". Nello stesso anno sposa Antonietta
Portulano, una bella e ricca compaesana. Le prove dure e amare
erano in agguato per i due coniugi: nel 1897 un grave dissesto economico
li costringe a trasferirsi a Roma, dove Luigi
insegna letteratura italiana all'Istituto Superiore di Magistero.
Nell'ambiente romano, prende consapevolezza del suo pensiero, soprattutto
nel corso di una polemica antidannunziana, che si svolge nelle riviste
il "Marzocco" e "La
nuova antologia". Intanto, nel 1903, cominciano ad
apparire i primi sintomi del male che avrebbe afflitto la povera consorte
distruggendo la felicità della famiglia. Lo scoppio della grande
guerra del 1914-18 e la prigionia del figlio Stefano
ferito ed ammalato, contribuiscono ad affliggere maggiormente lo scrittore,
che già attraverso l'amara esperienza del dolore ha consolidato
la sua triste concezione del vivere nel mondo.
 A
guerra finita si immerge in un lavoro frenetico e senza soste, spinto
dall'urgenza di insegnare agli uomini le verità da lui scoperte.
Nel 1921 nascono "Sei personaggi in cerca d'autore"
ed "Enrico IV". Dopo quattro anni
fonda la "Compagnia del teatro d'arte"
con i due grandissimi ed insuperati interpreti dell'arte pirandelliana:
Marta Abba e Ruggero Ruggeri, con i quali intraprende il giro d'Europa
e delle due Americhe, mentre dappertutto crescono
i consensi alla sua opera, tanto che nel 1934 è consacrata dal
premio Nobel. Si ammala di polmonite e muore
il 10 dicembre 1936; le sue ceneri sono tumulate in una roccia nella tenuta
del Caos nella quale era nato sessantotto anni prima, con
funerali strettamente privati, come aveva scritto nelle sue ultime volontà.
A
guerra finita si immerge in un lavoro frenetico e senza soste, spinto
dall'urgenza di insegnare agli uomini le verità da lui scoperte.
Nel 1921 nascono "Sei personaggi in cerca d'autore"
ed "Enrico IV". Dopo quattro anni
fonda la "Compagnia del teatro d'arte"
con i due grandissimi ed insuperati interpreti dell'arte pirandelliana:
Marta Abba e Ruggero Ruggeri, con i quali intraprende il giro d'Europa
e delle due Americhe, mentre dappertutto crescono
i consensi alla sua opera, tanto che nel 1934 è consacrata dal
premio Nobel. Si ammala di polmonite e muore
il 10 dicembre 1936; le sue ceneri sono tumulate in una roccia nella tenuta
del Caos nella quale era nato sessantotto anni prima, con
funerali strettamente privati, come aveva scritto nelle sue ultime volontà.
L'OPERA
"I VECCHI E I GIOVANI"
"I vecchi e i giovani" è un romanzo diviso in due parti di otto capitoli ciascuna, suddivisi in paragrafi, i capitoli sono numerati con numeri romani, apparso parzialmente a puntate, fino al primo paragrafo del cap. IV della seconda parte, sulla "Rassegna contemporanea", tra il gennaio e il novembre 1909, anno II, dal n. 1 al n. 11. L'edizione Treves del 1913, che al posto della numerazione all'interno di ciascun capitolo recava un sottotitolo per ogni paragrafo, risulta largamente rimaneggiata nella parte già pubblicata e con una sezione inedita, dal secondo paragrafo del cap. IV della seconda parte fino alla fine. Nel 1931 segui l'edizione definitiva "completamente riveduta e rielaborata dall'Autore", in cui erano soppressi i sottotitoli. In una pagina autobiografica, successiva alla parziale pubblicazione su rivista Pirandello parla de I vecchi e i giovani, come del "romanzo della Sicilia dopo il 1870, amarissimo e popoloso romanzo, ov'è racchiuso il dramma della mia generazione". "I vecchi e i giovani" è un romanzo storico, ambientato nella prima parte a Girgenti, dettato dal più cupo pessimismo sulle sorti della terra natale, affollato di personaggi appartenenti ai diversi ceti sociali che vivono il disagio e le contraddizioni della caduta degli ideali, nel trapasso dalla generazione risorgimentale a quella post-unitaria italiana.
LA STORIA
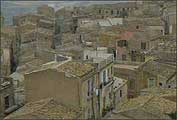 A
Girgenti, nel 1893, si deve eleggere il deputato
del collegio da inviare in Parlamento; la contesa
politica vede schierati clericali e affaristi, governativi, socialisti
e il nuovo movimento dei Fasci siciliani.
Girgenti, "paese morto" in cui "d'accidia
era radicata nella più profonda sconfidenza della sorte",
guarda con indifferenza alla prossima consultazione; infatti "nessuno
aveva fiducia nelle istituzioni, né mai l'aveva avuta. La corruzione
era sopportata, come un male cronico, irrimediabile". In questo
contesto di degrado morale e civile, all'inizio della vicenda, Flaminio
Salvo, banchiere, proprietario di miniere, rappresentante del
ceto borghese imprenditoriale, offre al partito clericale il suo appoggio
elettorale e, per sancire l'alleanza, combina, attraverso la mediazione
del vescovo, il matrimonio della cinquantenne sorella Adelaide
con il sessantacinquenne principe Ippolito Laurentano,
feudatario di fede borbonica e clericale. Il frutto dell'intesa tra borghesia
affaristica e aristocrazia latifondista è la candidatura per i
clericali dell'avvocato Ignazio Capolino, consulente
legale e uomo di fiducia di Salvo. I governativi candidano invece un reduce
garibaldino, Roberto Auriti che, a soli dodici anni,
aveva combattuto a Milazzo accanto al padre
Stefano, caduto nella battaglia. Roberto Auriti è
figlio di Caterina Laurentano, sorella del principe Ippolito,
la quale, per avere fede agli ideali liberali, aveva rinunciato all'eredità
familiare in favore del fratello borbonico e, rimasta vedova, aveva scelto
con dignità una vita di ristrettezze. Nell'imminenza delle elezioni,
Roberto, che vive a Roma dove esercita con modesta
fortuna la professione di avvocato, torna a Girgenti.
Nei suoi confronti il partito clericale scatena sulla stampa cittadina
una campagna diffamatoria. Le insinuazioni calunniose dei reazionari e
una candidatura socialista di disturbo, su cui convergono i voti "dei
lavoratori delle zolfare e delle campagne della provincia, già
raccolti in fasci", decretano la sconfitta elettorale dell'Auriti.
Il candidato clericale Ignazio Capolino viene eletto
deputato, mentre in tutta la Sicilia monta la
protesta sociale di contadini e zolfatari, sullo sfondo della crisi economica
e dell'industria solfifera dell'isola.
A
Girgenti, nel 1893, si deve eleggere il deputato
del collegio da inviare in Parlamento; la contesa
politica vede schierati clericali e affaristi, governativi, socialisti
e il nuovo movimento dei Fasci siciliani.
Girgenti, "paese morto" in cui "d'accidia
era radicata nella più profonda sconfidenza della sorte",
guarda con indifferenza alla prossima consultazione; infatti "nessuno
aveva fiducia nelle istituzioni, né mai l'aveva avuta. La corruzione
era sopportata, come un male cronico, irrimediabile". In questo
contesto di degrado morale e civile, all'inizio della vicenda, Flaminio
Salvo, banchiere, proprietario di miniere, rappresentante del
ceto borghese imprenditoriale, offre al partito clericale il suo appoggio
elettorale e, per sancire l'alleanza, combina, attraverso la mediazione
del vescovo, il matrimonio della cinquantenne sorella Adelaide
con il sessantacinquenne principe Ippolito Laurentano,
feudatario di fede borbonica e clericale. Il frutto dell'intesa tra borghesia
affaristica e aristocrazia latifondista è la candidatura per i
clericali dell'avvocato Ignazio Capolino, consulente
legale e uomo di fiducia di Salvo. I governativi candidano invece un reduce
garibaldino, Roberto Auriti che, a soli dodici anni,
aveva combattuto a Milazzo accanto al padre
Stefano, caduto nella battaglia. Roberto Auriti è
figlio di Caterina Laurentano, sorella del principe Ippolito,
la quale, per avere fede agli ideali liberali, aveva rinunciato all'eredità
familiare in favore del fratello borbonico e, rimasta vedova, aveva scelto
con dignità una vita di ristrettezze. Nell'imminenza delle elezioni,
Roberto, che vive a Roma dove esercita con modesta
fortuna la professione di avvocato, torna a Girgenti.
Nei suoi confronti il partito clericale scatena sulla stampa cittadina
una campagna diffamatoria. Le insinuazioni calunniose dei reazionari e
una candidatura socialista di disturbo, su cui convergono i voti "dei
lavoratori delle zolfare e delle campagne della provincia, già
raccolti in fasci", decretano la sconfitta elettorale dell'Auriti.
Il candidato clericale Ignazio Capolino viene eletto
deputato, mentre in tutta la Sicilia monta la
protesta sociale di contadini e zolfatari, sullo sfondo della crisi economica
e dell'industria solfifera dell'isola.
Nella seconda parte l'azione si sposta a Roma,
dove Roberto Auriti è ritornato dopo la negativa
esperienza elettorale. La capitale è sommersa dal "fango"
dello scandalo della Banca Romana in cui, in
una sorta di "bancarotta del patriottismo", sono implicati
eminenti uomini politici. Anche Roberto Auriti viene
coinvolto nello scandalo, perché ha contratto con la Banca un prestito
non restituito di quarantamila lire, come prestanome dell'amico deputato
Corrado Selmi. Costui ha dissipato il patrimonio di valori
risorgimentali che avevano illuminato la sua giovinezza e si è
indebitato per sostenere una relazione sentimentale con Giannetta,
giovane moglie del vecchio ministro del Tesoro
Francesco D'Atri, anche lui dal nobile passato garibaldino.
Roberto Auriti viene arrestato e Corrado Selmi, per il quale la Camera
si accinge a votare l'autorizzazione a procedere, si avvelena lasciando
un biglietto che scagiona l'amico. A Roma si riannodano le vicende di
alcuni personaggi girgentini convenuti nella capitale con motivazioni
diverse: l'onorevole Ignazio Capolino, con la giovane
moglie Nicoletta, per svolgere il suo mandato parlamentare;
l'ingegnere minerario Aurelio Costa, direttore delle
zolfare di Flaminio Salvo, inviato dall'imprenditore
per presentare al Ministero un progetto di consorzio fra i produttori
di zolfo siciliani; lo stesso Salvo per curare di persona i propri interessi.
Flaminio Salvo è accompagnato dalla figlia Dianella,
per la quale, perseverando nei suoi disegni di alleanze matrimoniali,
vorrebbe combinare le nozze con Lando Laurentano, figlio
del principe Ippolito, che risiede a Roma
impegnato nella causa socialista. Respinto dal Ministero il progetto di
consorzio, Aurelio Costa è rimandato a Girgenti
per placare l'animo degli zolfatari "inferociti dalla fame per
la chiusura delle zolfare"; nel viaggio di ritorno l'accompagna
Nicoletta Capolino.
Il viaggio si trasforma in una fuga d'amore fra i due giovani. Giunto
in Sicilia, Costa, seguito da Nicoletta,
si reca ad Aragona per parlamentare con gli
zolfatari delle miniere, ma questi, sobillati da un provocatore, assalgono
la carrozza dell'ingegnere, lo uccidono insieme con l'amante e ne bruciano
i corpi. Alla notizia della morte di Costa, Dianella
Salvo, che ne era innamorata, impazzisce. Intanto tutta la Sicilia
è in tumulto. Il principe Lando Laurentano lascia
Roma e si reca a Palermo,
per seguire da vicino gli eventi. Il governo decreta lo stato d'assedio
in Sicilia e procede ad arresti in massa degli
esponenti socialisti e degli aderenti ai Fasci.
Lando, con alcuni compagni, fugge da Palermo
e si dirige verso Porto Empedocle, dove intende
imbarcarsi per espatriare. Sulla strada della fuga arriva a Valsania,
il feudo di famiglia dove vive estraniato, in filosofico distacco dal
mondo, lo zio don Cosmo Laurentano. Don Cosmo, portavoce
dell'autore, distilla al nipote e agli altri fuggiaschi il succo amaro
delle sue riflessioni: "Una sola cosa è triste, cari miei;
aver capito il giuoco! Dico il giuoco di questo demoniaccio beffardo che
ciascuno di noi ha dentro e che si spassa a rappresentarci di fuori, come
realtà, ciò che poco dopo egli stesso ci scopre come una
nostra illusione. Bisogna vivere, cioè illudersi".
LA CRITICA
Il romanzo "I vecchi e i
giovani", al suo apparire in volume, è accolto
dalla critica con riserva. Emilio Cecchi, su "La
Tribuna", ne parla come di un'opera fondata "su
una materia fantastica più adatta a prestare motivi di arguzie,
e di macchiette, che d'epopea". Il giudizio riduttivo è
riconfermato in seguito da Benedetto Croce. Nel 1960
il romanzo è stato rivalutato da Carlo Salinari,
che vi ha letto la rappresentazione di una serie di fallimenti storici:
del Risorgimento, dell'Unità,
del Socialismo e personali: "dei vecchi
che non hanno saputo passare dagli ideali alla realtà e si trovano
ad essere responsabili degli scandali dei giovani che si sentono soffocare
in una società ormai cristallizzata". Massimo
Onofri vi ha colto le motivazioni profonde dei personaggi: "ogni
personaggio, persino nelle sue azioni politiche e di pubblica rilevanza,
sembra essere mosso, oltre che da palesi moventi ideologici, soprattutto
da personali interessi, non di rado sordidi, e sempre in una direzione
che cementi o violi i vincoli familiari".
 La
dialettica tra le generazioni nel contesto sia familiare sia politico
e sociale è l'argomento sul quale studiosi di diverse discipline,
provenienti da vari Paesi, terranno lezioni e seminari, in occasione del
corso residenziale promosso dalla Scuola europea di studi
comparati. Il titolo scelto per questo corso di formazione
post-laurea, riconosciuto a livello europeo è I vecchi
e i giovani, a testimoniare come, citando l'omonimo romanzo
di Pirandello, l'analisi della sfera privata dell'individuo
sia spunto per affrontare temi socio-politici e culturali di più
ampio respiro, attraverso la letteratura e l'arte. Il ciclo di conferenze,
seminari e tavole rotonde, proiezioni di film e spettacoli teatrali ha
visto protagonisti letterati, storici dell'arte, semiologi, filosofi delle
arti, del cinema e del teatro, del migliore mondo accademico italiano
e straniero, che, insieme agli studenti, hanno dato vita a un dibattito
culturale, ripercorrendo per una settimana i molteplici aspetti del Novecento.
Apre i lavori Umberto Eco, seguiranno gli interventi
di Maurizio Bettini, Roberto Bigazzi,
Remo Ceserani, Antonio Tabucchi e di
molti altri insigni esponenti dell'Università e della cultura.
La
dialettica tra le generazioni nel contesto sia familiare sia politico
e sociale è l'argomento sul quale studiosi di diverse discipline,
provenienti da vari Paesi, terranno lezioni e seminari, in occasione del
corso residenziale promosso dalla Scuola europea di studi
comparati. Il titolo scelto per questo corso di formazione
post-laurea, riconosciuto a livello europeo è I vecchi
e i giovani, a testimoniare come, citando l'omonimo romanzo
di Pirandello, l'analisi della sfera privata dell'individuo
sia spunto per affrontare temi socio-politici e culturali di più
ampio respiro, attraverso la letteratura e l'arte. Il ciclo di conferenze,
seminari e tavole rotonde, proiezioni di film e spettacoli teatrali ha
visto protagonisti letterati, storici dell'arte, semiologi, filosofi delle
arti, del cinema e del teatro, del migliore mondo accademico italiano
e straniero, che, insieme agli studenti, hanno dato vita a un dibattito
culturale, ripercorrendo per una settimana i molteplici aspetti del Novecento.
Apre i lavori Umberto Eco, seguiranno gli interventi
di Maurizio Bettini, Roberto Bigazzi,
Remo Ceserani, Antonio Tabucchi e di
molti altri insigni esponenti dell'Università e della cultura.
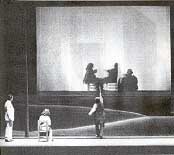 Per
Pirandello le cause, nella vita, non sono mai così
logiche come lo possono essere nell'opera narrativa o teatrale,in cui
tutto è congegnato, combinato, ordinato ai fini che lo scrittore
si è proposto, anche se sembra in alcuni casi che il procedimento
sia libero e casuale. Perciò nell'umorismo non possiamo parlare
di coerenza, perché in ogni personaggio ci sono tante anime in
lotta fra loro, che cercano di afferrare la realtà: l'anima istintiva,
l'anima morale, l'anima affettiva, l'anima sociale, e i nostri atti prendono
una forma, i personaggi assumono una maschera, la nostra coscienza si
atteggia a seconda che domini questa o quella, a seconda del momento;
per questo ciascuno di noi ritiene valida una determinata interpretazione
della realtà o dei nostri atti non possono essere mai d'accordo
con l'interpretazione degli altri, in quanto la realtà e il nostro
essere interiore non si manifestano mai del tutto, ma ora in un modo ora
in un altro. Pirandello guarda dentro la vicenda e i personaggi, ed agisce
come il bambino che rompe il giocattolo per vedere come è fatto
dentro. Nell'umorismo, quindi, distingue due aspetti: il comico, che deriva
dall'avvertimento del contrario;L'umoristico o drammatico che deriva dal
sentimento del contrario; il primo è esterno all'uomo e facilmente
visibile, per cui ciascuno è capace di coglierlo; il secondo è
invece interno, ma non può essere colto se non attraverso la riflessione.
Per
Pirandello le cause, nella vita, non sono mai così
logiche come lo possono essere nell'opera narrativa o teatrale,in cui
tutto è congegnato, combinato, ordinato ai fini che lo scrittore
si è proposto, anche se sembra in alcuni casi che il procedimento
sia libero e casuale. Perciò nell'umorismo non possiamo parlare
di coerenza, perché in ogni personaggio ci sono tante anime in
lotta fra loro, che cercano di afferrare la realtà: l'anima istintiva,
l'anima morale, l'anima affettiva, l'anima sociale, e i nostri atti prendono
una forma, i personaggi assumono una maschera, la nostra coscienza si
atteggia a seconda che domini questa o quella, a seconda del momento;
per questo ciascuno di noi ritiene valida una determinata interpretazione
della realtà o dei nostri atti non possono essere mai d'accordo
con l'interpretazione degli altri, in quanto la realtà e il nostro
essere interiore non si manifestano mai del tutto, ma ora in un modo ora
in un altro. Pirandello guarda dentro la vicenda e i personaggi, ed agisce
come il bambino che rompe il giocattolo per vedere come è fatto
dentro. Nell'umorismo, quindi, distingue due aspetti: il comico, che deriva
dall'avvertimento del contrario;L'umoristico o drammatico che deriva dal
sentimento del contrario; il primo è esterno all'uomo e facilmente
visibile, per cui ciascuno è capace di coglierlo; il secondo è
invece interno, ma non può essere colto se non attraverso la riflessione.
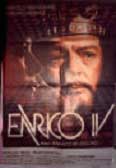 È
da sottolineare, che mentre tutti possono percepire l'aspetto comico in
quanto ognuno può avvertire che una cosa avvenga o che un personaggio
si comporti in modo contrario a ciò che tutti ritengono normale,
il drammatico-umoristico viene capito e sentito solo da coloro che usano
la riflessione, e comunque non dalla massa in quanto questa segue regole
generali accettate supinamente e non i singoli individuali bisogni. Da
quanto ho detto a proposito dell'umorismo, appare chiaro che, attraverso
la riflessione, si giunge a cogliere l'aspetto normale o anormale della
vita e degli atteggiamenti dei personaggi.
È
da sottolineare, che mentre tutti possono percepire l'aspetto comico in
quanto ognuno può avvertire che una cosa avvenga o che un personaggio
si comporti in modo contrario a ciò che tutti ritengono normale,
il drammatico-umoristico viene capito e sentito solo da coloro che usano
la riflessione, e comunque non dalla massa in quanto questa segue regole
generali accettate supinamente e non i singoli individuali bisogni. Da
quanto ho detto a proposito dell'umorismo, appare chiaro che, attraverso
la riflessione, si giunge a cogliere l'aspetto normale o anormale della
vita e degli atteggiamenti dei personaggi.
Il personaggio, come Enrico IV o Ciampa,
Belluca o Chiàrchiaro, nella
sua ribellione contro le regole rifiuta la realtà imposta dalle
norme, perché in essa ogni possibilità di vita si cristallizza.
 Il
suo rapporto con il personaggio non ha nessun'àncora di salvezza,
nessuno scoglio cui aggrapparsi per cambiare la propria maschera o per
andare oltre i limiti imposti dalla fantasia creatrice dello scrittore:
non ha nessuna possibilità di instaurare rapporti umani con gli
altri personaggi, perché ciascuno è obbligato a recitare
la sua parte indefinitamente e indipendentemente da quella rappresentata
dagli altri: deve accontentarsi e capire che solo nella rappresentazione
della propria parte può diventare personaggio vivo.
Il
suo rapporto con il personaggio non ha nessun'àncora di salvezza,
nessuno scoglio cui aggrapparsi per cambiare la propria maschera o per
andare oltre i limiti imposti dalla fantasia creatrice dello scrittore:
non ha nessuna possibilità di instaurare rapporti umani con gli
altri personaggi, perché ciascuno è obbligato a recitare
la sua parte indefinitamente e indipendentemente da quella rappresentata
dagli altri: deve accontentarsi e capire che solo nella rappresentazione
della propria parte può diventare personaggio vivo.
Proprio sul piano di questo rapporto si verifica la disintegrazione fisica
e spirituale dei personaggi che riassume in tre punti essenziali, che
chiama: teoria della triplicità esistenziale.
L'arte di Pirandello non rispecchia la realtà così come
comunemente è intesa, ma raccoglie i casi comuni della vita, che
diventano particolari per le cause vere che li generano e che non sempre
gli uomini riescono a cogliere e a sentire. Le azioni non sono descritte
nella loro globalità, ma nei particolari contrasti e nelle contraddizioni
quotidiane che cambiano di momento in momento senza una logica apparente,
spesso in opposizione con tutti e, troppo spesso irrealizzabile.
IL TERRITORIO
 Girgentu,
oggi Agrigento, dista dal mare solo tre chilometri;
è la città fra le più antiche della Sicilia.
Si trova ad una altitudine di duecentotrenta metri sul livello del mare
e la sua superficie è si duecentoquarantacinque metri quadrati.
Girgentu,
oggi Agrigento, dista dal mare solo tre chilometri;
è la città fra le più antiche della Sicilia.
Si trova ad una altitudine di duecentotrenta metri sul livello del mare
e la sua superficie è si duecentoquarantacinque metri quadrati.
Akragas, nome del luogo e del fiume che lo bagna
è fondata nel 582 avanti Cristo da coloni di origine greca. Sotto
il tiranno Terone la città diviene una potenza:
la vittoria su Cartagine dà ad Akragras
e a Siracusa la supremazia sulla Sicilia
e il controllo dei traffici marittimi. Lo splendore di quel tempo è
ancora presente nella Valle dei Templi e nei
reperti del Museo Archeologico. Nel 406 avanti
Cristo, però i Cartaginesi assediano e distruggono
la città la cui potenza decade. Nel 210 a vanti Cristo Akragas
è occupata dai Romani che la ribattezzano Agrigentum
e dopo i Romani, cade sotto la dominazione bizantina.
"L'antica famosa Colimbrètra Akragantina era veramente molto più giù, nel punto più basso del pianoro, dove tre vallette si uniscono e le rocce si dividono e la linea dell'aspro ciglione, su cui sorgono i Tempii, è interrotta da una larga apertura. In quel luogo, ora detto dell'Abbadia bassa, gli Akragantini, cento anni dopo la fondazione della loro città, avevano formato la peschiera, gran bacino d'acqua che si estendeva fino all'Hypsas e la cui diga concorreva col fiume alla fortificazione della città. (…) Colimbrèta aveva chiamato don Ippolito la sua tenuta, perché anch'egli lassù, nella parte occidentale di essa, aveva raccolto un bacino d'acqua, alimentato d'inverno dal torrentello che scorreva sotto Bonamorore e d'estate da una nòria, la cui ruota stridula era da mane a sera girata da una giumenta cieca. Tutt'intorno a quel bacino sorgeva un boschetto delizioso d'aranci e melograni" (Da I vecchi e i giovani)
LA CITTA' DEI TEMPLI
"Don Ippolito guardò i Templi che si raccoglievano austeri e solenni nell'ombra, e sentì una pena indefinita per quei superstiti d'un altro mondo e d'un'altra vita. Tra tanti insigni monumenti della città scomparsa solo ad essi era toccato in sorte di vedova…" (Da I vecchi e i giovani)
 Arrivando
dalla strada costiera, Agrigento propone, con
la vista dei templi, la sua immagine classica nota a tutti, quella stessa
che indusse Pindaro a definirla "la città
più dei mortali"; raggiungendola invece da Caltanissetta,
ci si imbatte subito nella recente, caotica espansione edilizia e quasi
si ignora la presenza delle costruzioni medioevali sulla collina, a ovest
della piazza centrale. Guardando Agrigento dalla collina dei
Templi, le moderne palazzine che fanno da sfondo ai vuoti
delle colonne lascerebbero pensare ad uno sviluppo massiccio, magari come
logica continuazione dell'antica magnificenza. Esiste invece una netta
separazione fra la città odierna e quella del passato: la prima
è distratta e sopita in una realtà meno che provinciale,
tagliata fuori dai grandi circuiti viari siciliani e quindi rinchiusa
in se stessa; la seconda, come per miracolo si è conservata alla
nostra ammirazione e trasmette ancora la sua vocazione ad aprirsi. Ma
la diversità, oltre che spazio-temporale, è anche culturale,
quella stessa descritta con disagio da Pirandello e denunciata con violenza
da Sciascia.
Arrivando
dalla strada costiera, Agrigento propone, con
la vista dei templi, la sua immagine classica nota a tutti, quella stessa
che indusse Pindaro a definirla "la città
più dei mortali"; raggiungendola invece da Caltanissetta,
ci si imbatte subito nella recente, caotica espansione edilizia e quasi
si ignora la presenza delle costruzioni medioevali sulla collina, a ovest
della piazza centrale. Guardando Agrigento dalla collina dei
Templi, le moderne palazzine che fanno da sfondo ai vuoti
delle colonne lascerebbero pensare ad uno sviluppo massiccio, magari come
logica continuazione dell'antica magnificenza. Esiste invece una netta
separazione fra la città odierna e quella del passato: la prima
è distratta e sopita in una realtà meno che provinciale,
tagliata fuori dai grandi circuiti viari siciliani e quindi rinchiusa
in se stessa; la seconda, come per miracolo si è conservata alla
nostra ammirazione e trasmette ancora la sua vocazione ad aprirsi. Ma
la diversità, oltre che spazio-temporale, è anche culturale,
quella stessa descritta con disagio da Pirandello e denunciata con violenza
da Sciascia.
L'Akragas dei greci, l'Agrigentum
dei romani, la Kirkent degli arabi,
dove dal nome di Girgenti diventò l'Agrigento
attuale. E' stata fondata nel 581 avanti Cristo dai coloni Rodii
e Cretesi, sul punto della costa del Mediterraneo, geograficamente
più utile per il commercio. La tradizione indica come suoi fondatori
Aristinoo e Pistillo. Le condizioni
topografiche sono favorevoli a un redditizio commercio con la vicina e
ricca Cartagine e un suolo particolarmente adatto all'habitat umano. Agrigento
raggiunge un incredibile opulenza come attestano i suoi templi, peristili,
statue e opere d'arte.
 Impareggiabile
è la vista del "Tempio della concordia",
un Tempio che esprime tutta la grandiosità ellenica, immerso in
una meravigliosa e prepotente natura solare; è innalzato intorno
al 430 avanti Cristo.
Impareggiabile
è la vista del "Tempio della concordia",
un Tempio che esprime tutta la grandiosità ellenica, immerso in
una meravigliosa e prepotente natura solare; è innalzato intorno
al 430 avanti Cristo.
L'ignoto architetto ha creato degli effetti ottici, noto come "l'effetto
bottiglia" ottenuto con il rigonfiamento della colonna ci circa
22 cm. e l'inclinazione delle colonne verso l'interno, tant'e che prolungandole
al cielo si unirebbero a circa un chilometro e mezzo sopra il tempio.
Deve il suo nome allo storico Fazello che rinvenne un'iscrizione
latina nelle vicinanze. Divenne poi basilica cristiana consacrata a San
Gregorio.
Il Tempio della Concordia è dichiarato
monumento nazionale nel 1743, restaurato e modificato nel medesimo anno,
ad opera del Torremuzza, e poi nel 1784 ad opera del
Re Ferdinando.
Hera Lacinia, corrisponde alla Giunone
dei romani, il Tempio di Giunone, è il
santuario dedicato alle donne maritate agrigentine, destinate anche a
subire le infedeltà coniugali dei mariti, che piene di fede vi
si recano per lamentare il comune destino che hanno con la sposa di Giove.
Hera, come sappiamo, sposando Giove diviene la regina
del cielo dove spesso scoppiano violenti temporali, simbolo di litigi
tra i due coniugi divini. Hera, la dea della fecondità presiede
alla nascita ed è la protettrice del matrimonio. Questo tempio
risulta formato dall'insieme di tre vani: il pronao, la cella,
e l'opistodomo. Una base elevata di quattro gradoni, posta in
fondo alla cella, è il luogo riservato alla statua della Divinità.
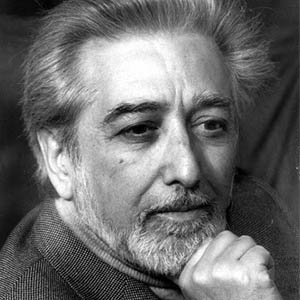
Reno Bromuro è nato a Paduli, in Campania, nel 1937. E' stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale. Nel 1957, a Napoli, ha fondato il Centro Sperimentale per un Teatro neorealista. Ha fondato nel 1973 (di fatto) l'A.I.A. Associazione Internazionale Artisti "Poesie della Vita", e, come critico letterario, ha recensito molti poeti italiani e stranieri. Si è spento nel 2009, qualche anno dopo averci dato l'opportunità di collaborare con lui. Noi di Letteratour lo ricordiamo con affetto qui.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG