
L'odissea di una ragazzina ribelle
nei meandri di Parigi
di Reno Bromuro
Nella categoria: HOME | TOURismi letterari
• Biografia
• L'opera: "Zazie nel metrò"
• La storia
• Il commento
• Il luogo (un ricordo)
 Raymond
Queneau nacque a Le Havre il 21 febbraio
1903. Si laurea in Filosofia, fra il 1924 e il 1929 partecipa attivamente
al movimento surrealista.
Dal 1938 è Redattore della Casa Editrice Gallimard; ha un ruolo
di spicco nella cultura dell'antifascismo europeo, entrando nel 1944 nel
direttivo del Comitato Nazionale degli Scrittori (C.N.E.), nato negli
ambienti della Resistenza francese.
Raymond
Queneau nacque a Le Havre il 21 febbraio
1903. Si laurea in Filosofia, fra il 1924 e il 1929 partecipa attivamente
al movimento surrealista.
Dal 1938 è Redattore della Casa Editrice Gallimard; ha un ruolo
di spicco nella cultura dell'antifascismo europeo, entrando nel 1944 nel
direttivo del Comitato Nazionale degli Scrittori (C.N.E.), nato negli
ambienti della Resistenza francese.
Nel 1951 è eletto all'Académie Goncourt, tre anni dopo diviene
direttore della Encyclopédie de la Pléiade. E’ stato
appassionato di matematica, linguistica, letteratura, psicoanalisi.
Nel 1927 si accosta al movimento surrealista, condividendone la curiosità
per i giochi del linguaggio, ma se ne allontana nel 1929, dopo la rottura
con Breton.
Nel 1933 Esordisce con il romanzo La gramigna, cui seguono Odile, Pierrot
amico mio e nel 1951 pubblica i versi Piccola cosmogonia portatile.
Queneau prende di mira le convenzioni della lingua letteraria, contrapponendovi
la libertà del linguaggio parlato. La disarticolazione della sintassi
e l'introduzione di vocaboli popolari, tratti dall'argot o del tutto inventati,
accanto al recupero delle forme più solenni della retorica, generano
un irresistibile umorismo, nel quale dispiega un’inesauribile verve
e uno straordinario virtuosismo tecnico. Il racconto procede in modo bizzarro
e in apparenza strampalato, richiamando l'attenzione del lettore sui meccanismi
più che sull'oggetto della narrazione. Se in alcune opere del 1947,
quali Esercizi di stile, prevale il gioco linguistico, in altre del 1959,
soprattutto in quelle mature come Zazie nel metro; La domenica della vita;
I fiori blu, forse il suo capolavoro; e Icaro involato, del 1975.
 Queneau
non distrugge del tutto la finzione narrativa. Da questi romanzi è
evidente che la sua opera non è solo esplorazione verbale e formale,
ma vi emerge un singolare universo immaginario, malinconico e insieme
grottesco. In grigie periferie urbane vagano esseri ingenui e mediocri,
a tratti capaci di comunicazione, più spesso respinti in una solitudine
venata di pacato pessimismo. «Ironia e pathos, realtà e sogno,
comico e tragico convivono mirabilmente in un'opera di grande ricchezza,
senza dubbio una delle più interessanti e significative della letteratura
francese del secondo dopoguerra».
Queneau
non distrugge del tutto la finzione narrativa. Da questi romanzi è
evidente che la sua opera non è solo esplorazione verbale e formale,
ma vi emerge un singolare universo immaginario, malinconico e insieme
grottesco. In grigie periferie urbane vagano esseri ingenui e mediocri,
a tratti capaci di comunicazione, più spesso respinti in una solitudine
venata di pacato pessimismo. «Ironia e pathos, realtà e sogno,
comico e tragico convivono mirabilmente in un'opera di grande ricchezza,
senza dubbio una delle più interessanti e significative della letteratura
francese del secondo dopoguerra».
«E’ morto il papà di Zazie»: così nel
1976 la stampa francese celebra la scomparsa del grande scrittore. Il
suo romanzo piú bello, l'odissea di una ragazzina ribelle nei meandri
di Parigi.
Parecchi romanzi del Novecento narrano storie di gente
comune, che diventano eroi. Alcuni scrittori, però si perdono nei
rivoli delle possibilità delle nostre vite o delle nostre fantasticherie.
Il linguaggio, afferma Jean Paul Sartre, è: «uno strumento
sempre troppo ricco o troppo scarso che finisce per imprigionare l'individuo,
mistificandone i significati soggettivi...»
Secondo Raymond Queneau, per questo motivo la letteratura è «poco
più di un delirio scritto a macchina», che non riesce a restituirci
la straordinaria poliedricità delle cose illuminata dalla potenza
destrutturante del linguaggio.
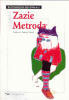 Due
giorni a Parigi per Zazie, ragazzina molto sveglia e con un...
Due
giorni a Parigi per Zazie, ragazzina molto sveglia e con un...
- Me ne sbatto! -, sempre impaziente di prorompere.
Indipendente, fantasiosa, si muove nel mondo degli adulti a velocità
frenetica proferendo parolacce e recitando, come personalissima mossa
difensiva, la «sceneggiata» della piccola vittima di proposte
oscene.
Zazie è impertinente nella sua curiosità di ragazzina che
non afferra il significato delle parole, che gli adulti contribuiscono
a mistificare, Zazie è in visita dallo zio Gabriel trovandosi improvvisamente
di fronte alla duplicità del reale.
Gli individui che frequenta, raramente sono aperti,chiari e puliti, perché
chiusi in ruoli standardizzati. I personaggi che Zazie incontra spesso,
sono innumerevoli…
L'ambiente stesso, traspira poliformità; ma il linguaggio è
insufficiente a raccontare la realtà là dove si utilizzano
modelli stilistici rigidi i quali, ricercando la determinatezza, generano
una crescente e caotica ambiguità. Il mondo degli adulti si presenta
a Zazie filtrato dal linguaggio che, dicendo sempre troppo o troppo poco,
confonde. I modelli letterari epici, romantici, edificanti con cui la
vita si racconta sono sempre altra cosa dal battito vivo del reale e le
regole grammaticali, stilistiche, sintattiche possono infilzare la vita
come una farfalla imbalsamata.
Zazie, nella sua inquietudine, oppone ai conformismi del linguaggio una
forza distruttiva: apostrofando un volgare:
- Carina un c...
- Persone grandi un c....
- Condannabile un c.... -,
impone un tentativo di semplificazione, di ordine.
Quindi occorre spingersi più in là, percorrere nuovi sentieri
letterari in cui sia il linguaggio a plasmarsi sulla duplicità
delle cose.
Ecco allora lo scrittore, grande domatore nel circo che è «Zazie
nel metrò», ingaggiare, come afferma Roland Barthes, «una
lotta corpo a corpo con la Letteratura», per ricomporre con le sue
rovine un diverso e gioioso modo di parlare.
Spezzare le regole grammaticali che impongono un’uniformità
temporale del racconto: presente e passato remoto si alternano di continuo,
quasi distrattamente, nel romanzo, conferendo movimento e leggerezza:
«Una secca scarica di mitra stroncò quel tentativo. La vedova
Mouaque, con le budella in mano, crollò. - Che stupida, - mormorò.
- Proprio io, che avevo dei risparmi. E muore».
Parodiare i generi di scrittura a deridere l’enfatismo, per rendere
in chiave umoristica le espressioni retoriche, a declamare con la letteratura
il nulla della letteratura: «L'essere o il nulla, ecco il problema.
Salire, scendere, andare, venire; tanto fa l'uomo che alla fine sparisce.
Un tàssi lo reca, un metrò lo porta via, la torre non ci
bada, e il Pànteon neppure. Parigi è solo un sogno, Gabriel
è solo un'ombra, Zazie il sogno d'un'ombra (o di un incubo) e tutta
questa storia il sogno di un sogno, l'ombra di un'ombra, poco più
di un delirio scritto a macchina da un romanziere idiota».
Ripetere nella narrazione identiche scene o espressioni ad effetto,ma
anche utilizzare una stessa frase per dar voce, contemporaneamente, a
due interlocutori «- Che cosa (che caro) insinui (mi ha chiamata)
sul mio conto (fraulàin), - dissero sincroni, Gabriel (e la vedova
Mouaque), l'uno con furore (l'altra con fervore)».
Spargere alla rinfusa, nobili termini latini per forzare il tempio del
linguaggio colto «Sono calzolaio, io, non negoziante di calzature.
Ne sutor ultra crepidam, come dicevano gli antichi. Lei capisce il latino?
Usque non ascendam anch'io son pittore adios amigos amen e toc.».
Inventare nuove parole a partire dalla trascrizione fonetica o dall'unione
dei vocaboli, che, nella loro brutalità, recidano i nessi del conformismo
e della letteratura già nell'unità elementare del linguaggio:
«quelkaidettòra, ìcchett-nunk, issofatto, kivvammaginàrselo,
seleddàta, fattidicronicità».
Come pure sperimentare nei vocaboli la rottura dei legami di contesto
spaziale «si però, se io non ce l'ho un tailleur due pezzi
e bagno con una camicetta reggicalze e cucina, che cosa devo fare?».
Le trovate sono tali da provocare un'incredibile accelerazione del ritmo
narrativo, un grande effetto comico pure nella serietà e nella
pesantezza dello scontro con la letteratura, che fa dire infine alla stessa
Zazie:
- Sono invecchiata.
Dall'analisi dell'opera di Raymond Queneau ci si aspetterebbe
un’illuminazione decisiva sulla natura della combinazione letteraria:
François Le Lionnais crea un neologismo per meglio chiarire l'espressione
narrativa di Queneau: «letteratura combinatoria» in riferimento
ai suoi Cent mille milliards de poèmes.
 Eppure,
nell'apparente abbondanza di questi due fenomeni nell'opera di Queneau
si sente l'assenza della sospirata integrazione tra l'essere «letteratura»
e l'essere «combinatoria».I procedimenti combinatori adoperati
dallo scrittore sono «squilibrati dalla parte d'un’immediata
applicazione delle formalizzazioni matematiche alle procedure d'invenzione
e di analisi letteraria»; essi non sono applicati alle misure letterarie
fondamentali, quali il romanzo, il racconto, il testo teatrale, ma hanno
uno spazio a sé: «un ideale campo di sperimentazione in cui
realizzare una sintesi da laboratorio tra i valori stranieri delle matematiche
e quelli letterari, ad essi subordinati». Dall'altro lato, nelle
misure letterarie più tradizionali affrontate, in primo luogo il
romanzo, è effettivamente rintracciabile il modello d'una ricerca
di coesistenza tra stili e generi letterari diversi: ma la combinazione
di discorsi è realizzata quasi esclusivamente da una combinazione
di modalità discorsive, secondo il modello degli esercizi di stile,
in cui la serie di unità diverse non è sottoposta a regole
dispositive combinatorie, ma assume lo statuto del catalogo, dell'elencazione.
Eppure,
nell'apparente abbondanza di questi due fenomeni nell'opera di Queneau
si sente l'assenza della sospirata integrazione tra l'essere «letteratura»
e l'essere «combinatoria».I procedimenti combinatori adoperati
dallo scrittore sono «squilibrati dalla parte d'un’immediata
applicazione delle formalizzazioni matematiche alle procedure d'invenzione
e di analisi letteraria»; essi non sono applicati alle misure letterarie
fondamentali, quali il romanzo, il racconto, il testo teatrale, ma hanno
uno spazio a sé: «un ideale campo di sperimentazione in cui
realizzare una sintesi da laboratorio tra i valori stranieri delle matematiche
e quelli letterari, ad essi subordinati». Dall'altro lato, nelle
misure letterarie più tradizionali affrontate, in primo luogo il
romanzo, è effettivamente rintracciabile il modello d'una ricerca
di coesistenza tra stili e generi letterari diversi: ma la combinazione
di discorsi è realizzata quasi esclusivamente da una combinazione
di modalità discorsive, secondo il modello degli esercizi di stile,
in cui la serie di unità diverse non è sottoposta a regole
dispositive combinatorie, ma assume lo statuto del catalogo, dell'elencazione.
Ma più che gli ultimi tentativi potenziali di Queneau, ma interessa
evidenziare le molteplici risoluzioni della sua scrittura che saranno
eredità fondamentale nella attività di Perec, suo discepolo
prediletto, e di Calvino; questa condivisione di opzioni letterarie contribuirà
sensibilmente all'aggregazione di quel nucleo centrale della letteratura
combinatoria che allinea i nostri autori.
E' a Calvino del resto che si deve principalmente la diffusione nel nostro
paese dell'opera di Queneau, con un lavoro costante di stimolazione interpretativa,
che si concreta anche nella traduzione di «I fiori blu». Ed
è lo stesso Calvino a ricordarci il precoce interesse per Roussel.
Il gioco del combinare è un’operazione che ha luogo su un
piano di lettura delle combinazioni: è quest'ultimo dato che fa
parlare Calvino di una prossima morte della figura dell'autore, poiché
«smontato e rimontato il processo della composizione letteraria,
il momento decisivo della vita letteraria sarà la lettura»
 Ho
trascorso qualche mese a Parigi, e prendo spesso il metrò per spostarmi
attraverso la capitale, curioso di vedere quella città di cui ho
tanto sentito parlare. Il ricordo è preciso di dove fossi, come
è certo il giorno e il motivo per cui fossi in quel tratto di metrò;
c'erano molti passeggeri, pur non essendoci calca; ero in piedi e non
cercavo nemmeno un posto a sedere se il viaggio non durava intorno al
quarto d'ora. Ad una fermata, nel vagone in cui io sto viaggiando, entra
un tizio, di una certa età, curato e vestito discretamente; non
l'avrei notato se non mi avesse rivolto la parola.
Ho
trascorso qualche mese a Parigi, e prendo spesso il metrò per spostarmi
attraverso la capitale, curioso di vedere quella città di cui ho
tanto sentito parlare. Il ricordo è preciso di dove fossi, come
è certo il giorno e il motivo per cui fossi in quel tratto di metrò;
c'erano molti passeggeri, pur non essendoci calca; ero in piedi e non
cercavo nemmeno un posto a sedere se il viaggio non durava intorno al
quarto d'ora. Ad una fermata, nel vagone in cui io sto viaggiando, entra
un tizio, di una certa età, curato e vestito discretamente; non
l'avrei notato se non mi avesse rivolto la parola.
- Oggi è il 21 marzo, la primavera apre le sue porte… - Comincia
a dire.
- Bella entrata della primavera! – Gli rispondo – Non vede
che cielo fuligginoso, grigio, pesante, irrespirabile?
Lui lascia cadere il discorso e inizia a raccontare una storia che gli
è capitata il giorno prima.
Sono i primi giorni che trascorro a Parigi, il mio primo soggiorno in
Francia, e mi è difficile seguire il francese veloce, smozzicato,
troncato, tipico dei parigini, quindi non sono in grado di ripetere tutto
il suo racconto, ma non nascondo che mi è piaciuto molto.
In sintesi mi sembra che abbia narrata di essere giunto il giorno prima,
in una città in cui si avventura per la prima volta, e subito vede
che tutte le persone per la strada corrono veloci, ognuno sicuro della
propria meta, almeno così gli è sembrato, senza guardarsi
intorno né vedere gli altri; tutti hanno fretta, sono tutti indaffarati.
 Anche
lui si lascia prendere dall'ansia e comincia a correre, ma non sa dove
andare, né cosa fare; cerca di chiedere a qualcuno, ma nessuno
lo ascolta.
Anche
lui si lascia prendere dall'ansia e comincia a correre, ma non sa dove
andare, né cosa fare; cerca di chiedere a qualcuno, ma nessuno
lo ascolta.
Ad un certo punto vede un signore e lo apostrofa:
- in questa città tutti corrono, tutti hanno fretta, sembra quasi
che nessuno abbia abbastanza tempo.
- sì, corrono tutti per fare in fretta i loro affari. – Gli
risponde il signore con gentilezza.
- ma perché? Gli chiedo.
- perché correndo riescono a risparmiare tempo.
- e cosa fanno del tempo risparmiato?
- il tempo è denaro, e lo depositano in banca.
- ma allora qui sono tutti pazzi!
- si, - mi risponde sicuro il signore.
- scusi, ma allora anche lei è pazzo?
- no, io non sono pazzo; il signore gentile mi risponde - io sono il banchiere.
Capita spesso invece di rivedere varie volte gli stessi senza casa, o
senza fissa dimora come si usa dire a Parigi, che chiedono soldi, raccontando
la loro presunta storia, sempre sugli stessi tratti del metrò,
specie se si tratta di percorsi lunghi.
Di questi ho ricordi amari e forse un po’ anche sgradevoli e, sarei
bugiardo se dicessi che non mi fanno un po’ paura,c'e' sempre del
ricatto nel loro modo di porsi.
Una certa pena, invece, mi ha fatto un’anziana signora, piuttosto
grassa, mal vestita, che nel vagone si è messa a cantare ad alta
voce; non so dire cosa, non riesco a capire le parole, ma canta male,
non ha certo una voce gradevole. Credo che nessuno le abbia dato nulla,
e lei ha aspettato di scendere alla stazione successiva, si è messa
vicino alla porta, parlando con una signora per dirle che in quel tratto
di metro davvero non erano per nulla generosi, che non riesce a raccattare
niente.
Alla fermata, scendo. Uscendo dalla stazione, vicino ad un albergo, vedo
la polizia che sta arrivando in forze: un furgone, alcune macchine; già
ho incrociato due poliziotti sulle scale, più d'una decina stanno
arrivando mentre uscivamo all'aperto; bell'esempio di efficienza, per
portarsi via un tizio, magro come un chiodo, e che piangeva come un bambino.
Sono ritornato, a Parigi, dopo cinquant’anni esatti, un giorno di
dicembre di cinque anni fa. A Gare de Lyon, aspetto che scrivano il binario
di partenza del mio treno, ho sempre avuto l'impulso ad arrivare molto
prima della partenza, una specie di fobia per l’orario e per il
tempo.
Ho passato qualche tempo nella sala d'attesa, ma a mano a mano che si
affolla sono sempre più inquieto, e decido di uscire. Mi sono ritrovato
nella galleria degli affreschi, per evitare il freddo totale dell'esterno,
verso i binari, ma in modo d’avere il tabellone degli orari sotto
gli occhi. Passa tantissima gente in una stazione; alcuni poi non si spostano
mai dalla stazione, forse la gente che passa costituisce il loro viaggio;ripassi
dopo ore,e gli abitanti di una stazione sono completamente cambiati. Strano
mondo le stazioni, insieme monumentali e brutte, luccicanti e sporche!
Ad un certo punto passa un arabo, ben vestito, con un carrello su cui
trasporta un paio di valige e qualche borsa; si ferma in un angolo, stende
per terra una specie di tappeto leggero, si toglie le scarpe, e comincia
la sua preghiera; continua per qualche minuto, poi si alza, si rimette
le scarpe, sbatte il suo tappetino, e riparte con il carrello.
Parigi, ormai mi è entrata nel sangue, sto imparando a conoscerla.
Incontro Enrico, un amico napoletano giornalista, che mi indica dove poter
mangiare con pochi soldi e il pranzo più economico è il
panino. Mi offre da leggere «Le Figaro» dove ha sottolineato
il titolo di un articolo: «Il panino prosciutto cotto». M’invogli
ad assaggiarlo: è leggero, croccante, ma sparisce in un minuto.
- Ecco perché dev'essere l'espressione dell'istantaneità.
– Mi dice ridendo Enrico -
Sul sacchetto, in cui è stato infilato il panino, «Si specifica
la cottura del pane, sempre piuttosto sul ben cotto!»
Dopo ci incamminiamo per avenue du Président-Wilson e ci troviamo
a Palais Galliera. Intorno al fontanile centrale e alla scultura di Pierre
Roche, stile 1900, è la massa imponente e elegante non solo del
palazzo ma anche dei tigli, aceri e degli ippocastani.
«Parigi (mi racconta Enrico, che vive a Parigi come inviato da oltre
quindici anni), vive con Londra appieno la grande rivoluzione industriale
dell'800, e dopo la metà del secolo, con Napoleone III, vive una
seconda giovinezza che durerá fino all'inizio del nostro secolo.
I grandi boulevard progettati da Haussman ospitano la vita della Belle
Epoque, Parigi é la culla della cultura europea, del modo europeo
di vedere l'arte, soprattutto quelle figurative. Ecco che tra le imponenti
facciate stile terzo impero e i viali alberati della allora periferia
spuntano come un sogno deliziosi palazzi Art Nouveau, spesso poco piú
che villette, altre volte palazzi di rappresentanza, ma sempre un po'
defilati rispetto alla vita ufficiale.
Ma Parigi non ospita solo decorative palazzine, essa raccoglie nelle sue
viscere non solo di singolo edificio, a livello di quartiere e a livello,
addirittura, cittadino.
È il famoso style Metro di Guimard, che per un breve lasso di tempo
caratterizza l'arredo urbano della Ville Lumiére. Ciò che
rimane oggi, splendide entrate di metropolitana con lampioni in ferro
battuto, é solo una parte del grande progetto di questo geniale
architetto».
Prima di ritornare a Londra dove è stato destinato da due anni,
mi porta a visitare l’ Île-de-France che occupa il cuore della
città ed è situata a trentasette metri, quasi al centro
del Bacino Parigino, sulla Senna, alla confluenza di altre importanti
vie d'acqua quali la Marna e l'Oise; divisa amministrativamente in venti
circondari contrassegnati con numeri progressivi dati in base alla loro
posizione topografica rispetto al Louvre e secondo una spirale che si
sviluppa per circa due volte e mezzo intorno al centro in senso orario.
Tra gli agglomerati più popolosi sono quelli di Argenteuil, Asnières-sur-Seine,
Aubervilliers, Boulogne-Billancourt, Clichy, Colombes, Courbevoie, Levallois-Perret,
Montreuil, Neuilly-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Maur-des-Fossés
e Versailles.
 Un
posto di rilievo ha il turismo, risorsa economica di notevole importanza
per l'interesse culturale dell'università e delle scuole di arte
e di scienza, dei numerosi musei e per la bellezza e l'interesse storico
dei monumenti. L'intensità del traffico e l'estensione della città
hanno imposto già da tempo la necessità di servizi pubblici
sotterranei (métro), che oggi si estendono su una rete lunga oltre
duecentotrentacinque chilometri. Ma le vie di accesso all'agglomerato
parigino sono numerose e varie: tre autostrade e ventitre strade nazionali
confluiscono nella città; sei grandi stazioni ferroviarie mantengono
le comunicazioni con altrettanti settori del territorio francese e una
linea ferroviaria corre attorno alla città collegando tra loro
i sobborghi. Per via d'acqua gli scambi commerciali, oltre trenta milioni
di tonnellate di merci annue, si effettuano soprattutto con la bassa Senna
e con il Nord; sulle rive della Senna si succedono, oltre cinquanta porti.
Un
posto di rilievo ha il turismo, risorsa economica di notevole importanza
per l'interesse culturale dell'università e delle scuole di arte
e di scienza, dei numerosi musei e per la bellezza e l'interesse storico
dei monumenti. L'intensità del traffico e l'estensione della città
hanno imposto già da tempo la necessità di servizi pubblici
sotterranei (métro), che oggi si estendono su una rete lunga oltre
duecentotrentacinque chilometri. Ma le vie di accesso all'agglomerato
parigino sono numerose e varie: tre autostrade e ventitre strade nazionali
confluiscono nella città; sei grandi stazioni ferroviarie mantengono
le comunicazioni con altrettanti settori del territorio francese e una
linea ferroviaria corre attorno alla città collegando tra loro
i sobborghi. Per via d'acqua gli scambi commerciali, oltre trenta milioni
di tonnellate di merci annue, si effettuano soprattutto con la bassa Senna
e con il Nord; sulle rive della Senna si succedono, oltre cinquanta porti.
A Parigi ci sono oltre duecento musei, fra cui quello del Louvre, uno
dei più grandi del mondo.  All'arte
egizia e orientale sono dedicati i musei Cernuschi e Guimet, quest'ultimo
fra i più notevoli d'Europa per l'arte cinese e giapponese. All'arte
moderna e contemporanea sono invece destinati il Musée d'Orsay,
il Petit Palais il Musée National d'Art Moderne, parte integrante
del Centre Georges-Pompidou meglio conosciuto come Beaubourg, realizzato
dall'architetto italiano Renzo Piano, che conserva un'eccezionale raccolta
di opere di Matisse, Picasso e Braque e numerose opere rappresentative
delle più importanti tendenze artistiche del dopoguerra; accanto
a questi vanno ancora ricordati il Musée Picasso, aperto nel 1985
nella prestigiosa sede del secentesco Hôtel Salé, che presenta
un vasto insieme di opere dell'artista e il Jeu de Paume, riaperto nel
1991 per ospitare solo mostre temporanee, la prima delle quali dedicata
a Jean Dubuffet, esponente di spicco della pittura francese moderna.
All'arte
egizia e orientale sono dedicati i musei Cernuschi e Guimet, quest'ultimo
fra i più notevoli d'Europa per l'arte cinese e giapponese. All'arte
moderna e contemporanea sono invece destinati il Musée d'Orsay,
il Petit Palais il Musée National d'Art Moderne, parte integrante
del Centre Georges-Pompidou meglio conosciuto come Beaubourg, realizzato
dall'architetto italiano Renzo Piano, che conserva un'eccezionale raccolta
di opere di Matisse, Picasso e Braque e numerose opere rappresentative
delle più importanti tendenze artistiche del dopoguerra; accanto
a questi vanno ancora ricordati il Musée Picasso, aperto nel 1985
nella prestigiosa sede del secentesco Hôtel Salé, che presenta
un vasto insieme di opere dell'artista e il Jeu de Paume, riaperto nel
1991 per ospitare solo mostre temporanee, la prima delle quali dedicata
a Jean Dubuffet, esponente di spicco della pittura francese moderna.
Bibliografia
R. Minguet, Géographie industrielle de Paris, Parigi,
1957;
P. Lavedan, Histoire de Paris, Parigi, 1960;
P. M. Duval, Paris antique, des origines au IIIe siècle, Parigi,
1961;
G. Piccinato, L'architettura contemporanea in Francia, Bologna, 1964;
Autori Vari, R. Gargiani, Parigi. Architetture tra purismo e Beaux-artes
1919-1939, Milano, 1989.
P. A. Touchard, Histoire sentimentale de la Comédie-Française,
Parigi, 1955.
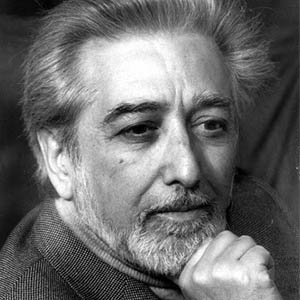
Reno Bromuro è nato a Paduli, in Campania, nel 1937. E' stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale. Nel 1957, a Napoli, ha fondato il Centro Sperimentale per un Teatro neorealista. Ha fondato nel 1973 (di fatto) l'A.I.A. Associazione Internazionale Artisti "Poesie della Vita", e, come critico letterario, ha recensito molti poeti italiani e stranieri. Si è spento nel 2009, qualche anno dopo averci dato l'opportunità di collaborare con lui. Noi di Letteratour lo ricordiamo con affetto qui.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG