
di Reno Bromuro
Nella categoria: HOME | TOURismi letterari
• Intro
• Biografia
• Il romanzo
• La critica
 Lo
scrittore francese Stendhal, pseudonimo di Marie-Henri
Beyle, nacque nel 1783 e partecipò, giovanissimo, alle
campagne napoleoniche. S'appassiona talmente dell'Italia, che, dopo avervi
ricoperto incarichi diplomatici in seguito alla calata di Napoleone,
vi ambientò molti dei suoi romanzi, tra i quali: "La
Certosa di Parma", dominata dall'atmosfera di liberazione
che seguì l'arrivo delle truppe francesi sul nostro territorio
e la conseguente eliminazione del dominio austriaco, il volume di viaggi
"Roma, Napoli e Firenze" e "Passeggiate
Romane".
Lo
scrittore francese Stendhal, pseudonimo di Marie-Henri
Beyle, nacque nel 1783 e partecipò, giovanissimo, alle
campagne napoleoniche. S'appassiona talmente dell'Italia, che, dopo avervi
ricoperto incarichi diplomatici in seguito alla calata di Napoleone,
vi ambientò molti dei suoi romanzi, tra i quali: "La
Certosa di Parma", dominata dall'atmosfera di liberazione
che seguì l'arrivo delle truppe francesi sul nostro territorio
e la conseguente eliminazione del dominio austriaco, il volume di viaggi
"Roma, Napoli e Firenze" e "Passeggiate
Romane".
Le storie sono ambientate in un'Italia ottocentesca in parte fantastica,
in parte reale, le avventure di Fabrizio del Dongo si
snodano in una serie d'incontri peripezie al termine dei quali si trova
il luogo del silenzio. Lo spazio simbolico dell'isolamento e della rinuncia:
la Certosa di Parma.
Alla battaglia di Waterloo, che apre il percorso del protagonista, Fabrizio
scopre che la realtà è indecifrabile e sfuggente. Restano
le emozioni, i sentimenti, primo fra tutti la passione amorosa. Ma l'amore
tanto cercato sfugge all'infinito: la "caccia alla felicità"
si risolve in un gioco di prospettive e di dissonanze.
L'opera da noi esaminata è l'edizione curata da Franca
Zanelli Quarantini, che ha un saggio introduttivo di Paul
Valéry. La certosa di Parma
è un romanzo modernissimo, profondamente "realista".
Stendhal vi riassume ad un tempo lo spaesamento che la
nascente società borghese determina nell'individuo immerso in una
realtà politica e sociale in continua evoluzione e la perdita tutta
individuale delle illusioni, il disincanto che scopre, soggetto ad un
insieme di forze che dirigono arbitrariamente la sua esistenza, incapace
di risolvere i propri dubbi intorno al passato e al futuro.
Ma di fondamentale importanza è il romanzo "Il
Rosso e il Nero", formalmente e contenutisticamente
permeato da un realismo moderno che, nell'ambito di una sensibilità
di tipo romantico, si pone in maniera attenta nei confronti della società
ma che, ai tempi della sua pubblicazione, incontrò pochi consensi.
Stendhal nacque a Grenoble da
una ricca famiglia borghese. A sette anni perse la madre cui era molto
affezionato. A Sedici anni, insofferente al padre che aveva ccominciato
a contestare e forse detestare per il suo conservatorismo sfacciatamente
bigotto, abbandonò la casa paterna per recarsi a Parigi.
Sua intenzione, senza risorse economiche, era quella di iscriversi alla
Ecole Polytechnique, ma per ristrettezze finanziarie
fu costretto a rinunciarvi. Si trattenne lo stesso a Parigi lavorando,
aiutato da suo cugino Daru, alcuni mesi come semplice
impiegato al ministero della guerra; poi, scoppiati tra i giovani gli
entusiasmi per le campagne napoleoniche in Italia, l'anno dopo raggiunse
l'armata di Napoleone a Milano.
Qui nacque il suo amore per l'Italia, che non
cessò mai di riconoscere come sua patria d'elezione. Il giovane,
conquistati i gradi di sottotenente, a Venticinque anni diventa aiutante
di campo del generale Michaud, e quasi subito entra a
far parte della amministrazione imperiale civile e militare. Incarico
che gli permette frequenti viaggi in Italia,
in Austria, in Russia,
in Germania, fino alla caduta di Napoleone.
Dieci anni di singolari esperienze; sempre a contatto con uomini d'ogni
ceto sociale; e con loro a vivere lo "spirito del tempo".
Alla restaurazione non rientrò in Francia
ma si ritirò a Milano. Un soggiorno di
sei anni che gli permise di vivere e partecipare con intensità
alla vita culturale milanese di quel periodo molto instabile politicamente
e anche molto critico; infatti dovette interrompere questo idillio dopo
i moti piemontesi,per far rientro a Parigi dopo essere entrato nei sospetti
degli austriaci come seguace della carboneria milanese.
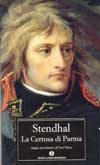 In
Francia, trentasettenne, senza molte risorse
economiche, e ancora del tutto sconosciuto come scrittore, iniziò
a collaborare con alcune riviste di critica d'arte e musicali con articoli
piuttosto singolari. Non esprimendo una critica rigida ristretta su questi
argomenti, ma diventando un poligrafo, con diverse forme d'espressione,
un narratore, un giornalista, uno storico, un memorialista, un diarista;
non dimenticando di fare l'osservatore politico, di inserire nelle sue
pagine le polemiche culturali in atto, ed infine di fare lo psicologo
e concedersi anche momenti di meditazione autobiografica con l'io narrante,
inventandosi il fortunato pseudonimo Stendhal, di un
personaggio attento ma disinvolto, spigliato ma competente, brillante
ma ben informato, con toni confidenziali, spesso anche sublimi, come in
Considerazioni sull'amore, uscito nel 1822,
suscitando l'entusiasmo dei lettori e dei critici, avidi in questo periodo
d'indagini tra cronaca e storia.
In
Francia, trentasettenne, senza molte risorse
economiche, e ancora del tutto sconosciuto come scrittore, iniziò
a collaborare con alcune riviste di critica d'arte e musicali con articoli
piuttosto singolari. Non esprimendo una critica rigida ristretta su questi
argomenti, ma diventando un poligrafo, con diverse forme d'espressione,
un narratore, un giornalista, uno storico, un memorialista, un diarista;
non dimenticando di fare l'osservatore politico, di inserire nelle sue
pagine le polemiche culturali in atto, ed infine di fare lo psicologo
e concedersi anche momenti di meditazione autobiografica con l'io narrante,
inventandosi il fortunato pseudonimo Stendhal, di un
personaggio attento ma disinvolto, spigliato ma competente, brillante
ma ben informato, con toni confidenziali, spesso anche sublimi, come in
Considerazioni sull'amore, uscito nel 1822,
suscitando l'entusiasmo dei lettori e dei critici, avidi in questo periodo
d'indagini tra cronaca e storia.
Sopravvivendo fino alla rivoluzione del 1830, con l'avvento di Luigi
Filippo, riuscì ad ottenere quello che desiderava:con
la nomina di Console a Trieste ritornò
in Italia. Ma anche qui, in terra austro lombardo-veneta,
come a Milano anni prima, fu considerato dalle autorità austriache
persona indesiderata. Dovette ripiegare sullo Stato Pontificio
a Civitavecchia; non male come destinazione giacché
con continui viaggi scoprì a fondo gli ambienti, e non solo artistici-culturali,
di Roma, Firenze,
Napoli. Tre mondi molto diversi, con viaggi
nel mezzo di condizioni umane altrettanto diverse.
Scrisse libri che sono specchi d'incontri umani, con quella preziosa sensibilità
stendhaliana che distingue questo scrittore che ha il segreto di comunicare
con uno stile inconfondibile; un taglio giornalistico ma anche sapienti
sollecitazioni intellettuali che mantengono sempre viva l'attenzione del
lettore.
I suoi romanzi costituiscono il primo grande modello della narrativa realistica
ottocentesca, che da epoche remote attingeva le tematiche più adatte
a descrivere la contemporaneità ed i cui protagonisti erano dominati
da un ardente volontà di affermazione personale e di fuga dalla
grigia quotidianità. Dialoghi tra l'autore-personaggio e il lettore-
ascoltatore. Strumenti di una comunicazione nuova, dei veri e propri incontri.
L'autorità dello scrittore supera i limiti di una cultura nazionale,
raggiungendo dimensioni universali, trovando accoglienza ovunque si era
pronti a ricevere e discutere idee nuove, tanto più se proposte
con energia e onestà. Idee libere di muoversi in spazi propri,
ancora caotici, ma che dal giorno della sua scomparsa diventeranno veri
e propri universi in formazione.
 Un
giovane sensibile e bello, Fabrizio del Dongo, compie
il tragitto stendhaliano della felicità, che si adempie sia oggettivamente
attraverso l'impegno nella storia sia soggettivamente attraverso il compimento
pieno delle passioni della vita privata. Pubblico e privato, Waterloo
e Napoleone, s'intrecciano alla passione per la Sanseverina,
e nel romanzo premono con la stessa potenza virile.
Un
giovane sensibile e bello, Fabrizio del Dongo, compie
il tragitto stendhaliano della felicità, che si adempie sia oggettivamente
attraverso l'impegno nella storia sia soggettivamente attraverso il compimento
pieno delle passioni della vita privata. Pubblico e privato, Waterloo
e Napoleone, s'intrecciano alla passione per la Sanseverina,
e nel romanzo premono con la stessa potenza virile.
Figlio del tenente Robert, arruolato nella Grande Armata
napoleonica che aveva varcato le Alpi il 15 maggio 1796, destando l'Italia
dai secoli bui in cui era caduta dalla Controriforma, Fabrizio è
figlio illegittimo del militare francese e della marchesa del
Dongo.
Protetto dalla zia, Gina donna deliziosa di trent'anni,
modello d'impertinenza e di seduzione, votata alla felicità ed
irriducibilmente libera e diventata duchessa Sanseverina
in seguito ad un matrimonio d'interesse combinato dal conte Mosca,
primo ministro della minuscola corte di Parma,
e suo spasimante, Fabrizio inizierà una carriera brillante ecclesiastica
che lo porterà fino all'arcivescovato di Parma.
La Sanseverina è il personaggio centrale del romanzo da Italo
Calvino indicata paradossalmente come "il più grande
personaggio femminile della... letteratura italiana". Il suo amore
per il nipote Fabrizio è la riproposizione dell'amore tra due esseri
con una forte differenza di età, e, nell'Ottocento una "donna
di trent'anni" era una donna "matura".
Perseguitato dal potere oscurantista e dispotico che regna a Parma,
i maneggi politici tra il Principe, il conte Mosca
e la Sanseverina sono tra gli aspetti più godibili
del romanzo. Imprigionato e condannato a morte, Fabrizio
incontra l'amore proprio in prigione nella figura di Clelia Conti,
la figlia del governatore della fortezza. Liberato dalla Sanseverina,
con una fuga romanzesca, dopo molte tribolazioni e sofferenze, finirà
per trovare il suo unico amore, Clelia, da cui avrà un figlio,
Sandrino. Ma la morte del bambino determina quella, di
crepacuore, della madre, come anche il ritiro di Fabrizio
alla Certosa di Parma, dove non tarderà
a seguire nella tomba le persone amate.
In questo romanzo si incrociano tutte le costanti stendhaliane: nascita
illegittima, due donne e due amori di età differenti, la ricerca
difficile della felicità nell'individuazione della sua intima essenza.
Senza dubbio appare come il vero testamento del romanziere poiché
vi si trova accolta in forma romanzesca tutta la mitologia stendhaliana.
Il principale protagonista del romanzo è l'Italia,
o piuttosto ciò che Michel Crouzet chiama la "Stendhalie"
ossia il personale mito romantico di Stendhal, un Paese idoleggiato impastato
di sole e del profumo degli aranci, terra della passione bollente, dove
l'intrigo machiavellico, l'amore libero e disinibito si legano al brio,
all'energia, al delitto. Intrigo politico, con estremisti sempre in agguato,
ecco la figura di Ferrante Palla, passioni, pugnali e
veleni: l'Italia di sempre?
 La
Certosa di Parma esprime il distacco più
completo di Stendhal dal mondo contemporaneo e il suo
trionfo su di lui; il romanzo è l'espressione della sua alienazione
rispetto all' epoca e del suo rifiuto di lasciarsi bloccare da quella
alienazione. La Parma di Stendhal
non appartiene né al Diciannovesimo secolo né, come sostengono
alcuni critici, all'epoca di Machiavelli; è indipendente
dal tempo e dallo spazio, un modello in formato ridotto di governo autocratico;
qui la politica, per un paradosso che è la molla segreta della
grandezza di Stendhal, si presenta ai nostri occhi con l'evidenza rappresentativa
di una parabola e con la stilizzata illogicità di un'opera lirica.
La maggior parte dei romanzieri che volgono la loro attenzione alla politica,
penso soprattutto a Conrad, tendono a considerarla un
ostacolo che il mondo interpone sulla strada che porta alla felicità.
Anche Stendhal vede la politica sotto questa luce, ma il suo modo di considerarla
e di accostarsi ad essa è molto più complesso. La politica
non permette al conte Mosca e alla duchessa Sanseverina
di godersi la felicità che sarebbe alla loro portata, impedisce
a Fabrizio di fuggire con la sua cara, Clelia; la politica
è la forza del mondo esterno che impedisce agli uomini di seguire
i loro più sani istinti ma è anche qualcos'altro e di ciò
si rendono conto pienamente solo Stendhal e Dostoevkij
tra i romanzieri dell'Ottocento: è un modo di sfogare quelle stesse
passioni che la politica soffoca;non è solo un ostacolo per la
volontà ma anche uno stimolo e una sfida; non è semplicemente
un invito alla pusillanimità ma, a volte, un invito all'eroismo.
La
Certosa di Parma esprime il distacco più
completo di Stendhal dal mondo contemporaneo e il suo
trionfo su di lui; il romanzo è l'espressione della sua alienazione
rispetto all' epoca e del suo rifiuto di lasciarsi bloccare da quella
alienazione. La Parma di Stendhal
non appartiene né al Diciannovesimo secolo né, come sostengono
alcuni critici, all'epoca di Machiavelli; è indipendente
dal tempo e dallo spazio, un modello in formato ridotto di governo autocratico;
qui la politica, per un paradosso che è la molla segreta della
grandezza di Stendhal, si presenta ai nostri occhi con l'evidenza rappresentativa
di una parabola e con la stilizzata illogicità di un'opera lirica.
La maggior parte dei romanzieri che volgono la loro attenzione alla politica,
penso soprattutto a Conrad, tendono a considerarla un
ostacolo che il mondo interpone sulla strada che porta alla felicità.
Anche Stendhal vede la politica sotto questa luce, ma il suo modo di considerarla
e di accostarsi ad essa è molto più complesso. La politica
non permette al conte Mosca e alla duchessa Sanseverina
di godersi la felicità che sarebbe alla loro portata, impedisce
a Fabrizio di fuggire con la sua cara, Clelia; la politica
è la forza del mondo esterno che impedisce agli uomini di seguire
i loro più sani istinti ma è anche qualcos'altro e di ciò
si rendono conto pienamente solo Stendhal e Dostoevkij
tra i romanzieri dell'Ottocento: è un modo di sfogare quelle stesse
passioni che la politica soffoca;non è solo un ostacolo per la
volontà ma anche uno stimolo e una sfida; non è semplicemente
un invito alla pusillanimità ma, a volte, un invito all'eroismo.
L'ultimo romanzo di Stendhal fu scritto, o piuttosto
dettato, tra il 4 novembre ed il 26 dicembre 1838. In cinquantadue giorni.
Uno degli exploits più memorabili della letteratura francese.
Dopo i romanzi ambientati nella Francia contemporanea (Armance,
Il rosso e il nero), l'autore ritorna all'Italia, terra dell'altrove
e della felicità, ultima utopia poetica.
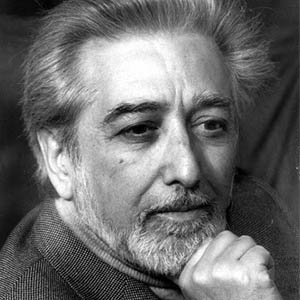
Reno Bromuro è nato a Paduli, in Campania, nel 1937. E' stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale. Nel 1957, a Napoli, ha fondato il Centro Sperimentale per un Teatro neorealista. Ha fondato nel 1973 (di fatto) l'A.I.A. Associazione Internazionale Artisti "Poesie della Vita", e, come critico letterario, ha recensito molti poeti italiani e stranieri. Si è spento nel 2009, qualche anno dopo averci dato l'opportunità di collaborare con lui. Noi di Letteratour lo ricordiamo con affetto qui.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG