
Giuseppe Ungaretti
e la tragicità della nostalgia
"L'Isonzo scorrendo/ mi levigava/ come un suo sasso"
di Reno Bromuro
Nella categoria: HOME | TOURismi letterari
 •
Biografia
•
Biografia
• La prima Guerra Mondiale e il soldato Ungaretti
• Origine della poesia ungarettiana: le battaglie
dell'Isonzo
• Il soldato Giuseppe Ungaretti
• L'opera "I miei fiumi"
• Commento e critica
• Il luogo
• "I miei fiumi"
• Bibliografia
 Giuseppe
Ungaretti nasce ad Alessandria d'Egitto
l’8 febbraio 1888 da Antonio Ungaretti e Maria
Lunardini entrambi lucchesi, trascorre l'infanzia e l'adolescenza
ad Alessandria d'Egitto. A ventidue anni si
reca a Parigi per perfezionarsi negli studi
e stringe amicizia con Apollinaire. Nel 1916 pubblica
la sua prima opera cui dà il titolo Il porto sepolto,
dove le cadenze crepuscolari e futuriste delle precedenti Poesie
disperse si sono dissolte in un nuovo contesto morale: la
liberazione dalla costruzione sintattica tradizionale è il segno
più grande di una poesia essenziale, volta alla riscoperta del
valore primordiale della parola.
Giuseppe
Ungaretti nasce ad Alessandria d'Egitto
l’8 febbraio 1888 da Antonio Ungaretti e Maria
Lunardini entrambi lucchesi, trascorre l'infanzia e l'adolescenza
ad Alessandria d'Egitto. A ventidue anni si
reca a Parigi per perfezionarsi negli studi
e stringe amicizia con Apollinaire. Nel 1916 pubblica
la sua prima opera cui dà il titolo Il porto sepolto,
dove le cadenze crepuscolari e futuriste delle precedenti Poesie
disperse si sono dissolte in un nuovo contesto morale: la
liberazione dalla costruzione sintattica tradizionale è il segno
più grande di una poesia essenziale, volta alla riscoperta del
valore primordiale della parola.
La prima stagione lirica ungarettiana è nella raccolta L'Allegria
del 1931; uscita in precedenza, 1919, con il titolo Allegria
di naufragi: un titolo paradossale, nato senza dubbio, dal
fondo di disperazione della guerra di trincea del 1915, 1918, in cui il
paesaggio costante è il deserto, nella sua duplice dimensione fisica
e spirituale. Solo in un'"intima comunione" con le cose, il
poeta riesce ad appagare il suo anelito di "sentirsi in armonia"
con l'universo. In questo clima scaturisce la tensione ad una parola incorrotta,
ad uno stile scabro che affida ogni capacità di suggestione all'evocazione
degli oggetti e alla loro forza analogica.
Nella seconda raccolta, Sentimento del tempo
del 1933, all'ipotesi di una parola preistoricamente vergine si sostituisce
la convinzione che non c'è purezza fuori della storia; è
necessario, allora, ricuperare la tradizione poetica, da Petrarca
a Leopardi, ed è necessario, recuperare un discorso
più largo e disteso, non frantumato, mediante il ritorno all'endecasillabo
classico.
Nel 1936 accetta la cattedra di letteratura italiana all'Università
di San Paolo, in Brasile; il soggiorno americano è
tragicamente segnato nel 1940 dalla morte del figlio di nove anni. Questa
luttuosa circostanza, unita alla tragedia corale della guerra, ispira
i versi de Il Dolore che vedono la luce nel
1947, in cui l'intimismo della rievocazione si fonde con il rigonfiamento
del paesaggio tropicale e l'intensità della sofferenza, che riesce
a placarsi in una tristezza senza lacrime.
L'ansia di giungere ad un "paese innocente" ha il suo approdo
nel 1950, nei versi della Terra promessa, un'opera
di rigore classico, in cui la pena di vivere si cristallizza nella limpidezza
dello stile. A questa lucida esperienza poetica segue, due anni dopo,
nel 1952 Un grido e paesaggi, nuova testimonianza
della profonda umanità del poeta, che includente un testo di notevole
rilievo: il Monologhetto, tutto giocato sul
tema della memoria, in chiave d’ironica saggezza.
L'itinerario poetico di Ungaretti si chiude nel 1960, con gli scintillanti
frammenti del Taccuino del vecchio, dove il
paesaggio è ormai assorbito in un ragionamento teso e rigoroso,
e con il Dialogo d'amore di otto anni dopo, ultimo esempio di quell'inesausta
vitalità e di quella lucida ebbrezza che rendono esemplare la sua
lezione poetica.
Ho avuto l’onore, il privilegio, direi, di assaporare questa sua
"inesausta vitalità" , allorché una sera del maggio
1955, fui chiamato dal "mio amico insperato", il quale aveva
preparato per me un "comitato d’accoglienza", perché
dovevano esprimersi sulla mia poesia, la prima raccolta pubblicata, con
i soldi del mio benefattore "amico insperato". Come varcai la
soglia, vidi un’infinità di volti incorniciati da un’aureola
luminosissima, tra cui la splendente riconobbi subito e le gambe mi tremavano:
Lui, il grande Vecchio, che mi squadrava dalla testa ai piedi con suo
sguardo penetrante e il sorriso sornione stampato sulle labbra. Mi voltai
verso l’"amico insperato" chiedendo aiuto con lo sguardo
e… fu in quel momento che mi resi conto di quanto sarebbe accaduto:
sulla scrivania erano sparpagliate, come frutta fresca al sole, alcune
copie della racconta di poesie: "Note e Motivi",
che il mio "amico insperato" m’invitò a leggere.
Alla fine della lettura ogni persona presente espose il suo parere, il
"Grande Vecchio" disse con la sua voce inconfondibile: "sublimi
le liriche della seconda parte, intitolate:"Canti del viandante notturno"
dedicate ai segni dello zodiaco, veramente sublimi". Piansi
di gioia e lo amai ancora di più, il suo "Sentimento
del tempo" divenne la mia bibbia.
La prima guerra mondiale e il soldato Ungaretti
 L’occasione
che fa scoppiare il conflitto giunge il 28 giugno 1914 a Sarajevo
(Serbia), quando avviene l’uccisione dell’Arciduca
Francesco Ferdinando d’Austria e sua moglie da parte di
Gavrilo Princic, uno studente nazionalista serbo appena
diciannovenne. Dopo l’uccisione l’Austria
inviò un ultimatum alla Serbia, nel quale
spiegava che avrebbe collaborato al ritrovamento dei colpevoli del delitto,
ma per far questo avrebbe invaso il loro territorio, ed inoltre vuole
la totale repressione dei movimenti nazionalisti ed irredentisti. L’ultimatum
non è accettato e l’Austria, il 27 luglio 1914, non perde
tempo a dichiarare guerra. In appoggio alla Serbia la Russia
mobilitò subito il suo esercito, ed automaticamente la Germania,
che altro non aspetta, le dichiara guerra il primo agosto 1914. Nei giorni
successivi anche Francia ed Inghilterra
entrano nel conflitto in favore della Russia. L’unica potenza a
rimanere neutrale per il momento è l’Italia
che secondo il patto che la lega con Austria e Germania, puramente difensivo,
doveva entrare in conflitto al loro fianco solo in caso che fossero loro
le prime ad essere attaccate.
L’occasione
che fa scoppiare il conflitto giunge il 28 giugno 1914 a Sarajevo
(Serbia), quando avviene l’uccisione dell’Arciduca
Francesco Ferdinando d’Austria e sua moglie da parte di
Gavrilo Princic, uno studente nazionalista serbo appena
diciannovenne. Dopo l’uccisione l’Austria
inviò un ultimatum alla Serbia, nel quale
spiegava che avrebbe collaborato al ritrovamento dei colpevoli del delitto,
ma per far questo avrebbe invaso il loro territorio, ed inoltre vuole
la totale repressione dei movimenti nazionalisti ed irredentisti. L’ultimatum
non è accettato e l’Austria, il 27 luglio 1914, non perde
tempo a dichiarare guerra. In appoggio alla Serbia la Russia
mobilitò subito il suo esercito, ed automaticamente la Germania,
che altro non aspetta, le dichiara guerra il primo agosto 1914. Nei giorni
successivi anche Francia ed Inghilterra
entrano nel conflitto in favore della Russia. L’unica potenza a
rimanere neutrale per il momento è l’Italia
che secondo il patto che la lega con Austria e Germania, puramente difensivo,
doveva entrare in conflitto al loro fianco solo in caso che fossero loro
le prime ad essere attaccate.
Il 10 luglio 1914, proprio il giorno d’inizio del conflitto mondiale,
è nominato come nuovo capo di Stato Maggiore dell’esercito
italiano il generale Luigi Cadorna, che
non perde tempo e avanza immediatamente richieste di fondi per l’attrezzatura
e l’addestramento dell’esercito, preoccupato per lo stato
di impreparazione in cui esso si trovava. Il governo però, pur
di salvaguardare una certa impostazione del bilancio dello stato, si oppone
sistematicamente alle richieste del generale. Solo in un secondo momento,
con l’incalzare degli avvenimenti bellici, il governo è costretto
a sostenere con rito d’urgenza spese per Un miliardo e novantadue
milioni di lire previste per l’anno finanziario 1914, 1915.
Il 26 aprile del 1915, è stipulato segretamente, anche dal generale
Cadorna, il Patto di Londra, le sue clausole
prevedono, che qualora l’Italia entrasse in guerra a fianco dell’Intesa,
ed il conflitto si risolva vittoriosamente, i vantaggi territoriali richiesti:
il Trentino e il Tirolo
fino al Brennero, Gorizia,
Trieste e l’Istria
(esclusa Fiume), parte delle Dalmazia e le isole
del Dodeccaneso. Il 24 maggio 1915, l’Italia
dichiara guerra all’Austria.
Le truppe italiane, nella notte tra il 23 e il 24 maggio, oltrepassano
dappertutto il confine italo-austriaco abbattendo i cippi di delimitazione.
Nelle giornate successive, mentre gli austriaci fanno saltare tutti i
ponti sull’Isonzo, gli italiani occupano Cormòns,
Versa e Cervignano,
cioè la zona del basso Isonzo.
Il mattino del 5 giugno l’esercito italiano incomincia le prime
operazioni per il passaggio dell’Isonzo, ma i tentativi purtroppo
sono sistematicamente vanificati dall’artiglieria austriaca che
contrasta efficacemente la costruzione di ponti o passerelle, da parte
degli italiani. Solo nei pressi di Papariano e Pieris, l’avanzata
ha più successo. I reparti italiani, passato il fiume Isonzo, proseguono
verso Monfalcone e il Monte Sei
Busi, ostacolati anche dall’inondazione della pianura
provocata dagli austriaci, rompendo gli argini del canale Dottori.
Origine della poesia ungarettiana: Le battaglie dell’Isonzo
Gli austriaci occupano, di là del fiume, posizioni
ben fortificate, difese da cannoni e mitragliatrici, e protette da una
fascia di reticolati che per gli italiani costituiscono una novità.
Il 18 luglio, Cadorna da il via ad una seconda offensiva,
e stavolta v’insiste per due settimane, senza pause. Per due settimane
le batterie seguitano ad accumulare morti sui reticolati austriaci, in
cui le artiglierie non riescono a far breccia, e le forbici per tagliarli
non sono ancora arrivate. Cadorna decide di sospendere il massacro il
3 agosto.
La battaglia dell’Isonzo, quella decisiva
durata dal 24 ottobre al 9 novembre, è combattuta lontano dal teatro
di lotta preso in considerazione fino ad ora, e si sposta nella conca
di Caporetto. In seguito a trenta mesi di battaglie,
gli italiani, dopo aver attenuto anche delle vittorie, sono stremati.
Cadorna, pensa anch’esso di poter concedersi un po’ di riposo
e spinto dai risultati avuti, dalla chiamata alle armi anticipata dei
ragazzi del 1899, che avrebbero dovuto ricevere un addestramento adeguato,
e dall’arrivo degli americani previsto per la primavera del 1918,
lascia il quartier generale di Udine per recarsi
a Vicenza, dove intende trascorrere due settimane
di ferie. Il nemico però è lontano dal predisporsi al riposo,
e va preparando la più formidabile delle sue offensive. Infatti
gli austriaci chiedono in prestito alla Germania
sette divisioni, una delle quali comandata dal tenente Erwin Rommel,
il futuro maresciallo del reich, che si schierano
sui monti intorno a Caporetto dove si trova
un importante centro delle retrovie del nostro esercito. Il piano d’attacco
prevede di bombardare furiosamente un brevissimo tratto di fronte, per
aprire una breccia e lanciare in essa i loro reparti, che avrebbero dovuto
avanzare senza guardarsi ai fianchi o alle spalle, fino a raggiungere
ed investire le retrovie, dando al nemico l’impressione di essere
accerchiato. Sul resto del fronte, altre truppe avrebbero agganciato i
reparti italiani per impedire ai comandi di accorgersi tempestivamente
della minaccia. In questo modo le truppe austro tedesche, approfittando
della confusione, riescono a sfondare le nostre linee.
 Cadorna,
quando sa dell’attacco non ne intuisce né gli obiettivi né
il pericolo. Comincia a prendere coscienza della realtà solo nella
notte fra il 26 e il 27 ottobre, quando la stessa Udine
era minacciata dalle avanguardie tedesche. Solo il 27, impartisce l’ordine
di ripiegare sul Tagliamento, ma ben pochi reparti
lo ricevono, e il ripiegamento si fa, non per piano, ma per fuga. Il 28
ottobre, il generale decide di arretrare fino alla linea del Piave,
perché viene a sapere che le avanguardie nemiche hanno in qualche
punto oltrepassato il Tagliamento.
Cadorna,
quando sa dell’attacco non ne intuisce né gli obiettivi né
il pericolo. Comincia a prendere coscienza della realtà solo nella
notte fra il 26 e il 27 ottobre, quando la stessa Udine
era minacciata dalle avanguardie tedesche. Solo il 27, impartisce l’ordine
di ripiegare sul Tagliamento, ma ben pochi reparti
lo ricevono, e il ripiegamento si fa, non per piano, ma per fuga. Il 28
ottobre, il generale decide di arretrare fino alla linea del Piave,
perché viene a sapere che le avanguardie nemiche hanno in qualche
punto oltrepassato il Tagliamento.
Gli Italiani, risvegliati dopo Caporetto da un’inattesa volontà
di resistenza, fermano il nemico sul Piave e salvano Verona,
Padova e Venezia.
 A
San Martino del Carso, piccolo paesino del
comune di Sagrado posto sotto il monte San
Michele, si trova il valloncello dell’albero isolato.
Ed è proprio lì, in una delle sue cavernette che combatte
e scrive molte delle sue poesie Giuseppe Ungaretti. Poeta
di grande rilievo nella cultura italiana e mondiale del novecento, vive
nelle trincee, nei camminamenti, negli anfratti del San Michele
in un intenso travaglio dell’anima all’interno di un dramma
umano di proporzioni immani.
A
San Martino del Carso, piccolo paesino del
comune di Sagrado posto sotto il monte San
Michele, si trova il valloncello dell’albero isolato.
Ed è proprio lì, in una delle sue cavernette che combatte
e scrive molte delle sue poesie Giuseppe Ungaretti. Poeta
di grande rilievo nella cultura italiana e mondiale del novecento, vive
nelle trincee, nei camminamenti, negli anfratti del San Michele
in un intenso travaglio dell’anima all’interno di un dramma
umano di proporzioni immani.
Alcune fra le sue più significative liriche, infatti, sono sgorgate,
sofferte e angosciose, all’interno di precise coordinate geografiche
e temporali: i giorni della guerra sull’altipiano nel 1915 1916.
Sul San Michele non incontra solo la Musa della
sua poesia di guerra, ma s’imbatte anche nel suo primo editore,
il trentino Ettore Serra, che stampa in pieno periodo
di guerra la raccolta di poesie di "Il Porto Sepolto",
pubblicato a Udine nel 1916.
"Questi sono i miei fiumi
contati nell'Isonzo
Questa è la mia nostalgia
che in ognuno
mi traspare
ora ch'è notte
che la mia vita mi pare
una corolla
di tenebre"
Il fiume Isonzo è il principale corso d'acqua della zona e da il nome a molti paesi ed all' intera zona, chiamata Isontino, appunto. Benché nasca in Slovenia ed entri in Italia solamente all' altezza di Gorizia, è un fiume che ha rivestito particolare importanza non solo a livello locale, in particolare nel corso dei conflitti mondiali. Dopo un primo tratto montagnoso fino a Gorizia, il fiume si apre in una vasta pianura che si estende a nord sino al Collio ed a sud fino alla Laguna di Grado. Alla sua foce si trovano vaste terre ancora selvagge, oasi naturalistiche quali la Cona e la Val Cavarera, dove molte specie di animali, in particolare migratori, trovano rifugio.
Il componimento si divide in quindici strofe di versi
liberi, senza punteggiatura.
La situazione iniziale trova verbi al presente: è una notte quieta,
anche se la guerra è pur sempre presente, il Poeta si sente un
"albero mutilato", in quell’immensa solitudine, marcatamente
viva e vigile dalla forte presenza di pronomi e aggettivi possessivi in
prima persona!
Nasce il "Flash back" nella poesia, in quella giornata passata
nelle retrovie, in riva all'Isonzo, in armonia con l'universo, e usa verbi
al passato:
"Ho tirato su/le mie quattr'ossa/e me ne sono andato/come un acrobata/ sull'acqua"
Riprende la metafora del circo della prima strofa. In questo
senso sono sempre importantissimi i titoli delle liriche, che ne sono
parte integrante:
"L’albero mutilato…/ in questa dolina…"
sono elementi legati all’identità spesso sotto forma anagogica.
Gli elementi naturali, invece hanno spesso valore simbolico.
"Questi sono i miei fiumi" sono elementi legati alla realtà
della guerra e alla precarietà del soldato, che il Poeta spesso
narra usando metafore.
"L’Isonzo scorrendo/ mi legava/ come un suo sasso".Questo
procedimento permette di mettere in evidenza la polisemia, della parole
"Ho tirato su/ le mie quattr'ossa/ e me ne sono andato/come un acrobata/
sull'acqua"e qui risalta il suo valore simbolico ed anche fonetico.
Su questi aspetti insiste il Poeta stesso quando recita i suoi versi.
Dopo le prime poesie pubblicate su "Lacerba"
nel 1915, con "Il porto sepolto" Ungaretti
imbocca la strada indicata e la seguirà coerentemente fino alla
conclusione dell’esperienza poetica globale dell’"Allegria".
Ne "L’Allegria", che contiene
"Il porto sepolto", sono presenti
tutte le innovazioni portate alla poesia, sia sul piano strutturale e
lessicale, sia su quello sintattico e metrico:
 abolisce
la punteggiatura, conservando solo il punto interrogativo, e la sostituisce
con spazi bianchi, che hanno la funzione di pause espressive;
abolisce
la punteggiatura, conservando solo il punto interrogativo, e la sostituisce
con spazi bianchi, che hanno la funzione di pause espressive;
al linguaggio della tradizione classica sostituisce parole comuni, capite
e usate da tutti e per questo adatte ad esprimere la profondità
del pensiero, perché "scavate" nella vita; in questo
senso si può parlare di linguaggio non poetico a proposito delle
scelte lessicali. "Quando trovo / in questo mio silenzio / una
parola / scavata è nella mia vita / come un abisso";
sconvolge la sintassi tradizionale e separa gruppi di parole legate logicamente
tra di loro, facendo sì che acquistino quasi una vita propria,
catturando magneticamente l’attenzione del lettore; rifiuta le forme
metriche tradizionali, adottando il verso libero, lungo o breve, anche
brevissimo, formato di una sola parola; attinge i suoi temi dalla sua
esperienza di vita e, in particolare, da quella di combattente della Grande
Guerra: le sofferenze patite, il senso di caducità della vita,
l’angoscia della morte che incombe, la solitudine, il dolore, la
fratellanza umana, il desiderio di pace e di serenità, l’aspirazione
a sentirsi in armonia con se stesso e con la natura.
Le sue poesie sembrano nate di getto, invece sono oggetto di un continuo
lavoro di lima e di riduzione, come testimonia il confronto tra le numerose
varianti. Si tratta di poesie intonate alla tragedia che sta vivendo.
"Se la parola fu nuda, se si fermava a ogni cadenza del ritmo,
a ogni battito del cuore, se si isolava momento per momento nella sua
verità, era perché in primo luogo l’uomo si sentiva
uomo, religiosamente uomo, e quella gli sembrava la rivoluzione che necessariamente
dovesse in quelle circostanze storiche muoversi dalle parole. Le condizioni
della poesia nostra e degli altri paesi allora, non reclamavano del resto
altre riforme se non quella fondamentale".
Il poeta, in un intervento del 1963 "Ungaretti commenta
Ungaretti", dice della sua raccolta: "Ci sono
tre momenti nel Sentimento del tempo del mio modo di sentire successivamente
il tempo. Nel primo mi provavo a sentire il tempo nel paesaggio come profondità
storica; nel secondo, una civiltà minacciata di morte mi induceva
a meditare sul destino dell’uomo e a sentire il tempo, l’effimero,
in relazione con l’eterno; l’ultima parte del Sentimento del
tempo ha per titolo L’amore, e in essa mi vado accorgendo dell’invecchiamento
e del perire nella mia carne stessa". Scrive Lui stesso: "La
parabola dell’anno e quella del giorno sono forse eterne figure
dell’armonia universale, mentre l’uomo non è che un
punto fra due infiniti oblii. Il silenzio della tomba è uguale
a quello della prima culla. E’ l’eternità. Ma l’uomo
in vita, non s’affanna che a volere, invano, percorrere da vivo,
cosciente, con la sua intatta persona, la sua patria silenziosa, l’eternità.
Ho voluto dire che l’uomo, creatura, fatto temporale, si porta,
morendo, con sé il mondo, il quale con lui era nato, cresciuto,
con lui era giunto, quando ci arriva, all’apice della salita, e
poi, ai piedi del declivio".
La memoria a me pareva, invece, un’ancora di salvezza: io rileggevo
i poeti, i poeti che cantano. Non cercavo il verso di Dante, o del Petrarca,
o del Tasso, o del Leopardi: cercavo il loro canto. Non era l’endecasillabo,
non il novenario, non il settenario che cercavo: era il canto della lingua
italiana che cercavo con costanza attraverso i secoli, attraverso voci
così numerose e così diverse di timbro e così gelose
della propria novità e così singolari ciascuna nell’esprimere
pensieri e sentimenti…
Nell’esprimere in poesia la sua tragedia privata, il poeta non si
isola, anzi, con il suo canto vuole dare voce alla sofferenza collettiva
dell’umanità, che è tornata ad assistere e a partecipare
all’immane tragedia di un’altra guerra: la Seconda Guerra
Mondiale. E questa volta, il poeta non è più un soldato,
ma un civile, che, rientrato in Italia, vive
la tragica occupazione di Roma da parte dei Tedeschi.
La raccolta "Il Dolore" scandisce
i momenti diversi del dramma del poeta e del suo smarrimento di fronte
alla morte e alla distruzione. "Il Dolore, per certi versi, può
essere definito il libro più petrarchesco, quello che rivela con
maggiore evidenza la sua struttura di diario poetico. Nel linguaggio compaiono
toni biblici ed evangelici, che ripropongono il valore della fede religiosa
e una richiesta di umana solidarietà, cui affidare le sorti di
una civiltà minacciata. I toni biblici ed evangelici rappresentano
la sola novità sostanziale nello stile di Ungaretti rispetto a
"Sentimento del tempo".
Più interessante è "Il Taccuino del Vecchio",
composto tra il 1952 e il 1960, che ospita i ventisette "Ultimi
Cori per la Terra Promessa", una specie di appendice
al poema incompiuto: si tratta di frammenti resi coerenti dai temi e dall’omogeneità
stilistica. Torna l’idea della ricerca della terra promessa, accompagnata
dalla certezza che l’uomo non potrà raggiungere la conoscenza
se non attraverso barlumi intermittenti. I periodi più favorevoli
per avvicinarsi all’intuizione del vero sono l’infanzia e
la vecchiaia, cioè quelle fasi della vita che costituiscono gli
estremi ideali di un ciclo: il bambino possiede l’innocenza, mentre
il vecchio trova la pace nell’esaurirsi dei desideri.
Giuseppe Ungaretti è stato un poeta di grandissimo
valore, lo è stato perché è anche un uomo straordinario,
con un cuore giovane, con un’intelligenza penetrante, d'una grande
onestà intellettuale e morale, perle rare nella società
del nostro tempo, ma soprattutto senza superbia ed in particolare modo
amante dei bambini. Molti ricorderanno come negli ultimi anni della sua
esistenza si sia prestato ad andare nelle scuole, dove lo invitavano,
a leggere le sue poesie. E grande sempre era la sua gioia nel guardare,
mentre "recitava", gli sguardi di quei tredicenni seduti tutti
intorno a lui. La sua recitazione era qualcosa di inenarrabile. La voce
profonda e un poco rauca, il pronunciare le parole apparentemente con
fatica, come se dovessero essere prese da una profondità abissale,
articolandole con lentezza, le inattese pause e l'espressione del sul
volto dominato dagli occhi incavati, da un grande naso e da un'altrettanto
grande bocca, davano un brivido all'ascoltatore trascinandolo immediatamente
in una dimensione sovrumana.
 Ebbene
questo grandissimo uomo e poeta si è spento, come lui aveva anticipato:
Ebbene
questo grandissimo uomo e poeta si è spento, come lui aveva anticipato:
"Morire come le allodole assetate sul miraggio
Ma ben sola e ben nuda senza miraggio porto la mia anima
II carnato del ciclo sveglia oasi al nomade d'amore..".
Nella notte tra il 31 dicembre 1969 e il primo gennaio 1970 scrive l'ultima poesia L'impietrito e il velluto. Torna negli Stati Uniti per ricevere un premio all'Università di Oklahoma. A New York s'ammala è ricoverato in clinica. Rientra in Italia e per curarsi si stabilisce a Salsomaggiore. Muore d'improvviso a Milano la notte tra l'1 e il 2 giugno 1970. Non ha avuto funerali di Stato, come in vita non era stato nominato senatore per meriti letterari, né gli erano state conferite particolari onorificenze. L'Italia della cultura ufficiale non lo aveva infatti amato, anzi lo aveva ostacolato. Non è riuscita tuttavia ad emarginarlo, ed egli era rimasto in piedi.
 La
Valle ha una storia antica. Ritrovamenti e scavi hanno permesso di attestare
presenze umane sin dal Paleolitico quaranta
o cinquantamila anni fa. I primi insediamenti risalgono all'Età
del Bronzo. Di sicuro vi arrivarono avamposti Etruschi,
poi furono i Liguri - Apuani a popolarla
intorno al Trecento avanti Cristo. Terra di passaggio e di congiunzione
con il nord padano, concluso il ciclo romano, fu per secoli sottoposta
a divisioni politiche ed amministrative che ancora si fanno sentire. La
stessa difficoltà ad usare una denominazione comprensiva. E così
si usano termini diversi a seconda dei punti di vista e dei retaggi culturali:
Garfagnana o Alta Valle del Serchio,
Media Valle del Serchio o Bassa Garfagnana.
Tutti ugualmente validi, ma tutti ugualmente inadatti a dare rappresentazione
alla organica unitarietà del territorio.
La
Valle ha una storia antica. Ritrovamenti e scavi hanno permesso di attestare
presenze umane sin dal Paleolitico quaranta
o cinquantamila anni fa. I primi insediamenti risalgono all'Età
del Bronzo. Di sicuro vi arrivarono avamposti Etruschi,
poi furono i Liguri - Apuani a popolarla
intorno al Trecento avanti Cristo. Terra di passaggio e di congiunzione
con il nord padano, concluso il ciclo romano, fu per secoli sottoposta
a divisioni politiche ed amministrative che ancora si fanno sentire. La
stessa difficoltà ad usare una denominazione comprensiva. E così
si usano termini diversi a seconda dei punti di vista e dei retaggi culturali:
Garfagnana o Alta Valle del Serchio,
Media Valle del Serchio o Bassa Garfagnana.
Tutti ugualmente validi, ma tutti ugualmente inadatti a dare rappresentazione
alla organica unitarietà del territorio.
 Rocche,
fortezze e castelli che segnano il suo territorio ricordano quando Lucchesi,
Fiorentini ed Estensi hanno trasformato
la Valle del Serchio in un crocevia "internazionale": Barga
è proprietà della signoria medicea, gli Estensi
hanno Castelnuovo e gran parte della Garfagnana,
dove Lucca dispone di Castiglione,
di Gallicano, di Minucciano
e delle "Tre Terre". Con tutte le
conseguenze che una simile condizione comporta. Antiche consuetudini,
come il mercato al giovedì a Castelnuovo, momento d'incontro della
gente della Valle, ed esperienze entrate in voga di recente, soprattutto
come manifestazioni del vivere giovanile, si integrano senza laceranti
traumi. Piazze e strade, caffè, cinema e teatro sono ancora luoghi
di socialità. Il ritmo della vita cammina assai più spedito
di un tempo, ma sa trovare pause che consentono di apprezzare il valore
eterno dei sentimenti, il sapore vero delle cose: l'amicizia, la solidarietà,
l'accoglienza.
Rocche,
fortezze e castelli che segnano il suo territorio ricordano quando Lucchesi,
Fiorentini ed Estensi hanno trasformato
la Valle del Serchio in un crocevia "internazionale": Barga
è proprietà della signoria medicea, gli Estensi
hanno Castelnuovo e gran parte della Garfagnana,
dove Lucca dispone di Castiglione,
di Gallicano, di Minucciano
e delle "Tre Terre". Con tutte le
conseguenze che una simile condizione comporta. Antiche consuetudini,
come il mercato al giovedì a Castelnuovo, momento d'incontro della
gente della Valle, ed esperienze entrate in voga di recente, soprattutto
come manifestazioni del vivere giovanile, si integrano senza laceranti
traumi. Piazze e strade, caffè, cinema e teatro sono ancora luoghi
di socialità. Il ritmo della vita cammina assai più spedito
di un tempo, ma sa trovare pause che consentono di apprezzare il valore
eterno dei sentimenti, il sapore vero delle cose: l'amicizia, la solidarietà,
l'accoglienza.
Il Nilo dall’arabo Bahr el-Nil,
è il fiume dell'Africa nordorientale,
il più lungo del mondo. Scorre in direzione nord dal lago
Vittoria fino al Mediterraneo dopo un percorso di 5584 km
attraverso l'Uganda, il Sudan
e l'Egitto. Se si comprende il fiume Kagera,
che è il suo principale ramo sorgentifero, la lunghezza complessiva
del fiume raggiunge i 6671 km.
Nell'ampio delta del Nilo, noto per le sue terre
fertili che hanno dato vita a una delle più grandi civiltà
della storia, le acque del fiume si dividono nei due rami del Nilo
Rosetta e del Nilo Damietta, oltre
che in parecchi canali navigabili. La prima diga di Assuan
fu costruita nel 1902.
La Senna mi sono fermato per riposare qualche
minuto sull'altopiano di Langres, dove nasce la Senna. Il fiume scorre
verso nord ovest, attraversa vari altipiani, poi passa la pianura della
Champagne, riceve vari affluenti e dopo 776
km si getta nell'Oceano Atlantico. Guardo estasiato
la sua meravigliosa sorgente, che nel cammino s’ingrandisce e diventerà
la Senna. Quando raggiungo la champagne mi vedo circondato da infiniti
vigneti che coprono le colline che sembrano "seni di donna"
al sole, dalle cui uve si ricava uno dei vini più pregiati e famosi:
lo champagne. Dopo chilometri, che sembrano infiniti, il fiume diventa
navigabile, salgo su una barca e arrivo a Parigi! È la città
di ritrovo di molti artisti, anche Ungaretti, ne "I
miei fiumi" la ricorda.
Quello che colpisce nella lirica ungarettiana è, prima di tutto,
la profonda umanità che da essa sprigiona: «Poesia /
è il mondo l'umanità / la propria vita / fioriti dalla parola»;
non c'è possibilità di accordo tra l'universale e la voce
singolare del poeta, se questi non si perfeziona come uomo e se non si
rende partecipe della vita del suo tempo. Questa è la tematica
di Ungaretti uomo, perciò affermo che anche come
poeta egli ha saputo trovare una sua voce originale e innovatrice, «costruendosi
— osserva il Petronio — un lavoro paziente di eliminazione
e di condensazione, un modulo nel quale il "frammento" raggiungeva
un massimo estremo di essenzialità attraverso una poetica da lui
stesso definita della "parola"».
Mi tengo a quest'albero
mutilato
abbandonato in questa dolina
che ha il languore
di un circo
prima o dopo lo spettacolo
e guardo
il passaggio quieto
delle nuvole sulla luna
Stamani mi sono disteso
in un'urna d'acqua
e come una reliquia
ho riposato
L'Isonzo scorrendo
mi levigava
come un suo sasso
Ho tirato su
le mie quattr'ossa
e me ne sono andato
come un acrobata
sull'acqua
Mi sono accoccolato
vicino ai miei panni
sudici di guerra
e come un beduino
mi sono chinato a ricevere
il sole
Questo è l'Isonzo
e qui meglio
mi sono riconosciuto
una docile fibra
dell'universo
Il mio supplizio
è quando
non mi credo
in armonia
Ma quelle occulte
mani
che m'intridono
mi regalano
la rara
felicità
Ho ripassato
le epoche
della mia vita
Questi sono
i miei fiumi
Questo è il Serchio
al quale hanno attinto
duemil'anni forse
di gente mia campagnola
e mio padre e mia madre
Questo è il Nilo
che mi ha visto
nascere e crescere
e ardere dell'inconsapevolezza
nelle estese pianure
Questa è la Senna
e in quel torbido
mi sono rimescolato
e mi sono conosciuto
Questi sono i miei fiumi
contati nell'Isonzo
Questa è la mia nostalgia
che in ognuno
mi traspare
ora ch'è notte
che la mia vita mi pare
una corolla
di tenebre
[Cotici, il 16 agosto 1916]
M. Petrucciani, La poetica dell'ermetismo italiano, Torino,
1955;
O. Macrì, Caratteri e figure della poesia italiana contemporanea,
Firenze, 1956;
G. Cavalli, Ungaretti, Milano, 1958;
G. Barberi Squarotti, Astrazione e realtà, Milano, 1960;
L. Rebay, Le origini della poesia di G. Ungaretti, Roma, 1962;
F. Portinari, Ungaretti, Torino, 1967;
L. Piccioni, Vita di un poeta, Giuseppe Ungaretti, Milano, 1970;
G. Cambon, La poesia di Ungaretti, Torino, 1976;
M. Forti, Ungaretti girovago e classico, Milano, 1991.
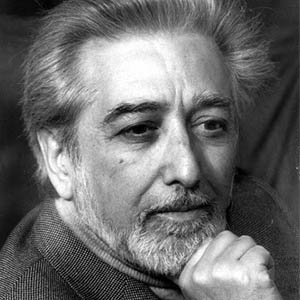
Reno Bromuro è nato a Paduli, in Campania, nel 1937. E' stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale. Nel 1957, a Napoli, ha fondato il Centro Sperimentale per un Teatro neorealista. Ha fondato nel 1973 (di fatto) l'A.I.A. Associazione Internazionale Artisti "Poesie della Vita", e, come critico letterario, ha recensito molti poeti italiani e stranieri. Si è spento nel 2009, qualche anno dopo averci dato l'opportunità di collaborare con lui. Noi di Letteratour lo ricordiamo con affetto qui.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG