
"Una volta, mentre il treno passava vicino ad Aci-Trezza, voi, affacciandovi allo sportello del vagone, esclamaste: Vorrei starci un mese laggiù!".
di Reno Bromuro
Nella categoria: HOME | TOURismi letterari
• Biografia
• L'opera "Vita nei campi": fantasticheria
• "Fantasticheria": incipit
• Le radici del Verismo
• La poetica
• La concezione della vita
• L'ambientazione: Aci-Trezza
 Giovanni
Carmelo Verga nacque a Catania, il
2 settembre 1840 al numero 8 di via Sant'Anna secondo di sei figli di
Giovan Battista Verga Catalano e Caterina Di
Mauro Barbagallo originaria di Belpasso,
un paesino a circa 15 Km ad ovest di Catania, ed era discendente del ramo
cadetto dei baroni di Fontanabianca, appartenente alla
nobiltà antica di Vizzini, un grosso borgo che
si trova a metà strada sulla via che porta da Catania a Ragusa,
e che ha cercato di rivendicare i natali dello scrittore, perché
un documento dell'8 settembre 1840 dell'archivio arcivescovile di Catania
attesta che la nascita di Verga era stata rivelata in quello stesso giorno
insieme al battesimo avvenuto nella chiesa dei Santi Apostoli,
alla presenza dei due padrini, gli zii don Giuseppe e
donna Domenica Verga.
Giovanni
Carmelo Verga nacque a Catania, il
2 settembre 1840 al numero 8 di via Sant'Anna secondo di sei figli di
Giovan Battista Verga Catalano e Caterina Di
Mauro Barbagallo originaria di Belpasso,
un paesino a circa 15 Km ad ovest di Catania, ed era discendente del ramo
cadetto dei baroni di Fontanabianca, appartenente alla
nobiltà antica di Vizzini, un grosso borgo che
si trova a metà strada sulla via che porta da Catania a Ragusa,
e che ha cercato di rivendicare i natali dello scrittore, perché
un documento dell'8 settembre 1840 dell'archivio arcivescovile di Catania
attesta che la nascita di Verga era stata rivelata in quello stesso giorno
insieme al battesimo avvenuto nella chiesa dei Santi Apostoli,
alla presenza dei due padrini, gli zii don Giuseppe e
donna Domenica Verga.
Se l'ambiente familiare era colto e sensibile, oltre che agiato, quello
cittadino era molto provinciale. Alcuni tratti di questo provincialismo
culturale avrebbero avuto nella formazione del giovane Verga un'importanza
almeno pari a quella della buona situazione familiare. Il livello degli
insegnamenti impartiti comunemente nella città era assai basso,
e non faceva eccezione la scuola di Antonino Abate, dove
Verga rimase una decina di anni, da quando sapeva appena leggere, scrivere
e far di conto, a quando si iscrisse all'università.
Da un maestro del genere, autore di poemi e romanzi di ispirazione patriottica
e di ritardati sentimenti romantici, il futuro scrittore acquisisce un
senso altissimo della missione morale e civile del letterato e una sovrana
disinvoltura nei confronti delle istituzioni linguistiche e culturali.
Aveva solo sedici quando sottopose al suo Maestro il primo romanzo, un
voluminoso manoscritto di 672 pagine, datato 23 dicembre 1856-26 agosto
1857 e significativamente intitolato Amore e patria,
ricevendo un parere assai incoraggiante.
La vocazione letteraria di Verga fu sicuramente precoce. Tra i sedici
e i ventitré anni, scrive tre romanzi e ne pubblica due. Questi
avvenimenti gli fanno maturare la decisione irrevocabile di fare lo scrittore,
e perché questo suo desiderio si realizzasse interrompe gli studi
di giurisprudenza alla vigilia della laurea, riuscendo a persuadere anche
il padre.
 La
decisione di Verga non comporta alcuna drammatica lacerazione, pur essendo
la sua vena ancora romantica nella sua assolutezza di vocazione e nel
suo velleitarismo; persino sul piano dello orientamento letterario di
quale scrittore insomma lui volesse essere si riferisce con una certa
sicurezza e altrettanta ingenuità a un'immagine di onesto artigianato
da scrittore d'appendice.
La
decisione di Verga non comporta alcuna drammatica lacerazione, pur essendo
la sua vena ancora romantica nella sua assolutezza di vocazione e nel
suo velleitarismo; persino sul piano dello orientamento letterario di
quale scrittore insomma lui volesse essere si riferisce con una certa
sicurezza e altrettanta ingenuità a un'immagine di onesto artigianato
da scrittore d'appendice.
I tre romanzi giovanili, al contrario della vocazione, possono essere
considerati tutt'altro che precoci proprio perché sono completamente
estranei a qualsiasi pretesa d'arte e non solo agli sviluppi della maggiore
narrativa verghiana. Essi pagano un pesante tributo ai pessimi modelli
raccomandati nella sua scuola dall'Abate e felicemente acclimatati nella
estrema provincia siciliana: non tanto le composizioni in prosa e in versi
dell'Abate medesimo e dell'altra improbabile gloria locale di Domenico
Castorina, quanto i romanzoni a forti tinte.
 L'evidente
schematicità di tali straordinarie passioni e avventure, che ricorrono
con minime variazioni di romanzo in romanzo e di autore in autore, ha
infallibilmente la meglio anche sul più prestigioso concorrente
modello manzoniano dal punto di vista di chi cerca poi i propri schemi
belli e pronti da riprodurre.
L'evidente
schematicità di tali straordinarie passioni e avventure, che ricorrono
con minime variazioni di romanzo in romanzo e di autore in autore, ha
infallibilmente la meglio anche sul più prestigioso concorrente
modello manzoniano dal punto di vista di chi cerca poi i propri schemi
belli e pronti da riprodurre.
Raggiunta l'agiatezza economica e la tranquillità sentimentale,
dopo alcune relazioni anche adulterine, nel 1894 si ritira a Catania
e pubblica ancora una raccolta di novelle, "Don Candeloro";
nel 1903 esce il dramma "Dal tuo al mio",
nel 1911 inizia il terzo romanzo del ciclo, "La duchessa
di Leyra", che rimane fermo al primo capitolo. Nominato
senatore nel 1920, muore nel 1922.
L'OPERA "VITA NEI CAMPI" : FANTASTICHERIA
Il racconto presenta l'esaltazione dei valori
patriarcali divisibili in quattro blocchi. I primi due contengono la risposta
dell'autore alla domanda postagli dall'amica aristocratica. Il terzo è
un'anticipazione dei personaggi che in seguito saranno presenti nei Malavoglia.
L'ultimo è l'enunciazione dell'ideale dell'ostrica vale a dire
l'eroico attaccamento dei miseri alla propria condizione e la celebrazione
della rassegnazione coraggiosa al proprio destino. Al mondo aristocratico
e raffinato della giovane dama, di cui l'autore era stato affascinato
all'inizio della sua stagione creativa, Verga contrappone il mondo degli
umili e degli oppressi, con la loro vita semplice e povera ma più
autentica perché fondata sulla rassegnazione eroica al proprio
destino. Vita fatta di valori semplici, di sentimenti e di dolori autentici
e non d'atteggiamenti convenzionali e falsi come la società aristocratica.
Al mondo della città. caotico e turbinoso, in continua trasformazione,
egli contrappone la società arcaica siciliana fatta di ritmi sempre
uguali, di miseria e lavoro, di gerarchie immutabili, d'egoismi individuali,
di violenza della natura, ma per questo più vera perché
capace che accettare fino in fondo la durezza della lotta per la vita.
Alle "irrequietudini del pensiero vagabondo" lo scrittore contrappone
"i sentimenti miti, semplici che si succedono calmi, inalterati di
generazione in generazione". Ma come esprimere questo mondo attraverso
il canone dell'impersonalità secondo l'ottica verista? Nella novella
Giovanni Verga lo spiega bene "Bisogna farsi piccini, chiudere tutto
l'orizzonte fra due zolle e guardare col microscopio le piccole cause
che fanno battere i piccoli cuori". In questo modo, adottando il
punto di vista di chi vive quella realtà, la lontananza che separa
il mondo borghese da quello dei poveri, è superata con la fantasticheria.
 "Una
volta, mentre il treno passava vicino ad Aci- Trezza, voi, affacciandovi
allo sportello del vagone, esclamaste: "Vorrei starci un mese laggiù!".
"Una
volta, mentre il treno passava vicino ad Aci- Trezza, voi, affacciandovi
allo sportello del vagone, esclamaste: "Vorrei starci un mese laggiù!".
Noi vi ritornammo e vi passammo non un mese, ma quarantott'ore; i terrazzani
che spalancavano gli occhi vedendo i vostri grossi bauli avranno creduto
che ci sareste rimasta un par d'anni. La mattina del terzo giorno, stanca
di vedere eternamente del verde e dell'azzurro, e di contare i carri che
passavano per via, eravate alla stazione e, gingillandovi impaziente colla
catenella della vostra boccettina da odore, allungavate il collo per scorgere
un convoglio che non spuntava mai. In quelle quarantott'ore facemmo tutto
ciò che si può fare ad Aci-Trezza: passeggiammo nella polvere
della strada e ci arrampicammo sugli scogli; col pretesto di imparare
a remare vi faceste sotto il guanto delle bollicine che rubavano i baci;
passammo sul mare una notte romanticissima, gettando le reti tanto per
far qualche cosa che a' barcaiuoli potesse parer meritevole di buscarsi
dei reumatismi; e l'alba ci sorprese in cima al faraglione - un'alba modesta
e pallida, che ho ancora dinanzi agli occhi, striata da larghi riflessi
violetti, sul mare di un verde cupo, raccolta come una carezza su quel
gruppetto di casuccie che dormivano quasi raggomitolate sulla riva, mentre
in cima allo scoglio, sul cielo trasparente e profondo, si stampava netta
la vostra figurina, colle linee sapienti che vi metteva la vostra sarta,
e il profilo fine ed elegante che ci mettevate voi. - Avevate un vestitino
grigio che sembrava fatto apposto per intonare coi colori dell'alba. -
Un bel quadretto davvero! E si indovinava che lo sapeste anche voi dal
modo in cui voi modellaste nel vostro scialletto, e sorrideste coi grandi
occhioni sbarrati e stanchi a quello strano spettacolo, e quell'altra
stranezza di trovarvici anche voi presente. Che cosa avveniva nella vostra
testolina allora, di faccia al sole nascente? Diceste soltanto ingenuamente:
"Non capisco come si possa viver qui tutta la vita".
(…) "Vi siete mai trovata, dopo una pioggia di autunno, a sbaragliare
un esercito di formiche, tracciando sbadatamente il nome del vostro ultimo
ballerino sulla sabbia del viale? Qualcuna di quelle povere bestioline
sarà rimasta attaccata alla ghiera del vostro ombrellino, torcendosi
di spasimo; ma tutte le altre, dopo cinque minuti di pànico e di
viavai, saranno tornate ad aggrapparsi disperatamente al loro monticello
bruno. - Voi non ci tornereste davvero, e nemmen io; - ma per poter comprendere
siffatta caparbietà, che è per certi aspetti eroica, bisogna
farci piccini anche noi, chiudere tutto l'orizzonte fra due zolle, e guardare
col microscopio le piccole cause che fanno battere i piccoli cuori. Volete
metterci un occhio anche voi, a cotesta lente? voi che guardate la vita
dall'altro lato del cannocchiale? Lo spettacolo vi parrà strano,
e perciò forse vi divertirà".
Il Verismo
nasce in Italia nella seconda metà dell'Ottocento come conseguenza
degli influssi del Positivismo che suscitò
negli intellettuali fiducia nel progresso scientifico. L'influenza del
Positivismo si manifestò in vari settori, fra i quali la letteratura.
Esso è un movimento filosofico che nasce in Francia
e si diffonde grazie al francese Comte e all'inglese
Darwin.
La collezione completa di novelle di Giovanni Verga, tra le quali la raccolta
pubblicata nel 1880 con il titolo "Vita dei campi",
da cui abbiamo tratto "Fantasticheria",
narra, come accennato, del mondo elementare degli umili che si sostituisce
a quello artefatto della società oziosa e romantica dei suoi primi
romanzi e lo stile diventa agile e scarno. Pur mutando tono e personaggi
la passione rimane il movente principale dell'azione: l'ardore dei sensi,
la gelosia e la vendetta sono le forze oscure che determinano il tragico
destino dei personaggi. Vale la pena spendere due parole anche a proposito
della raccolta, pubblicata nel 1883, con il titolo di "Novelle
Rusticane". Può considerarsi un'anticipazione
di "Mastro don Gesualdo", di cui condivide
il motivo dominate: l'attaccamento alla roba. Dal pathos violento delle
novelle della "Vita dei campi" si
passa a un umorismo doloroso in cui l'impeto delle passioni è irriso
dall'inflessibile durezza del destino.
 Verga,
a differenza di altri scrittori, non espone le proprie idee sulla letteratura
e sull'arte in opere compiute; preferisce immergersi nel suo scrupoloso
e concreto lavoro di scrittore. Il canone fondamentale cui si ispira è
quello dell'impersonalità, che egli intende come "schietta
ed evidente manifestazione di osservazione coscienziosa". Verga
indaga nel misterioso processo dei sentimenti umani presentando il fatto
nudo e schietto come è stato "raccolto per viottoli dei
campi, pressappoco con le medesime parole semplici e pittoresche della
narrazione popolare", sacrificando "l'effetto della
catastrofe, allo sviluppo logico, necessario delle passioni e dei fatti
verso la catastrofe resa meno imprevedibile ma non meno fatale";
l'obiettivo è quello di giungere ad una storia in cui l'affinità
di ogni sua parte sarà completa, in cui il processo della creazione
rimarrà un mistero, la mano dell'artista rimarrà invisibile
e "l'opera d'arte sembrerà essersi fatta da sé".
Verga rappresenta la lotta per la vita ripercorrendo la scala sociale,
dai livelli più bassi a quelli più elevati e questo sia
per la sua esigenza personale di ri-meditare la propria esperienza umana
e artistica e anche per estendere l'indagine che si era in genere limitata
ai ceti popolari, alle classi più alte.
Verga,
a differenza di altri scrittori, non espone le proprie idee sulla letteratura
e sull'arte in opere compiute; preferisce immergersi nel suo scrupoloso
e concreto lavoro di scrittore. Il canone fondamentale cui si ispira è
quello dell'impersonalità, che egli intende come "schietta
ed evidente manifestazione di osservazione coscienziosa". Verga
indaga nel misterioso processo dei sentimenti umani presentando il fatto
nudo e schietto come è stato "raccolto per viottoli dei
campi, pressappoco con le medesime parole semplici e pittoresche della
narrazione popolare", sacrificando "l'effetto della
catastrofe, allo sviluppo logico, necessario delle passioni e dei fatti
verso la catastrofe resa meno imprevedibile ma non meno fatale";
l'obiettivo è quello di giungere ad una storia in cui l'affinità
di ogni sua parte sarà completa, in cui il processo della creazione
rimarrà un mistero, la mano dell'artista rimarrà invisibile
e "l'opera d'arte sembrerà essersi fatta da sé".
Verga rappresenta la lotta per la vita ripercorrendo la scala sociale,
dai livelli più bassi a quelli più elevati e questo sia
per la sua esigenza personale di ri-meditare la propria esperienza umana
e artistica e anche per estendere l'indagine che si era in genere limitata
ai ceti popolari, alle classi più alte.
Le tecniche narrative riguardano il rapporto tra autore e materia rappresentata,
le tecniche espressive, la sintassi e il lessico. La novità di
Verga sta nella distinzione tra autore
e narratore e nella definizione e invenzione del narratore regredito.
L'autore per essere impersonale deve rinunciare ai suoi pensieri e giudizi,
alla sua morale e cultura perché non deve esprimere se stesso ma
si deve nascondere impedendo così al lettore di percepire la sua
presenza. Verga cerca di realizzare l'eclissi dell'autore delegando la
funzione narrante a un narratore che è perfettamente inserito nell'ambiente
rappresentato, regredito al livello sociale e culturale dei personaggi
rappresentati che assume la loro mentalità e non fa trapelare l'idea
dell'autore.
 Giovanni
Verga ha una concezione dolorosa e tragica della vita. Pensa che tutti
gli uomini siano sottoposti a un destino impietoso e crudele che li condanna
non solo all'infelicità e al dolore,ma ad una condizione d'immobilismo
nell'ambiente familiare, sociale ed economico in cui sono venuti a trovarsi
nascendo. Chi cerca di uscire dalla condizione in cui il destino lo ha
posto, non trova la felicità sognata, ma va incontro a sofferenze
maggiori, come succede a 'Ntoni Malavoglia e a Mastro
Don Gesualdo. Con questa visione un po' pietrificata della società
rinnova il mito del fato, ma senza accompagnarlo con il sentimento della
ribellione perché non crede nella possibilità di un qualsiasi
cambiamento o riscatto. Per Verga non rimane che la rassegnazione eroica
e dignitosa al proprio destino. Questa concezione fatalistica e immobile
dell'uomo sembra contraddire la fede nel progresso propria delle dottrine
positivistiche ed evoluzionistiche. In verità, non nega il progresso,
ma lo riduce alle sole forme esteriori ed appariscenti;
Giovanni
Verga ha una concezione dolorosa e tragica della vita. Pensa che tutti
gli uomini siano sottoposti a un destino impietoso e crudele che li condanna
non solo all'infelicità e al dolore,ma ad una condizione d'immobilismo
nell'ambiente familiare, sociale ed economico in cui sono venuti a trovarsi
nascendo. Chi cerca di uscire dalla condizione in cui il destino lo ha
posto, non trova la felicità sognata, ma va incontro a sofferenze
maggiori, come succede a 'Ntoni Malavoglia e a Mastro
Don Gesualdo. Con questa visione un po' pietrificata della società
rinnova il mito del fato, ma senza accompagnarlo con il sentimento della
ribellione perché non crede nella possibilità di un qualsiasi
cambiamento o riscatto. Per Verga non rimane che la rassegnazione eroica
e dignitosa al proprio destino. Questa concezione fatalistica e immobile
dell'uomo sembra contraddire la fede nel progresso propria delle dottrine
positivistiche ed evoluzionistiche. In verità, non nega il progresso,
ma lo riduce alle sole forme esteriori ed appariscenti; in ogni caso, è un progresso che comporta pene infinite. La visione
del mondo sarebbe la più squallida e desolata di tutta la letteratura
italiana se non fosse confortata da tre elementi positivi. Il primo è
quel sentimento della grandezza e dell'eroismo che porta lo scrittore
ad assumere verso i vinti un atteggiamento misto di pietà e di
ammirazione: pietà per le miseria e le sventure che li travagliano,
ammirazione per la loro rassegnazione. Secondo elemento positivo è
la fede in alcuni valori che sfuggono alla dure leggi del destino e della
società: la religione, la famiglia, la casa, la dedizione al lavoro,
lo spirito del sacrificio e l'amore nutrito di sentimenti profondi ma
fatto di silenzi, sguardi furtivi e di pudore. Il terzo elemento è
la saggezza che ci viene dalla coscienza dei nostri limiti e ci porta
a sopportare le delusioni.
in ogni caso, è un progresso che comporta pene infinite. La visione
del mondo sarebbe la più squallida e desolata di tutta la letteratura
italiana se non fosse confortata da tre elementi positivi. Il primo è
quel sentimento della grandezza e dell'eroismo che porta lo scrittore
ad assumere verso i vinti un atteggiamento misto di pietà e di
ammirazione: pietà per le miseria e le sventure che li travagliano,
ammirazione per la loro rassegnazione. Secondo elemento positivo è
la fede in alcuni valori che sfuggono alla dure leggi del destino e della
società: la religione, la famiglia, la casa, la dedizione al lavoro,
lo spirito del sacrificio e l'amore nutrito di sentimenti profondi ma
fatto di silenzi, sguardi furtivi e di pudore. Il terzo elemento è
la saggezza che ci viene dalla coscienza dei nostri limiti e ci porta
a sopportare le delusioni.
 La
fondazione di Acitrezza si deve al Principe
di Campofiorito Don Stefano della Casa Reggio.
Mandato da Don Francesco Fernandez de Cueva, Duca
di Alburquerque e Vicerè di Sicilia per organizzare
i soccorsi e prestare aiuto alla città di Catania
minacciata, nel 1669, dall'eruzione dell'Etna.
La
fondazione di Acitrezza si deve al Principe
di Campofiorito Don Stefano della Casa Reggio.
Mandato da Don Francesco Fernandez de Cueva, Duca
di Alburquerque e Vicerè di Sicilia per organizzare
i soccorsi e prestare aiuto alla città di Catania
minacciata, nel 1669, dall'eruzione dell'Etna.
Durante la sua permanenza s'innamora della splendida contrada che si estende
dai mitici scogli dei ciclopi fino al bosco
di Aci. Nel gennaio del 1672 compra un feudo
della Reale Corte, dal Marchese Don Nicolò
Diana di Cefalà, per trentaseimilacinquecento scudi, la
città di Aci SS. Antonio e Filippo, e cosciente
di quale vantaggio potesse apportare allo sviluppo di un paese uno sbocco
al mare, pretende il territorio di fronte agli scogli dei
Ciclopi precisamente quella spiaggia dove oggi sorge Acitrezza. Il Principe si da subito da fare affinché su questo incantevole
luogo nasca un vero e proprio paese. Fa ripulire la spiaggia,fa costruire
uno scalo per le barche e un porticciolo proprio di fronte agli scogli
dei Ciclopi: l'Isola Lachea, la
Longa, il Faraglione grande,
quello di mezzo, il Faraglione piccolo
e, fra gli ultimi due, gli scogli du Zu Ianu,
chiamati Zu Ianu di terra e Zu Ianu
di fora, detti così a seconda di dove si metteva
a pescare, con la sua barchetta, un certo Sebastiano Greco,
agli inizi del secolo scorso.
Il Principe si da subito da fare affinché su questo incantevole
luogo nasca un vero e proprio paese. Fa ripulire la spiaggia,fa costruire
uno scalo per le barche e un porticciolo proprio di fronte agli scogli
dei Ciclopi: l'Isola Lachea, la
Longa, il Faraglione grande,
quello di mezzo, il Faraglione piccolo
e, fra gli ultimi due, gli scogli du Zu Ianu,
chiamati Zu Ianu di terra e Zu Ianu
di fora, detti così a seconda di dove si metteva
a pescare, con la sua barchetta, un certo Sebastiano Greco,
agli inizi del secolo scorso.
In seguito il Principe pensando di trasformare il porticciolo in un luogo
più sicuro tenta di fare chiudere quel tratto di mare tra l'Isola
Lachea e la Longa. Sono usate
pietre, prese dalla stessa isola, e gettate senza una vera sistemazione,
sopra strati di sarmento. Ma ciò non serve a nulla, perché
alla prima mareggiata, durante l'inverno, tutto va distrutto. Intanto
gli abitanti del nascente villaggio sono ancora pochi ed il Principe,
per popolarlo escogita di dare asilo politico a tutti coloro che hanno
problemi con la giustizia, cioè ai ricercati dalla polizia spagnola,
i quali qui possono trovare scampo perché sotto la sua protezione.
Aumentata la popolazione, si sviluppa non solo l'attività peschereccia,
ma anche il traffico di piccole imbarcazioni a vela lungo le coste per
il commercio di oggetti vari e prodotti alimentari. Il principe è
veramente innamorato della Trezza a testimoniarlo
fu il fatto che conservò per lungo tempo, tra i suoi titoli quello
di Signore di Acitrezza.
Quanto riguarda l'origine del nome, le ipotesi
sono diverse:
1) Tri pizzi, le tre punte o pizzi cioè
i vertici dei tre scogli maggiori.
2) acis lateritiae, fabbrica di mattoni di Aci,
attività esercitata nella zona sino a qualche decennio addietro.
3) Latruzza, donna molto scaltra, proprietaria
della posada esistente ad Acitrezza ancor prima
della fondazione, la quale la notte dava ospitalità ai viandanti
e, mentre questi dormivano, li derubava.
4) Trizera di Aci, scorciatoia a fondo naturale
per recarsi in minor tempo ad Acireale dai paesi
vicini.
5) La Trezza, dalla tessitura delle reti da
pesca, fatta dai pescatori del luogo.
6) La Treccia,modo di sistemazione degli scogli
ciclopici, che formano una treccia.
Oggi la storia di Acitrezza, non si legge
solo per l'amore di Verga, anche questa cittadina sistemata tra due scogli
si è aggiornata, è stata restaurata anche la casa
dei Malavoglia, situata esattamente nella scalinata di via
Centrale, ed è stata aperta la casa del
nespolo, gestita dall'associazione "Fantasticheria".
 Nell'arco
di un anno sono infinite le manifestazioni sia religiose sia culturali:
mostre fotografiche, di pittura, di alto rilievi, culinarie e così
via. Di particolare colore pittoresco è la degustazione di prodotti
tipici del luogo, intitolata "Una sera a casa dei Malavoglia".
Nella casa del nespolo si possono trovare vecchi arnesi, utilizzati dai
pescatori, per le diverse tipologie di pesca, nonché alcune foto
tratte dal film "La terra trema" di
Luchino Visconti girato nel 1948 ad Acitrezza con attori
gli abitanti del luogo.
Nell'arco
di un anno sono infinite le manifestazioni sia religiose sia culturali:
mostre fotografiche, di pittura, di alto rilievi, culinarie e così
via. Di particolare colore pittoresco è la degustazione di prodotti
tipici del luogo, intitolata "Una sera a casa dei Malavoglia".
Nella casa del nespolo si possono trovare vecchi arnesi, utilizzati dai
pescatori, per le diverse tipologie di pesca, nonché alcune foto
tratte dal film "La terra trema" di
Luchino Visconti girato nel 1948 ad Acitrezza con attori
gli abitanti del luogo.
Affollatissima di giovani, Acitrezza, di notte si trasforma in una grande
giostra di colori, luci, musica e tanto, tanto cibo prelibato. Si trovano
locali per tutti i gusti: paninerie, birrerie, bar, ristoranti, trattorie,
disco pub, gelaterie, pizzerie e tanto, tantissimo altro. Poco fuori Acitrezza
si trova un famosa discoteca estiva affollatissima ogni notte. Il mercato
del pesce è l'ultimo spettacolo prima di andare a letto. Ma chi
vuole può attendere ancora un po' e vedere sorgere il sole da dietro
i mitici Faraglioni: uno spettacolo unico al
mondo. E' possibile che tutto questo accada ad Acitrezza? No, accade molto
più...
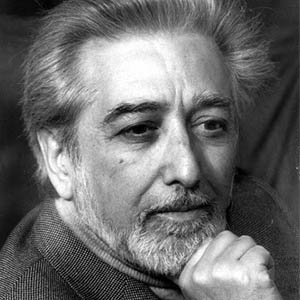
Reno Bromuro è nato a Paduli, in Campania, nel 1937. E' stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale. Nel 1957, a Napoli, ha fondato il Centro Sperimentale per un Teatro neorealista. Ha fondato nel 1973 (di fatto) l'A.I.A. Associazione Internazionale Artisti "Poesie della Vita", e, come critico letterario, ha recensito molti poeti italiani e stranieri. Si è spento nel 2009, qualche anno dopo averci dato l'opportunità di collaborare con lui. Noi di Letteratour lo ricordiamo con affetto qui.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG