
VIRGINIA WOOLF
Gita al faro
l'escursione a una delle isole Ebridi
di Reno Bromuro
Nella categoria: HOME | TOURismi letterari
"Non corrompeva i fatti, non alterava una parola sgradevole per assecondare il piacere o l'interesse di un altro, meno che mai dei suoi figli, che generati dai suoi lombi dovevano rendersi conto fin dall'infanzia che la vita è difficile, i fatti incorruttibili, e il passaggio a quella terra favolosa"
 Virginia
Woolf se rinascesse oggi con tutta probabilità, si chiamerebbe
Virginia Stephen, perché è questo il cognome
di Adeline Virginia al momento della nascita, avvenuta
a Londra il 25 gennaio 1882. Oggi, infatti, non si usa più che
le donne diventino famose usando il nome del marito. Ma, allora, nel periodo
vittoriano, le donne erano poco più che una graziosa appendice
del marito, o almeno la società voleva che così fosse.
Virginia
Woolf se rinascesse oggi con tutta probabilità, si chiamerebbe
Virginia Stephen, perché è questo il cognome
di Adeline Virginia al momento della nascita, avvenuta
a Londra il 25 gennaio 1882. Oggi, infatti, non si usa più che
le donne diventino famose usando il nome del marito. Ma, allora, nel periodo
vittoriano, le donne erano poco più che una graziosa appendice
del marito, o almeno la società voleva che così fosse.
Virginia Woolf è scrittrice dotata di qualità stilistiche
d'avanguardia per il linguaggio rarefatto ed essenziale e l'originale
concezione del tempo, qualità che va ben al di là di un
preteso autobiografismo. Solo negli anni Settanta, la critica ha superato
la visione riduttiva della sua opera come narrativa "impressionistica"
al femminile.
... La signorina Stephen però, dimostra di avere della stoffa ben
prima di sposarsi. Figlia di un noto storiografo, cresce fin da piccola
in un ambiente ad altissima densità intellettuale.
Quando il fratello Thoby entra a Cambridge,
nel 1899, lei stringe amicizia con i cosiddetti "Apostoli
del Trinity college", come Russell
e Wittgenstein, fra i maggiori filosofi del momento.
Nel 1906, insieme al fratello e alla sorella Vanessa, pittrice di un certo
talento, si trasferisce nel quartiere di Bloomsbury.
Intorno a loro si riunisce un gruppo di intellettuali, che per circa trenta
anni rimane un punto di riferimento fondamentale nella vita artistica
londinese. Virginia è uno degli elementi più importanti
e trainanti di quel gruppo di intellettuali. Ma la sua salute mentale
è alquanto instabile. Già preda di gravi momenti di depressione
in occasione della morte della madre avvenuta nel 1895, e poi del padre,
nel 1904, poco dopo il suo matrimonio con Leonard Woolf, nel 1912, piomba
in un nuovo e grave stato di malessere psichico, che si prolunga per tre
anni.
Nonostante questo riesce a scrivere e nel 1915 esce il suo primo romanzo,
La crociera.
La sua attività letteraria, da quel momento in poi, non conosce
soste.
Nel 1919 pubblica il racconto Kew gardens, al
quale fanno seguito Giorno e notte, Lunedì
o martedì, La stanza di Giacobbe
e La signora Dalloway.
Il suo capolavoro, Gita al faro, è del 1927 e Orlando, che tratta
anche esplicitamente la relazione dell'autrice con Vita Sackville
West è del 1928; nel 1929 esce il saggio Una stanza tutta
per sé. Tutti i suoi romanzi e saggi, insieme a quelli di autori
come T.S. Eliot, Katherine Mansfield
e Robert Graves, vengono pubblicati dalla rivista The
Hoarth Press, che la Woolf fonda insieme al marito.
Nel 1940, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, la scrittrice cade
di nuovo in una profonda depressione e il 28 marzo 1941, a 59 anni, si
riempie le tasche di pietre e si lascia annegare nelle acque del fiume
Ouse, a Rodmeil.
Virginia Woolf è tuttora considerata una figura fondamentale nella
lotta per l'emancipazione femminile, avendo profuso tempo ed energie in
favore della battaglia per la conquista dei diritti delle donne. Il suo
stile trasparente, quasi classico e per molti versi vicino alla poesia
ne fanno una delle scrittrici più incisive del Novecento.
VIRGINIA WOOLF: UN "ESEMPIO" ISOLATO
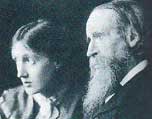 Si
ritorna a parlare dell'esempio isolato di Virginia Woolf e del periodo
di tempo particolare in cui è vissuta, sia per le trasformazioni
sia che avvengono in ambito sociale, economico sia per le novità
che interessano la cultura, la filosofia, la letteratura, l'arte. Sembra
che tutto, in quel momento, stia cambiando: cambia la realtà, cambia
il pensiero nel senso che il positivismo esaurisce il suo ciclo e si mettono
in evidenza nuove concezioni, più ampie, più complesse poiché
Scienze con Einstein e la Psicanalisi
con Freud, filosofie come il Superomismo con
Nietzsche e l'Intuizionismo con Bergson
contribuivano ad estendere gli orizzonti noti sino ad allora, "svelavano
la presenza e l'azione (affermano gli studiosi dell'Università
di Lecce), nell'uomo, di una vita interiore che, consapevolmente o inconsapevolmente,
determina quella esteriore. Dall'oggettività perseguita dai filosofi
positivisti e dai contemporanei scrittori naturalisti, veristi o realisti
si passa alla soggettività e spiritualità che sono state
tipiche dei nuovi filosofi e degli autori detti decadenti".
Primi sarebbero stati i poeti ad avvertire tale mutata atmosfera, poi
gli scrittori James Joyce, Marcel Proust
e, appunto, Virginia Woolf. Questa sarà così
naturalmente disposta ad accogliere i nuovi fermenti culturali ed artistici
da non ritenersi privilegiata né isolarsi a causa loro ma da abbandonare
la maniera realista e piuttosto tradizionale che era stata dei suoi primi
lavori e pervenire, col tempo, ai romanzi che l'avrebbero resa celebre
quali
Si
ritorna a parlare dell'esempio isolato di Virginia Woolf e del periodo
di tempo particolare in cui è vissuta, sia per le trasformazioni
sia che avvengono in ambito sociale, economico sia per le novità
che interessano la cultura, la filosofia, la letteratura, l'arte. Sembra
che tutto, in quel momento, stia cambiando: cambia la realtà, cambia
il pensiero nel senso che il positivismo esaurisce il suo ciclo e si mettono
in evidenza nuove concezioni, più ampie, più complesse poiché
Scienze con Einstein e la Psicanalisi
con Freud, filosofie come il Superomismo con
Nietzsche e l'Intuizionismo con Bergson
contribuivano ad estendere gli orizzonti noti sino ad allora, "svelavano
la presenza e l'azione (affermano gli studiosi dell'Università
di Lecce), nell'uomo, di una vita interiore che, consapevolmente o inconsapevolmente,
determina quella esteriore. Dall'oggettività perseguita dai filosofi
positivisti e dai contemporanei scrittori naturalisti, veristi o realisti
si passa alla soggettività e spiritualità che sono state
tipiche dei nuovi filosofi e degli autori detti decadenti".
Primi sarebbero stati i poeti ad avvertire tale mutata atmosfera, poi
gli scrittori James Joyce, Marcel Proust
e, appunto, Virginia Woolf. Questa sarà così
naturalmente disposta ad accogliere i nuovi fermenti culturali ed artistici
da non ritenersi privilegiata né isolarsi a causa loro ma da abbandonare
la maniera realista e piuttosto tradizionale che era stata dei suoi primi
lavori e pervenire, col tempo, ai romanzi che l'avrebbero resa celebre
quali  La
Camera di Giacobbe, La signora Dalloway,
Al faro, Le onde,
Gli anni, Tra un atto e l'altro.
Tuttavia come in ogni fenomeno letterario collettivo i vari esponenti
conservano le loro peculiarità pur in un contesto comune così
in questo la Woolf si distingue dagli scrittori suoi contemporanei e partecipi
degli stessi modi. La sua prosa più che all'analisi tende alla
sintesi, a condensarsi, cioè, in immagini uniche, molto significative,
a divenire poesia. C'è, nella Woolf, insieme all'intento di ritrarre
lo sterminato fluire del tempo e le conseguenti infinite trasformazioni,
anche e soprattutto l'altro di fissare dei momenti, di cercare tra tanta
indeterminazione dei punti di riferimento, di scoprirli in tempi, luoghi,
ambienti,pur lontani tra loro, di rintracciare le continuità tra
l'incessante mutamento, di salvare l'integrità, l'identità
della persona, l'autenticità della vita minacciate dall'inevitabile
ed inesorabile scorrere del mondo esterno. Ma neanche la letteratura riesce
a sollevarla dalle sue gravi condizioni nervose! Ha creduto di scoprire,
il modo di vivere senza le turbe psichiche che l'ammantellano come "una
camicia di forza" lo ha tentato, nei famosi "momenti
d'essere" senza accorgersi che anch'essi avrebbero manifestato
la loro transitorietà ed aggravato lo stato di smarrimento. Quella
letteratura, quel romanzo che le erano sembrati i modi più idonei
a rappresentare i tempi e contenere i pericoli di una mente minacciata
dalla malattia, non le potevano offrire le certezze sperate perché
i loro "momenti d'essere" non sono definitivi ma destinati
a venire sostituiti da altri, a scorrere come ogni altro aspetto dell'esistenza.
L'opera non risolve il problema e non rimane che finire con l'una e con
l'altro.
La
Camera di Giacobbe, La signora Dalloway,
Al faro, Le onde,
Gli anni, Tra un atto e l'altro.
Tuttavia come in ogni fenomeno letterario collettivo i vari esponenti
conservano le loro peculiarità pur in un contesto comune così
in questo la Woolf si distingue dagli scrittori suoi contemporanei e partecipi
degli stessi modi. La sua prosa più che all'analisi tende alla
sintesi, a condensarsi, cioè, in immagini uniche, molto significative,
a divenire poesia. C'è, nella Woolf, insieme all'intento di ritrarre
lo sterminato fluire del tempo e le conseguenti infinite trasformazioni,
anche e soprattutto l'altro di fissare dei momenti, di cercare tra tanta
indeterminazione dei punti di riferimento, di scoprirli in tempi, luoghi,
ambienti,pur lontani tra loro, di rintracciare le continuità tra
l'incessante mutamento, di salvare l'integrità, l'identità
della persona, l'autenticità della vita minacciate dall'inevitabile
ed inesorabile scorrere del mondo esterno. Ma neanche la letteratura riesce
a sollevarla dalle sue gravi condizioni nervose! Ha creduto di scoprire,
il modo di vivere senza le turbe psichiche che l'ammantellano come "una
camicia di forza" lo ha tentato, nei famosi "momenti
d'essere" senza accorgersi che anch'essi avrebbero manifestato
la loro transitorietà ed aggravato lo stato di smarrimento. Quella
letteratura, quel romanzo che le erano sembrati i modi più idonei
a rappresentare i tempi e contenere i pericoli di una mente minacciata
dalla malattia, non le potevano offrire le certezze sperate perché
i loro "momenti d'essere" non sono definitivi ma destinati
a venire sostituiti da altri, a scorrere come ogni altro aspetto dell'esistenza.
L'opera non risolve il problema e non rimane che finire con l'una e con
l'altro.
IL ROMANZO
L'azione si svolge nelle Isole
dell'Incanto, a Mull, la terza più
grande isola delle Ebridi, è un paradiso
tranquillo di bellezze ancora intatte. È il centro di un gruppo
di isole tra cui le più famose sono Iona, l'isola sacra di Columba,
meta di pellegrinaggio, Staffa, famosa per la
Caverna di Fingal e per le affascinanti formazioni
rocciose, e poi Ulva, Gometra,
le isole Treshnish e molte altre più
piccole, tutte bellissime.
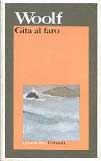 Con
una costa di oltre trecento miglia, Mull è
un'isola più grande di quella che i visitatori si aspettano solitamente
di trovare. È un invito a fuggire in un'isola che offre uno scenario
da mozzare il fiato, con torrenti rapidi e impetuosi, cime altissime,
viste stupende, cascate, animali selvatici, storia e atmosfera. È
un rifugio di persone amiche, dove il numero dei cervi supera quello degli
uomini e dove la popolazione delle lontre continua ad aumentare. È
un luogo in cui non occorre andare lontano per trovare pace e solitudine
e nel quale si può sempre partecipare ad una festa. Il premiato
fondo per la tutela delle balene e dei delfini delle isole Ebridi,
ma Mull e Iona, sono
soprattutto luoghi in grado di ispirare diversi stati d'animo. La giornata
può iniziare con un mare immobile come uno specchio ed un sole
splendente, senza un alito di vento e poi terminare con una cena memorabile
nella cornice di uno degli spettacolari tramonti dell'isola. Questa è
la giornata in cui potrete compiere splendide passeggiate, con il vento
che vi soffia sul viso. Ogni giorno sarà diverso dall'altro ed
un viaggiatore esperto vi confermerà che una giornata come quelle
soleggiate nelle Ebridi non si trova in nessun'altra
parte del mondo.
Con
una costa di oltre trecento miglia, Mull è
un'isola più grande di quella che i visitatori si aspettano solitamente
di trovare. È un invito a fuggire in un'isola che offre uno scenario
da mozzare il fiato, con torrenti rapidi e impetuosi, cime altissime,
viste stupende, cascate, animali selvatici, storia e atmosfera. È
un rifugio di persone amiche, dove il numero dei cervi supera quello degli
uomini e dove la popolazione delle lontre continua ad aumentare. È
un luogo in cui non occorre andare lontano per trovare pace e solitudine
e nel quale si può sempre partecipare ad una festa. Il premiato
fondo per la tutela delle balene e dei delfini delle isole Ebridi,
ma Mull e Iona, sono
soprattutto luoghi in grado di ispirare diversi stati d'animo. La giornata
può iniziare con un mare immobile come uno specchio ed un sole
splendente, senza un alito di vento e poi terminare con una cena memorabile
nella cornice di uno degli spettacolari tramonti dell'isola. Questa è
la giornata in cui potrete compiere splendide passeggiate, con il vento
che vi soffia sul viso. Ogni giorno sarà diverso dall'altro ed
un viaggiatore esperto vi confermerà che una giornata come quelle
soleggiate nelle Ebridi non si trova in nessun'altra
parte del mondo.
 E
in quale posto più incantevole di questo paradiso Virginia Woolf
poteva ambientare il suo romanzo? Un romanzo che narra la "Gita
al faro" il capolavoro della Woolf, in cui il divario
tra tempo esterno e tempo interno, è protagonista assoluto. Il
romanzo unisce simbolicamente i tre momenti narrativi principali.
E
in quale posto più incantevole di questo paradiso Virginia Woolf
poteva ambientare il suo romanzo? Un romanzo che narra la "Gita
al faro" il capolavoro della Woolf, in cui il divario
tra tempo esterno e tempo interno, è protagonista assoluto. Il
romanzo unisce simbolicamente i tre momenti narrativi principali.
Tra la fine dell'Ottocento e i primi venticinque anni del Novecento, la
cultura occidentale fu scossa da una delle più gravi crisi che
l'abbiano mai attraversata. Il suo fondamento va in frantumi. Questo fondamento
è il soggetto, quell' "io" che guarda e giudica e costruisce
scale di valori e che fin da Protagora è stato "la misura
di tutte le cose".
Improvvisamente esso si rompe in tanti pezzi, così come alcuni
decenni più tardi si sarebbe rotto l'atomo, che in greco significa
"quello che non si può rompere".
"Come sarebbe stato in seguito per l'atomo, anche la frammentazione
del soggetto avviene in una sorta di bombardamento a catena, in cui sono
coinvolti la psicologia William James, la filosofia Henri Bergson, la
psicoanalisi Freud, la musica dodecafonia, la pittura il surrealismo,
la letteratura T. S. Eliot, Svevo, Pirandello, Proust, Joyce. Di questi
due ultimi un precursore ingiustamente dimenticato è il francese
Eduard Dujardin che nel 1887 aveva pubblicato I lauri sono tagliati prendendo
a prestito il titolo da un antico girotondo.
Ora tutto è diventato soggettivo, relativo, oscillante, ambiguo,
molteplice. Il tempo non è più quello misurato dagli orologi
ma quello della coscienza; la memoria non può più essere
certa di quello che ricorda; e un sogno può valere più di
una riunione d'affari fatta alle nove del mattino. Ma a questa corrente
filosofico - letteraria non vi parteciparono molte donne; una delle poche
donne che partecipano al banchetto delle idee è lei Virginia Woolf,
intelligentissima e dotata, trasgressiva molto al di là di quanto
i suoi tempi potessero sopportare, e anche malata di depressione".
 La
scrittura di Virginia Woolf contribuisce in modo sostanziale
alla sperimentazione e alla trasformazione del romanzo, e lo si vede splendidamente
in Gita al faro, uscito nel 1927 dopo due anni
di lavoro teso e nervoso.
La
scrittura di Virginia Woolf contribuisce in modo sostanziale
alla sperimentazione e alla trasformazione del romanzo, e lo si vede splendidamente
in Gita al faro, uscito nel 1927 dopo due anni
di lavoro teso e nervoso.
"Gita al Faro", prima di tutto, è un libro che ha una
trama precisa. A torto si è soliti affermare che Virginia Woolf
trascurasse, appunto, gli avvenimenti del mondo esterno. Prima della grande
guerra una famiglia della buona borghesia inglese che si trova in vacanza
al mare, decide di fare una gita al faro che lampeggia da un'isola di
fronte alla spiaggia. Ma la gita non si può fare per via del maltempo.
Si farà, però: dopo dieci anni e una guerra mondiale, quando
ormai la madre, l'indimenticabile signora Ramsay che
è l'eroina del racconto sarà morta da tempo. Dei molti figli,
uno è morto in guerra altri saranno comunque volati via dal nido
e saranno rimasti solo i due più piccoli: Cam
e James, che da piccolissimo desiderava questa gita più
di ogni altra cosa al mondo.
Ormai i due sono una ragazza e un giovanotto che durante la navigazione
sopportano pazientemente il padre mentre legge spiegazioni sul faro. Al
faro dunque si arriva, e come tutte le mete agognate e finalmente raggiunte,
esso appare deludente, una torre nera e nuda su un'isola a forma di foglia
che è proprio un'isola col mare che entra negli anfratti della
roccia e la circonda da ogni parte.
Questa trama, da molti considerata fragile è invece molto importante
e convoglia un'enorme quantità di significati. Gita al faro è
un libro sull'amore coniugale,sulla prepotenza, o desiderio di prepotenza
del maschio e la ribelle arrendevolezza della donna, sull'amore materno,
sulla fine dell'infanzia, sul passare del tempo, sui pensieri di un doppio
soggetto femminile, sulla vita che continua malgrado tutto, sulla realtà
esterna che esiste nonostante la diversità di intensità
e durata delle nostre percezioni.
CRITICA
Il mondo della Woolf, e in particolare di
"Gita al faro", ha già scoperto
Freud, e ha già conosciuto le opere di Sartre
e di Joyce, anzi, il suo filo coscienziale, si allaccia
a questi scrittori con agilità. "La frantumazione di cui
è stato vittima il mondo riecheggia la sua dissonanza sui vari
personaggi, i quali - come scrive Debenedetti - si sono trasformati da
personaggi-uomo a personaggi-particella vaganti indipendenti nella trama
dell'opera, la loro caratterizzazione non può così avvenire
dall'esterno, per bocca di un narratore, ma può solo essere riorganizzata
tramite le voci interne dei pensieri dei diversi personaggi, i quali rivelano
poco a poco, con le loro osservazioni, lati e sfumature degli altri, dandone
comunque un insieme tutt'altro che unitario".
 La
Woolf, segue le linee dell'Ulisse,
non si preoccupa di reintegrare gli oggetti esplosi e li lascia liberi
e incompleti; l'opera, dunque, rifiuta ogni compiutezza riconoscendola
falsa rispetto alla reale esistenza. Anche dietro le esplosioni, si può
ben vedere Joyce, anche se qui la Woolf ha realizzato
una severa selezione degli oggetti: non tutti infatti sono epifanie in
senso proustiano, Ella fa una cernita ben ferma solo su alcune delle immagini
e degli oggetti più significativi, come ad esempio i quadri di
Lily o la scogliera accanto alla villa dei Ramsay.
La
Woolf, segue le linee dell'Ulisse,
non si preoccupa di reintegrare gli oggetti esplosi e li lascia liberi
e incompleti; l'opera, dunque, rifiuta ogni compiutezza riconoscendola
falsa rispetto alla reale esistenza. Anche dietro le esplosioni, si può
ben vedere Joyce, anche se qui la Woolf ha realizzato
una severa selezione degli oggetti: non tutti infatti sono epifanie in
senso proustiano, Ella fa una cernita ben ferma solo su alcune delle immagini
e degli oggetti più significativi, come ad esempio i quadri di
Lily o la scogliera accanto alla villa dei Ramsay.
Nel romanzo vi è un gioco introspettivo possibile solo attraverso
la registrazione della coscienza dall'interno, in modo da coglierne ogni
oscillazione; il narratore diviene così una figura secondaria,
atta a svolgere, come già in Joyce, il compito
di mero introduttore nella storia e di collegatore tra le parti, fingendosi
a sua volta pensiero del narratore stesso: nella seconda parte del libro
infatti, la Woolf sorvola su interi anni occupandoli con il filo dei pensieri
costruiti come se appartenenti al narratore.
Si attua così lo stesso fenomeno presente in Joyce,
ove, come scrive Debenedetti "L'estremo rallentamento
di certi episodi anche più narrativi, porta i singoli istanti,
per dare tempo a ciascuno di mettersi a fuoco, quasi al limite del discontinuo",
comunque legati a tracciare l'identità attraverso il monologo interiore.
Attraverso questo grande espediente joyciano la Woolf riesce nel suo intento,
questa infatti raccogliendo attentamente i vari flussi di parole, di immagini
istantanee, di interiezioni e di fonemi insensati, e registrando le eruzioni
sentimentali e le evoluzioni emotive, costruisce quel grande labirinto
che è "Gita al faro", sotto
questo aspetto introduce, ma forse non se ne rende conto, quel labirinto
kafkiano, in cui i binari delle coscienze si intrecciano per formare un
tutto visibile solo da chi si è perso in quel labirinto esistenziale,
che non è altro che la risposta al quesito iniziale.
 Nello
sguardo limpido e disincantato che raccoglie le contraddizioni del reale,
oltre all'importanza di "essere duttili e nudi di fronte alla verità",
si radica l'angoscioso travaglio con cui la sua esasperata sensibilità
avverte la prossimità di vita e morte: "...perché
è così tragica la vita; così simile a un tenue nastro
gettato sopra un abisso. Io guardo giù; ho le vertigini; mi chiedo
come potrò camminare sino alla fine".
Nello
sguardo limpido e disincantato che raccoglie le contraddizioni del reale,
oltre all'importanza di "essere duttili e nudi di fronte alla verità",
si radica l'angoscioso travaglio con cui la sua esasperata sensibilità
avverte la prossimità di vita e morte: "...perché
è così tragica la vita; così simile a un tenue nastro
gettato sopra un abisso. Io guardo giù; ho le vertigini; mi chiedo
come potrò camminare sino alla fine".
IL PENSIERO DOMINANTE E LE MALATTIE MISTICHE
I periodi di crisi e le lunghe giornate in
cui è costretta a letto per placare l'eccitabilità dei suoi
nervi la espongono al rischio di scivolare rovinosamente nella follia,
nonché alla tentazione di far tacere con un gesto estremo quel
confuso brusio di voci che, in un crescendo inquietante di paure, fiacca
la sua mente. Ciononostante, Virginia Woolf è
quanto mai consapevole della fecondità artistica di queste pause
forzate tanto da riconoscere nei suoi diari che: "sei settimane
di letto farebbero di Falene (poi divenuto Le onde) un capolavoro"
e più avanti: "credo che nel mio caso queste malattie
siano - come dire - in parte mistiche. Qualcosa succede alla mia mente.
Rifiuta di continuare a registrare impressioni. ... poi, d'improvviso,
scaturisce qualcosa".
Sebbene le "malattie mistiche" cui allude non siano di natura
religiosa, Marguerite Yourcenar, che ha curato la traduzione
in francese de Le onde, esalta il profondo senso
di umanità che trapela dall'opera della scrittrice inglese la cui
arte è, a suo giudizio, intrisa di "un'essenza mistica, anche
se a questo misticismo lei esita o rifiuta di dare un nome". E definisce
"eterni" i "minuti di meditazione mistica" accordati
dalla Woolf ai sei personaggi de Le onde che, nelle intenzioni dell'autrice,
doveva essere un romanzo "estatico" capace di riprodurre
attraverso soliloqui "una mente che pensa", "la
vita stessa che scorre".
La triste minaccia della follia
Nel corso degli anni Trenta, un ciclo di
depressione l'assedia nuovamente. Diversi fattori concorrono ad inasprire
presso la scrittrice le paure sempre più ossessive e afflittive:
la lontananza di Vita Sackville-West, la morte di un
nipote - figlio maggiore di Vanessa, ucciso durante la
guerra civile in Spagna -, l'orrore incombente
del nazismo e, una volta scoppiata la guerra, il timore di un'invasione
tedesca, un timore che le origini ebree di Leonard non
fanno che aumentare a mano a mano che si confermano i segni della barbarie.
 In
questo ambiente e discontinuità psicologica, la sua attività
inclina sempre più a toni cupi nella scelta dei temi e più
titubante appare il suo progetto letterario. L'ossessione della solitudine
e della morte è al centro de Le onde del 1931. Nel 1937 esce Gli
anni: in questa lunga cronaca, costruita intorno dell'agonia di una madre,
Virginia Woolf traccia, in modo classico, dall'epoca vittoriana agli anni
Trenta, la storia del clan Pargiter, famiglia dell'alta
borghesia. Per il suo ultimo romanzo, Tra un atto e l'altro
del 1941, ritorna alle complessità delle costruzioni a specchio:
al di là della metafora di una festa di paese dove si mescolano,
in un turbinio, illusione e realtà, passato e presente, si addentra
in una meditazione sulle fondamenta della civilizzazione. Mentre i bombardieri
tedeschi solcano il cielo inglese, Virginia Woolf, sempre più convinta
che la follia abbia preso il dominio del mondo, decide di porre fine al
suo "Attraversamento delle apparenze". Il 28 marzo 1941, si
annega nel fiume Ouse, il cui corso delimita
la proprietà di Monk's House, a Rodmell,
piccolo villaggio del Sussex dove, in quei mesi
bui, i Woolf si rifugiano spesso. C'è, in questa morte cercata
nell'acqua, il simbolo di un completamento impossibile, come un'eco di
quella fluidità che la sua opera ha cercato sempre di cogliere.
In
questo ambiente e discontinuità psicologica, la sua attività
inclina sempre più a toni cupi nella scelta dei temi e più
titubante appare il suo progetto letterario. L'ossessione della solitudine
e della morte è al centro de Le onde del 1931. Nel 1937 esce Gli
anni: in questa lunga cronaca, costruita intorno dell'agonia di una madre,
Virginia Woolf traccia, in modo classico, dall'epoca vittoriana agli anni
Trenta, la storia del clan Pargiter, famiglia dell'alta
borghesia. Per il suo ultimo romanzo, Tra un atto e l'altro
del 1941, ritorna alle complessità delle costruzioni a specchio:
al di là della metafora di una festa di paese dove si mescolano,
in un turbinio, illusione e realtà, passato e presente, si addentra
in una meditazione sulle fondamenta della civilizzazione. Mentre i bombardieri
tedeschi solcano il cielo inglese, Virginia Woolf, sempre più convinta
che la follia abbia preso il dominio del mondo, decide di porre fine al
suo "Attraversamento delle apparenze". Il 28 marzo 1941, si
annega nel fiume Ouse, il cui corso delimita
la proprietà di Monk's House, a Rodmell,
piccolo villaggio del Sussex dove, in quei mesi
bui, i Woolf si rifugiano spesso. C'è, in questa morte cercata
nell'acqua, il simbolo di un completamento impossibile, come un'eco di
quella fluidità che la sua opera ha cercato sempre di cogliere.
Bibliografia
"Segni e comprensione", a cura del Dipartimento di Filosofia
(Università di Lecce) e del "Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche"
(Roma)
"Gita al faro" Garzanti Editore
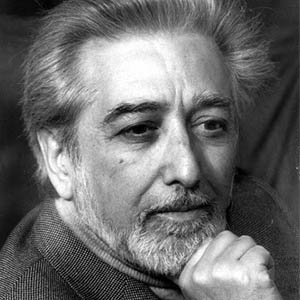
Reno Bromuro è nato a Paduli, in Campania, nel 1937. E' stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale. Nel 1957, a Napoli, ha fondato il Centro Sperimentale per un Teatro neorealista. Ha fondato nel 1973 (di fatto) l'A.I.A. Associazione Internazionale Artisti "Poesie della Vita", e, come critico letterario, ha recensito molti poeti italiani e stranieri. Si è spento nel 2009, qualche anno dopo averci dato l'opportunità di collaborare con lui. Noi di Letteratour lo ricordiamo con affetto qui.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG