
Nella categoria: HOME | TOURismi letterari

Quando si legge Petrarca occorre rifuggire dalla tentazione di farne un romantico ante litteram, perché sarebbe certamente una forzatura interpretativa immaginarlo mestamente in preda al malinconico Sehnsucht (ovvero allo “struggimento”, nella banale traduzione italiana); eppure le sue opere ed anche la sua vita sono attraversate da un assillo irrisolto, dal costante impegno a dirimere un conflitto interiore provocato da una personalità inquieta. Fu inquieto con se stesso, perché irretito nel rovello tra l’essere e il dover essere, e col mondo del suo tempo, che in parte apprezzava e in parte disprezzava; così come lo fu col tempo passato, per quella classicità che sentiva nostalgicamente lontana, e perfino con quello futuro, a cui volle consegnare – con la Lettera ai posteri - un ingannevole autoritratto. Però fu maestro nel conferire a questo originario intimo tumulto una rappresentazione letteraria stilisticamente armonica e intellettualmente lucida.
Una delle molteplici espressioni dell’inquietudine di Petrarca è il complementare desiderio di viaggiare e di sostare, di conoscere nuovi paesi e nuove genti e di rifugiarsi nella propria solitudine.
Nel De vita solitaria della solitudine fece uno stile di vita, dedicata all’otium letterario, allo studio, alla contemplazione e alla scrittura; ma è proprio così che a lungo visse, sia nei lunghi ritiri nella provenzale Valchiusa che nel breve ma intenso ristoro di Selvapiana ed infine nell’ultimo riparo dal mondo di Arquà sui Colli Euganei. Era così desideroso di vivere in un ambiente rustico e silenzioso che quando, dopo aver abbandonato Avignone, si stabilì a Milano, andò ad abitare in una casetta vicina al monastero di Sant’ Ambrogio, cosicché poteva accedere all’orto del monastero, trovandovi almeno un surrogato di vita agreste, in cui – come scrisse in una delle Familiari, nel libro XIX - “contemplo come da una spiaggia tranquilla le tempeste del mare ed odo il fragore dei flutti ma non ne sono toccato”. Su queste parole ritorneremo ma intanto vorrei far notare la coincidenza con quelle del II libro del De rerum natura di Lucrezio: “Dolce è mirar l’altrui grave travaglio, quando i venti scompongono l’ampia distesa del mare”; ancor più significativa se si ricorda che a Petrarca l’opera del poeta latino era sconosciuta, in quanto il manoscritto fu ritrovato nel 1417 nel monastero di San Gallo da Poggio Bracciolini.
Desideroso di quiete e schivo di compagnia eppure sempre in viaggio. Da bambino il periglioso trasferimento da Arezzo ad Avignone, poi in Europa: Montpellier, Combez, Parigi, Gand, Liegi, Aquisgrana, Colonia, Basilea, Lione (in cui giunse attraversando da solo a cavallo la foresta delle Ardenne) e infine Praga; e in Italia Bologna, Roma, Garda, Milano, Genova, Napoli, Venezia, Mantova, Verona, sino a Trento e al passo di Resia. Tanto amava sostare in qualche angolo riposto del mondo quanto il percorrerlo, pur affrontando disagi, imprevisti e pericoli. Viaggiava per assolvere incarichi diplomatici che i signori suoi ospiti gli assegnavano, ma anche per i suoi interessi, per la sua ansia di conoscenza, frugando in biblioteche e abbazie in cerca di preziosi manoscritti e osservando acutamente paesaggi urbani e rurali, che poi puntualmente descriveva ai suoi corrispondenti, con una narrazione sempre intrecciata con citazioni classiche e riflessioni personali.
Perciò è considerato uno degli iniziatori del genere letterario odeporico (pedante aggettivo derivato dal greco oidoporì, che appunto significa “viaggio”). E’ un genere piuttosto poroso e dai confini elastici, poiché può comprendere il racconto del viaggio reale ma anche di quello immaginario e di quello interiore, ma proprio per questo affascinante, perché conduce il lettore verso l’esotico, l’ignoto e perfino l’estatico; d’altronde il viaggio è stato (almeno finché non s’inventò il turismo) sempre e comunque esperienza dell’azzardo e della prova, del sacrificio o della purificazione di sé, perciò diventando immediatamente metafora, forse la più diffusa e potente, della vita. E così fu per Petrarca. Lo si vede in quel testo esemplare, una lettera delle Familiari indirizzata all’amico Dionigi di San Sepolcro, che è il racconto della sua escursione sul Monte Ventoso nel 1336: un’ascesa ardua e faticosissima affrontata per curiosità, per il desiderio di contemplare il panorama provenzale dall’alta cima di quella montagna, perfettamente descritta con la sua consueta perizia paesaggistica, che progressivamente diviene esame interiore e meditazione religiosa ed infine, sulla vetta finalmente raggiunta, consapevolezza che non quelle rocce, non quelle magnifiche distese di terra e di mare, non il mondo è da ammirare, bensì “l’anima, di fronte alla cui grandezza non c’è nulla di grande”. Qualcuno giudica che questa lettera sia la testimonianza della nascita dell’alpinismo, dato che la scalata non fu fatta per fini pratici ma per diletto, e qualcun altro invece addirittura una manifestazione del sublime; comunque sia è evidente che vi si intrecciano indissolubilmente le due vie dell’itinerario geografico e dell’itinerarium mentis, della scoperta del luogo e della scoperta di sé.
Petrarca dunque viaggiatore instancabile, benché anelante alla quiete: nelle Familiari definiva se stesso “eterno viandante”, scriveva di avere “un animo errabondo e un occhio mai sazio di vedere cose nuove” e si paragonava ad Ulisse, per il comune ardore del viaggiare; ma anche per il nostos, la nostalgia per il ritorno, che tuttavia per lui, che si descriveva “ovunque straniero”, era impossibile (ed è inevitabile il riferimento al sonetto A Zacinto di Foscolo).
Eppure una volta al viaggio si sottrasse. E il fatto che si trattasse proprio di un viaggio in Terrasanta, cioè del tipico pellegrinaggio medievale, rende quel rifiuto molto intrigante e degno d’essere indagato, con un’indagine che riporterà Petrarca nel suo tempo, facendo svanire l’aura romantica che lo circonfonde.
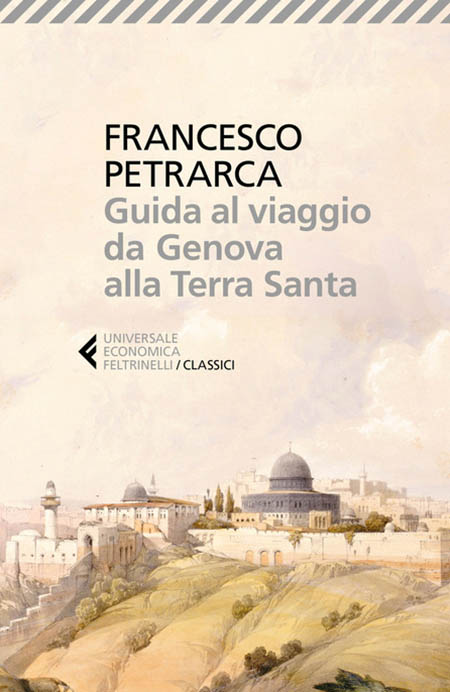
Il pellegrinaggio è una istituzione propria delle religioni storiche; ad esempio l’Islam ha l’hajj, il rituale viaggio del fedele alla Mecca, e il buddismo tra le devozioni comprende la visita dei luoghi della vita di Buddha, come Lumbini, dove nacque; nella Cristianità fu inaugurato da S. Elena, la madre dell’imperatore Costantino, che si recò a Gerusalemme nel 326 d. C in cerca delle tracce di Gesù; nel Basso Medio Evo a Gerusalemme si aggiunsero altri luoghi sacri, Roma e Santiago di Campostela soprattutto. Dopo Elena che, insieme al figlio, contribuì a trasformare Gerusalemme e la Palestina nella Terrasanta, altri cristiani vi si recarono, tra cui San Gerolamo, che al pellegrinaggio conferì la sua dimensione simbolica di atto di fede e itinerario spirituale salvifico; a lui si deve pure un resoconto del viaggio per giungervi, ma il più antico è l’Itinerarium burdigalense del 333 d. C, scritto da un anonimo pellegrino che descrive il suo viaggio dall’attuale Bordeaux a Gerusalemme, indicando il percorso fatto sia all’andata che al ritorno.
Il pellegrinaggio divenne quindi un rilevante fenomeno religioso, sociale e culturale del Medio Evo, uno dei modi di esprimerne la spiritualità; tanto rilevante da costituire un nuovo spazio cristiano che si sovrappone alla geografia e topografia classiche, da diventare stimolo per la rinascita economica post-carolingia (basti ricordare il ruolo della via Francigena nell’attrarre attività e commerci) nonché giustificazione della Crociata, che appunto era un “pellegrinaggio armato”; un suo effetto fu anche la comparsa di una letteratura che riguarda i luoghi sacri del cristianesimo e gli itinerari per raggiungerli: dell’Itinerarium burdigalense si è già detto, di poco posteriore è l’Itinerarium egeriae (del 390, Egeria probabilmente era una monaca spagnola), poi la produzione di queste “guide” si intensificò, ovviamente corrispondendo alla dinamica fluttuante dei pellegrinaggi, che dipendeva dai rapporti dell’Europa cristiana con l’Islam, dalle vicende delle Crociate e del regno d’Outremer: se ne scrissero di più tra il XII e il XIII sec., quando i Crociati erano in Terrasanta, diminuirono quando se n’andarono, si tornò a scriverne nel XIV sec., quando si trasformarono spesso in memoriali di viaggio.
Un itinerarium lo scrisse anche Petrarca, un po’ paradossalmente, dato che lo scrisse proprio perché a Gerusalemme non ci andò, non volle andarci.
Nel 1358, quando abitava a Milano, Giovanni Mandelli, un cortigiano al servizio dei Visconti, lo invitò ad unirsi a lui in un pellegrinaggio in Terrasanta; Petrarca declinò l’invito tuttavia il rifiuto fu amichevolmente accompagnato da una guida al viaggio, che Mandelli gli aveva richiesta; di questo testo esistono diversi esemplari manoscritti, di cui il più attendibile è forse quello conservato nella Biblioteca Statale di Cremona, appartenuto nel XVI sec., a Girolamo Mandelli, quindi dovrebbe essere un discendente diretto della versione originaria inviata a Giovanni: l’Itinerarium ad sepulcrum Domini nostri Ihesu Cristi ad Iohannem de Mandello.
Ma – e non poteva essere altrimenti – si differenzia notevolmente dai canonici itineraria dell’epoca. Intanto perché è una scrittura d’occasione, inoltre perché non corrisponde ad un viaggio realmente avvenuto, ma soprattutto perché Petrarca curva la narrazione verso un altro genere per lui fondamentale: l’epistolografia, e specificamente l’epistolografia odeporica di cui fu maestro, come mostrano il racconto dell’ascesa al Monte Ventoso e altre lettere, come quelle Familiari indirizzate a Giovanni Colonna, che sono dei resoconti di un suo viaggio nell’Europa del Nord del 1335. Infatti nella parte proemiale del testo è il poeta stesso a definirlo literulae, ovvero “letterina”, definizione da intendersi nella sua intenzionalità ironica ma anche come indicazione ermeneutica.
E’ articolato in tra parti: la prima, breve, è l’introduzione, in cui Petrarca svolge una riflessione sulla morte, ma di fatto è una giustificazione del suo rifiuto; la seconda è la descrizione del viaggio, l’itinerarium vero e proprio; la terza, brevissima, è il commiato dal mancato compagno di viaggio; sulla prima e la terza torneremo, ora seguiamo il percorso che il poeta consiglia e descrive, rilevandone alcuni aspetti peculiari.
Innanzi tutto che si tratta di un viaggio in parte non realizzato bensì immaginato, nonché anomalo. Quando nel XIV sec. i pellegrinaggi tornarono a farsi frequenti, di fatto Venezia ebbe il monopolio della traversata del Mediterraneo, ma Petrarca invece lo fa insolitamente iniziare da Genova. I motivi di questa diversione sono molteplici, personali e letterari: poiché vi ha viaggiato conosce il Mar ligure, il Mar Tirreno e le loro coste, mentre non conosce l’Adriatico; inoltre la rotta che sceglie gli permette anche di mescolare intenzionalmente i paesaggi con le citazioni erudite tratte dalle sua amate fonti latine, cosa che l’itinerario adriatico non gli avrebbe consentito; infine, come ricorda in un passo del testo, lui stesso ha descritto quei posti nel suo poema Africa (il poema scritto in esametri latini che narra di Scipione l’Africano e che – a parer suo – avrebbe dovuto procurargli la fama desiderata). Ciò ovviamente determina anche l’andamento del racconto, che procede più lento sino a Napoli, dato che Petrarca indulge sui particolari, che ben conosce, e diventa sintetico dopo l’attraversamento del canale d’Otranto, quando le conoscenze non possono che essere letterarie e cartografiche (d’altronde egli era anche cartografo, per diletto).
Così, ad esempio, meticolosamente descrive la costa del Levante ligure:
Lasciata Genova alla volta del Ponente, cerca di non distogliere mai, per tutto il giorno, lo sguardo dalla costa; ti si faranno incontro panorami che sarà più facile per te rimirare che per qualsiasi uomo descrivere: bellissime valli, fiumicelli che scorrono, colli piacevolmente selvaggi e da ammirare per la sorprendente fertilità, villaggi arroccati sulle rocce, paesi assai vasti; vedrai sparse sulla costa, ovunque ti volgerai, case adorne di marmi e ori, e ti stupirai come una città del genere ceda in splendore e piacevolezza ai suoi dintorni
e della Toscana settentrionale:
Non molto dopo (Pietrasanta) sboccano le foci del Serchia e dell’Arno: l’uno lambisce Lucca e l’altro attraversa prima le mura della mia patria e quindi Pisa. Lucca non so dire, Firenze sicuramente si sottrae alla vista, invece il comandante della nave ti mostrerà dalla poppa del vascello Pisa, città antichissima, di aspetto tuttavia moderno e gradevole, che non si segnala, sebbene sia situata in pianura, come la maggior parte delle città, con poche torri, ma appare nella sua interezza con edifici imponenti (…) dopo poche miglia ci sarà un porto artificiale chiamato Pisano e, quasi attaccato, Livorno, ove c’è una solida torre sulla cui cima di notte viene acceso un fuoco che mostra ai naviganti la rotta sicura. Da questo punto, se ti girerai a destra, ti saranno di fronte Gorgona e Capraia (…) ed anche una piccola torre, ritta in mezzo al mare, che la gente chiama Meloria, infausta ai Pisani
Ma nondimeno alla descrizione collegata alle proprie esperienze di viaggiatore si sovrappongono sempre le memorie letterarie, gli echi e le citazioni di Virgilio, Plinio il Vecchio, Svetonio, ecc., ad esempio quando descrive Capo Miseno, riferendosi al VI libro dell’Eneide:
Da questo punto in poi si protende in mare il colle di Miseno, che riceve il nome dal trombettiere Frigio che vi è sepolto, come dice Virgilio. C’è chi ritiene che Miseno sia stato ucciso lì da Enea per fare un sacrificio agli dei inferi, atto che non può essere compiuto, come asseriscono, senza l’uccisione di un uomo e che l’atrocità del gesto venne giustificata dalla poesia di Virgilio; si sostiene inoltre che Virgilio ha raccontato che Enea sacrificò nello stesso luogo in cui l’aveva fatto Ulisse, secondo la narrazione di Omero, con lo stesso crudele rito (la cosa comunque è assai incerta). Questi luoghi sono assai adatti ai riti sacrificali di tal genere, poiché vi si trovano i nomi infernali di Averno e Acheronte, e vi è la porta di Dite, soglia che può essere varcata una sola volta. Da là è facile la discesa all’Averno, di cui parla Virgilio, definendolo facilmente individuabile di giorno e di notte, invece più difficile è il ritorno (…) Qui si può vedere, sullo scosceso dirupo dell’Averno, l’immensa dimora della Sibilla Cumana, ormai distrutta da tempo e disabitata, ma piena di nidi d’uccelli d’ogni specie.

Ma dopo Napoli la narrazione si accelera, poiché ora Petrarca può solo ricorrere a conoscenze indirette, storiche, geografiche e cartografiche, ed anche le citazioni dalle fonti classiche necessariamente scemano; perciò la navigazione rapidamente termina: o a Nord, a Giaffa o altri porti vicini, o a Sud, più vicino a Gerusalemme, con un viaggio meno faticoso di quello terrestre. Di Gerusalemme non è detto quasi nulla, solo alcune sommarie indicazioni sui luoghi sacri: il sepolcro, il Calvario, Sion, il sito dell’ascensione al cielo, Betlemme. Infine giunge l’ultimo consiglio, inconsueto eppure sintomatico del punto di vista petrarchesco: ripercorrere il percorso della fuga in Egitto di Giuseppe e Maria, un viaggio duro, attraverso il Sinai, per giungere alla nuova Babilonia, il Cairo, il cui scopo finale però è visitare le tombe di Alessandro Magno e di Pompeo. Che c’entra quest’ultima tappa dell’itinerarium col pellegrinaggio cristiano? Nulla. Ma questa incoerenza religiosa è l’indizio che ci conduce verso una più esaustiva interpretazione del testo.
Torniamo alla sua parte proemiale, laddove il poeta rivolgendosi a Mandelli spiega il suo rifiuto:
ti era dunque maturata la decisione di avermi come compagno di viaggio, volontario e, direi, quasi speranzoso. Esiste infatti un tragitto più desiderabile e più sacro? Un pellegrinaggio più giusto dell’andare al sepolcro ove giacque Colui la cui morte temporale ha generato per noi l’immortalità e la vita eterna?
Le domande sono retoriche, la risposta ovvia, eppure Petrarca rifiuta
Strani peccati ora mi ostacolano e sono accalappiato da misteriosi uncini
Affermazione enigmatica che, se non si liquida come espediente retorico, richiede una esplicazione, perché poi la spiegazione appare banale, troppo semplice, priva di peccati e di misteri: Petrarca ha paura del mare:
Sebbene insomma numerosi motivi mi trattengono, nessuno è più forte della paura del mare
Ciò è comprensibile e perfino giustificabile, conoscendo le sue disavventure marittime: perché non solo già da bambino, nel viaggio di trasferimento ad Avignone, la nave su cui era imbarcato rischiò il naufragio davanti al porto di Marsiglia, ma gli capitò pure d’essere testimone del terribile maremoto che il 25 novembre 1343 devastò il porto di Napoli; di quell’evento ci ha lasciato una drammaticissima descrizione, che racconta di edifici distrutti, navi affondate, equipaggi dispersi, cadaveri galleggianti, terre sprofondate, in una lettera delle Familiari indirizzata al Cardinale Giovanni Colonna, che si conclude col proposito di non andar più per mare, “mai più a commettere la vita mia al mare e ai venti”. Anche se, dichiara a Mandelli, “d’altro canto mi piace a tal punto starlo a guardare, che è sorprendente con quanta passione rimiri ciò che aborrisco”, affermazione che è una conferma di quanto pensava nell’orto milanese, in sintonia coi versi di Lucrezio; ma appunto: se il travaglio è altrui, non suo, che preferisce starsene sulla terraferma.
Ma allora, se il rifiuto al pellegrinaggio è biograficamente ben motivato ed impossibile da eccepire, non si comprende l’allusione a quei “numerosi motivi” che lo trattengono, agli “strani peccati”, ai “misteriosi uncini”: o si tratta di iperboliche espressioni retoriche o, invece, sono parole che celano qualcosa di recondito, inespresso ed inesprimibile. Oppure la disgiunzione sarebbe da interpretare come inclusiva, cioè non questo o quello bensì questo o quello o ambedue, nel senso che non è soltanto la paura a superare la fede ma anche qualcos’altro che Petrarca non dice ma che si lascia intravedere in quel suo interesse per luoghi che sacri non sono e che pure egli inserisce nell’itinerario, poiché hanno un valore per lui, cultore della classicità. Insomma: il ritratto che implicitamente traluce dall’itinerarium è quello di cristiano un po’ negligente perché devoto non tanto ai luoghi e ai testi sacri quanto piuttosto alle biblioteche e a testi classici, per cui val veramente la pena di viaggiare (e d’altronde quando si trattò di incontrare il re Roberto d’Angiò sulla nave ci salì). Dunque anche qui riaffiora quel dilemma tra fede e vita che è proprio di Petrarca, la consapevolezza dell’incapacità d’essere un perfetto cristiano, con lo sguardo rivolto all’altro mondo e il disprezzo per questo, con il senso di colpa che ne consegue necessariamente e sempre lo angustia. Tuttavia riaffiora in una forma sfumata, non drammatica come nel Secretum, tant’è che l’epilogo dell’Itinerarium, più che un congedo sembra un ironico sberleffo (a voler essere irrispettosi lo si potrebbe giudicare un metaforico gesto dell’ombrello):
Si è tuttavia viaggiato abbastanza, e si è scritto abbastanza: tu fino a questo punto coi remi e andando per mare e terre, io solcando questa carta con una penna veloce, e non so se tu sia a questo punto stanco di viaggiare, veramente io lo sono di scrivere, tanto più che sono avanzato a gran velocità. Il tuo viaggio di circa tre mesi, io l’ho concluso in tre giorni.
E qui sia il termine del cammino per ambedue. Tu devi ritornare a casa, io ai miei studi. Ciò che io ho fatto in fretta, tu devi compierlo con maggior impegno attivo, felicemente con l’aiuto di Cristo. Dopo aver visto tutto ciò, con la sua guida, ritornerai da noi più saggio e più santo.
Sembrerebbe quasi una versione anticipata della proverbiale ingiunzione “armiamoci e partite”, che ai neutralisti del 1915 servì a deridere - ingiustamente, a onor del vero, perché poi si arruolò - l’interventista Mussolini; ma insomma il concetto è chiaro: a te, caro Mandelli, la saggezza e la santità, a me il riposo e la tranquillità.

Tiziano Gorini (Livorno, classe 1953), ha trascorso una vita estenuandosi nel provare ad insegnare Lingua e letteratura italiana e Storia; all'insegnamento ha sempre affiancato la ricerca, spaziando dalla critica letteraria all'epistemologia, dalla storia della scienza alla pedagogia. Ha pubblicato con M. Carboni e O. Galliani Le stanze di Ophelia, il manuale di storia della letteratura Excursus e Il professore riluttante. Di se stesso pensa di essere una brutta copia dell'uomo rinascimentale, perché come gli umanisti del Rinascimento girovaga tra i molteplici campi della conoscenza e dell'arte, ma - a parer suo - con mediocri risultati. Nel tempo libero soprattutto legge e scrive, altrimenti se ne va a contemplare il mare e le nuvole.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG