
Nella categoria: HOME | Lingua e comunicazione
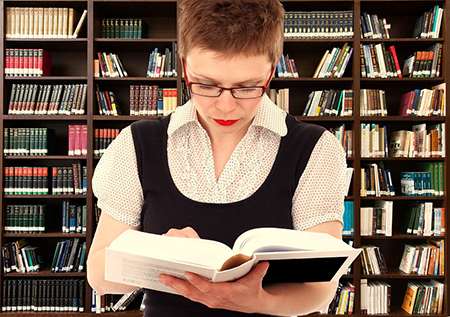
Quest'articolo nasce con lo scopo di agevolare gli studenti che arrivano alla tesi e, più in generale, di fornire preziosi consigli a chiunque abbia la necessità di scrivere un lavoro critico su materiale cartaceo. Nonostante sia la meta di ogni studente, la tesi in particolare può presentare alcuni problemi durante la sua stesura, di ordine sia pratico che contenutistico, anche perché rappresenta un lavoro di tipo "scolastico" che si basa su uno standard abbastanza preciso.
Dopo il libro di Umberto Eco Come si fa una tesi di laurea - già di qualche anno -, e tramite Internet, affrontiamo qui di seguito uno per volta i momenti fondamentali di una buona redazione, dando per scontato che venga fatta con mezzi elettronici (computer).
L'impaginazione
comprende l'insieme di norme, di natura essenzialmente tipografica, per
cui un testo viene inserito - dunque visualizzato - in un preciso modo
sulla pagina. Le regole di base per una buona impaginazione prevedono:
- l'uso di rientri sporgenti per ogni paragrafo
(ogni "andata a capo") - per la tesi, il rientro può essere
di 1 cm o di 1,5 cm. L'uso dei paragrafi non dovrebbe essere troppo "capriccioso".
Il paragrafo va concepito come una sorta di unità di misura del pensiero
che si sta sviluppando. Perciò la scansione tipografica in paragrafi riflette
visivamente il "ritmo" del discorso. La misura ottimale di un paragrafo
è di mezza pagina anche se, naturalmente, si tratta solo di un'indicazione
orientativa.
- margini appropriati al tipo di stampa. Solitamente
questa opzione è già prevista dai principali programmi di
scrittura (incluso Word), ma nel caso della tesi si può prevedere un margine
di circa 2,5 cm sopra e sotto, e di circa 4 cm a sinistra e a destra.
Nel caso specifico di una tesi che superi le 150 pagine, è consigliabile
prevedere anche un margine sinistro che tenga conto della rilegatura.
- una divisione tipografica in capitoli, attraverso
spazi bianchi e titoli. Ogni capitolo dovrebbe essere numerato, così
da permettere, soprattutto nel caso in cui vi siano sottocapitoli, di
numerare nuovamente questi ultimi come sottosezioni del capitolo, secondo
lo schema seguente:
| 1.
Titolo capitolo 1 1.1. Titolo sottocapitolo 1 1.2. Titolo sottocapitolo 2 |
-
l'uso di font (caratteri) classici, come ad esempio Times, Garamond,
Century Schoolbook, ecc. Altri tipi di font possono appesantire inutilmente
l'aspetto visivo del testo e danneggiarne la leggibilità. Il font
scelto deve rimanere lo stesso in tutto il lavoro, tranne per le note
e il numero di pagina, dov'è possibile usare un altro font (però
sempre "classico").
- una grandezza standard del font, che nel caso
della tesi può variare da 12 a 14 punti (fermo restando l'opportunità
di ingrandire il font nei titoli, e di diminuirlo nelle note).
- un'interlinea (cioè una distanza tra
le righe del testo) doppia per la tesi, di 1,5 punti per un altro tipo
di lavoro.
Un discorso a parte meritano citazioni, note
e bibliografia.
La stesura di una tesi prevede almeno 6 elementi: l'introduzione, il testo della tesi (l'oggetto della ricerca) opportunamente diviso in capitoli, la conclusione, la bibliografia e l'indice.
L'introduzione
In media di 4 o 5 pagine, l'introduzione deve presentare il lavoro in
maniera chiara e succinta, giustificandone l'esistenza e definendo il
metodo utilizzato. In particolare, può essere utile spiegare anche l'eventuale
suddivisione in parti.
L'oggetto
La tesi più classica ha per oggetto un singolo autore. È
preferibile che si tratti d'un autore "minore", per definizione
meno studiato e che, quindi, può permettere dei contributi più
originali. Affrontare autori di prima grandezza come Goethe, Proust o
Joyce può rivelarsi una scelta ingenua e/o arrischiata: sia perché
tale scelta comporta il dominio di una bibliografia sterminata, sia perché
- per definizione - le problematiche aperte intorno a questi scrittori
sono molto ardue e complesse. È comunque possibile scegliere di
studiare un autore di prima grandezza a condizione di disporre di un "taglio"
interpretativo sufficientemente "peculiare"; vuoi in quanto
si concentra il lavoro su un'opera o una serie di opere di quell'autore
ritenute meno importanti o comunque meno studiate; vuoi in quanto si adotta
un approccio metodologico originale e non inflazionato.
Lo studio di un autore minore implica una presentazione iniziale della
sua figura. Tale presentazione deve comportare una serie di informazioni
biografiche; ma è importante non limitarsi a un mero racconto della
vita del singolo scrittore, e occorre abbozzare una ricostruzione quanto
più possibile approfondita del contesto culturale relativo. Nel
caso d'un "maggiore", la conoscenza della sua figura si dà
invece per scontata, anche se è pensabile illuminare qualche aspetto
biografico particolare.
Il singolo autore è l'oggetto più comune per una tesi letteraria,
ma è possibile anche soffermarsi a studiare più autori,
magari evidenziandone i rapporti, oppure analizzare singole tematiche
o privilegiare un metodo.
La
conclusione
In media di 6-8 pagine, la conclusione per molti aspetti può sembrare
un doppione dell'introduzione, dato che riassume nuovamente il lavoro
svolto; in realtà ha una funzione molto diversa. Principalmente,
il suo ruolo è quello di "tirare le somme" della nostra
ricerca esplicitando chiaramente quello che si è cercato di dimostrare
in precedenza nel testo, magari dedicando un paragrafo per ogni ambito
di ricerca (per ogni capitolo, o parte).
La
parte forse più problematica della tesi è la bibliografia,
luogo di riferimento, per il lettore, di tutto il nostro lavoro originale
di ricerca sui testi. Essa deve comprendere non solo i testi sui quali
verte la tesi, ma anche tutti quelli di critica, di metodologia, di storia,
di cultura o altro a cui si è fatto riferimento diretto o indiretto.
Per ogni testo è necessario specificare:
- il nome e il cognome dell'autore (eventualmente
l'iniziale del nome e il cognome) - ad es:
A. Gide
- il titolo (da scrivere in corsivo, meglio se
con una maiuscola sul primo sostantivo, e dopo una virgola che lo separi
dall'autore) - seguendo l'es. precedente avremo:
A. Gide, Les Nourritures
terrestres
- il luogo, la casa editrice e l'anno dell'edizione
originale, sempre dopo una virgola. Avremo quindi:
A. Gide, Les Nourritures
terrestres, Paris, Mercure de France, 1897.
- al termine di ogni riferimento bibliografico
si può aggiungere un punto.
L'insieme dei testi deve essere ordinato secondo un criterio preciso e
coerente lungo tutta la bibliografia, con suddivisioni pertinenti. Ad
es., si può distinguere tra monografie (singoli libri) e articoli, oppure
tra testi letterari e testi non letterari (di critica, di metodologia,
ecc), o ancora, all'interno dei testi letterari, tra opere in prosa e
poesie, ecc. Ovviamente ogni categoria può intersecarne un'altra. All'interno
di ogni suddivisione è necessario scegliere un criterio di inserimento
dei testi: i più correnti sono il criterio alfabetico o quello
cronologico, relativo all'anno di pubblicazione.
Le
citazioni
Parte fondamentale di un testo di critica, le citazioni affiancano la
nostra riflessione dimostrandone la pertinenza.
Esse Possono essere inserite in due modi nel testo:
- all'interno del nostro discorso, di una nostra
frase, quando è più breve di una frase e stando attenti
a inserirla nel modo corretto (rispettando il tempo verbale e il soggetto
del contesto linguistico). In questo caso la citazione non si distingue
con particolari accorgimenti tipografici, tranne che per l'uso delle virgolette.
Es:
Lo studioso arriva
a formulare la legge per cui, "con mossa spudorata o furtiva, scissa
o inconscia, il nazionalista imita la qualità presunta più
avversa dello straniero".
- al di fuori del nostro discorso, in uno spazio
tipografico separato. In questo caso bisogna distinguere la citazione
dal testo. È possibile farlo utilizzando una grandezza diversa
del font (di un punto in meno) e un'interlinea più stretta. Anche
il rientro sporgente può essere leggermente più piccolo, ad es.
di 0,5 cm.
Una regola fondamentale alla citazione è la riproduzione esatta
del testo che citiamo: non si deve cambiarlo. Quando, per motivi contingenti,
si ha bisogno di farlo, è necessario far capire al lettore che
in quel preciso punto il testo è stato manipolato, e ciò è
possibile con l'uso di parentesi quadre e di puntini di sospensione:
- per segnalare un cambiamento di parola - in
questo caso la parola aggiunta o modificata va inserita nelle parentesi
- per segnalare che la frase citata è già
cominciata o non è finita - in questo caso si aggiungono dei punti
di sospensione prima e/o dopo il passo citato, senza mettere maiuscole
d'inizio di frase
- per segnalare che una frase o un discorso, all'interno
della citazione, sono stati omessi - in questo caso si aggiungono, al
posto del testo mancante, dei puntini di sospensione all'interno di parentesi
(sempre quadre).
Il testo inserito in parentesi quadre indica una nostra manipolazione
del testo, e al suo interno sono dunque possibili tutte le operazioni
che vogliamo, persino un cambiamento di lingua. Ecco un esempio di citazione
in cui si trovano tutti i casi sopra riportati:
... in collegamento
con l'inchiesta di Fianchetti e Sonnino sul lavoro minorile nelle miniere
di zolfo [...] [la novella] finisce per trovare nella natura stessa una
giustificazione ideologica...
Le note
Oltre ad essere un luogo dov'è possibile aggiungere osservazioni
non strettamente inerenti alla nostra ricerca, la nota è l'importante
compagno della citazione. In altre parole, ogni citazione deve essere
seguita da un rimando ad una nota. Questa può essere messa a fine capitolo,
addirittura a fine volume, oppure (scelta consigliata per i testi lunghi)
a piè di pagina (in basso alla pagina).
Il font del testo in nota deve essere più piccolo di quello del
testo, per es. di 8 punti, e l'interlinea singola.
Il rimando bibliografico in nota segue le stesse regole tipografiche della
bibliografia, salvo per qualche accorgimento in
più, come la possibilità di scrivere in maiuscolo tutto
il cognome dell'autore e la necessità di aggiungere le pagine da
cui proviene la citazione (non necessariamente dall'edizione originale
dell'opera).
La questione è più complessa relativamente a testi che vengono
citati più d'una volta nel testo:
- se un autore è citato per la prima volta,
e in riferimento ad una sola opera, si deve scrivere, ad es:
A. MALRAUX, La Condition
humaine, Paris, Gallimard, 1999, p. 16.
In seguito, lo stesso autore sarà richiamato così:
MALRAUX, op. cit.,
p. 22.
- se un autore è citato per la prima volta,
ma nel testo si fa riferimento a più di una sua opera, si deve
scrivere:
A. MALRAUX, La Condition
humaine, Paris, Gallimard, 1999, p. 16.
e, in seguito, richiamarsi così ad una sua precisa opera:
MALRAUX, La Condition
humaine cit., p. 22.
Nel caso in cui uno stesso testo sia citato più volte di seguito,
basta un primo richiamo alla prima citazione, e poi un semplice:
Ibid., p. 26.
alle note successive.
Nel caso in cui le pagine da cui è tratto il passo siano più
d'una, di possono usare due "p", oppure due "p" seguite
dall'abbreviazione "e segg." (che sta per "e pagine seguenti");
es:
Ibid., pp. 22-23.
Ibid., pp. 22 e segg.
Può essere utile consultare il seguente libro:
Umberto Eco, Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche.
articolato in 7 capitoli: "Cos'è una tesi di laurea e a cosa
serve", "La scelta dell'argomento", "La ricerca del
materiale", "Il piano di lavoro e la schedatura", "La
stesura", "La redazione definitiva", "Conclusione".
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG