
Nella categoria: HOME | Lingua e comunicazione
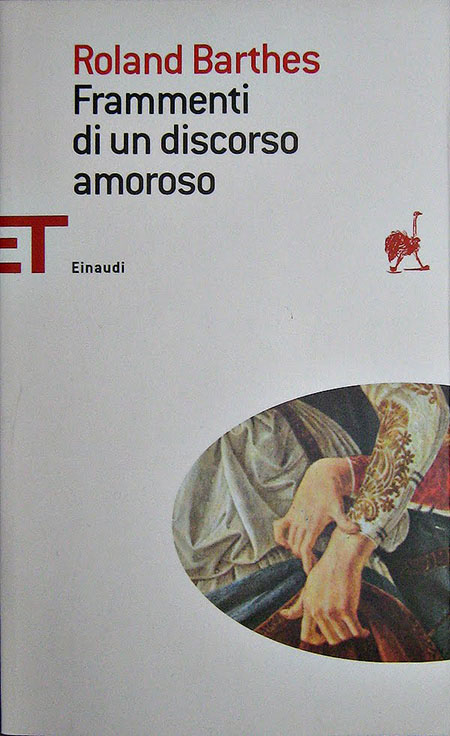
Ognuno di noi si è ritrovato almeno una volta nella vita a porsi quesiti sul sentimento che più rallegra e tormenta l’animo umano: l’amore. Roland Barthes sceglie di darci tutte le sue risposte in maniera tecnica e romantica allo stesso tempo. In “Frammenti di un discorso amoroso” l’autore scompone l’amore in pezzi e li posiziona in ordine alfabetico in questo saggio che va letto come se fosse un vocabolario, un catalogo. Pubblicato nel 1977 per Editions du Seuil e scomposto in 80 voci, l’obiettivo di questo testo è spiegare la crisi del sentimento amoroso nel ‘900. A come abbraccio, I come incontro, L come languore d’amore, O come oggetti dell’amore, P come pazzo d’amore, R come rapimento, S come solitudine dell’amore o suicidio d’amore: in quest’opera c’è la volontà di affrontare l’amore attraverso dei particolari minimalisti. La scelta dell’ordine alfabetico è una scelta originale e autoironica, infatti è l’autore stesso a non voler concepire la sua opera come un saggio critico serio.
In ogni sezione del testo si trovano citazioni da fonti diverse. Fortissima è l’influenza di Nietzsche (in particolar modo per tutto ciò che riguarda la necessità di adottare un metodo di drammatizzazione) e de “I dolori del giovane Werther” di Goethe, ma nel saggio sono presenti anche grossi riferimenti al Simposio di Platone, a Freud e la sua psicanalisi, passando per Victor Hugo fino ad arrivare a De Balzac e Dostoevskij.
Il libro si presenta con dei paragrafi contenenti le figure dell’amore catalogate con un titolo, una definizione da manuale ed un breve testo che riprende una citazione di altri autori (Barthes solitamente cita la fonte con il nome dell’autore, tranne nel caso del Simposio di Platone e I dolori del giovane Werther per i quali citerà il libro). I riferimenti non vengono considerati come citazioni colte, si tratta piuttosto di prestiti a titolo di amicizia.
Passando per le prospettive filosofiche, a quelle psicologiche ed infine linguistiche, il soggetto analizzato non è necessariamente l’autore in quanto ci sono elementi provenienti dal Werther o da letture culturali, da confidenze e conversazioni amichevoli. La tesi portata avanti da Barthes tra le pagine di questo saggio invita i lettori a riflettere su un concetto fondamentale: nel ‘900 ci si innamorava più dell’idea del sentimento amoroso che della persona amata in sé.
Tra le tante definizioni del libro trovano spazio due concetti chiave: l’attesa e l’assenza dell’amato.
“Sono innamorato? – Sì, poiché sto aspettando”. L’altro, invece, non aspetta mai. Talvolta, ho voglia di giocare a quello che non aspetta; cerco allora di tenermi occupato, di arrivare in ritardo; ma a questo gioco io perdo sempre: qualunque cosa io faccia, mi ritrovo sempre sfaccendato, esatto, o per meglio dire in anticipo. La fatale identità dell’innamorato non è altro che: io sono quello che aspetta.

L’attesa è dunque per Barthes la figura più importante, chi aspetta è sempre innamorato, chi arriva prima a un appuntamento è più innamorato così l’attesa diviene un tumulto di angoscia suscitato dall’attesa dell’essere amato, in seguito a piccoli ritardi, appuntamenti, telefonate, lettere e ritorni. Barthes ci propone una scena divisa in tre atti più il prologo; ci si trova all’interno di un Bar dove l’innamorato attende la persona amata che però tarda ad arrivare. Mentre nel prologo il ritardo è ancora un’entità matematica computabile, nel primo atto il soggetto amoroso dà libero sfogo all’angoscia dell’attesa domandandosi se la persona amata arriverà. Nel secondo atto il soggetto inizia a formulare congetture, “e se per caso non ci fossimo capiti sull’orario, il luogo?”, il soggetto ripensa al momento in cui è stato fissato l’appuntamento e si interroga sul da farsi: “andare in un altro caffè, telefonare? E se l’altro dovesse arrivare mentre io non ci sono e non dovesse trovarmi?”. Nel terzo atto, in chiusura, esplode l’ira, l’angoscia pura, quella dell’abbandono; si passa in un attimo dall’assenza alla morte. L’attesa è dunque per Barthes una sorta di delirio: chi non aspetta chiacchiera e ride, chi attende si proibisce di muoversi o di telefonare per tenersi libero.
A questo punto Barthes analizza l’assenza e ci dice che ogni episodio di linguaggio (concetto caro all’autore in quanto linguista) che mette in scena l’assenza dell’oggetto amato tende a trasformare quest’assenza in una prova di abbandono. Barthes cita Goethe e il suo “I dolori del giovane Werther”: Carlotta (l’oggetto amato) non si muove, Werther (il soggetto amoroso) si allontana. Andando avanti l’autore si serve delle parole di Victor Hugo, affermando che storicamente il discorso dell’assenza viene espresso dalla donna in quanto la donna è fedele e aspetta l’uomo, mentre l’uomo è cacciatore e cerca l’avventura. La conclusione è che l’uomo che attende e che soffre è miracolosamente femminilizzato poiché è innamorato.
Roland Barthes sceglie così di scomporre la letteratura e i sentimenti in frammenti al fine di permettere al lettore di riconoscersi tra le righe del saggio, avendo la sensazione che quei concetti, quelle parole e quelle sensazioni non siano proprie solo dell’autore ma di tutti noi. L’innamorato riesce così ad uscire dall’angoscia della propria solitudine per entrare in una dimensione linguistica e mistica in cui riesce, interpretando i propri sentimenti come se stesse leggendo un manuale, a comprendere in pieno il significato delle proprie emozioni.

Federica De Sanctis è nata a Brindisi nel 1999. Studia alla facoltà di Lettere dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi. Da sempre appassionata di letteratura, arte, musica e lingue straniere. Collezionista e lettrice di libri, cantante e tastierista. Sostiene da sempre l'arte in tutte le sue forme di espressione.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG