
Nella categoria: HOME | Recensioni
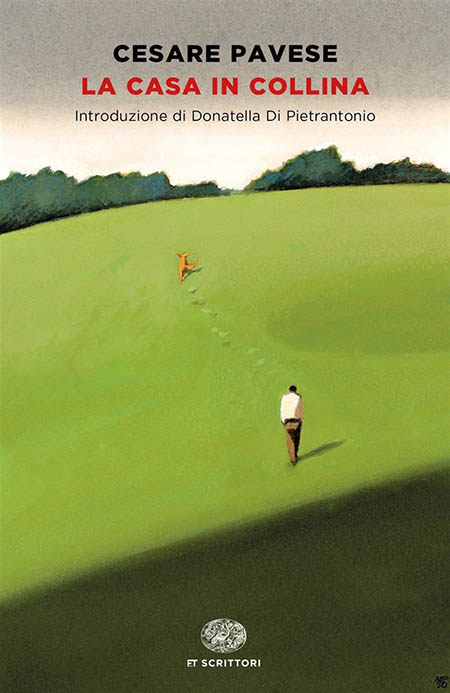
‘Ora che ho visto cos’è la guerra, cos’è la guerra civile, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi: e dei caduti che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere. Non adesso almeno. Né mi pare che gli altri lo sappiano. Forse lo sanno unicamente i morti, e soltanto per loro la guerra è finita davvero.’
Nel panorama della letteratura della resistenza Cesare Pavese rappresenta quell’eccezione che ne conferma la regola o, per meglio dire, il canone; infatti, a differenza di scrittori come Fenoglio o Calvino, Pavese non ha preso parte alla guerra, alla resistenza. Come il migliore esistenzialista, il suo coraggio balbuziente lo spinse su una casa in collina, a guardare la guerra, a sentirne i rumori ma mai a giocarla. Dunque saremmo tentati di dire che il romanzo ‘La casa in collina’, scritto nel 1948, sia un’autobiografia dell’autore, chiedendoci se sia la migliore o la peggiore che potesse scrivere. Ma essa si scosta violentemente da qualsiasi giudizio etico o estetico, appare ingorda di cinismo, morte, vive d’aria sospesa, ci lascia intendere, ammicca e l’unica cosa che rimane in vita sono i morti.
I morti che, come in tutta la letteratura resistenziale, sono l’unica fonte di verità, gli unici che dovrebbero essere vivi e come fantasmi tormentano il compagno rimasto in vita con il loro coraggio perduto, e le loro parole spezzate, e quella verità e quel dolore che solo loro sanno; e con i partigiani caduti muore anche la parola, quella colma, piena. La retorica della colpa affolla le opere del postguerra, di scrittori combattenti che nel loro scrivere si sentono usurpatori, vili, di troppo ma affinché nulla sia dimenticato c’è bisogno di testimonianze. Pavese non resiste al senso di colpa, non resiste alla sua non-morte, si chiede: perché è ancora vivo? Perché lui? Così in quella casa in collina cede alla morte e fa quello che non aveva fatto la guerra o i nazisti o i fascisti: s’ammazza.
‘Sei come un ragazzo, un ragazzo superbo. Di quei ragazzi che gli tocca una disgrazia, gli manca qualcosa, ma loro non vogliono che sia detta, che si sappia che soffrono. Per questo fai pena. Quando parli con gli altri sei sempre cattivo, maligno. Tu hai paura, Corrado.’
Quello che il protagonista dell’opera, Corrado, e di riflesso lo stesso Pavese, vivono, è un’impossibilità etica ed estetica di agire, lo stesso blocco esistenziale e romantico di Michele, personaggio del romanzo moraviano ‘Gli indifferenti’ ma, a differenza di esso, ciò che ostacola e spinge alla fuga, alla nostalgia e all’invidia per i morti Corrado è la violenza. Corrado precipita nella voragine della violenza che come cagna avara più mangia e meno si sazia; rimane impietrito, spaventato non da quello che potrebbe subire ma da quello che potrebbe fare, perché la vera violenza non è mai quella che si patisce ma quella si fa; dunque la paura di diventare carnefice crudele, senza pietà, amore o compassione, fa muovere il personaggio solo all’interno della sua solitudine che graffia e stringe un dolore muto, un pianto archetipo, il timore di diventare tutto ciò che si è sempre odiato... e allora l’unica soluzione diventa arrestare la crescita, frenarsi, uccidersi forse, un giorno.

Celato, avvolto dal suo rigorismo etico che è superbia cinica, Corrado lo strumentalizza contro se stesso, un coltello che affonda nel cuore e scava e trova quella non-scelta, il coraggio mancato, la violenza evitata, eppure tutto ciò che è esistente si staglia come immagine eterea di ciò che è sopravvissuto nonostante tutto, nonostante lui, nonostante il suo ‘no’.
Con ‘La casa in collina’ Pavese quindi entra ed esce da tutti i topoi della letteratura della Resistenza: non partigiano, combattente, ma scrittore, solo scrittore sotto bombordamento, sotto regime ma fuori controllo, isolato in una realtà dell’altrove. Vive la guerra come se l’avesse vista, muore come se l’avesse combattuta. Il senso di colpa, i morti, i vuoti colmi di sangue sono nemici più forti dei nazifascisti. La resistenza di Pavese ha ceduto davanti al peso di un’esistenza ormai balbuziente.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG