
Nella categoria: HOME | Teorie letterarie
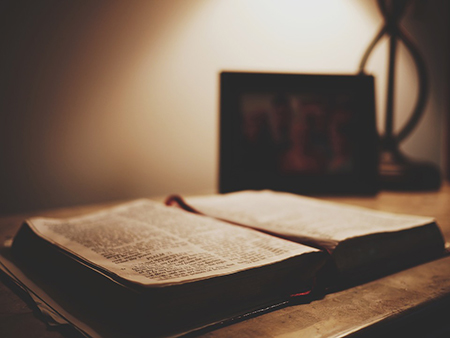
"L'arte non conosce il rumore (nel senso informazionale della parola), è un sistema puro, non c'è, non vi è mai una unità perduta, per lungo allentato tenue che sia, il filo che le collega ad uno dei livelli della storia"
Roland Barthes , L'analisi del racconto
Scrive Blanchot:
Chi scrive l'opera è messo in disparte, chi l'ha scritta è congedato
Così l'opera esiste in sé, nella sua essenziale solitudine e attraverso la fascinazione con cui seduce il lettore si apre alla molteplicità delle interpretazioni. Non tutte le interpretazioni sono plausibili, alcune sono ingiustificate, ma tutte sono consentite. Questa libertà però arranca se l'opera è scritta da un autore che dichiara la propria ispirazione divina e quindi si afferma come portatrice di verità. In questo caso l'interprete liberale (infedele , per i custodi della verità), allontanandosi dalla richiesta ed imposta (in passato in Europa, e ancor oggi altrove, violentemente imposta) lettura dogmatica, si espone al rischio dell'anatema; per fortuna ora, qui, si vive in una società sufficientemente laica e tollerante per cui al massimo leggendo liberamente un testo religioso, il Vangelo di Marco, rischio soltanto una controversia filologica e teologica. Ne vale la pena perché in quel vangelo c'è qualcosa di affascinante che ha su me lettore un effetto vertiginoso.
Per parlarne tuttavia devo introdurre una premessa metodologica, senza la quale l'argomentazione sarebbe privata dei necessari riferimenti critici e della sua esemplarità per la teoria letteraria.
Dunque: la letteratura esiste, c'è. Eppure cosa sia esattamente non si sa. Infatti la domanda che cosa è la letteratura? ha avuto molteplici risposte a seconda delle epoche, delle culture, delle ideologie di chi rispondeva. Era appena nata che già Platone ed Aristotele fornivano definizioni contrastanti. Forse perché è un prodotto bastardo della storia, nato dall'incontro tra oralità affabulatoria, rituale e scrittura in determinate circostanze che portarono una classe sociale aristocratica a caratterizzarsi come letterata, per evolversi poi in modi piuttosto complessi che ne hanno liberalizzato l'esercizio, l'uso e l'abuso. Così è diventata una biblioteca e un canone dalle categorie difficilmente definibili.
Certo si possono usare dei criteri di identificazione. Un criterio formale , secondo cui la letteratura sarebbe un insieme di testi forniti di letterarietà , ovvero distinti da un uso specifico del linguaggio orientato alla forma (sintattica, metrica, retorica). Ma tale letterarietà si incontra ovunque nel linguaggio, dal motto di spirito allo slogan pubblicitario. Oppure un criterio causale , che considera lo scopo per cui un testo è scritto; se non è strumentale bensì gratuitamente rivolto ad un pubblico di lettori allora esso è letterario. Ma se si incontrano opere come le Lettere della marchesa de Savigné, che è ritenuto un capolavoro letterario benché scritto con uno scopo non letterario né gratuito poiché privatamente rivolto all'istruzione della figlia, il criterio si fa evanescente. Infine c'è il criterio di verità , che individua la letteratura come finzione , in cui i testi sono il frutto dell'immaginazione, privi di fattualità e referenzialità.
Sembrerebbe questo il criterio più agevole e valido, apparentemente. Eppure sono moltissime le opere considerate letterarie che non sono finzione; il Principe di Machiavelli e il Discorso sui massimi sistemi di Galilei, ad esempio. Inoltre mentre è abbastanza riconoscibile il carattere finzionale del racconto è discutibile se attribuirlo alla poesia lirica, che è espressione di sentimenti veri dell'autore. Ma la questione essenziale è un'altra: utilizzando questo criterio si entra nel vortice aporetico del concetto di verità , così controverso che l'epistemologia contemporanea ha cercato di sbarazzarsene. Il filosofo ironico non ne ha nostalgia, così come non ama, conseguentemente, la domanda che cosa è? , che insegue sempre l'oggettività e universalità del concetto, dell' idea . Perciò, per sfuggire a definitorie compulsioni veritative sarebbe preferibile ricorrere all'infallibile ovvietà della tautologia e considerare la letteratura come l'insieme di testi che una civiltà di lettori, per consuetudine, educazione, condivisione di sentimenti estetici, riconosce come letterari finché si mantengono tali condizioni culturali e disconosce quando esse mutano. Così è (se vi pare). Allora la letteratura apparirebbe come una biblioteca virtuale, labirintica, dal catalogo un po' confuso e perennemente modificato, con bibliotecari perennemente all'opera.
Ma l'atteggiamento filosoficamente ironico è scarsamente diffuso e inviso ai dogmatici, per cui le controversie sono sempre in agguato quando si tratta di finzione e di verità , specialmente quando il giudizio investe quei testi che potrebbero essere considerati letterari ma che alla letteratura vogliono essere eccentrici in quanto per essi sono decisive l'asserzione della verità e la verità dell'asserzione. Questi testi sono prevalentemente testi religiosi, come i Vangeli . E per questi testi il così è (se vi pare) dell'ironico semina zizzania.
Dunque: è possibile trattare i Vangeli come testi letterari, ovvero finzionali? Ha questo trattamento un valore ermeneutico?
Intanto occorre riconoscere che comunque essi sono basilari nella letteratura occidentale, di cui sono radice e modello. Ad esempio è filologicamente e stilisticamente accertato che la narrativa moderna deriva dal sermo humilis , dal fondo dell'aneddotica evangelica usata nel Medio Evo come repertorio della predicazione; così come è agevolmente riconoscibile la genealogia di personaggi eccellenti: Smerdjakov non è che l'ultimo ritratto di traditore in una galleria che, passando per Gano di Magonza e Jago, inizia con Giuda. Molti altri esempi si potrebbero addurre. Tuttavia mentre certamente i cristiani son pronti ad ammettere, anzi ad esaltare il ruolo intertestuale dei testi evangeli nella tradizione letteraria, devono invece rifiutarne l'appartenenza letteraria, per conservarne e custodirne la finalità non gratuità bensì religiosa e il carattere di testimonianza verace. Per loro la letteratura è finzione , i Vangeli sono documento . Vedremo però un caso in cui dubitare è legittimo e i criteri si rimescolano.
Molti furono i vangeli scritti in epoca protocristiana. Rifiutati i cosiddetti apocrifi perché poco storici e molto romanzeschi (lo Pseudo-Matteo , il Protovangelo di Giacomo , ecc.), la comunità cristiana ne accolse come veridici soltanto quattro, i canonici ; dei canonici tre, quelli di Matteo, Marco e Luca furono accomunati sin dai primordi dell'evangelizzazione in un'unica lettura. Perché ciò fosse agevole vennero redatti in colonne parallele, da cui il nome di sinottici, dal greco synòpsis: "visione d'insieme", che consentisse di verificarne le significative concordanze. O le discordanze, che c'erano.
Una discordanza rilevante si trova nel Vangelo di Marco, là dove si narra della cattura di Gesù nell'orto di Getsemani; vi si legge:
Allora, abbandonatolo, tutti fuggirono. Vi fu però un giovanetto che lo seguiva, avvolto in un lenzuolo sul corpo nudo, e lo presero. Ma lui, lasciato il lenzuolo, scappò via nudo.
La scena è questa: nella notte più angosciosa di Gesù Giuda lo tradisce recando con sé gli uomini che lo devono imprigionare; nella disperata confusione che ne segue un apostolo (forse Pietro) aggredisce uno di loro; allora Gesù, placando gli animi, si lascia catturare. Così, mentre i suoi discepoli smarriti e intimoriti si disperdono, viene condotto al Sinedrio dove sarà processato.
Su ciò concordano i tre vangeli sinottici, e anche il quarto, di Giovanni. Ma la versione di Marco se ne distingue proprio per questa ulteriore drammatizzazione priva di qualsiasi rimando o riscontro negli altri testi evangelici.
Il passo del giovanetto fuggitivo è un vero e proprio microracconto che irrompe nella sequenza narrativa perturbandola, poiché per un momento inclina la prospettica del racconto verso un altro punto di fuga, per ritornare subito dopo sulla vicenda di Cristo. Non se ne comprende la funzione né lo scopo: è uno scarto narrativo che quasi sfugge al lettore, che è concentrato sulla figura di Gesù, come uno di quei movimenti che l'occhio vede ai margini del campo visivo ma la mente ignora perché insignificante.
Gli esegeti testamentari giudicano l'episodio irrilevante, privo di relazione con il contesto e in sé non importante. Per giustificarne la presenza hanno avanzato l'ipotesi che quel giovanetto possa essere stato l'evangelista stesso. Potrebbe essere un'ipotesi plausibile, anche se molto azzardata. Di Marco sappiamo che fu a lungo discepolo di Pietro, da cui probabilmente raccolse la storia di Gesù, ma anche che trascorse la sua infanzia a Gerusalemme, figlio di una Maria nella cui casa si radunavano i primi cristiani; dunque non sarebbe impossibile una sua prossimità alla primitiva piccola congrega degli apostoli.
Se così fosse si comprenderebbe la ragione della sua deviazione dal racconto canonico: Marco non volle rinunciare alla rappresentazione del fatto - insignificante per i lettori del suo vangelo ma non per lui - che per un istante ha fatto incrociare la sua esistenza con quella di Gesù, un istante che nella sua memoria deve essersi dilatato nella temporalità arbitraria e ossessiva del sublime. Che ciò andasse a scapito della coerenza narrativa non s'avvide o non gliene importò: quel frammento di realtà che gli apparteneva doveva essere raccontato, per eternare quello che quella notte gli accadde mentre si svolgeva il destino di Gesù.
Questa ipotesi, ovviamente, non può essere verificata. Negare valore all'episodio eppure ritenerlo per vero comunque è un atto che esprime l'inquietudine, intellettuale e teologica, di chi paventa che l'autore abbia inventato qualcosa, cioè si sia lasciato affascinare dalla finzione letteraria. Cosa che incrinerebbe il valore testimoniale del testo evangelico. Perciò gli esegeti testamentari fanno propria l'avvertenza che Melville ha posto alla fine di Billy Budd :
L'armonia di forme, che si può ottenere in un racconto di pura immaginazione, non è la stessa che si può pretendere da un'opera narrativa molto più simile alla realtà dei fatti che non alla fantasia. La verità narrata senza compromessi presenterà sempre superfici scabre
Ovvero: è proprio perché Marco racconta la verità che il suo racconto presenta questo disarmonico episodio, questa scabrezza del reale che non apparirebbe invece nell'ordine artificiale dell'opera di immaginazione. E' tuttavia evidente che il ragionamento è ottativo.
La tipologia testuale distingue tra cronaca , il racconto di fatti realmente accaduti, e il racconto d'invenzione , che ha finalità estetiche; i vangeli dovrebbero rientrare nel primo tipo. Per questo i canonici sono distinti dagli apocrifi . Tuttavia è arduo orientarsi nelle fluttuazioni che coinvolgono il reale e l'immaginario, sottrarsi all'ipnotica opacità degli stereotipi narrativi o alle ovvietà di cui il reale si ammanta nel giudizio; specialmente quando si è di fronte ad un testo divenuto oggetto di fede. Avanzo quindi un'altra ipotesi: che l'episodio del giovanetto possa essere uno di quei nodi narrativi in cui la realtà devia verso la finzione trasformando la testimonianza in puro atto letterario, rimandando perciò ad altri livelli di senso.
Un esempio, per introdurre l'ipotesi. In Morte a Venezia l'esordio ci presenta l'inquieto protagonista, Aschenbach, che in un primaverile pomeriggio gravido di pioggia attende il tram presso il cimitero; nell'attesa si sofferma a scrutare un uomo dall'aspetto strano, atteggiato con il "braccio sinistro puntato sull'anca"; un insignificante particolare che tuttavia nella conclusione del racconto diventa rilevantissimo, perché nel momento della sua morte ad Aschenbach sembra di intravedere il suo giovane amato che "staccando la mano dall'anca, gli indicasse l'orizzonte lontano". Quindi il particolare descrittivo della mano sull'anca consente di sovrapporre simbolicamente le due figure dell'uomo del cimitero e dell'efebo e di interpretarle come l'epifania di un destino che si sdipana, rivelandoci la mortale necessità che il racconto cela.
Il testo letterario è un microcosmo creato dal suo demiurgo secondo una logica che ne fonda il senso. Il racconto è un mosaico in cui ogni tessera si dispone in una forma e in un ordine atti a determinare la totalità della rappresentazione, un tessuto in cui la trama e l'ordito degli eventi, dei personaggi, delle descrizioni si snodano seguendo un disegno dove nulla è accidentale, tutto necessario. Può dunque accadere in un racconto che dalla solitudine immensa del mare emerga l'alter ego di un uomo (com'è in Il compagno segreto di Conrad), che un altro uomo si trasformi in un ripugnante insetto (com'è in La metamorfosi di Kafka), che in Morte a Venezia un personaggio sia l'ombra di un altro; eppure di ciò non ci si stupisce, poiché ragioniamo secondo la coerenza incantata dell'affabulazione che il narratore ci propone come in un gioco di prestigio.
Invece la sequenza del giovane fuggitivo di Marco ci stupisce. Lo stupore nasce proprio perché si avverte l'incoerenza del particolare, la forzatura dell'inserto nel documento. Se tuttavia io tratto il brano evangelico non come un documento bensì come un fatto letterario allora quell'incoerenza narrativa non deve sussistere, deve essere apparente. Se pare stavolta che il prestigiatore abbia compiuto un gesto sbagliato, rompendo l'incanto, svelando il trucco, infrangendo l'intimo accordo stipulato col lettore, in virtù del quale questi ha sospeso il giudizio di realtà ed è penetrato nel mondo virtuale dell'immaginario, allora se ne deve rintracciare l'implicita necessità.
Il testo è una macchina pigra, che attende l'opera di decifrazione del lettore per manifestare il proprio senso. E il lettore ha un indizio da seguire che può mettere il cammino dell'interpretazione sulla via letteraria dell' allegoria .
Se nella traduzione italiana si trova la parola "lenzuolo" nell'originale si legge invece sindon , che si conserva anche nella versione latina del testo, la quale opportunamente non usa linteum , che significa "telo", "vela di lino", "tenda", né il suo diminutivo linteolum. La questione non è di poco conto, perché sindone non è semplicemente un lenzuolo bensì il drappo di lino col quale gli Ebrei usavano avvolgere i cadaveri dei defunti per la sepoltura. Non c'è dubbio che questa non lieve sfumatura semantica insinua nel già sconcertante episodio evangelico un ulteriore elemento enigmatico: che ci fa sulla scena della cattura di Gesù un giovanetto avvolto in un lenzuolo funebre che copre la sua nudità per poi scomparire come uno spettro nella notte?
L'ipotesi autobiografica degli esegeti testamentari, che si basa sulla presunta veridicità dell'episodio, non può non ritrarsi davanti al riconoscimento di tale inesplicabile inverosimiglianza. Inesplicabile finché non si scelga una lettura simbolica, nel qual caso il giovane fuggitivo e la sua repentina apparizione nel racconto potrebbero recuperare un senso. In questo contesto interpretativo si potrebbe pensarlo nei termini di un' ombra junghiana, che incarna l'inconscio destino di Gesù; oppure come il doppio che si sottrae in sua vece alla morte, quasi che il racconto volesse clandestinamente proporre un'altra possibilità a se stesso; oppure ancora potrebbe trattarsi di un allegorico annuncio della prossima resurrezione.
Ulteriori sviluppi dell'interpretazione non sembrano possibili, al di là del riconoscimento di una simmetria che lega Gesù e il giovanetto, la cattura e la morte dell'uno e la fuga e la vita dell'altro. Si potrebbe ricorrere al simbolismo del colore: la sindone è bianca, il bianco esprime la condizione della purezza, il giovanetto avvolto nel funebre lenzuolo bianco è dunque candidus, candidatus , ovvero colui che aspira ad un nuovo stato. Ciò tuttavia, mentre conferma la funzione di duplicazione simbolica dell'inserto rispetto alla storia evangelica, aggiunge ben poco all'interpretazione. Piuttosto avvicina un po' Marco alla sublimità di Giovanni; ma questo è pane per i teologi.
Infine, comunque, il riconoscimento di una intenzionalità allegorica dell'episodio lo introduce nello spazio della letteratura e lo sottrae finalmente al giudizio di irrelevanza che l'accompagna, perché invece è appunto letterariamente rilevante. E cessa di essere strano: è proprio del racconto di aprirsi ad espansioni imprevedibili, com'è in questo caso, alle disgiunzioni delle possibilità narrative; ma ciò che ad un livello si disgiunge si integra ad un livello superiore, nella costruzione di una isotopia in cui si realizza l'unità del senso e che ad esso impedisce - per dirla con Barthes - di "ballare", cioè di cadere nell'incoerenza.

Tiziano Gorini (Livorno, classe 1953), ha trascorso una vita estenuandosi nel provare ad insegnare Lingua e letteratura italiana e Storia; all'insegnamento ha sempre affiancato la ricerca, spaziando dalla critica letteraria all'epistemologia, dalla storia della scienza alla pedagogia. Ha pubblicato con M. Carboni e O. Galliani Le stanze di Ophelia, il manuale di storia della letteratura Excursus e Il professore riluttante. Di se stesso pensa di essere una brutta copia dell'uomo rinascimentale, perché come gli umanisti del Rinascimento girovaga tra i molteplici campi della conoscenza e dell'arte, ma - a parer suo - con mediocri risultati. Nel tempo libero soprattutto legge e scrive, altrimenti se ne va a contemplare il mare e le nuvole.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG