
di Raffaella Di Meglio
Nella categoria: HOME | Articoli critici
Analisi:
• Invocazione agli dei
• Nell'ombra della notte solitaria
• Gli abitanti dell'oltretomba
• L'albero e i mostri infernali
• La trepidazione di Enea
• Caronte
• Le anime degli insepolti
>> Visualizza il testo e la sua traduzione <<
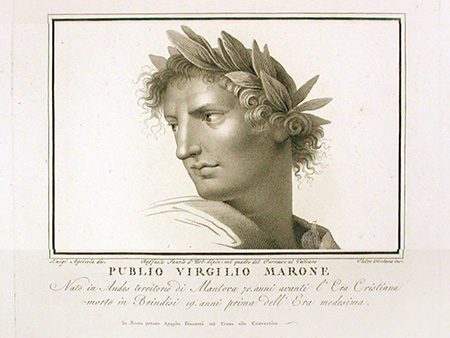
Il VI libro dell’Eneide costituisce
lo spartiacque tra la prima parte del poema, dedicata al racconto delle
peripezie di Enea e la seconda, incentrata sulle guerre condotte nel Lazio
dall’eroe troiano per fondare una nuova stirpe, secondo la profezia
ascoltata dal padre Anchise proprio alla fine del libro VI.
Approdato a Cuma e udita la profezia della Sibilla, Enea, si accinge,
insieme ad essa, ad entrare negli Inferi per incontrare l’ombra
del padre, che gli indicherà i grandi personaggi della futura Roma,
in un passo esemplificativo dell’intento celebrativo del poema.
Nella rappresentazione del mondo sotterraneo Virgilio mette però
da parte la finalità etico-pedagogica e rivela tutte le sue qualità
di artista. Il poeta utilizza e fonde insieme diverse fonti rielaborandole
con la sua fantasia, come risalta fin dall’invocazione iniziale:
non solo la tradizione poetica (Omero innanzitutto, Esiodo) e filosofica
greca ed ellenistica, ma anche la cultura religiosa orfica, la civiltà
etrusca (Caronte ad esempio) e le credenze popolari (Orcus).
La suggestione della descrizione è amplificata dagli elementi distintivi
del linguaggio poetico virgiliano: fonosimbolismo, uso dell’aggettivazione,
similitudini.
La narrazione della catabasi è preceduta dalla classica
invocazione agli dei (vv.264-267): qui, però, il poeta si rivolge
agli dei infernali (Plutone e Proserpina), alle ombre dei morti, a Caos
e Flegetonte e ai luoghi stessi. Virgilio è consapevole del carattere
misterico, della difficoltà e diversità della materia: l’invocazione
non vuole infatti ottenere l’ispirazione ma il permesso (sit
mihi fas, numine vestro) di svelare segreti impenetrabili agli umani.
Espressiva a questo proposito la collocazione delle parole pandere
e mersas, dal significato opposto, ai due estremi del verso 267:
data la difficoltà dell’argomento, Virgilio sceglie un verbo,
pandere, derivato da Lucrezio, suo maestro e modello, sebbene
il poeta mantovano si accinga ad “aprire”, a rivelare proprio
quel mondo infernale mersus, “nascosto”, che Lucrezio
aveva tentato di dimostrare inesistente per liberare gli uomini dalla
paura della morte.
Fin dall’invocazione questo mondo “altro” è connotato
con sostantivi ed aggettivi che ne indicano il silenzio, l’oscurità
e la vastità (umbrae … silentes, efficace sinestesia,
loca nocte tacentia late, res … caligine mersas)
e che creano un’atmosfera irreale, misteriosa, segreta. Il ricorrente
suono cupo della /u/ al v. 264 e della /o/ al v. 265, nonché l’iterazione
di -um al v. 264 (imperium, animarum,
umbrae) intensificano a livello fonico la lugubre
cupezza del luogo e allo stesso tempo conferiscono solennità all’invocazione.
Nell’ombra della notte solitaria
Al v. 268 l’imperfetto ibant segna la ripresa della
narrazione, riportando l’attenzione su Enea e Deifobe, soggetti
sottintesi, perché il vero protagonista di tutto il passo è
l’oltretomba.
Fino al v. 272 Virgilio insiste ancora sull’immagine dell’oscurità
(obscuri, sub nocte, per umbram) e della solitudine, dell’assenza
di vita (sola sub nocte, domos vacua, inania regna), servendosi
di espressioni vaghe, indeterminate che creano nel lettore uno stato di
suspense, di attesa e di curiosità verso una realtà temuta
e costantemente presente nella vita e nella mente dell’uomo romano.
Il v. 268 con la lentezza degli spondei iniziali accentua l’effetto
suggestivo ottenuto con la scelta degli aggettivi obscuri e sola. Da notare
inoltre la costruzione del v. 269, dove Virgilio accosta ad un’immagine
concreta (domos Ditis) una generica (inania regna) e
unisce due aggettivi sinonimici (vacuas et inania), ad amplificare
il senso di vastità irreale del luogo; suggestivo anche l’iterato
suono cupo della /o/ e della /u/ e della sibilante /s/ (obscuri sola
sub) nel v. 268. Per dare più efficacia all’immagine,
il poeta inserisce una similitudine, paragonando l’antro ai boschi
(allusione all’impenetrabilità dei luoghi sotterranei) e
la luce a quella della luna incerta.
Risaltano alcune corrispondenze con i versi precedenti, quali la ripresa
delle preposizioni per e sub, aggettivi espressivi, incertam
e maligna (particolarmente significativa l’etimologia di
quest’ultimo aggettivo: malus gigno= cattivo per natura)
e di nuovo immagini di buio, di assenza di colore (umbra, come
nox, compare per la terza volta nel giro di otto versi, anche
se al primo nel significato di ombre dei morti, con il quale la ritroviamo
anche ai vv. 289 e 294).
Al v. 273 quest’atmosfera caliginosa (caligine,
v. 267) inizia a diradarsi, le porte si aprono (pandere), si
entra nella domos Ditis, a partire dal vestibulum, elemento
inedito, introdotto da Virgilio per la prima volta (forse di derivazione
orfica).
Per dare credibilità, verosimiglianza alla sua descrizione, per
renderla immaginabile al lettore, ma anche per esorcizzare la paura dell’oltretomba,
Virgilio assimila l’estraneo al familiare, mescola realtà
e fantasia, concretezza ed indeterminatezza, umanità e disumanità
(basti pensare all’indicazione vestibulum ante ipsum del
v. 273 precisata subito dopo con quella fantastica primisque in faucibus
Orci): si spiega così il suo frequente ricorrere ad indicazioni
di luogo attraverso complementi (vestibulum ante ipsum, primisque
in faucibus Orci, adverso in limine v. 279, in medio v.
282, in foribus v. 286) o avverbi (hinc v.295, huc
v.305) o il tentativo di dare una connotazione umana a quei luoghi (domos
Ditis v. 269, posuere cubilia v. 274, habitant
v. 275, Eumenidum thalami v. 280, stabulant v. 286).
Nell’intento rientra anche l’uso del presente storico che,
oltre a segnalare una pausa rispetto alla narrazione vera e propria e
ad alludere alla realtà eterna di quei luoghi, conferisce vivezza
alla descrizione.
I vv. 274-289 costituiscono (con la breve interruzione dei vv. 282-284)
un esempio di letteratura catalogica, che risponde ad una tendenza tipica
dei Romani alla parata e rivela l’esperienza alessandrino-neoterica
di Virgilio. Qui, però, non sono enumerati, come in occasione dell’incontro
con Anchise, eroi o illustri personaggi, ma le prime orrende figure (terribiles
visu formae) che abitano il vestibolo: rappresentano le personificazioni
dei mali naturali e morali che tormentano l’umanità. Si tratta
di formae, non meglio determinate, semplicemente citate o connotate
mediante aggettivi che alludono agli effetti provocati sull’uomo
(pallentes Morbi, tristis Senectus, malesuada Fames, turpis egestas,
mala mentis Gaudia, mortiferum Bellum, Discordia demens). Non hanno
rilievo fisico, Virgilio non dà loro una riconoscibilità,
lasciandole astratte, ad eccezione dei ferrei thalami delle Furie
e della Discordia la cui descrizione occupa un verso e due piedi.
L’angosciante stupore provocato da questo strano corteo è
sottolineato dal ritmo incalzante del polisindeto variato e da alcuni
artifici stilistici, come le allitterazioni Letumque Labosque, mala
mentis, Discordia demens, vipereum vittis, crinem cruentis.
Negli ultimi tre versi non è difficile scorgere riferimenti all’attualità
(mortiferum Bellum, Discordia demens) e nella scelta degli aggettivi
lo spirito pacifista di Virgilio.
L’elenco è interrotto da una breve sequenza
(vv. 282-284) dedicata all’ulmus opaca ingens, albero infernale
perché non produce frutti e sede dei Sogni vani, secondo un’antichissima
credenza che immagina i sogni come demoni-uccelli: anche qui risalta l’abilità
del poeta nell’uso di aggettivi comuni (come ingens) che,
inseriti in particolari contesti, acquistano un valore evocativo di grande
efficacia. In questo caso, poi, l’enjambement
ai vv. 282-283 (pandit ulmus), la sinalefe al v. 283 (opaca ingens), l’asindeto
e la cesura dopo ingens
paiono voler rappresentare visivamente la mole minacciosa ed inquietante
dell’albero i cui rami sono assimilati a braccia umane.
La rassegna prosegue poi con i veri e propri monstra, ibridazioni
di diverse bestie (ma l’animalità era già implicita
in espressioni come in faucibus Orci del v. 273 e cubilia
del verso successivo), la cui ferinità è sottolineata dal
verbo stabulant, riferito propriamente ai Centauri ma allargato
con uno zeugma a tutti gli
altri. Virgilio ha modo di sfoggiare la sua erudizione inserendo le Scille,
donne-pesce, il gigante Briareo dalle cento braccia, la belva di Lerna,
sorella di Cerbero, la Chimera, le Gorgoni, le Arpie e Gerione, mostri
che rompono il silenzio (ma già i ferrei thalami suggerivano
sinistri stridori metallici), preparando quello che sarà il vero
e proprio paesaggio infernale.
Solo a questo punto Enea è nominato perché Virgilio interrompe la descrizione per riportare lo sguardo sull’eroe e descriverne la reazione di fronte a tale fitta nube di mostri (vv. 290-294): al v. 290 il verbo corripit (continua l’uso del presente) in incipit, il ritmo dattilico e l’allitterazione formidine ferrum accompagnano la velocità del gesto impulsivo di Enea (il nome compare in iperbato e in enjambement all’inizio del verso successivo) che afferra la spada istintivamente, mentre in posizione centrale compare trepidus, aggettivo tipicamente virgiliano. L’iterazione della /r/, raddoppiata (corripit, ferrum) o in unione con altre consonanti (trepidus, formidine, inruat, frustra, diverberet umbras) rende, attraverso la durezza fonica, l’agitazione dell’eroe pronto allo scontro. Vi si oppone la “dottrina” della Sibilla (la solennità è accentuata dagli arcaismi ni e tenuis) che ammonisce Enea tranquillizzandolo sull’inoffensività di quelle che sono solo ombre prive di consistenza (nel v. 293 è evidente il debito verso Lucrezio da cui è ripreso il frequentativo volitare): al suono aspro dei versi iniziali si oppone così quello aperto e chiaro della /a/ (ben cinque sono in arsi).
Dal v. 295 prosegue il cammino verso le sponde dell’Acheronte.
Significativa la paronomasia
tra umbras (v. 294) e undas (v. 295) che crea una corrispondenza
tra le ombre svolazzanti e spaventose dei mostri e le onde torbide e agitate
dell’Acheronte. Sullo sfondo di un paesaggio primordiale (il pensiero
ritorna al Chaos invocato all’inizio di ascendenza orfica) di acque
fangose e ribollenti (da notare l’espressività del v. 296:
l’iperbato che evidenzia turbidus e gurges ai
due estremi, l’effetto onomatopeico creato dai gruppi consonantici,
l’allitterazione vasta voragine, l’enjambement), appare la
figura più viva di questo brano, Caronte, a cui è dedicata
la più lunga sequenza descrittiva (vv. 298-304).
Il nome è enfaticamente ritardato al v. 299 (anche questa tendenza
all’occultamento del soggetto, come quella all’abolizione
delle preposizioni, concorre a dare ambiguità, suspense al racconto)
dove acquista evidenza per la cesura eftemimera. Virgilio lo presenta
innanzitutto attraverso la sua funzione con l’apposizione portitor
(al v. 315 sarà navita) seguita da un aggettivo, horrendus
che introduce, insieme a terribili squalore (richiama terribiles visu
formae del v. 277), la descrizione del personaggio, incentrata su
due elementi, la ruvidezza e la sporcizia (horrendus da horreo
= essere irto, squalor da squaleo = essere ruvido).
La descrizione è sviluppata nei versi successivi attraverso tre
proposizioni relative introdotte da cui e coordinate per asindeto. Si
tratta di una caratterizzazione fisiognomica: la barba incolta e lo sporco
mantello da marinaio precisano il senso di quell’horridus
e di squalor. La scelta del verbo iacet accentua il
senso di trascuratezza, stant di fissità irreale della
figura (da notare il chiasmo
che avvicina i due verbi).
La corrispondenza tra paesaggio (al v. 298 il pleonasmo
aquas et flumina amplifica il senso di vastità e di mistero
dei luogo) e personaggio è sottolineata dal parallelismo sintattico
tra il v. 301 e il v. 296: aggettivo in incipit (turbidus - sordidus)
separato in iperbato dal sostantivo in explicit (gurges - amictus).
Un eguale gusto simmetrico (e anche musicale) rivela inoltre, nei vv.
298-300, la scelta di parole isosillabiche e isometriche (quinto piede
dattilico): flumina, plurima e lumina.
Tutta la descrizione di Caronte è caratterizzata da espressioni
ambigue, forse a tradurre anche sintatticamente lo stupore e lo spavento
provocato da quest’apparizione: pensiamo a stant lumina flamma
al v. 300 (dove flamma può essere interpretato come ablativo
di materia senza preposizione o, meno probabilmente, come apposizione
o predicativo di lumina); a subvectat (il ricorrere
della preposizione sub soprattutto nella parte iniziale del passo,
al v.293 e nella composizione dei verbi riferiti a Caronte, subigit
e subvectat, potrebbe essere un’allusione, magari non consapevole,
al mondo sommerso, sub-umano) corpora cumba al v. 303 (dove cumba
può essere inteso come ablativo di mezzo o compl. di stato in luogo
senza preposizione); a cruda deo viridisque senectus al v. 304
(dove sorprende l’uso variato di senectus e l’ellissi
del verbo, mentre deo può essere inteso come dativo di
possesso (in questo caso il verbo sottinteso sarebbe est) o dativo
dipendente dagli aggettivi.
Quella di Caronte è un’immagine talmente forte, quasi ipnotica
(stant lumina flamma) da restare isolata, da catturare su di
sé tutta l’attenzione. Solo al v. 302 il poeta lo “umanizza”
rappresentandolo, quasi con stupore (ipse), dato l’aspetto
fisico, nell’atto di governare la barca, qui definita ratis
(zattera) come a completare il quadro di squallore (mentre al v. 303 è
indicata come cumba per creare allitterazione con corpora):
è comunque una vera e propria barca dotata di pertica e di vele
(ancora uno sforzo di precisione realistica di Virgilio), ma ferruginea
(ricordiamo i ferrei thalami del v. 280) perché tutto
qui è sommerso dalla caligo (v. 267).
In questo paesaggio monocromo (rebus nox abstulit atra colorem,
v.272), grigio e opaco, spicca dunque una sola luce, un solo, infernale
colore: il rosso, quello delle bende insanguinate della Discordia, delle
fiamme della Chimera e quello degli occhi di Caronte.
Al v. 304 Virgilio rivela che è un vecchio, ma un vecchio robusto
come può essere solo un dio (significativo l’ossimoro viridis
senectus che accentua la diversità fantastica del personaggio).
L’immagine virgiliana di Caronte ha esercitato una profonda suggestione
nella tradizione poetica: basti pensare alla descrizione del demone infernale
nel canto III dell’Inferno dantesco.
Ai vv. 305-316 l’inquadratura si sposta sulla turba
delle anime degli insepolti che attendono sulle sponde dell’Acheronte
(l’huc si riallaccia ai vv.295-297) di essere traghettati
sull’altra sponda. Ritorna l’imperfetto (ibant del
v. 268) al posto del presente, forse per indicare la continuità
senza fine di una scena che si ripete in eterno. Virgilio vuole comunicare
l’idea della moltitudine e, prima di ricorrere alle due famose similitudini
riprese da Dante (Inferno, III), lo fa attraverso le parole: omnis
turba, pleonasmo (dove omnis nella sua indefinitezza rende
l’idea dell’incalcolabile quantità), effusa,
usato propriamente per i liquidi che si spargono, ad indicare l’ansioso
accorrere disordinato (ruebat). Virgilio passa dal campo lungo
al piano ravvicinato per dare un volto a quell’anonima omnis
turba (i vv. 306-308 si trovano identici anche nella parte del IV
libro delle Georgiche dedicata alla catabasi di Orfeo): il pathos della
scena è intensificato dal ritmo incalzante del polisindeto variato,
dalla suggestiva espressione defunctaque corpora vita, con l’effetto
emozionale creato dalla ridondanza defuncta vita.
Seguono le due similitudini coordinate dal nesso disgiuntivo aut,
introdotte entrambe da quam multa-ae e accomunate dall’immagine
del volo (quello obliquo delle foglie secche lapsa, quello degli
uccelli migratori) perché le anime sono volteggianti, ma asimmetriche.
La seconda occupa ben due versi e mezzo, ha dunque una lunghezza doppia
rispetto alla prima e maggiore complessità sintattica: anziché
al semplice complemento di tempo (autumni frigore primo), il
poeta ricorre a proposizioni temporali coordinate introdotte da ubi.
Questo maggiore rilievo non è senza significato, in quanto il secondo
paragone, oltre a visualizzare la massa (glomerantur), rende
anche l’idea della corsa precipitosa (fugat) da un luogo
inospitale (gurgite ab alto che richiama gurges dell’Acheronte)
a terris apricis (i Campi Elisi). Sia per le foglie che per gli
uccelli la spinta è il freddo, per le anime ripae ulterioris
amor, che ha la stessa irresistibile forza di quella naturale della
stagione fredda.
Questi ultimi versi rivelano la pietas del poeta che ora guarda quelle
anime ora ferme (stabant) sulla riva a pregare con le mani tese
verso l’altra sponda: la tristezza dell’immagine è
intensificata dal ritmo lento degli spondei e dalla forte pausa al v.
314, mentre la presenza commossa del poeta è evidenziata dall’aggettivo
riferito a Caronte, tristis, (la ruvidezza fisica è anche
ruvidezza morale) e dall’avversativa sed al v. 315.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG