
Nella categoria: HOME | Articoli critici
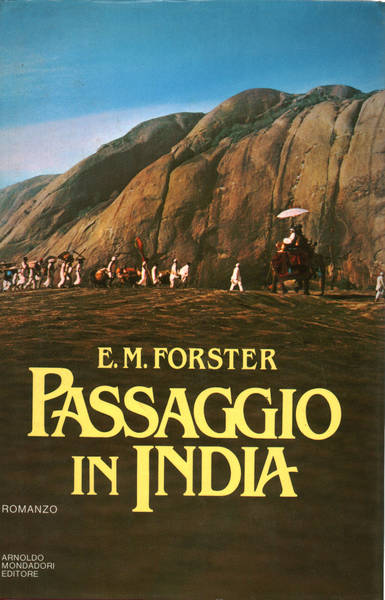
Il romanzo e il suo contesto
E. M. Forster è un classico della letteratura. Già nel 1927 Richards parlò di un “culto” per lo scrittore [1], nel 1943 Trilling gli dedicò un libro fondamentale [2], l’interesse per la sua narrativa andò crescendo nella seconda metà del ‘900, spostandosi dall’assenso militante alle sue tematiche (gradite allo schieramento liberal) verso l’analisi stilistica e formale; è stato sempre apprezzato dalla critica, studiato in numerosi saggi e monografie, è stata anche realizzata una edizione dell’opera omnia. Infine, ad ulteriore conferma del suo successo, alcuni suoi romanzi sono stati tradotti in film, come Camera con vista e Casa Howard.
Fu contemporaneo degli altri grandi romanzieri del primo Novecento: Mann, Kafka, Proust, Joyce, Svevo, e i suoi romanzi s’accompagnano ai loro; Ulisse, ad esempio, è del 1922, Il processo del 1925, La montagna incantata del 1924, lo stesso anno di pubblicazione di Passaggio in India.
Eppure come una di quelle persone che nelle foto di gruppo serbate per ricordo si trovano sempre a lato, per propria timidezza o perché relegatevi dall’altrui protagonismo, così nella schiera dei grandi autori novecenteschi Forster sembra situato ai margini (ne è prova il fatto che raramente lo si incontra nelle antologie letterarie, cioè laddove si cristallizza il canone). Ciò è sicuramente dovuto al fatto che non ne condivide le tendenze innovatrici: avulse dalle sperimentazioni linguistiche e dalla ricerca introspettiva, le sue opere seguono la linearità narrativa del romanzo ottocentesco, i suoi riferimenti possono essere autori come Austen e James. Apparentemente volto al passato e molto anglosassone, come narratore novecentesco è quindi difficilmente classificabile e meno apprezzabile di altri. Anche se si sa che i giudizi di valore della storia letteraria sono mobili e sempre riscrivibili da qualche bastian contrario di talento.
Tuttavia se dal giudizio complessivo si passa a quello sulle singole opere occorre riconoscere che c’è un romanzo eccezionalmente affascinante ed interessante, che può ergersi accanto a quei grandi ricordati prima e anzi manifesta una rilevante attualità ideologica. E’ Passaggio in India.
All’inizio di Morte a Venezia presentando il protagonista Mann lo descrive come uno scrittore “troppo occupato dai problemi posti dal proprio io e dall’anima europea”; indubbiamente Joyce, Proust, Mann, ecc. sono tutti collocabili entro questa descrizione, e i loro racconti sono sempre variazioni tematiche di quei problemi, tanto che infine ci s’annoia quando la variabilità diventa una moda a disposizione degli epigoni. Invece Passaggio in India distende un orizzonte più ampio dell’anima europea, disegna paesaggi geografici (la storia si svolge nell’India coloniale) ed interiori (si narrano mentalità e comportamenti esotici) che raramente s’incontrano nella letteratura contemporanea occidentale; comunque non a questo livello estetico ed etico.
Non è certo un caso che il suo autore sia di nazionalità britannica, cioè membro di un impero coloniale esteso a tutto il mondo. L’imperialismo curvò la letteratura verso l’esotismo ma ne ampliò l’immaginario con nuovi ambienti, nuove trame, nuove idee; con Kipling trovò la propria mitologia (anche se Kipling non è solamente e semplicemente il cantore dell’imperialismo [3]), con Cuore di tenebra di Conrad e Passaggio in India la propria demistificazione.
In Passaggio in India è centrale la consapevolezza dei limiti di tutta una tradizione culturale. E’ un romanzo che rappresenta, tra realismo e simbolismo, lo scontro tra l’Occidente e l’Oriente, il loro epocale culturale dissidio; con l’onestà di non darvi soluzione, intravedendo ombre non illuminabili dalla ratio europea, rispettando l’enigma che l’uno è per l’altro.
La trama
La trama è apparentemente semplice e lineare. Apparentemente: perché invece è complicata da una complementare trama simbolica che costella il racconto di enigmi e di intrecci clandestini. Per esempio l’accostamento – che non si lascia compiutamente decifrare - di Mrs. Moore e la vespa, che si presenta come marginale all’inizio della storia per rivelarsi essenziale nella visione finale di Godbole, il bhramino) [4].
Mrs. Moore e Adela, la madre e la fidanzata di un giovane funzionario britannico si recano in India perché la ragazza possa conoscere la vita che l’attenderà laggiù una volta sposata. Le due donne cercano di comprendere la realtà indiana, forzando i pregiudizi della ristretta élite dei coloniali; così fanno amicizia con un medico musulmano, Aziz, che per ingraziarsele e dimostrarsi ospitale le conduce in gita presso delle grotte fuori dalla città. La gita tuttavia ha un esito infausto: l’anziana signora uscirà sconvolta dalla visita di una grotta, la giovane addirittura fugge fuori di sé convinta di essere stata aggredita da Aziz. Il quale viene incarcerato e processato, mentre si rischia la rivolta perché la popolazione indigena protesta contro l’amministrazione inglese per quella che ritiene un’ingiustizia razzista. Durante il processo però è proprio la stessa Adela a discolpare il medico, rendendosi improvvisamente conto di essersi sbagliata, d’aver avuto una sorta di allucinazione. Aziz dunque viene scagionato e Adela, ormai disprezzata dalla locale comunità britannica, torna in patria; Mrs. Moore muore durante il viaggio di ritorno; Fielding, l’unico inglese che si era schierato in difesa del medico, sposerà più tardi la figlia di Mrs. Moore. L’epilogo del romanzo è l’incontro, dopo alcuni anni, tra Aziz e Fielding, in cui ricordano quegli eventi e la grazia di Mrs. Moore. Un incontro in cui, pur con la nostalgia per la trascorsa amicizia, si rendono conto che essa non può sussistere, poiché appartengono a due mondi differenti e contrastanti. Poiché questa è la storia appunto del fallimento della volontà d’incontrarsi tra le due culture d’Occidente e d’Oriente; fallimento che Forster incarna in Mrs. Moore (la vera protagonista del romanzo, la persona anziana e saggia, adatta a far da ponte ideale tra gli estremi opposti, come il Mr. Emerson di Camera con vista e la Mrs. Wilcox di Casa Howards), la cui figura diviene infine l’espressione della consapevolezza della tragicità della vita. Ma perché ciò avvenga ella deve attraversare l’esperienza fondamentale della propria vita, una sorta di discesa agli inferi qual è la visita agli antri del Marabar, antichi e misteriosi luoghi di preghiera; un’esperienza che consente a Forster di curvare la storia verso una dimensione metafisica espressa con una forza stilistica straordinaria.

Il tema della caverna
Ogni racconto ha un centro, un fulcro in cui si incardinano le linee di forza narrative. Questo centro in Passaggio in India è l’episodio dell’escursione alle caverne dei monti Marabar, dove avviene l’incidente drammatico che scatena passioni, timori, rancori. Per uno dei personaggi - la vera protagonista: l’anziana, empatica e pacata Mrs. Moore - l’ingresso in una di queste è uno shock dall’esito angoscioso.
La caverna è il luogo emblematico di drammi esistenziali e, soprattutto, metafisici, frequentato dalla letteratura (ad esempio il racconto di Beckett, l’angoscioso Le depeupleur, e quello di Pirandello, il commovente Ciaula scopre la luna) e dalla filosofia (ad esempio il mito platonico del dialogo La repubblica [6] e il sogno leonardesco della “scura spilonca” [7]). Scenario primigenio di miti cosmogonici e leggende, il misterioso vestibolo del mondo sotterraneo, il santuario arcaico di molti culti religiosi, funebri e iniziatici, adornato di pitture rupestri e graffiti, poiché è il posto dove è possibile la comunicazione con le potenze ctonie. Ad esempio nella tradizione mediterranea le caverne spesso erano considerate luoghi di nascita di dei ed eroi, nonché dimore di oracoli; il mondo religioso cretese-miceneo conosceva caverne sacre, ma lo stesso accade in quello orientale; nelle leggende popolari furono dimora di gnomi e draghi. Perciò è sempre stato uno spazio simbolicamente intenso. Nelle tradizioni iniziatiche greche l'antro rappresenta il mondo, ma è anche la cavità oscura, regione sotterranea dai limiti invisibili, abisso spaventoso da cui emergono mostri, in cui si sotterrano i morti che cominciano così il viaggio nell'oltretomba; è anche luogo di rinascita, perché la discesa agli inferi è un momento preliminare al nuovo avvento nel mondo; è anche principio femminile, come nei misteri eleusini in cui era il protettivo grembo della Madre Terra, e simulacro cosmico, come nella religione zoroastrica e nel neoplatonismo. Misterioso e misterico confine tra l’umano e il divino e perciò luogo di eventi straordinari come la nascita e la resurrezione di Gesù e la rivelazione all’apostolo Giovanni dell’Apocalisse.
Qualcosa di analogo accade a Mrs. Moore: nella cripta ella vive l’esperienza di una eco terrificante, che provocherà in lei una catastrofe esistenziale. Infatti appena esce dalla grotta già s’accorge che l’eco
stava cominciando a minare la sua vita in chissà quale indescrivibile modo
Che ha, dunque, di terrificante questa eco? In sé, nulla. L’eco è un incanto, inquietante per una mente arcaica, ormai dissolto dalla scienza: non si tratta altro che di una ripetizione di suoni provocata dalla riflessione delle onde sonore. Eppure l’eco di quella grotta è diversa da ogni altra: è un’eco indistinta, poiché ad ogni suono risponde sempre uno stesso rumore cupo, monotono ed ossessivo che rimbomba strisciando sulle pareti della grotta finché non sprofonda nel silenzio.
A qualunque cosa si dica, risponde lo stesso rumore monotono, e vibra su e giù per le pareti finché il soffitto non lo assorbe. ‘Bum’ è il suono, fin dove l’alfabeto umano può renderlo, o ‘bu-um’ oppure ‘u-bum’ – completamente ottuso.
L’impressione che l’eco provoca in Mrs. Moore è una catastrofe fisica e morale, perché la smarrisce in un vortice di malinconia, rivelandole l’indifferenza cosmica per l’umanità. L’iniziale malessere, una crisi di panico, si dilata fino a diventare malattia mortale.
Se in quel luogo avesse profferito un’infamia, o citato versi sublimi, il commento sarebbe stato lo stesso: ‘uu-bum’. Se uno avesse parlato con la lingua degli angeli o chiesto grazia per tutta l’infelicità e l’incomprensione del mondo passata, presente e futura, per tutti i patimenti che gli uomini debbono subire, quale che sia la loro opinione o condizione, si ingegnino di evitarli o dissimularli, il risultato sarebbe stato lo stesso, il serpente sarebbe disceso per poi tornare al soffitto
Ogni parola si perde nell’eco, che frantuma e liquefa ogni senso come se l’invischiasse e risucchiasse nell’abisso del silenzio; niente si salva da questa disintegrazione della comunicazione, neanche – penserà più tardi – il piccolo cristianesimo ciarliero, neanche divine parole come sia fatta luce. Tutto si perde in quel nulla dove i rumori indistinti precipitano nel silenzio dopo che ogni suono è stato disarticolato e reso insensato. Perciò Mrs. Moore è atterrita da questa esperienza e dopo
non voleva comunicare con nessuno, nemmeno con Dio
Perché ha ormai compreso che non ci può essere comunicazione, che le parole sono vani espedienti escogitati dall’essere umano per dare al mondo e a se stesso un senso, un’illusione di senso che invece in questo universo indifferente non c’è.
La presa di coscienza
Paolo mutò radicalmente la propria vita dopo il suo incontro straordinario sulla via di Damasco: fu un altro uomo, ebbe un’altra vita. Gautama abbandonò la sua vita cortigiana e il suo destino regale dopo essere rimasto impressionato dalla vista di un vecchio, di un malato, di un cadavere, di un asceta; così comprese la tragicità dell’esistere, avvertì il bisogno di cercare una strada verso la liberazione della vita e dalla vita. Talvolta irrompono nell’esistenza eventi che la sconvolgono o travolgono: piccoli o grandi catastrofi che inducono alla riflessione, alla trasformazione di sé, talvolta perfino all’autodistruzione. Conversione, risveglio, folgorazione sono i termini che possono designare questa crisi. Paolo e Buddha ne sono esempi straordinari, ma di altri esempi, semplici e anonimi, brulica la vita degli uomini: eroi per caso, succubi di tragedie, illuminati dal destino, ecc.; ma sempre c’è il momento culminante dell’intuizione, della visione di un nuovo paesaggio interiore che occorre apprendere ad abitare, se è possibile, se non è un inferno.
Questo è quello che accade al personaggio di Mrs. Moore: una folgorazione, uno strappo nel tessuto rappresentativo dell’esistenza che ne ha rivelata l’infima dimensione provocando ciò che Sartre ha definito nausea. La folgorazione è un uscire fuori da sé, un abbandono della propria individuazione; qualcosa fuori di noi ci libera di noi stessi e ci sospinge verso un’altra conoscenza; questo qualcosa può essere la visione del dio o della miseria dell’uomo o il prosaico vaso di zinco dalla cui visone sorse l’estasi di Jacob Bòhme o il grande masso di forma piramidale che comparve improvvisamente alla vista di Nietzsche sul lago di Silvaplana, ma sempre ha un effetto estatico.
Per Mrs Moore è l’eco delle grotte dei Marabar. E’in quest’eco che traligna e le appare repentinamente il silenzio nauseante del mondo, che assorda l’umanità e la rende attonita. Nell’antichità si inventarono dei, si è perfino supposta - con filosofica fantasia - una musica delle sfere celesti per riempire quel silenzio. Ma invano.
3 Esemplare espressione dell’atteggiamento quasi antropologico di Kipling verso l’India è il racconto I costruttori di ponti, che narra della costruzione di un ponte sul Gange minacciata dalla forza del fiume, manifestazione divina espressa da un visionario consesso di dei indù.
4 Non mi convince il tentativo di decifrazione di T. Zulli, Come leggere A Passage to India, 2014, a mio parere superficiale; credo che si sarebbe bisogno piuttosto di una interpretazione correlata con la religione induista.
6 Platone fu un filosofo dall’istinto drammatico, perciò la sua filosofia si avvale frequentemente di miti, nel senso di racconti allegorici. Nel dialogo La repubblica narra di esseri umani prigionieri in una caverna, con l’intento di rappresentare la condizione di ignoranza in cui essi sono costretti a vivere
7 Nel Codice Arundel, in quella parte dove Leonardo esprime in forma aforistica i temi principali delle sue speculazioni sulla natura e sull’arte si trova, benché esposto in frammenti, il breve racconto di un sogno in cui Leonardo scruta l’oscuro interno di una caverna; si tratta evidentemente di una rappresentazione allegorica della conoscenza. Da notare che il racconto leonardesco è l’esatto contrario di quello platonico, la sua negazione. Là vi sono uomini schiavi delle illusioni immersi nell’oscurità, qui un uomo che dall’oscurità è affascinato e la scruta timoroso ma desideroso di penetrarla; là la conoscenza è intesa come un percorso che va dalla tenebra alla luce, qui, viceversa, come un percorso che va dalla luce alla tenebra: è la plastica contrapposizione tra la concezione antica e quella moderna di conoscenza. Cfr. T. Gorini, La scura spilonca, Sapere, 11, 1991.

Tiziano Gorini (Livorno, classe 1953), ha trascorso una vita estenuandosi nel provare ad insegnare Lingua e letteratura italiana e Storia; all'insegnamento ha sempre affiancato la ricerca, spaziando dalla critica letteraria all'epistemologia, dalla storia della scienza alla pedagogia. Ha pubblicato con M. Carboni e O. Galliani Le stanze di Ophelia, il manuale di storia della letteratura Excursus e Il professore riluttante. Di se stesso pensa di essere una brutta copia dell'uomo rinascimentale, perché come gli umanisti del Rinascimento girovaga tra i molteplici campi della conoscenza e dell'arte, ma - a parer suo - con mediocri risultati. Nel tempo libero soprattutto legge e scrive, altrimenti se ne va a contemplare il mare e le nuvole.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG