
Nella categoria: HOME | Articoli critici

Dante era a conoscenza degli autori che avevano studiato il mito, il suo significato allegorico e il suo rapporto con la religione cristiana. Gli erano noti i mitografi classici come Omero, Esiodo, Ovidio, Virgilio, Lucano, Stazio e quelli medioevali che spiegavano il mito in chiave cristiana. Additare l’Eneide come unica fonte, da cui attinse gli elementi antichi e pagani, è fuorviante. Il mito di Matelda, ad esempio, in relazione a quello di Proserpina, Dante poteva averlo appreso dalle Metamorfosi di Ovidio, dall’Egogla IV di Virgilio, da Il sogno di Scipione di Cicerone, dalla Farsalia di Lucano, dalla Sacra Scrittura e dalla patrologia cristiana.
A riprendere il tema del mito in Dante fu Marco Apollonio che nel 1951 studiò la fusione dantesca del pagano col cristiano ed arrivò ad affermare che, mediante lo studio del mito in Dante, è possibile una maggiore comprensione della Divina Commedia e di molti dogmi cristiani. Ora Apollonio giustamente mette in evidenza la liricità del mito nella poesia dantesca, si sbaglia quando afferma che la funzione del mito in Dante “resta quasi una decorazione murale”. Il poeta, al contrario, fa tesoro della mitologia antica, la filtra attraverso la narrativa della rivelazione, la riempie di significati cristiani, attraverso l’esegesi patristica e l’arricchisce di immagini poetiche.
Il mito, perciò, non è introdotto nella Divina Commedia unicamente per il suo valore decorativo, ma per unire il passato con il presente, per una presa di coscienza con la storia della civiltà umana e con quelle “favole” primitive, che illustrano le verità cristiane in modo persuasivo e affascinante. Certo non si può escludere totalmente il ruolo decorativo del mito, ma tale funzione è di valore secondario nella Divina Commedia. La sintesi umanistica di Dante riesce a giustificare l’esistenza dei miti pagani e li concilia con la teologia cristiana, fondendo la scienza razionale della Grecia e di Roma con le mistiche rivelazioni giudaiche-cristiane. Il mito concorre a strutturare il mondo dantesco e ad agganciarlo alla cultura classica e biblica; il mito è in Dante un fattore culturale, poetico, estetico ed erudito, un mezzo particolare d’espressione artistica che unisce il passato col presente e viceversa. Questa è l’opinione prevalente: il mito è una presa di coscienza con l’antichità e con la storicità del cristianesimo.
Per capire bene il valore del mito nel poema dantesco bisogna analizzare i termini danteschi di “favola”, “menzogna”, “ errore”, che, applicati ai miti pagani, non devono essere separati dal loro contesto specifico; che la lira di Orfeo mettesse in movimento gli alberi e le pietre e rendesse mansueti gli animali feroci è “una menzogna”; che Ulisse avesse varcato le colonne d’Ercole risale ad una tradizione creduta vera. Ciò dimostra che Dante rievoca le narrazioni antiche, non tutte ma quasi, come se fossero vere, anche le poche volte che ci dice che non lo sono; come per il culto particolare reso a Venere e Cupido. Le credenze pagane vengono usate dal poeta cristiano, che per esse lascia trasparire non solo una certa tolleranza ma anche simpatia. Infatti “le genti antiche ne l’antico errore” ci fanno ricordare una terzina importante della prima cantica: “Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, / e vissi a Roma sotto il buon Augusto/ al tempo de lli dei falsi e bugiardi”. A tal proposito Dante probabilmente ha attinto da Sant’Agostino. Le analisi semantiche per il mito dantesco hanno importanza, in quanto “dei falsi” nega la loro natura reale e storica, e “bugiardi” significa che ingannano e deviano dalla vera fede. Dante, infatti, nell’espressione “dei falsi e bugiardi”, sembra fondere l’origine fittizia dei miti pagani e l’invenzione ingegnosa dei poeti-teologi, la cui menzogna si esprimeva attraverso la voce degli oracoli che davano risposte ambigue.
Comunque li chiami pure “falsi e bugiardi”, gli dei del paganesimo sono figure importanti per il suo discorso, ad esempio Giove è ben lungi dall’essere considerato falso e bugiardo. Dante ne fa addirittura la rappresentazione di Cristo: “certamente O Sommo Giove/ che fosti in terra per noi crocifisso,/son gli giusti occhi tuoi rivolti altrove?”.
Certamente Dante qui si riferisce a Cristo, il misericordioso Dio-Uomo del Nuovo Testamento. Il poeta inveisce contro Firenze e l’Italia, preda degli stranieri, senza speranza di libertà e di indipendenza, e perciò chiama Cristo “Sommo Giove” e gli domanda se abbia abbandonato la sua città nativa e l’Italia. Ma Dante credente nella Divina Provvidenza, rettifica: “O è preparazion che ne l’abisso/ del tuo consiglio fai per alcun bene/ in tutto dell’accorger nostro scisso?”. Qui il poeta riconosce Giove sia come il Dio giusto del Vecchio Testamento che quello misericordioso del Nuovo. La parola chiave Giove è divenuta immagine, mentre la vera realtà è nel Dio della giustizia ebraica e in Cristo Crocifisso. L’immagine di Giove crocifisso, perciò, sembra la più significativa per illustrare il metodo dantesco nella rielaborazione del mito in chiave cristiana. Il Giove crocifisso dantesco non è il dio falso dei pagani, ma è Cristo che muore sulla croce per redimere l’umanità dal peccato. Cosicché Dante accetta la realtà degli dei, come fatti mitologici, e li combina con le verità della fede; ciò che egli rifiuta non è lo pseudo divino a beneficio dell’umano, ma la confusione dell’umano e del divino: gli dei non sono per lui né uomini divinizzati né espressione delle forze della natura. Egli non dubita dell’esistenza di Orfeo, ma, essendo costui uomo e pagano, Dante nega ch’egli abbia potuto fare miracoli. Egli accetta alcuni miti come realtà storiche, ma di essi, come quelli in cui non crede, si serve per significare delle verità, alle quali egli crede come cristiano e, prima di tutto, come uomo e studioso. Tuttavia egli riconosce che gli antichi furono indotti in errore dalla loro religione politeista che li allontanò dalla rivelazione ebraica e cristiana. Ma occorre sottolineare che Dante è stato sempre affascinato dal parallelismo della storia culturale dei pagani, degli Ebrei, dei Cristiani ed è riuscito a scoprire l’epifania del vero Dio nelle false parvenze degli antichi, spiegando nel Convivio le origini delle religioni primitive mediante i miti.
Analizziamo ora la distribuzione del mito nelle tre cantiche della Divina Commedia. L’uso del mito è più frequente nell’Inferno, diminuisce nel Purgatorio, e si riduce ai minimi termini nel Paradiso. Il mito dantesco sembra dominante nell’Inferno, che è molto simile all’Averno di Virgilio ed in cui il peccato e l’odio, la punizione e la giustizia inflessibile in senso pagano sembrano trionfare sui concetti cristiani di amore, speranza e beatitudine. La legge del contrappasso, infatti, risale all’antica legge del taglione, per cui nell’abisso infernale si rivive eternamente l’esperienza del peccato commesso e punito proporzionalmente alla colpa, e molti contrappassi sottintendono un antico mito: per esempio, la pena degli avari e dei prodighi, il mito di Sisifo, quella dei golosi nel Purgatorio, il mito di Tantalo.

Che l’Inferno sia stato concepito paganamente da Dante l’aveva già scritto Pascoli nel 1923 (“Sotto il Velame”). Dante man mano che si avvicina a Dio e alla visione beatifica, si libera da molti motivi pagani, dalle superstizioni e dal peccato, fino al punto di divenire un perfetto cristiano. Tuttavia, anche alla fine del Paradiso egli sente la necessità di rievocare il mito di Giasone e della Sibilla. La riduzione del mito nelle tre cantiche è in qualche modo determinata dal progressivo avvicinarsi dell’individuo e dell’umanità a Dio. Ho già accennato che nel Purgatorio gli elementi pagani non dominano più su quelli cristiani, poiché il secondo regno dell’oltretomba è certamente luogo cristiano e motivo di futura salvezza. Esso cominciò a popolarsi dopo la venuta di Gesù ed è il regno della purgazione e della speranza di salire al cielo. Già Pascoli afferma che il Purgatorio è mezzo pagano e mezzo cristiano, ma non vi scopre la sintesi dantesca di questi due elementi. Infatti la tendenza allegorica e mitica della mente di Dante diventa più moraleggiante nella seconda cantica: essa è il segno più manifesto della mentalità medioevale di Dante che fonde il mito col dogma cristiano. Lo studio del mito in Dante deve servire, prima di tutto, a rivalutare il mondo poetico della Divina Commedia e porlo nella giusta prospettiva estetica. Nel Paradiso la fantasia del poeta si nutre meno di immagini e reminiscenze pagane con l’avvicinarsi alla visione beatificata di Dio. Gli elementi cristiani e dogmatici vi dominano, ma Dante non elimina il mito completamente neanche alla presenza di Dio. Il poeta ammonisce i lettori, a non seguirlo nell’ardua impresa nel secondo canto del Paradiso, dove non esita a menzionare nomi pagani (come Minerva, Apollo, le Muse) per significare il sovrannaturale cristiano. Sembra che non si possa arrivare al cristianesimo se non attraverso il paganesimo. Poi rifacendosi alle Metamorfosi, Dante richiama il mito di Giasone, per concludere che, come Giasone per conquistare il vello d’oro ha dovuto superare molti ostacoli, così egli per descrivere le verità di fede incontrerà molte difficoltà. In questa dura impresa, ciononostante, egli si sente guidato da divinità pagane che, naturalmente, sono immagini dell’ispirazione cristiana. A questo punto della Divina Commedia il poeta sembrerebbe dover abbandonare il mito per dedicarsi solamente ai dogmi cristiani; invece continua a fondere elementi pagani e cristiani fino alla fine. Cosicché, per Dante, il suo stesso viaggio oltremondano diventa un viaggio mitico verso l’ignoto, ma illuminato dalla grazia della rivelazione. Dante solleva i miti pagani, mediante la loro rappresentazione fantastica, al livello dei dogmi della religione cristiana. Nel mito il poeta ritrova la traccia del vero Dio, da cui si era allontanato allorché si era perduto nella selva oscura; mediante il mito il poeta riesce a varcare l’ignoto, a dare solennità epica alla sua poesia, a ritrovare i legami col passato, a sollevare ad una sfera universale la propria esperienza personale, a dare significato ad una religione (pagana) ormai scomparsa, a proiettare la propria impresa in quella di eroi antichi, a riaffermare l’unità del suo poema. Egli ha compiuto una sintesi poetico-mitica, religiosa e spirituale. Dante si serve dei miti non per pretesto, ornamento, convenzione letteraria o comodità artistica, ma come argomento e prova delle verità di fede e come espediente poetico per organizzare le idee principali della Divina Commedia.
Il mito diventa un’elevazione mistica e spirituale per il poeta che, pur attingendo da fonti svariate, sa scegliere i dati necessari alla rappresentazione fantastica del suo cosmo, sapendo essere originale e inventivo.
All’inizio del canto XIII Dante e Virgilio entrano in un bosco che nella sua contrapposizione ai boschi mondani si richiama alla “selva oscura” del I canto: gli alberi di questo bosco sono “di color fosco”, con rami “nodosi e ‘nvolti” in cui non crescono frutti ma punte spinose e velenose. Dante, su invito di Virgilio, strappa un ramicello di un albero; dal ramo esce sangue, e il tronco reagisce rimproverandolo per la sua crudeltà: “Uomini fummo, e or siam fatti sterpi”- dice la pianta con voce che esce insieme al sangue attraverso la ferita del ramo. Qui, a prima vista, sembra molto forte l’influenza dell’antecedente virgiliano dell’episodio, ma, analizzando l’intero canto, è possibile notare come esso sia cosparso di molteplici richiami a Ovidio. Nella seconda parte mi occuperò delle allusioni ovidiane disseminate nel canto dei suicidi prestando una particolare attenzione alle differenze tra le metamorfosi ovidiane e quelle dantesche. La prima parte è dedicata invece alle strutture antitetiche che costituiscono lo strumento retorico dominante in questo canto noto proprio per la sua retoricità.

Il canto XIII ha una notevole popolarità critica ed è possibile notare non pochi contributi che si occupano anche dell’aspetto linguistico-retorico del canto. Leo Spitzer scrive:
si deve notare subito che in questo canto uno dei motivi conduttori è l’ibridismo, la natura doppia: dal centauro Nesso, attraverso le Arpie e Minosse fino agli uomini piante.
Spitzer si concentra sulle caratteristiche della genesi del linguaggio, scoprendo un parallelismo nel carattere di contrappasso che la produzione del linguaggio ha nel caso di Ulisse e in quello degli uomini piante. Nell’intero canto una coloritura particolare è causata in parte dall’uso delle parole onomatopeiche: il lessico dei primi trenta versi con i suoi “nessi consonantici nodosi e stridenti” (per esempio bosco/fosco; bronchi/tronchi; stecchi con tosco; aspri sterpi) esprime perfettamente lo spavento provocato dal paesaggio. La peculiarità linguistica, atmosferica e iconica di questo canto si mostra anche sul livello lessicale: troviamo una gamma talmente vasta di espressioni di disperazione, dolore e infelicità, che non può essere superata da nessun altro canto dell’Inferno. Si possono contare dodici verbi che si ascrivono all’espressione o alla causa del dolore (per es. gemere v.41, piangere v.131, dilacerare 8v.128; otto nomi di significato luttuoso: dolore v. 122, guai v22, morte v.66e118) e dieci aggettivi cupi (fosche v.104, tristo v12,69,142,145, mesto v.106, foschev.4). Sono oscuri, nodosi’ nvolti, coperti da stecchi con tosco non soltanto gli alberi ma anche le parole che li descrivono, e le radici mentali di tutto ciò: i pensieri dell’anima dei suicidi, protagonisti afflitti di questo canto.
Questo orrendo ambiente naturale dipinto con un lessico esclusivamente cupo, vuol essere nel suo complesso segno della disperazione dei suicidi, secondo quanto Dante aveva percepito da un passo di San Bernardo: “homo absque gratia ut disperans est velut arbor silvestris, ferens fructus quibus porci infernales (ut Harpiae hic) pascuntur.”
Mettendo a fuoco le figure parlanti del canto vediamo come lo stile caratteristico del loro parlare sia in grado di conferire forma alle loro personalità. Il modo di esprimersi di Pier de la Vigna è una o meglio la prova della sua identità: le perifrasi ornate si riflettono nel suo primo monologo ed in esso si mescolano poi termini tecnici della caccia che fu attività gradita al suo signore, Federico II.
Il linguaggio tipico di Pier de la Vigna, denso di figure retoriche presenti comunque in tutto il canto, e l’eloquenza del suicida fiorentino, ultimo personaggio che appare nel canto, sono in relazione antitetica con le disadorne spiegazioni virgiliane e con il tacere tremante del Dante viaggiatore. Inoltre, questo stile retorico costituisce un contrasto con la produzione del linguaggio degli ibridi uomini-piante. Il parlare dei suicidi si connette al dolore: le piante sono in grado di parlare solo attraverso le loro ferite - quindi Dante non deve cogliere un ramicello dal cespuglio soltanto per dare la possibilità a Virgilio di dimostrare che l’Eneide non sia una mera favola, ma il suo atto ha anche una precisa funzione concreta. Il carattere di contrappasso di questa dolorosa produzione del linguaggio viene messo in particolare evidenza da Spitzer nel saggio “Moralità linguistica: il contrappasso linguistico”:
si esprime una concezione ragionata nella pena dei suicidi, siccome gettando la vita, si nega in sé l’essenza umana. Dall’essenza umana è inscindibile la capacità di parlare.
Nella sua interpretazione Spitzer sottolinea il carattere ibrido della lingua dei suicidi, metà umana metà vegetale.
Nel XIII le strutture antitetiche mettono in evidenza la bipolarità della condizione dei suicidi ed è stato frutto di un preciso, attento lavoro stilistico.
L’ibridismo è certo una mescolanza di due nature, ma è caratterizzato anche da una negatività reciproca: gli uomini-piante devono esistere senza la parola umana (sostituita da un doloroso linguaggio arboreo), senza la capacità di muoversi che è propria di ogni essere animato eccetto quelli vegetali, ma essi non sono dotati neanche dall’unico vantaggio della vita vegetale, quello di essere insensibili al dolore. La retorica della negazione prevale su quella delle strutture antitetiche. Le forme verbali in costruzione negativa contribuiscono a rafforzare questo orizzonte della negatività.
Barnes sottolinea che “non” è la parola chiave di tutto il canto e qui tale negazione si ripete tre volte all’inizio delle prime tre terzine del canto. Nell’analogia tra peccato e pena (quelli che respingono da se stessi la vita, nell’aldilà sono costretti ad esistere in un’imponente forma vegetale, e non sarà ridata loro forma umana neanche nel giorno del Giudizio Universale), in tale soluzione caratteristica di Dante, funziona con certezza e convinzione il principio della negazione. Spitzer nota che l’atmosfera morale e stilistica del canto è caratterizzata dalla tortura, dalla scissione, dallo sdoppiamento, in una parola, dalla disarmonia. Ed esiste un mezzo retorico più adatto dell’antitesi come pure della negazione a rappresentare la scissione e una forma umana irrecuperabile?

La seconda terzina del canto è composta di tre antitesi, le quali contrappongono la piacevolezza del paesaggio realistico all’orrore che pervade il paesaggio simbolico. Il risalto dato all’anafora e la descrizione della selva fosca con ogni probabilità derivano dall’Hercules furens di Seneca:
Horrent opaca fronde nigrantes comae/…..Non prata viridi laeta facie germinant, / Nec adulta lenti fluctuat zephyro seges; / Nec ulla ramos sylva pomyferos habet
Le tre opposizioni, la triplice ripetizione del “non” iniziale e del connettivo “ma” da un lato possono rendere monotona la costruzione delle frasi, ma dall’altro contribuiscono a creare un’intensificazione che culmina nella terza opposizione, in cui vengono messe in contrapposizione le spine velenose con la dolcezza dei frutti. Nei versi 8-9 sono le “fiere selvagge” e i “ luoghi colti” a costituire un contrasto. Le contrapposizioni successive (nei versi 20-21 tra l’autenticità dell’esperienza e l’incredibilità delle storie lette e nei versi 22-23 tra le due esperienze sensoriali: “Io sentia d’ogni parte trarre guai/ e non vedea persona che’l facesse”) servono di transizione dalla descrizione mitica al doloroso monologo di Pier de la Vigna. L’antitesi efficacissima tra la piccolezza dell’atto di Dante (“Allor un poco la mano avante/ e colsi un ramicel da un gran pruno”) e la terribilità dell’effetto (“e ‘l tronco suo gridò: “Perché mi schiante?”. Da che fatto fu poi di sangue bruno”). In tal situazione Pier de la Vigna nei suoi primi gridi di dolore identifica così se stesso e i suoi compagni di pena: “Uomini fummo, or siam fatti sterpi” v. 37, mettendo in contrasto il loro stato naturale precedente con quello degradato di adesso. Nella spiegazione di Virgilio (v.46-51) trova spazio il tema della possibile credibilità della storia di Polidoro, ma una credibilità mancata da parte di Dante: “S’elli avesse potuto creder prima (...) ciò c’ha veduto pur con la mia rima”, e ciò crea un’antitesi tra la possibilità di credere e la cosa incredibile. La prima terzina (v.55-57) del discorso di Pier de la Vigna è pervasa dalla gentilezza raffinata e formulata con stile elevato che furono propri del letterato. Questo linguaggio ricercato sta in posizione nettamente antitetica rispetto ai suoi gridi di dolore registrati poco prima nel testo. Nella sua auto-presentazione si può osservare una figura etimologica antitetica (serrando e diserrando); e un contrasto doloroso tra l’aggettivo posto in rilievo sintattico e metrico a chiusura di verso (...sì soavi) e il mutamento tragico che seguirà. Comincia qui la divisione (dal secreto suo quasi ogn’uom tolsi) tra Pier de la Vigna e gli altri uomini di corte che determinò l’invidia verso di lui e, attraverso l’invidia, la sua caduta. La parola “fede” ritorna tre volte nell’episodio (vv.21, 62 e 74), rafforzando così la sua importanza nell’interpretazione dantesca, la cui sostanza non è altro che il contrasto ingiusto tra le azioni e le conseguenze: “fede portai al glorioso offizio,/ tanto ch’i’ ne perde’ li sonni e’ i polsi”.
L’antitesi acuta e grave tra la fede di Pier de la Vigna e il suo risultato del tutto negativo, la perdita delle notti tranquille e infine della vita stessa, costituisce il nucleo della tragedia di questo cortigiano. Nei versi 67-68 gli artifici retorici trovano una massima efficacia nella ripetizione del verbo “infiammare” (“infiammò contra me li animi tutti; /e li infiammati infiammar sì Augusto”) e il contrasto tra il cortigiano Pier de la Vigna e gli animi tutti costituisce il crescendo delle peripezie di Pier de la Vigna che trova l’apice nella duplice antitesi del v.695: “lieti onor tornaro in tristi lutti”, in cui i due nomi e i due aggettivi, separatamente ma anche nei rispettivi sintagmi, stanno in contrapposizione tra loro. Nei versi 67-72 trova spazio la narrazione dell’ultima decisione di Pier de la Vigna: essa si compone di quattro antitesi di cui le più forti sono quelle sottolineate da questo “gioco” di parola: “per disdegnoso gusto, ... fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto”. Nell’espressione (me contra me), l’unità me contrasta con se stessa, mentre il gerundio credendo accentua la tragica illusione del gesto. Il credere di Pier de la Vigna contrasta con ciò che afferma Sant’Agostino nel De Civitate Dei :
la morte volontaria per il timore del disonore rende il suicida tanto più colpevole quanto più fu incolpevole nella vicenda per la quale ritenne di doversi uccidere.
Inoltre ancor più gravosa è la sorte dei suicidi, in quanto non è Minosse a decidere in relazione al peccato ove far cadere queste anime, ma le anime dei suicidi non hanno un luogo prestabilito, ma vengono gettate casualmente nella selva.
Nel verso 104 si amplia la differenza con gli altri peccatori: nel giorno del Giudizio Universale tutte le anime riavranno i loro corpi, eccetto i suicidi che non li riavranno, in nome della giustizia, in quanto essi hanno distrutto l’unità organica fra anima e corpo.

La fonte virgiliana si trova nel terzo libro dell’Eneide V22-68. La struttura e la situazione della storia dantesca e di quella virgiliana sono in sostanza conformi. La differenza più notevole tra le due scene concerne l’elemento della metamorfosi: il mirto cresce sopra il corpo di Polidoro (le parole che quest’ultimo rivolge ad Enea indubbiamente escono dal terreno, dal profondo di un tumulo), mentre le anime dei suicidi vivono all’interno di una pianta (secondo la legge del contrappasso il corpo umano è stato sostituito da un corpo vegetale e le loro membra sono diventate foglie, sensibili al dolore, ma incapaci di muoversi). Nel caso dell’antecedente virgiliano non si tratta dello stesso tipo di metamorfosi “diretta” (da uomo a pianta) che troviamo in Ovidio. Eppure anche se non è il corpo di Polidoro a trasformarsi in mirto, siamo comunque di fronte a una metamorfosi: da un lato perché i dardi che hanno trafitto il suo corpo, radicandosi nel terreno, danno origine ad un cespuglio di corniola e mirto; dall’altro perché la pianta avendo vicino l’anima, che è l’essenza dell’umanità, diventa simile al corpo umano, e ciò si rende evidente nel sangue che ne esce fuori e nella sensazione di dolore.
L’altra importante differenza tra l’antecedente virgiliano e la riscrittura di Dante è il motivo della punizione. Mentre Polidoro ha sofferto una morte violenta e la sua sopravvivenza in forma di pianta terrena non è il risultato dei suoi atti precedenti, la nuova esistenza dei suicidi danteschi viene invece determinata in ogni particolare dalla pena, che è la conseguenza dell’atto commesso. Il cespo di Polidoro non è prigione dell’anima, ma una sorta di lapide del giovane ingiustamente ucciso. Non trovo convincente l’opinione di chi sostiene che il giovane troiano riceverebbe in questa trasformazione un compenso alle sue pene, per volere degli dei, perché la conclusione dell’episodio virgiliano consiste nella descrizione della sepoltura di Polidoro e in tale sepoltura viene sepolta anche l’anima versi 67-68, per poter riposare finalmente in pace. Dunque la sua metamorfosi ha più il significato di un aiuto temporaneo ricevuto dagli dei che non quello di un vera ricompensa.
Nelle Metamorfosi di Ovidio troviamo numerosi esempi di trasformazioni in piante (dalla storia di Dafne fino a quella di Filomene e Bauci), ma soltanto in tre casi si tratta di piante sanguinanti. Nel caso delle Eliadi piangenti si tratta di una metamorfosi non ancora completata ed è per questa ragione che i loro rami sanguinano e si mostrano in grado di parlare mentre stanno assumendo una forma vegetale, e la loro madre, Climene, tenta di strappare i loro corpi dai tronchi. Invece a metamorfosi ultimata, quando la corteccia copre le loro labbra, esse tacciono, e non sono capaci di esprimersi in altro modo che con le lacrime diventate gocce d’ambra. Mentre nel mito di Diopre che coglie dei fiori purpurei da un albero di loto, lei è ignara del fatto che in quell’albero si era trasformata la ninfa Loti. Si tratta di metamorfosi compiute da lungo tempo, e il sangue e la parola sono i segni indiscutibili dell’essenza umana rimasta nella figura vegetale.
Spitzer nota una differenza notevole tra le metamorfosi in Ovidio e in Dante, per quel che riguarda il processo stesso attraverso cui la metamorfosi si compie: quando in Ovidio una persona vivente diventa una pianta (con i piedi che si irrigidiscono in radici, la chioma che si trasforma in fogliame) vi è un’identità ininterrotta tra la persona come totalità e la pianta in cui essa viene trasformata. Nel caso dei suicidi di Dante, invece, il corpo e l’anima sono stati disgiunti dall’atto del suicidio e l’unica parte che sopravvive è l’anima.
Ci sono altre due differenze importanti tra le metamorfosi ovidiane e quelle dantesche, differenze presenti nel saggio “Dante e i miti” di Picone. La fantasia dell’auctor classico non ha infatti mai contemplato l’ipotesi della trasformazione dell’uomo in pianta irreale, alienata dall’ordine naturale (una pianta dalle fronde non verdi ma scure, da rami non diritti ma contorti, e che al posto dei frutti porta spine velenose). E mentre le Metamorfosi sono interessate a spiegare ciò che precede la trasformazione, per esempio delle Eliadi in pioppi, la Commedia è invece interessata a rivelare ciò che segue la trasformazione dei suicidi in piante, ad evidenziare cioè come funziona la giustizia divina. Se le Metamorfosi sono un poema eziologico, che vuole conoscere le cause prime, la Commedia è un poema escatologico, che vuole capire le conseguenze ultime delle cose. Le Eliadi diventando pioppi terminano la loro esistenza infelice; i suicidi invece assumendo la natura vegetale iniziano un’esistenza infelice senza fine.
Si può notare anche una differenza nell’aspetto narrativo: mentre Dante è testimone del risultato della metamorfosi vegetale dei suicidi e ne dà una dettagliata descrizione sul piano narrativo, Ovidio svolge soltanto il ruolo di raccoglitore di miti, e, facendoli raccontare dai suoi personaggi, come accade in alcuni casi, ne rafforza il carattere fiabesco e li allontana da sé. Nonostante le marcate differenze, non si può negare la fitta rete di allusioni ovidiane di cui il canto dantesco è intessuto. La storia del centauro Nesso era nota a Dante tramite Ovidio, Nesso in qualità di traghettatore del Flegetonte. Anche le trasformazioni in piante sanguinanti comportano inevitabili associazioni alle metamorfosi ovidiane. L’antecedente ovidiano è la descrizione della morte di Meleagro: “aut dedit aut visus gemitus est ille dedisse / stipes et invitis correptus ab 5ignibus arsit” versi 40-42. (Come d’un tizzo verde ch’arso sia/ da l’un de’ capi, che da l’altro geme). Nelle metamorfosi ovidiane si può riscontrare come in quelle dantesche il motivo della punizione che si inserisce in un sistema morale.
Dante, sempre fedele all’eredità letteraria della cultura ellenica e romana, usa la mitologia rimodellata dall’interpretazione cristiana, ma non altera i dettagli dei miti. Potremmo dire che l’Ulisse dantesco personifica, direi in senso rinascimentale, l’autosufficienza della mente umana e il concetto, appunto rinascimentale, dell’uomo come misura di tutte le cose.
Dante poteva sentire affinità con Ulisse, perché egli vedeva se stesso come un marinaio, ansioso e vigile, in cerca di verità e conoscenza. Dante ha sempre tenuto a mente le affinità tra il suo viaggio e quello di Ulisse alla ricerca della conoscenza; il folle volo di Ulisse sta a simboleggiare la sua tragedia intellettuale, la grande passione del sapere che quasi l’allontanava dalla salvezza eterna.
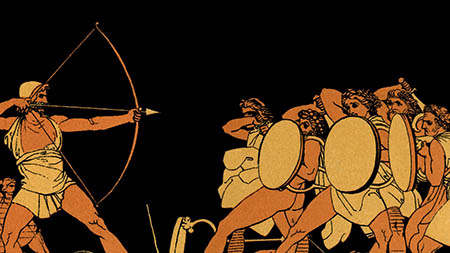
Il simbolismo universale di questo mito dantesco consiste in questo: il destino di Ulisse è il destino di ogni individuo che sempre si troverà posto dinanzi ad un limite; se quel limite dobbiamo considerarlo trascendente o immanente, o chiamarlo Natura, Fortuna o Dio, è questione che non appartiene alla poesia. I due momenti dell’animo dantesco, che esalta e condanna l’impresa di Ulisse, rivelano la complessità poetica di questo personaggio mitologico. Dante si ritiene un novello Ulisse; da qui il suo lirismo nella rappresentazione di questo mito, che illustra per riflesso il viaggio del cristiano attraverso il mondo e l’oltretomba.
Spesso Dante parla della navicella del suo ingegno che approda a più ardue spiagge e si rappresenta come navigante sia nel Purgatorio che nel Paradiso.
Affermare, credere che Dante abbia distrutto il mito omerico, in quanto non conosceva il greco, non è esatto ed è fuorviante nell’interpretazione dell’Ulisse dantesco. Seppur Dante non lesse l’Iliade e l’Odissea, egli conosceva bene il mito di Ulisse attraverso gli autori latini: Ovidio, Virgilio, Cicerone; perciò il suo eroe non è una figura assolutamente nuova, anche se ripresentata con molta originalità.
L’Ulisse dantesco non è differente dall’Ulisse classico, ma è una continuazione, una proiezione, una sublimazione dell’eroe greco che raggiunge l’universalità poetica.
Tale elevazione artistica si nota già nell’incoraggiamento da lui fatto ai compagni, nel vigore della sua orazion picciola con cui cerca di innalzare lo spirito umano ad un livello superiore a quello dell’uomo comune e delle bestie: “Considerate la vostra semenza// fatti non foste a viver come bruti/ ma per seguir virtute e canoscenza”.
Di Ulisse a Dante interessa maggiormente la suprema avventura, la morte e le circostanza che la causarono.
Dante presenta il mito di Ulisse nel XXVI canto dell’Inferno, che inizia con una sarcastica lode di Firenze, patria di ladri. I due poeti risalgono all’ottavo argine, donde ammirano, nel fondo dell’ottava bolgia infernale, una gran quantità di fiamme erranti, simili a lucciole, che d’estate, sul far della sera, il villano contempla nella distesa dei campi. Ognuna di queste fiammelle, come quella che nascose il carro del profeta Elia agli occhi del profeta Eliseo, cela l’animo di un cattivo consigliere.

Per meglio osservare la scena, Dante si sporge dal ponte, a rischio di precipitare nel fondo, e, vista una fiamma che, a differenza delle altre, si biforca nella parte superiore, vuol sapere chi essa racchiuda. Perciò chiede il permesso a Virgilio di poter interrogare i dannati che cela, ma Virgilio preferisce farsi suo portavoce dato che la lingua è più familiare a lui che a Dante. A questo punto comincia la presentazione del mito di Ulisse. I due puniti entro la fiamma biforcuta sono Ulisse e Diomede, oggi compagni nella pena come già furono negli inganni. Virgilio sollecita uno di essi a dir le cause della loro condanna eterna. La preghiera è esaudita da Ulisse che riepiloga le avventure della sua vita ed i peccati che determinarono la sua presenza nell’Inferno.
Il primo peccato di Ulisse è l’agguato del cavallo di Troia, di cui i greci si servirono per entrare nella città nemica. Omero attribuisce l’invenzione del cavallo ad Ulisse e Diomede. Dante scelse questa versione dell’episodio omerico, anziché il racconto virgiliano del II canto dell’Eneide, in cui il nome di Diomede non figura nell’invenzione del cavallo di legno. Il secondo peccato di Ulisse è il tranello per riconoscere Achille, travestito da donna tra le fanciulle alla corte di Licomede, re di Sciro. Tale astuzia guadagnò la partecipazione di Achille alla guerra contro Troia.
Stazio nell’Achilleide scrive che Teti aveva travestito da donna suo figlio e l’aveva mandato a quella corte, affinchè non prendesse parte alla spedizione contro Troia. Ulisse e Diomede, sotto le sembianze di mercanti, si recarono a Sciro ed andarono mostrando oggetti d’ornamento alle fanciulle della corte. Improvvisamente Ulisse fece suonare una tromba di guerra e mostrare uno scudo e una spada; subito Achille balzò fuori preso da entusiasmo bellico e fu così riconosciuto. Inoltre l’astuzia di Ulisse e Diomede provocò anche la morte di Deidamia, amante di Achille, che morì di dolore e ancor morta si duole dell’amante infedele da cui aspettava un figlio.
Il terzo reato del re di Itaca fu il furto del Palladio, la statua di Atena, conservata e custodita gelosamente dai Troiani, perché proteggesse la loro città dai Greci.
Quindi questi sono i tre peccati di Ulisse, per cui egli è punito nella bolgia infernale dei fraudolenti.
Il pensare ad una quarta colpa dell’eroe greco, cioè aver violato i limiti fissati alla capacità dell’uomo, cioè le colonne d’Ercole è una sorta di errore. Per questa colpa Dio non punisce affatto nell’Inferno, a mio avviso: in realtà egli si trova tra i fraudolenti e non tra i ribelli che sfidano o hanno sfidato Dio. Se fu punito per il folle volo fu punito in vita e non nell’Inferno; mentre le punizioni dell’Inferno originano dalla divina giustizia, quelle della vita possono venire da circostanze varie, ad esempio da umana ignoranza, ingiustizia. Altrimenti sarebbe come dire che Dante doveva considerare il suo esilio una punizione divina. L’amore disinteressato del vero, per il quale Ulisse affronta l’ignoto e la morte, non poteva mai essere un ardimento peccaminoso.
La chiave dell’interpretazione dell’Ulisse dantesco mi sembra dunque questa: egli è punito nella bolgia dei fraudolenti e non tra i ribelli a Dio; Dante, infatti, condanna le frodi di Ulisse e Diomede come aveva condannato ad esempio Francesca; ma mentre prova pietà per la vicenda amorosa di Francesca, egli sente ammirazione per l’ardimentoso e tragico viaggio di Ulisse. Ora come Dante non avrebbe potuto provare ammirazione, ma solo pietà per la vicenda peccaminosa di Francesca, così non potrebbe mostrare ammirazione per l’audace avventura di Ulisse, se in essa consistesse il peccato di costui: sarebbe ammirare il peccatore per il suo peccato; ciò che Dante non fa con Francesca né con nessun altro; mentre più di una volta si permette di manifestare rispetto, ammirazione, riverenza verso un dannato, per qualche qualità che nulla ha a che fare col peccato: è possibile ricordare, in tal senso, Farinata, Pier de la Vigne e Brunetto Latini ad esempio. A questo punto mi sembra importante mettere in risalto il racconto che Ulisse stesso fa del suo viaggio; Ulisse è commovente durante tale racconto, e Dante ne ammira l’audacia e l’eroismo. Dante ammira la brama del sapere e della scoperta presente in Ulisse. Tale brama lo ha indotto a ripartire da Itaca e a superare le colonne d’Ercole. Passato lo stretto di Gibilterra continua con la sua navicella il suo viaggio finché giunse ad una montagna, la montagna del Purgatorio: “noi ci rallegrammo e tosto tornò in pianto,/ che della nuova terra un turbo nacque/e percorse del legno il primo canto”. Ecco come Ulisse viene punito in vita per la sua temerarietà.
Qui Dante stabilisce un legame tra il mito pagano e la religione cristiana. Questo legame fa sì che Ulisse venga punito in vita e dopo la morte: in vita il viaggio del pioniere viene troncato da una tempesta improvvisa che lo sommerge nell’oceano insieme ai suoi compagni; dopo la morte viene punito col fuoco tra i consiglieri fraudolenti. Mediante questo duplice contrappasso Dante crea il legame tra il mito di Ulisse e il contesto cristiano del poema. Il mitico eroe greco, spinto dal suo ardente amore per il sapere, sacrifica gli affetti familiari, va verso il mistero dell’ignoto e raggiunge, attraverso il lume della ragione, il Paradiso Terrestre, a cui naturalmente non può accedere per mancanza della grazia divina.
Nel mito di Ulisse è certamente riflessa una parte dell’animo di Dante, che spesso fu tentato d’affidarsi più alla filosofia che alla teologia, e di ricercare verità eterne mediante l’uso della ragione, senza ricorrere alla fede. Per questo motivo a Dante interessa maggiormente la morte di Ulisse che la sua vita avventurosa.

La presentazione dantesca del mito di Ulisse comincia con l’analogia fra la potenza distruttiva della parola e quella del fuoco. Se breve è la presentazione dantesca delle anime punite nelle fiamme, lungo è il preambolo. La similitudine del villano che si riposa d’estate, quando il sole tramonta più tardi, racchiude in sé tre paragoni secondari: delle lucciole, di Elia e della nuvoletta. Il villano che si riposa al crepuscolo, il contadino che vendemmia e ara, la visione delle mosche e delle zanzare che poi spazia in quella delle lucciole lungo la valle ci richiamano un paesaggio idillico. L’episodio di Ulisse ha in sé un senso di grandiosità ed insieme di tristezza, di ardore e di malinconia, che richiama il dramma dell’umanità intera durante il paganesimo. Ulisse va verso il Paradiso perduto nel vano tentativo di riacquistarlo. La rinuncia di Ulisse agli affetti familiari, superati e sacrificati a causa di un ideale più alto, conferisce una maggiore grandezza all’eroe che evade di nuovo dalla patria terra che ha agognato per tanti anni. Tale evasione da un mondo circoscritto eleva l’eroe greco al di sopra degli affetti familiari ed avvolge la sua morte di un rito sacro.
Perché Dante condivide che Ulisse sacrifichi gli affetti familiari per appagare la sua sete di sapere?
Il viaggio di Ulisse corrisponde a quello di Dante stesso, il viaggio di Ulisse è il corrispettivo antico dell’avventura dantesca, il pellegrino Dante è il nuovo Ulisse che raggiunse non solo il lito deserto del Purgatorio, ma anche l’Empireo.
Il nuovo Ulisse è dunque Dante, l’argonauta che con tenace volontà oltrepassa il varco folle del suo simile.
A questo punto sorge qualche domanda, che rapporto c’è tra il vecchio e il nuovo Ulisse? Chi è Ulisse? Come si è formato? Un Ulisse rivoluzionario perché devia da un certo comportamento: rimanere nella tanto desiderata Itaca e vicino ai suoi famigliari. Forse il Poeta ha capito più di altri l’ardore che ribolliva nell’animo di Ulisse, un ardore che lo ha spinto lontano dalla patria.
L’Ulisse di Dante prende vita in Cristoforo Colombo e dopo Colombo molti altri navigatori attraversano gli immensi oceani e raggiungono i poli estremi.
Nel XX secolo non ci sono più terre ignote da scoprire.
Il folle volo di Ulisse si compie dunque anche nel XX scolo: uomini e donne si lanciano in viaggi d’avventura e d’esplorazione sfidando continuamente i limiti posti sul loro cammino. In questi viaggi-sfida o folli voli, si afferma Ulisse, ossia l’uomo in quanto volontà d’azione alla massima forza.
L’azione è, secondo Hannah Arendt, la sola attività che ci metta direttamente in relazione con la realtà, con gli altri e con noi stessi. L’azione crea la condizione del ricordo, vale a dire della Storia. Il viaggio-azione di Ulisse, che ha formato l’Uomo Ulisse, si fa parola, ricordo vivente, il viaggio – azione di Ulisse apre la via ad altri viaggi che si moltiplicano sino ad oggi.
Nella mia giovinezza ho navigato
lungo le coste dalmate. Isolotti
a fior d’onda emergevano, ove raro
un uccello sostava intento a prede,
coperti d’alghe, scivolosi, al sole
belli come smeraldi. Quando l’alta
marea e la notte li annullava, vele
sottovento sbandavano più al largo,
per fuggirne l’insidia. Oggi il mio regno
è quella terra di nessuno. Il porto
accende ad altri i suoi lumi; me al largo
sospinge ancora il non domato spirito,
e della vita il doloroso amore.
Il poeta Umberto Saba nel 1948 pubblica questa lirica in cui, per così dire, si identifica con Ulisse e che compendia la sua esistenza facendone un testamento spirituale. Il titolo, oltre ad evocare il topos della navigazione e del mare come metafora del viaggio e della vita, richiama l’Ulisse dantesco con la sua curiositas, la sete di conoscenza che lo spinge verso mete sempre nuove ed inesplorate. Il poeta nella sua giovinezza navigava alla scoperta di isolotti presso la costa dalmata pieni di insidie, come lo è la vita, ma, giunto alla maturità non desidera un rassicurante e confortevole approdo nel porto consueto, ma il suo “non domato spirto” lo induce a tornare al largo piuttosto che rinchiudersi, o peggio, accontentarsi di ciò che ha visto e conosciuto: egli vuole indagare, porsi domande, vagheggia nuove sfide e nuovi obiettivi, vuole infrangere ogni limite imposto e, più di ogni altra cosa, continua a perseguire e capire “della vita il doloroso amore”. Difficile trovare un ossimoro più significativo ed emblematico per esprimere la continua tensione dell’uomo verso la conoscenza di se stesso nonostante la consapevolezza della sofferenza.
Analoghe tematiche vengono trattate in una lirica famosa del poeta Konstantinos Kavafis dal titolo “Itaca”, scritta nel 1911, che ugualmente paragona il cammino della vita al viaggio mitico di Ulisse verso Itaca che diviene metafora della conoscenza, ambita vetta a cui l’uomo tende. Il poeta sottolinea che non si deve affrettare il percorso per giungere all’agognata meta, l’essenziale non è tanto guadagnarla velocemente quanto il viaggio per raggiungerla, i sogni, le aspirazioni di ognuno, la consapevolezza di aver faticato, lottato, conosciuto, fatto esperienze per giungervi in età matura dopo aver affrontato il percorso, talvolta burrascoso, della giovinezza. Si potrebbe pure rimanere delusi dalla nostra personale Itaca, ma l’importante è aver acquisito la coscienza di aver vissuto per uno scopo e di aver affrontato Ciclopi, Lestrigoni, l’avverso Poseidone, che sono i simboli degli ostacoli che si frappongono tra noi e Itaca, che noi dobbiamo superare senza che ai nostri occhi si ingigantiscano e diventino insormontabili. Solo al nostro arrivo avremmo così la possibilità di rielaborare le nostre conoscenze ed esperienze che sono le sole a rendere la nostra esistenza unica e ricca spiritualmente.

Solo la sapienza, pur senza beni materiali, è il solo bene che non delude mai.
Se per Itaca volgi il tuo viaggio,
fa voti che ti sia lunga la via,
e colma di vicende e conoscenze.
Non temere i Lestrigoni e i Ciclopi
O Poseidone incollerito: mai
Troverai tali mostri sulla via,
se resta il tuo pensiero alto e squisita
è l’emozione che ci tocca il cuore
e il corpo. Né Lestrigoni o Ciclopi
né Poseidone asprigno incontrerai,
se non li rechi dentro, nel tuo cuore,
se non li drizza il cuore innanzi a te .
Fa voti che ti sia lunga la via.
E siano tanti i mattini d’estate
che ti vedano entrare ( e con che gioia
allegra) in porti sconosciuti prima.
Fa scalo negli empori dei Fenici
per acquistare bella mercanzia,
madreperle e coralli, ebani e ambre,
voluttuosi aromi d’ogni sorta,
quanto più puoi voluttuosi aromi.
Recati in molte città dell’Egitto,
a imparare ai sapienti.
Itaca tieni sempre nella mente.
La tua sorte ti segna a quell’approdo.
Ma non precipitare il tuo viaggio.
Meglio che duri molti anni, che vecchio
Tu finalmente attracchi all’isoletta,
ricco di quanto guadagnasti in via,
senza aspettare che ti dia ricchezze.
Itaca t’ha donato il bel viaggio.
Senza di lei non ti mettevi in via.
Nulla ha da darti più.
E se la ritrovi povera, Itaca non t’ha illuso.
Reduce così saggio, così esperto,
avrai capito che vuol dire un’Itaca.

Maria Barchiesi è nata a Cremona nel '53; si è laureata in Lettere Classiche e perfezionata in Storia della Filosofia Antica presso l'Università di Pavia, sempre con il prof. Mario Vegetti con il quale ha collaborato presso lo IUSS pavese. Da sempre ama viaggiare e la cultura in tutte le sue manifestazioni e saperi è la sua scelta di vita prioritaria. Nell'insegnamento presso le scuole superiori e lo IUSS ha vissuto il rapporto con i giovani di età diversa sempre con entusiasmo e desiderio di vederli culturalmente crescere. Il principio che la guida nelle ricerche è: kalos kai agathos, ciò che esprime bellezza è anche buono eticamente, fa bene all'anima e alla mente.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG