
Nella categoria: HOME | Articoli critici
Aveva diciannove anni Leopardi quando scoprì il fascino della donna e i primi veri turbamenti erotici ingenerati in lui non da fantasie prodotte dall'immaginazione, ma dalla vista e dalla frequentazione di una creatura reale e, soprattutto, affascinante. E fu una vera rivoluzione. Infatti compare nella vita di Leopardi, provocando emozioni, sentimenti e riflessioni dirompenti, Geltrude Cassi Lazzari, una donna che, ignara di tutto, delle attenzioni particolari che Giacomo le riserva, degli stati d'animo che insorgono in lui e dei pensieri conseguenti, entra nella vita del giovane e poi, come un fantasma che scompare, se ne va lasciandolo ad interrogarsi sul mistero e sui segreti dell'amore, sulla sua natura, sulla sua essenza, sui meccanismi che mettono in moto l'innamoramento e sui percorsi che conducono ad esso.
La comparsa di questo fantasma risulta quasi invocata dallo stesso Leopardi che, tra tante intuibili fantasie tipiche dell'età giovanile, da tempo avvertiva la necessità di sperimentare l'effetto della vicinanza di una donna bella e seducente:
Io cominciando a sentire l'impero della bellezza, da più di un anno desiderava parlare e conversare, come tutti fanno, con donne avvenenti, delle quali un sorriso solo, per rarissimo caso gittato sopra di me, mi pareva cosa stranissima e meravigliosamente dolce e lusinghiera: e questo desiderio della mia forzata solitudine era stato vivissimo fin qui.
(“Diario del primo amore” pag.9)

Così scrive tra il dicembre del 1817 ed il gennaio del 1818 nel “Diario del primo amore” nel quale ripercorre le varie fasi della sua prima esperienza amorosa, un'esperienza che si svolge sul piano della fantasia e dell'immaginazione, anche se germinata dalla conoscenza di una donna reale, e poi viene rivissuta sul piano di una vera e propria operazione conoscitiva.
E l'occasione di soddisfare il suo tormentoso desiderio si presentò la sera di giovedì 11 dicembre 1817 quando una donna, proprio Geltrude Cassi Lazzari, entrò nella sua casa con quelle forme e quella bellezza vagheggiate dal giovane Giacomo nelle sue fantasie erotiche. E fu un evento sconvolgente anche se atteso. Fu un'apparizione che, come si è detto, mise in moto nel giovane oscuri meccanismi sentimentali e diede linfa ai suoi sogni e alle sue conturbanti fantasie erotiche.
Geltrude era figlia della sorella Virginia, madre di Monaldo Leopardi.
Giacomo si rese conto che nulla avrebbe potuto ottenere da quella bella signora. Una cosa apparve chiara al poeta: "quel piacere era stato più torbido e incerto ch'io non me l'era immaginato". Si tratta quindi di una scoperta, la scoperta di un piacere ambiguo, inatteso, non facilmente definibile e catalogabile, anche inquietante, come quello che può essere provocato dall'individuazione dei primi segni dell'eros e dai turbamenti ch'esso comporta. Poi egli cominciò a sentire nel suo cuore nuove sensazioni forse mai provate prima: "io mi sentiva il cuore molto molle e tenero, tenerezza che durante la sera, a cena, aumentò ancor di più: e insomma la Signora mi premeva molto".
E' amore vero quello del poeta?
Noi - e si inserisce anche Maria Corti che ha raccolto tutti gli scritti leopardiani - pensiamo che si sia trattato di un'infatuazione erotica, tipica del carattere di un giovane nella fase delle sue prime esperienze nel campo dell'amore. Forse è anche fin troppo facile pensare che Geltrude, con la sua avvenenza e la procacità del suo corpo, abbia attratto l'attenzione di Giacomo e ne abbia mobilitato i flussi sensuali. Per questo io propongo anche la teoria elaborata da Gazzola Stacchini nel suo saggio "Alle origini del sentimento leopardiano". Nel saggio in tal caso non è importante definire l'amore di Leopardi per Geltrude, ma chiarire i motivi per cui lei gli piacesse tanto. E prendendo spunto dal fatto che la mamma di Giacomo fosse "grande" fisicamente e tenendo conto delle predilezioni del poeta per donne "membrute", la studiosa afferma che egli è portato a cercare, nel suo ideale femminino, l'immagine materna. Ciò confermato dal fatto che nel Diario Geltrude è descritta come donna più grande di lui per età, protettiva, davvero materna. Quando nell'anno 1818 il fratello Carlo si innamorò di Geltrude l'infatuazione del poeta era già terminata.
C'è una ragazza che ha avuto nella vita di Leopardi una straordinaria importanza. E non per un rapporto sentimentale tra i due, anzi direi, che è del tutto esclusa ogni idea di innamoramento vero, com'è testimoniato direttamente sia da Giacomo che dal fratello Carlo, ma perché il suo fantasma agì nella mente e nella memoria del poeta per lungo tempo, almeno fino a quando non provocò in lui quello status logico emozionale e lirico da cui nacque Silvia, uno dei personaggi poetici più elevati della nostra letteratura. Si tratta della figlia del cocchiere di casa Leopardi ed abitava con la sua famiglia di fronte al palazzo Leopardi, dall'altro lato della piazza. Questa ragazza, nata il 10 ottobre 1797, ebbe un destino ingrato e tragico, anche se proprio ad esso deve la sua immortalità. “Teresa aveva statura conveniente, era bianca, secchettina, non familiare con altri; vestiva assai pulitamente e, portava i capelli neri, di cui si fa riferimento nel canto”. Tali notizie sono fornite da Piergili a Mestica: queste annotazioni sono conservate negli Studi Leopardiani presso Recanati.
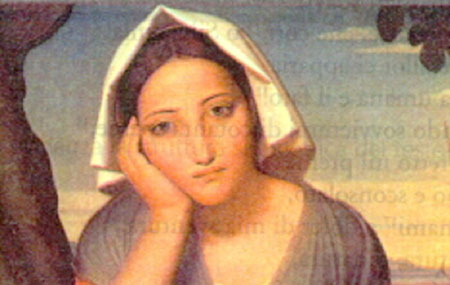
Ma quale fu il rapporto del poeta con Silvia?
Possiamo ricostruirlo sulla base di tre appunti contenuti nei “Ricordi d'infanzia e di adolescenza”, scritti nella primavera del 1819, come si evince da alcuni dati cronologici interni al testo. Nel primo il poeta annota, con un'evidente punta di rimprovero, di aver sentito “cenare allegramente dal cocchiere intanto che la figlia stava male”, e, soprattutto di aver nutrito “interesse” per “la storia di Teresa da me poco conosciuta”, interesse “ch'io ne prendeva come di tutti i morti giovani”.
Nel secondo Leopardi ricorda “il canto mattutino allo svegliarmi delle figlie del cocchiere e in particolare quello di Teresa”.
Nel terzo il poeta ricorda come Teresa si fosse trovata in una grave condizione psicologica per il caso” della sorella carcerata e condannata di furto” e come un bagno fosse stato cagione della sua malattia. Tali annotazioni compaiono in “Diario del primo amore ed annotazioni autobiografiche” pag.29-44.
Il destino di questa giovane vita, prima insidiata dal male, poi troncata dalla morte proprio nel fiore degli anni, scosse l'animo del poeta fino a diventare un fantasma della sua mente che lo accompagnerà almeno fino al 1828, anno in cui Giacomo farà di Teresa - ipostatizzata nella figura di Silvia - l'emblema delle speranze deluse e del tradimento perpetrato dalla natura ai danni dell'uomo. Fu proprio in quell’anno, infatti, che Leopardi compose la canzone A Silvia, nella quale, con un'elevata sintesi lirica, fece di Teresa-Silvia il simbolo della dolorosa condizione umana proiettando sullo sfondo di universale destino quello che era stato il destino di una povera ragazza uccisa da una malattia. E mi sembra importante sottolineare che Ranieri ricorderà significativamente, a proposito del periodo trascorso da Giacomo a Torre del Greco, nella villa Ferrigni che “al bordone di un telaio si compiaceva di udir il canto di una giovinetta fidanzata ad un figliuolo del fattore, e che aveva ancor essa il nome di Silvia”, come a dire che il fantasma della “tessitora” era destinato ad abitare nell'immaginario del poeta.
Non si deve incorrere nell'errore di credere che Silvia-Teresa non siano altro che in forma lirica la trasposizione di Teresa. Non bisogna dimenticare la distanza cronologica che separa Teresa da Silvia e l'approfondimento che avvenne in Leopardi in quegli anni. Certo Teresa è tutta in Silvia. Il poeta che aveva conosciuto Teresa e il suo dramma, si era sentito toccato profondamente dal suo destino di dolore e di morte e questo destino aprì le porte per penetrare in una teoresi del dolore umano e il fantasma rimasto in lui lo portò alla composizione dell'idillio. Infatti ha ragione il critico Dotti a notare che proprio quando Teresa muore, tradita dalla natura, che non mantiene le promesse, avvengono la sua resurrezione e la sua trasfigurazione e la sua epifania si svela in tutto il suo nodo problematico, tanto del duplice volto dell'esistenza, quello della promessa e quello del disinganno, Teresa Fattorini, trasfigurata in Silvia, è divenuto il simbolo eterno. Ed è vero perché nel mito di Silvia sono presenti di Teresa, liricamente trasfigurati: la via mortale, la beltà, gli occhi ridenti e fuggitivi, l'atteggiamento lieto e pensoso, l'avviarsi verso il limitar di gioventù, il canto perpetuo, il vago avvenire sognato e progettato, il suon della sua voce, la faticosa tela, i pensieri soavi, le speranze, vi sono anche il fiore degli anni, le negre chiome, gli sguardi innamorati e schivi, e la solitudine disperata che non consentiva alla giovane malata di ragionar d'amore con le sue compagne. Ma di Teresa vi è soprattutto la sventura e il tradimento subito dalla vita e dalla natura, la negazione della giovinezza, la fredda morte, e la tomba ignuda. Normalmente il poiein rifugge da schemi descrittivi di fatti o eventi reali e il poeta, pur quando si rifà alla realtà, la trasforma e trasfigura trascendendola attraverso un discorso lirico o mitopoietico. E si può quindi sostenere che Silvia, pur partendo il suo autore da un archetipo reale, sia stata costruita facendo leva sull'immaginazione creativa, anche se, a mio avviso, la simbolicità di Silvia non abbracciava un'idea, ma una donna realmente vissuta. E se leggiamo attentamente l'idillio soprattutto nella parte iniziale sembra di ritrovarsi di fronte ad una descrizione trecentesca: una figura femminile angelica e pura, nel fior della vita, capace di elevar l'animo, di portare con sé un'idea di felicità, insomma una donna tutta stilnovista. Direi però con qualche ripiegamento interiore (occhi ridenti e fuggitivi). Ma nella seconda parte la posizione di Leopardi muta radicalmente e il suo entusiasmo viene raggelato da considerazioni fortemente negative circa la possibilità di realizzare le proprie attese e i propri sogni da parte di una giovane che vive con grande intensità la progettazione del proprio futuro. Il poeta indubbiamente non fu innamorato di Teresa Fattorini, fu sensibile e colpito dal destino di quella ragazza e sottolineerei un aspetto autobiografico nella vicenda di Teresa: Giacomo vedeva il destino di Teresa molto simile al suo. La morte di Teresa-Silvia coincide per il poeta con la morte della speme rimasta viva con Teresa e quella speme, la sua speme muore con Teresa.
Ad avvalorare questa tesi, di una semplice conoscenza che mai è diventata altro, vi è la testimonianza del fratello Carlo che, trent'anni dopo la morte della ragazza a Prospero Viani durante una loro conversazione:
Molto più romanzeschi che veri gli amori di Nerina e di Silvia. Sì vedevano dalle nostre finestre quelle due ragazze e, talvolta parlavamo a segni. Amori, se tali possono dirsi, lontani e prigionieri. Le dolorose condizioni di quelle due povere diavole, morte nel fiore degli anni, furono bensì incentivo alla fantasia di Giacomo a creare due dei più bei tratti delle sue poesie. Una era figlia del cocchiere, l'altra tessitora (Viani “Appendici all'epistolario”).
Nella canzone “A Silvia” l'immagine di Silvia assedia la memoria del poeta, ad essa il poeta si rivolge come se la fanciulla fosse ancora viva, e come attendendo risposta. Ma dai versi deriva un'aura lontana di malinconia, che diffonde un pallore di morte sull'incanto di quei versi. I critici hanno individuato la fonte di ciò nelle parole: “rimembri ancora, quel tempo, quando beltà splendea”. Voci e parole ci suggeriscono più che dire, come sempre del resto, in questo canto mirabile. Sono tra i versi più lunghi e ariosi di Leopardi, pieni tutti di quel canto, e come odorosi di sogni e di liete speranze. Compaiono le tracce di un paesaggio tra i più luminosi e palpitanti, un paesaggio fatto solo di canto e luce, o meglio di speranza, di fiduciosa letizia. Nelle strofe precedenti il poeta ha rievocato l'immagine della fanciulla, in quelle che seguono se stesso, o meglio il suo stato d’animo in quegli anni, e l'eco che destava in cuor suo il canto di Silvia ed anche in questi versi un'incantevole descrizione paesaggistica, in quel cielo sereno, in quelle vie dorate, in quegli orti, in quell'immagine lontana di mari e di monti, è diffuso il canto di Silvia, cioè quell'ineffabile commozione che deriva dalle speranze giovanili. In questi versi sentiamo la comunanza degli affetti e del dolore dei due giovani, in una esclamazione “O Silvia mia!”. Dopo l'accusa verso la Natura, il poeta torna a rivolgersi a Silvia, per accennare alla sua morte, avvenuta prima che la fanciulla giungesse a vedere il fiore della sua giovinezza, prima che potessero gli sguardi dei giovani innamorati lusingare il suo cuore e quegli sguardi innamorati e schivi ci riallacciano come per un rimare vaghissimo e lontano, al verso della strofa iniziale: “gli occhi ridenti e fuggitivi”. Ma in questi sguardi schivi c'è un'intensità più sofferta. Come Silvia è morta prima di vivere la giovinezza, nello stesso modo caddero le speranze del poeta. Silvia è figura reale e, nello stesso tempo, simbolo di ciò che alimenta la giovinezza, la speranza.
Chi era Maria Belardinelli?
Era figlia di Tommaso e di Maddalena Antonelli, nata il 10 dicembre 1800, tessitrice. Coetanea di Giacomo, ma anche della Fattorini, dovette affrontare un destino forse ancor più tremendo di quello di Teresa. Per togliersi un dente, Maria si recò a Montesanto da un frate. L'intervento non ebbe un esito positivo: il dente si ruppe e provocò una cancrena che portò la giovane alla morte, dopo sette mesi di sofferenze e crudeli patimenti, il 3 novembre 1827. Ed anche Maria, come Teresa, entrerà in un mito poietico, quello di Nerina, il mito delle Ricordanze. La famiglia Belardinelli abitava vicino a palazzo Leopardi. Maria era una ragazza dalla carnagione bianca e bionda, secondo la testimonianza della sorella resa a Piegili nel 1880. Proprio come la Nerina virgiliana era bellissima e garbata nei modi e nel portamento. Nerina è qualcosa di meno autobiografico di Silvia, di molto più allusivo e simbolico. Anche Nerina, come Silvia, è rappresentata morta nel fior degli anni, ma noi non la vediamo in vita seduta al lavoro del telaio “assai contenta / di quel vago avvenir che in mente avevi”. Se Silvia era un'evocazione, era però nata dal concreto del vissuto, Nerina è un puro simbolo, quello della giovinezza destinata a sparire per non tradire. La stessa stupenda movenza con la quale viene rappresentato il suo entrare nell'esistenza - ivi danzando - è quanto mai sintomatica della levità dell'immagine simbolo, della giovinezza subito apparsa e subito scomparsa.
Netto è il contrasto fra la risonanza sentimentale affettuosa, ma in un certo senso, tranquilla, che il poeta esprime per Silvia e l'ardore, la fervida passione che lo anima quando la ricordanza coinvolge Nerina, come una evidente differenza c'è fra il rammarico pacato che manifesta per la morte di Silvia e la sofferenza quando pensa alla morte di Nerina, con qualche anno in più, cui, però, dedica solo gli ultimi 38 versi, pur intensi e struggenti, ma solo questi a fronte di 173 che compongono ”Le Ricordanze”.
E' chiaro che, in mancanza di qualche indicazione dello stesso poeta, non si possa andare al di là di semplici congetture, ma è ancora più chiaro che poco interessi alla comprensione del canto conoscere la verità: Nerina è Nerina come Silvia è Silvia: due momenti della storia interiore leopardiana, due fantasmi evocati dal sepolcro dei sogni infranti. Dai versi delle Ricordanze sembrano emergere riferimenti concreti che fanno pensare ad una creatura reale. Ma Nerina è soprattutto simbolo della rapidità con cui passano i sogni, della nostalgica ricordanza che ne avanza e su cui mesto riluce delle stelle il raggio.
Lontana da ogni equivoco amoroso è Silvia legata alla memoria. La dimensione del ricordo rende la fanciulla quasi priva di una sua fisionomia fisica precisa. I singoli tratti mortali di Silvia acquisiscono una certa immortalità: il “canto perpetuo” e risuona nelle “quiete stanze” anche dopo la morte di Silvia, anche se questa sorta di immortalità della fanciulla non si colora del divino, è un'immortalità conferitale dalla memoria del poeta. Sparisce Silvia ed appare Nerina nel momento in cui Leopardi racconta la sua giovinezza e ritornando alle speranze antiche, fra esse viene introdotta Nerina, fusione di giovinezza, femminilità, bellezza ed innocenza. Non sarebbe improprio sostituire l'esclamativo “O Nerina!” con quello di “O Giovinezza!”. Dietro a Nerina sta il ricordo della rapidità con cui fugge la giovinezza. Possiamo concludere che Silvia e Nerina evocano, sono il simbolo di una donna o una fanciulla che non si trova? Direi di sì, diversamente da altre presenze femminili leopardiane.
Dalle lettere del poeta si coglie una strana aspettativa, quella di essere accolto favorevolmente nei salotti romani sia dagli intellettuali che dalle donne. A tal proposito è interessante quanto scrive al fratello Carlo riguardo alle donne romane disprezzate esteticamente e all'amore che qui a Roma non si diversifica da Recanati. Sembra di poter dedurre dalle lettere inviate a Carlo, al quale riferisce la necessità di denaro, che il poeta frequentasse le cosiddette donne pubbliche e in più punti scrive di non conoscere donne di rango. Dall'epistolario emerge con evidenza che non rifuggisse da pratiche sessuali. Affermare che le donne romane “non la danno (credetemi) se non con quelle infinite difficoltà che si provano in altri paesi” sottintende che, sebbene tra intuibili difficoltà, una dimestichezza con le pratiche erotiche Giacomo dovette averla, tanto è vero che le sue parole suscitarono l'entusiasmo degli studiosi che sostenevano che il poeta recanatese certamente conosceva il piacere del sesso. Tali annotazioni del poeta sono presenti nella lettera del 6/12/22 indirizzata al fratello Carlo.
E allora è il caso di affrontare qui anche il problema della presunta verginità sessuale di Leopardi, sebbene affrontare argomenti di tale intimità possa sembrare una violazione della privacy, cosa tanto più grave trattandosi di un uomo che ha lasciato traccia di sé come poeta immortale. Ma il problema fu sollevato dal suo amico Ranieri quando affermò che “quest'uomo, degno per tutte le parti di un secolo migliore, si portò intatto nel sepolcro il fiore della sua verginità”: tale affermazione è presente in “Notizia intorno alla vita e agli scritti di Giacomo Leopardi”. Ebbene l'affermazione di Ranieri sembra poco plausibile, proprio se si tiene conto delle confidenze dello stesso Giacomo al fratello Carlo prima riportate. E tale apparve a Mestica (“Non si fa torto a Leopardi ricordando ch'egli non rifuggiva dalle inclinazioni erotiche insite nella natura umana”, in Studi leopardiani), ad Anna Traversi (che ammise “briciole di voluttà pregustate” in Studi su Giacomo Leopardi). Dunque sembrerebbe ipotizzabile che comunque Giacomo sperimentò la pratica sessuale. E piace affermarlo, ed ha un senso, perchè ciò confermerebbe ch'egli nutriva verso la vita e l'amore un istintivo trasporto, e che viveva con indicibile dolore i tradimenti che la vita e l'amore gli propinavano quasi quotidianamente.
Tra tutte le donne conosciute a Bologna da Leopardi, la Malvezzi fu l'unica a risvegliare veramente in lui il fuoco dell'amore e fargli provare sensazioni e stimoli nuovi e insperati che egli riteneva ormai cancellati dalla sua ancora giovane vita.

Chi era Teresa Carniani Malvezzi?
Era una donna bionda, bella, non più giovane con i suoi quarant’anni all'epoca in cui Giacomo la conobbe, un po' civettuola e maliziosa, un po' capricciosa e un po' seduttrice, un po' romantica e sognatrice e un po' accorta e concreta, elegante e raffinata. A queste qualità che la rendevano piacente, desiderabile, affascinante, aggiungeva un certo talento letterario. Nella sua formazione letteraria si fece guidare da insigni personaggi che frequentavano il suo salotto, così Teresa si costruì la fama di donna colta e raffinata. Anzi per dirla con Leopardi: “donna di molto spirito e molta cultura”. Il salotto della Malvezzi era tanto raffinato da diventare celebre a livello internazionale. Per Giacomo l'incontro con la Malvezzi fu la scintilla che rianimò il suo cuore e, per così dire, lo sollevò dal letargo in cui si trovava da parecchio tempo.
Che cosa significasse davvero per lui l'incontro e la frequentazione della Malvezzi è ampiamente documentato dalle lettere che i due si scambiarono e sulle quali vorrei soffermarmi, perchè costituiscono un documento eccezionale della tipologia particolare del loro rapporto e permettono di conoscere le pieghe più nascoste dell'animo del giovane poeta. Il 30 maggio 1826 Giacomo scrive al fratello Carlo una lettera nella quale gli descrive la donna che ha conosciuto e gli incontri che ha avuto e ha con lei:
“Sono entrato con una donna, fiorentina di nascita, in una relazione, che forma ora gran parte della mia vita. Non è giovane, ma è di una grazia e di uno spirito (...) che supplisce alla gioventù, e crea un'illusione meravigliosa (...). Non abbiamo mai parlato di amore, se non per ischerzo, ma viviamo insieme un'amicizia tenera e sensibile, con un interesse scambievole, e un abbandono, che è come un amore senza inquietudine. Ha per me una stima altissima; se le leggo qualche mia cosa, spesso piange di cuore, senza affettazione (...) quasi ogni sera io sono con lei dall'avemaria alla mezzanotte passata. Lei ha risuscitato il mio cuore (“Epistolario” del 30/5/1826)
Siamo di fronte al primo innamoramento vero del Leopardi, non essendo le altre avventure che semplici infatuazioni. Leopardi, però, non si azzarda a chiamare questa relazione amore. Ma si sa che il rapporto tra Giacomo e Teresa poggiava su una forte ambiguità. Teresa era interessata agli scritti di Leopardi ed un interesse di profonda amicizia con un letterato come lui, senza mai farsi sfiorare dall'idea di un vero rapporto di amore. E infatti la contessa cominciò a stancarsi di lui, anche perché a Bologna ormai il loro rapporto era diventato oggetto di chiacchiere, maldicenze, insinuazioni e pettegolezzi difficili da tollerare. Tra la fine di settembre e i primi di ottobre del 1826, la contessa, con modi bruschi e senza giri di parole, disse al suo spasimante che trovava noiosa la conversazione da solo a solo. Si trattò di un vero e proprio licenziamento, la contessa non voleva più vederlo. Giacomo scrisse una lettera nella quale presumibilmente chiedeva un appuntamento chiarificatore. E l'incontro ci fu e cosa si siano detti non lo sapremo. Certo la contessa promise al poeta che, partito nel 1827, avrebbe inviato lettere a Recanati, cosa che non accadde. Va sottolineato il carattere, a mio avviso, piuttosto ambiguo del rapporto tra Teresa e Giacomo; forse ad equivocare maggiormente fu proprio Giacomo che idealizzò questa donna definendola “la donna che non si trova”. Una certa responsabilità va attribuita anche alla contessa che, per coltivare interessi letterari e filosofici non volle vedere ciò che forse era evidente a tutti ed anche a lei: un poeta molto colto e molto innamorato.
Gli studiosi raffigurano questa nobildonna con una accentuata tendenza a metterne in rilievo la capacità di seduzione, il desiderio di essere corteggiata e amata, il carattere vivace e spigliato. Insomma si è parlato molto di una donna sostanzialmente leggera, sia nel senso di donna facile agli amori, spregiudicata e cinica, sia nel senso di disimpegnata culturalmente. Sulla base dei documenti, di una lettura interpretativa delle lettere e dei versi composti dal poeta ci serviremo per ricostruire una vicenda per molti aspetti ambigua ed equivoca, e tuttavia di grande momento nella vita del Leopardi. Giacomo, subito dopo averla conosciuta, cominciò a frequentare il salotto di Fanny della quale si innamorò di un amore vero e passionale. Alcuni ritengono che esso risalga ad un periodo antecedente al 1831, data della lettera che Giacomo inviò a Fanny da Roma; altri invece pensano ad un periodo che va dal luglio del 1832 all'aprile del 1833, cioè al tempo in cui Ranieri dovette tornare a Napoli e Giacomo restò solo a Firenze. In verità l'interesse di Giacomo per Fanny si manifestò assai presto, subito dopo la loro conoscenza. Lo dimostrano due fatti che sono la spia del desiderio di Giacomo di compiacerla e di conquistarsi la sua simpatia.
Leopardi, tramite Viessaeux si diede da fare per procurare a Fanny un album litografico. A tanto lo spinse il desiderio di far cosa gradita alla sua amica. E siamo nel luglio del 1830. Un impegno ben più accurato e sentito da Giacomo per procurarsi i meriti di Fanny fu quello di mettere in moto le sue amicizie per arricchire la collezione di autografi di uomini illustri che era una passione cui Fanny teneva particolarmente. Nel frattempo, seppure nell'ombra e in fase latente, l'innamoramento di Fanny per il bel Ranieri era già in fase di avanzamento, nonostante egli fosse impegnato nelle solite rincorse alla Pelzet. Fanny aveva conosciuto Ranieri fra il 1827 /1828 e fu subito un colpo di fulmine. Per allora sembrò che Fanny manifestò più sentimenti di amicizia che di amore verso Ranieri tormentato dal suo travagliato rapporto con la Pelzet. Fanny scrisse a Ranieri, mentre proprio da Roma Giacomo scrisse a Fanny una lettera che si apre significativamente con “Cara Fanny”.
Vorrei sottolineare che i tempi dell'innamoramento di Giacomo per Fanny sono due e, a mio avviso, è molto significativo il secondo: l'amore per Fanny nacque durante il periodo in cui Giacomo rimase solo a Firenze dopo la partenza di Antonio, richiamato a Napoli dal padre nel periodo dal luglio del 1832 all'aprile del 1838. Secondo tale ricostruzione, Fanny, innamorata di Antonio che era lontano da Firenze, avrebbe riversato sul poeta attenzioni ed anche blande carezze ed avrebbe intrattenuto con lui conversazioni più affettuose ed espansive sul tema dell'amore e dei sentimenti, inducendo in Giacomo un innamoramento progressivo, sempre più profondo e sofferto. Personalmente, supportata da molta critica, ritengo che, anche se gli atteggiamenti di Fanny verso Leopardi furono certamente in quel periodo più affettuosi e carezzevoli, è più probabile che egli fosse innamorato di lei già da prima della partenza per Roma. D'altra parte che egli fosse capace di innamorarsi a prima vista di una donna bella e piacente, è dimostrato dai suoi comportamenti. Lo testimonia il suo innamoramento per Geltrude Cassi. Giacomo subito dopo il ritorno da Roma, aveva cominciato a frequentare di nuovo la casa di Fanny e, dopo la partenza di Antonio, spesso dovette parlare con lei del suo amico. Anzi, forse si parlava solo di Ranieri. Non conosciamo la reale portata di queste conversazioni nelle quali coesistevano due sentimenti: l'amicizia devota per Ranieri e l'amore del poeta per Fanny. Non è difficile ipotizzare una tempesta di sentimenti contrastanti e corrosivi, amore, amicizia, gelosia, sofferenza e amarezza. E' questo probabilmente il periodo in cui Leopardi scrive Il pensiero dominante, uno dei canti dedicati a Fanny che costituiscono il cosiddetto ciclo di Aspasia (Il pensiero dominante, Amore e Morte, Consalvo, A se stesso, Aspasia). L'amore è appunto “un pensiero dominante”, un pensiero che occupa mente e cuore, che coinvolge e condiziona tutte le azioni dell'uomo, la sua vita psicologica e quella morale. Esso è
dolcissimo, possente
dominator di mia profonda mente,
terribile, ma caro
dono del ciel; consorte
ai lugubri miei giorni,
pensier che dianzi a me sì spesso torni (v.1-6)

E' la prima strofa del canto, nella quale il concetto di amore, questa divinità che mai viene nominata dal poeta, si impossessa di lui, quando è in sua presenza e viene espresso in connotazioni, riportate prima, che costituiscono un campo semantico contraddittorio. E' un amore dolcissimo, possente, dominatore di tutti i pensieri che da esso vengono condizionati, ma anche terribile, pensiero che ritorna anche senza essere richiamato. E inoltre da esso deriva una gioia celeste, che richiama, per certi aspetti, le tematiche e il linguaggio di stilnovistica memoria, tanto che Giacomo vede l'amore come una sorta di campo verde, come un lieto giardino. Tra tutti i sentimenti riportati nella argomentazione precedente è la gelosia che sorprende in Giacomo per l'amico Ranieri, sorprendente, ma non inspiegabile, perchè è impossibile che Giacomo non abbia avvertito un sentimento di gelosia verso l'amico. Giacomo avrà pur ascoltato le avventure amorose dell'amico e anche del suo amore per Fanny, ma è difficile dimenticare che il poeta era un uomo davvero innamorato. Giacomo ha sofferto da vero amante, da innamorato illuso prima, deluso poi. Il poeta è stato un amante silenzioso, incapace di dichiarare il suo amore. E' stato capace di parlarne solo liricamente, quando il silenzio si è trasformato in voce del canto. E infatti il ciclo di Aspasia che cosa è se non il momento della confessione dell'amore tormentato e vissuto nelle angosce procurate dal comportamento di lei? Nel ciclo di Aspasia il poeta riversa un forte e duro risentimento verso Fanny, donna vera e viva e non donna dell'immaginazione, donna che, pur nelle sue ambiguità e nell'inafferrabilità dei suoi sentimenti più profondi, ha comunque costituito il motivo di un'esperienza per il poeta, io penso, appagante. E' proprio del 1832 un altro testo del ciclo, Amore e Morte, la cui tematica fondamentale è questa: Amore e Morte sono due fratelli creati per gli uomini dalla sorte. Dall'Amore nasce il piacer maggiore/ che per lo mar dell'essere si trova; la Morte ogni gran dolore/, ogni gran mal annulla. Perchè l'Amore e la Morte si tengono compagnia e convivono nella vita dell'uomo? Come accade?
Quando novellamente
nasce nel cor profondo
un amoroso affetto,
languido e stanco insiem con esso il petto
un desiderio di morir si sente:
come, non so: ma tale
d'amor vero e possente è il primo effetto (v.27-33)
Ma non solo il languore generato dall'Amore richiama quello provocato dalla Morte, anche l'insorgenza di una passione d'amore può essere la causa scatenante del desiderio della morte:
Poi, quando tutto avvolge
la formidabil possa,
e fulmina nel cor l'invitta cura,
quante volte implorata
con desiderio intenso ,
morte, sei tu dall'affannoso amante! (v.45-50)
Come a dire che la Morte è compagna fedele dell'Amore perché, laddove l'amore si trasformasse in passione drammatica, la Morte potrebbe intervenire con il suo potere più grande, quello di ridare la pace a chi nella vita, e per amore, l'ha perduta.
E' interessante notare che su queste linee, l'impegno poetico leopardiano giunge ad incontrarsi con le aspirazioni più profonde e drammatiche dell'anima contemporanea, individuando una tematica che, su diversi versanti culturali e con diverso linguaggio sarà particolarmente sofferta nel Novecento; pensiamo solamente alla posizione centrale che assumerà, nell'esperienza freudiana, la dialettica tra Eros e Thanatos: tra Amore (inteso però quale istintuale principio e non quale conquista del sentimento) e Morte (interpretata come originario stimolo all'autodistruzione, e non come sofferto traguardo di un'esistenza esemplare).
All'interno di questo scenario di sofferenza e di dolore, non deve sfuggire quell'accenno all'amore definito sola causa degna di vivere. E' un grido di desiderio di vita di amore, grido che però rimane strozzato in gola: Fanny, qualunque sia la situazione che lo vede coinvolto, non lo ama, non l'ha mai amato, non sa di essere tanto amata o finge di non saperlo. E' un amore non corrisposto, quello di Giacomo, un amore forse mai direttamente dichiarato, un amore sentito e vissuto soltanto da lui, e proprio per questo più drammatico.
L'altro testo di questo periodo, “A se stesso”, composto con ogni probabilità nella primavera del 1833, è un monologo nel quale Leopardi canta il crollo definitivo di quelle illusioni, e quindi dell'amore, sulle quali egli aveva elaborato il suo sistema filosofico e che avevano costruito il tema centrale anche della poesia dei grandi idilli del 1828-1830 sebbene attraverso il recupero memoriale di esse.
Or poserai per sempre,
stanco mio cor. Perì l'inganno estremo,
ch'eterno io mi credei. Perì. Ben sento,
in noi di cari inganni,
non che la speme, il desiderio è spento.
Posa per sempre. Assai
Palpitasti. Non val cosa nessuna
i moti tuoi, né di sospiri è degna
la terra. Amaro e noia
la vita, altro mai nulla; e fango è il mondo.
T'acqueta omai. Dispera
L'ultima volta. Al gener nostro il fato
non donò che il morire. Omai disprezza
te, la natura, il brutto
poter che, ascoso, a comun danno impera,
e l'infinita vanità del tutto.
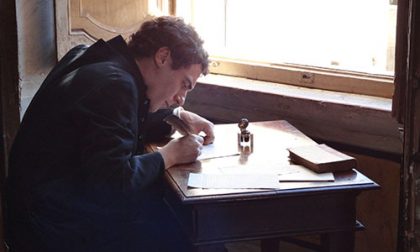
Ora le illusioni sono svanite definitivamente. Quelle che erano un inganno, un caro inganno, che aiutava l'uomo nel faticoso cammino dell'esistenza, scompaiono definitivamente nella lirica leopardiana. E l'amore, l'inganno estremo, che il poeta aveva creduto eterno, è morto per sempre e con esso il desiderio dell'amore. E la vita, senza l'amore, è amarezza e noia. Non resta allora che la morte, dono del fato.
Componimento triste e angosciato, segna il fallimento di un'altra esperienza, appunto quella dell'amore per Fanny, dalla quale Giacomo esce ancora sconfitto. Questi versi dicono di un'esperienza finita, di un dramma che è giunto a compimento. Come, però, si sia consumata la rottura tra Giacomo e Fanny, non lo sappiamo.

Maria Barchiesi è nata a Cremona nel '53; si è laureata in Lettere Classiche e perfezionata in Storia della Filosofia Antica presso l'Università di Pavia, sempre con il prof. Mario Vegetti con il quale ha collaborato presso lo IUSS pavese. Da sempre ama viaggiare e la cultura in tutte le sue manifestazioni e saperi è la sua scelta di vita prioritaria. Nell'insegnamento presso le scuole superiori e lo IUSS ha vissuto il rapporto con i giovani di età diversa sempre con entusiasmo e desiderio di vederli culturalmente crescere. Il principio che la guida nelle ricerche è: kalos kai agathos, ciò che esprime bellezza è anche buono eticamente, fa bene all'anima e alla mente.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG