
Giovanni Pascoli
Il gelsomino notturno
di Reno Bromuro
«È l'alba: si chiudono
i petali
un poco gualciti; si cova,
dentro l'urna molle e segreta,
non so che felicità nuova»
Nella categoria: HOME | TOURismi letterari
• Intro
• Il pensiero di Pascoli
• L'opera: Il gelsomino notturno
• Commento e critica
 Giovanni
Pascoli nacque a San Mauro di Romagna,
l’abbiamo già detto commentando «Arano».
Gli assassinarono il padre quando aveva solo dodici anni. Con la morte
del padre iniziano le tragedie in casa Pascoli, tra cui la morte della
madre, che influenzano profondamente la vita di Giovani e la sua visione
del mondo, nonché la poetica.
Giovanni
Pascoli nacque a San Mauro di Romagna,
l’abbiamo già detto commentando «Arano».
Gli assassinarono il padre quando aveva solo dodici anni. Con la morte
del padre iniziano le tragedie in casa Pascoli, tra cui la morte della
madre, che influenzano profondamente la vita di Giovani e la sua visione
del mondo, nonché la poetica.
Si laurea a Bologna e dopo la laurea, si avvicina
a gruppi anarchici e socialisti, è arrestato e,in seguito all’esperienza
del carcere che lo segnerà fortemente, abbandona la politica attiva.Decide
di dedicarsi all'insegnamento non tralasciando mai la sua unica passione:
la poesia. Come prima destinazione ha Matera,
per insegnare latino e greco nel locale Liceo Ginnasio. Giunge a Matera
il 7 ottobre del 1882. Era molto legato alle sorelle Ida
e Maria, cui scriveva spesso. Riporto alcuni brani:
«Sono a Matera sin dalle ore prime antimeridiane del 7. Arrivai all'una dopo mezzanotte, dopo molto trabalzar di vettura, per via selvagge, attraverso luoghi che io ho intravisto notturnamente, sinistramente belli. (…) Una città abbastanza bella, sebbene un poco lercia».
«I contadini vanno vestiti nel loro simpatico ed antiquato costume e stanno tutto il giorno, specialmente oggi che è domenica, girelloni per la piazza. Hanno corti i brachieri e scarponi grossi senza tacco, una giacca corta e in testa un berrettino di cotone bianco e sopra un cappello tondo. Sembrano che si siano buttati giù dal letto in fretta e furia, e si sian messi per distrazione il cappello sopra il berretto da notte».
Da una lettera del 19 ottobre 1882:
«...ma in generale sto bene a Matera… sai di una cosa mi lagno: qui è troppo caro il vivere e l'alloggio e tira quasi sempre scirocco (…)»
Il 5 ottobre dell’anno successivo scrive Giosuè Carducci:
«Non c'è un libro qua, da vent'anni che c'è un Liceo a Matera, nessuno v'è uscito con tanta cultura da sentire il bisogno d'un qualche libro; i professori pare che abbiano avuto tutti la scienza infusa; e perciò di libri non s'è n'è comprati. Ci vorrebbe forse un sussidio del governo, ma il Governo probabilmente non ne vorrà saper nulla».
 Ed
ora una lettera del 1902 al Preside del Liceo di Matera Vincenzo
Di Paolo:
Ed
ora una lettera del 1902 al Preside del Liceo di Matera Vincenzo
Di Paolo:
«Come mi giova, dopo una vita così torba tornare a cotesta serenità di pensiero e di parole, che avrei dovuto prendere da lei in quella povera città di trogloditi, in cui vissi così felice, sebbene così pensoso! Sì: delle città in cui sono stato, Matera è quella che mi sorride di più, quella che vedo meglio ancora, attraverso un velo di poesia e di malinconia»
A ricordo della permanenza di Giovanni
Pascoli a Matera è presente
una lapide in suo onore, apposta sulla facciata della Prefettura
in Piazza Vittorio Veneto, a sinistra della chiesa di San
Domenico.
La sua produzione poetica, vasta ed eclettica, s’incammina sopra
il binario di una ricerca metrica e formale su temi vari, che gli costa
un incessante sforzo. La sua ricerca più impegnativa si riversa
sul gusto per le piccole cose, viste con gli occhi del bambino; il torbido,
il nascosto; il bisogno ansioso di quiete, di un «nido» in
cui regnano gli affetti sereni; il simbolismo; la propria celebrazione,
delle ultime opere.
Uomo straordinariamente erudito, Pascoli, capace, costante nella sua opera
di rinnovamento, di frantumare il discorso poetico in lampi d’impressioni
fugaci, affascinato dalla classicità del periodo della decadenza,
fino a comporre i "Carmina" in lingua
latina, per la quale gli è assegnato il «Premio
Amsterdam» per la poesia latina.
 Giovanni
Pascoli ha una concezione dolorosa della vita, sulla quale s’imperniano:
la tragedia familiare e la crisi di fine ottocento.
Giovanni
Pascoli ha una concezione dolorosa della vita, sulla quale s’imperniano:
la tragedia familiare e la crisi di fine ottocento.
La tragedia familiare inizia il 10 agosto del 1867 quando gli è
ucciso il padre. Alla morte del padre seguono quella della madre, della
sorella maggiore, Margherita, e dei fratelli Luigi
e Giacomo. Questi lutti gli lasciano un dolore profondo
e gli ispirarono «il mito del "nido" familiare da
ricostruire, del quale fanno parte i vivi e idealmente i morti, legati
ai vivi dai fili di una misteriosa presenza. In una società sconvolta
dalla violenza e in una condizione umana di dolore e d’angoscia
esistenziale, la casa è il rifugio nel quale i dolori e le ansie
si placano».
Un altro elemento, però, influenza il pensiero di Pascoli: la crisi
che si verifica verso la fine dell'Ottocento e travolge i miti suoi più
celebrati: dalla scienza liberatrice e dal progresso. Nonostante fosse
un seguace delle dottrine positivistiche, non solo riconosce «l'impotenza
della scienza nella risoluzione dei problemi umani e sociali, ma l'accusa
anche di aver reso più infelice l'uomo, distruggendogli la fede
in Dio e nell'immortalità dell'anima, che sono da secoli il suo
conforto»:
«...tu sei fallita, o scienza: ed è bene: ma sii maledetta che hai rischiato di far fallire l'altra. La felicità tu non l'hai data e non la potevi dare: ebbene, se non hai distrutta, hai attenuata oscurata amareggiata quella che ci dava la fede...»
Perduta la fede nella forza liberatrice della
scienza, il Poeta fa oggetto della sua meditazione proprio ciò
che il positivismo rifiuta di indagare, il mondo che sta di là
dalla realtà fenomenica, il mondo dell'ignoto e dell'infinito,
il problema dell'angoscia dell'uomo, del significato e del fine della
vita; perciò conclude «che tutto il mistero nell'universo
è che gli uomini sono creature fragili ed effimere, soggette al
dolore e alla morte, vittime di un destino oscuro ed imperscrutabile».
Intanto esorta gli uomini a bandire l'egoismo, la violenza, la guerra,
ad unirsi e ad amarsi come fratelli nell'ambito della famiglia, della
nazione e dell'umanità. Soltanto con la solidarietà e la
comprensione reciproca possono vincere il male e il destino di dolore
che incombe su di loro e sentirsi fratelli, figli dello stesso Padre.
Pascoli rappresenta la condizione umana nella poesia I due
fanciulli, in cui si parla di due fratellini, che, dopo
essersi picchiati, messi a letto dalla madre, nel buio che li avvolge,
simbolo del mistero, dimenticano l'odio che li aveva divisi e aizzati
l'uno contro l'altro; allora, alla fioca luce della candela che proietta
sul muro ombre gigantesche, impauriti si abbracciano, trovando l'uno nell'altro
un senso di conforto e di protezione, così che quando la madre
torna nella stanza, li vede dormire l'uno accanto all'altro e rincalza
il letto con un sorriso.
E s'aprono i fiori notturni,
nell'ora che penso a' miei cari
Sono apparse in mezzo ai viburni
le farfalle crepuscolari.
Da un pezzo si tacquero i gridi:
là sola una casa bisbiglia.
Sotto l'ali dormono i nidi,
come gli occhi sotto le ciglia.
Dai calici aperti si esala
l'odore di fragole rosse.
Splende un lume là nella sala.
Nasce l'erba sopra le fosse.
Un'ape tardiva sussurra
trovando già prese le celle.
La Chioccetta per l'aia azzurra
va col suo pigolìo di stelle.
Per tutta la notte s'esala
l'odore che passa col vento.
Passa il lume su per la scala;
brilla al primo piano: s'è spento...
E' l'alba: si chiudono i petali
un poco gualciti; si cova,
dentro l'urna molle e segreta,
non so che felicità nuova.
 Giovanni
Pascoli usa forme classiche come il sonetto,
gli endecasillabi o le
terzine, ma la sua poesia costituisce la prima reale rottura con
la tradizione. Infatti, oltre l’apparente semplicità,
è dalla poesia di Pascoli che nasce buona parte della poesia del
Novecento. Le numerose pause all'interno del verso spezzato,
oppure le rime sdrucciole,
frequenti e insidiose, che producono accelerazione; l'uso delle onomatopee,
di parole ricavate dalla lingua dei contadini così come da quella
dei colti, l'inserimento di temi rifiutati dai poeti importanti, concorre
a produrre una poesia rivoluzionaria nella sostanza e nelle intenzioni
più che nella forma. Poeta, per Pascoli, è colui
che è «capace di ascoltare e dar voce alla sensibilità
infantile che ognuno continua a portare dentro di sé pur diventando
adulto». La poesia scopre rapporti che non sono quelli logici
della razionalità e attribuisce ad ogni cosa il suo nome, senza
proporsi direttamente scopi umanitari e morali, «porta ad abolire
l'odio, a sentirsi fratelli e a contentarsi di poco, come avviene nei
fanciulli».
Giovanni
Pascoli usa forme classiche come il sonetto,
gli endecasillabi o le
terzine, ma la sua poesia costituisce la prima reale rottura con
la tradizione. Infatti, oltre l’apparente semplicità,
è dalla poesia di Pascoli che nasce buona parte della poesia del
Novecento. Le numerose pause all'interno del verso spezzato,
oppure le rime sdrucciole,
frequenti e insidiose, che producono accelerazione; l'uso delle onomatopee,
di parole ricavate dalla lingua dei contadini così come da quella
dei colti, l'inserimento di temi rifiutati dai poeti importanti, concorre
a produrre una poesia rivoluzionaria nella sostanza e nelle intenzioni
più che nella forma. Poeta, per Pascoli, è colui
che è «capace di ascoltare e dar voce alla sensibilità
infantile che ognuno continua a portare dentro di sé pur diventando
adulto». La poesia scopre rapporti che non sono quelli logici
della razionalità e attribuisce ad ogni cosa il suo nome, senza
proporsi direttamente scopi umanitari e morali, «porta ad abolire
l'odio, a sentirsi fratelli e a contentarsi di poco, come avviene nei
fanciulli».
Afferma nella prefazione a «Primi poemetti» del 1897:
«... io vorrei trasfondere in voi, nel modo rapido che si conviene alla poesia, qualche sentimento e pensiero mio non cattivo. [...] Vorrei che pensaste con me che il mistero, nella vita, è grande, e che il meglio che ci sia da fare, è quello di stare stretti più che si possa agli altri, cui il medesimo mistero affanna e spaura. E vorrei invitarvi alla campagna».
Myricae è una raccolta
di liriche di argomento semplice e modesto, come dice lo stesso Poeta,
ispiratosi per lo più a temi familiari e campestri. Il titolo è
dato dal nome latino delle tamerici «non omnes arbusta iuvant
humilesque Myricae», che nella traduzione letterale significa:
non a tutti piacciono gli arbusti e le umili tamerici, umili
pianticelle prese a simbolo di una poesia senza pretese, legata alle piccole
cose quotidiane e agli affetti più intimi.
Insieme con i Canti di Castelvecchio sono liriche
che la critica ha definito del «Pascoli migliore», poeta
impressionista e fondatore del frammento: «Son frulli
di uccelli, stormire di cipressi, lontano cantare di campane»,
scrive il poeta stesso nella Prefazione del 1894.
La poesia di Giovanni Pascoli è dunque fatta di piccole cose, inerenti
per lo più alla vita della campagna, di quadretti rapidissimi,
conclusi nel giro di pochi versi impressionistici, dove le cose sono definite
con esattezza, col loro nome proprio. Vi compaiono anche poesie Novembre,
Arano in cui
le cose si caricano di una responsabilità simbolica e già
si affaccia il tema dei morti, sottolineando una visione della vita che
tende a corrodere i confini del reale. Nella raccolta, cresciuta nel tempo
dalle ventidue poesie della prima edizione alle centocinquantacinque dell'ultima,
tolti pochi componimenti rimasti a sé, le poesie si ordinano per
temi, corrispondenti ai cicli annuali della vita in campagna. La raccolta
si apre con Il giorno dei morti, il giorno in
cui il poeta si reca al camposanto che
«oggi ti vedo
tutto sempiterni
e crisantemi. A ogni croce roggia
pende come abbracciata una ghirlanda
donde gocciano lagrime di pioggia».
Nella raccolta Canti di Castelvecchio
del 1903 sono compresi e approfonditi i temi di Myricae
ma ha approfondimento particolare il tema del nido familiare e delle memorie
autobiografiche, suffragate da parecchi componimenti poetici narrativi;
finito il vagabondaggio per la campagna di Myricae
ne inizia uno nuovo: ma questo è un viaggio attorno al suo giardino,
dentro i cancelli e dentro il suo orto.
Il senso del mistero, unito al dolore della vita e all’angoscia
della morte, si traduce in allucinazioni, nel ricordo dei morti, come
ad esempio «La tessitrice»:
«Mi son seduto in una panchetta
come una volta...
quanti anni fa?
Ella, come una volta s’è stretta sulla panchetta»
Oppure, nell’ascolto dei richiami impercettibili, e non udibili all’uomo comune, non al Poeta, che tratteggia nella lirica Le rane :
«... mi chiamano le canapine
coi lunghi lor gemiti uguali»
ora scavalca la realtà, sconfinando nei ricordi, forse suggeriti dal suono delle campane, ai limiti del preconscio e che chiarisce ne «La mia sera»:
«Mi sembrano canti di culla
che fanno ch’io tori com’era
Sentivo mia madre... poi nulla...
sul far della sera».
Sono il tremore dell’animo e i simboli che lievitano frequentemente da note realistiche, espresse attraverso un discorso narrativo, come ne «Il gelsomino notturno»:
«E s’aprono i fiori notturni, nell’ora
che penso ai miei cari
Sono apparse in mezzo ai viburni
le farfalle crepuscolari»
Si può dire che nei Canti di Castelnuovo
sta il punto massimo della compenetrazione tra i due aspetti della poesia
pascoliana: il simbolo e la realtà.
Pascoli usa un linguaggio della poesia lirica, con risonanze melodiche
ottenute con ripetizioni di espressioni cantilenanti, arricchite di note
impressionistiche e di frasi spesso ridotte all’essenziale. Il lessico
è nuovo, con mescolanze di parole dotte e comuni ma sempre preciso
quando nomina uccelli (cince, pettirossi, fringuelli, assiuoli...) o piante
(viburni o biancospini, timo, gelsomini, tamerici...).
Nella realtà e nel simbolismo ricerca «nelle cose il loro
sorriso», la loro anima, il loro significato nascosto e simbolico.
Ecco perché la poesia pascoliana è sempre ricca di allusioni
e di analogie simboliche. Per la sintassi preferisce
periodi semplici, composti di una sola frase, o strutture
paratattiche con frasi accostate mediante virgole o congiunzioni.
L’aspetto metrico e fonico è classico e tradizionale innestato
di forme e metri nuovi, adatti ad esprimere timbri nascosti, assonanze
e allusioni; curata in particolare è la magia dei suoni, la trama
sonora, gli effetti musicali di onomatopee espressive e di pause improvvise;
cura molto la scelta delle espressioni per rendere le immagini più
vive, qualche volta ama l’ellissi, eliminando congiunzioni e verbi,
o fare accostamenti nuovi trasformando aggettivi e verbi in sostantivi,
facendo risaltare nella lirica uno stile impressionistico e nuovo.
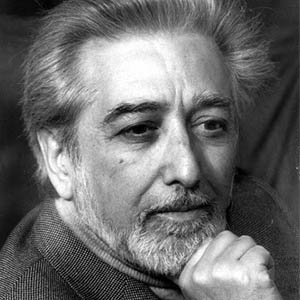
Reno Bromuro è nato a Paduli, in Campania, nel 1937. E' stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale. Nel 1957, a Napoli, ha fondato il Centro Sperimentale per un Teatro neorealista. Ha fondato nel 1973 (di fatto) l'A.I.A. Associazione Internazionale Artisti "Poesie della Vita", e, come critico letterario, ha recensito molti poeti italiani e stranieri. Si è spento nel 2009, qualche anno dopo averci dato l'opportunità di collaborare con lui. Noi di Letteratour lo ricordiamo con affetto qui.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG