
Nella categoria: HOME | Consigli di lettura
Letteratura e malattia: due
temi che si intrecciano spesso, non solo a livello biografico ma
spesso anche nel cuore della narrazione, dei personaggi, dello
stile narrativo. Proponiamo alcuni studi che approfondiscono questo
vastissimo argomento.
• Letture e libri
• Link interessanti
La
nevrosi tra medicina e letteratura. Approccio epistemologico alle malattie
nervose nella letteratura italiana (1865-1922)
Edwige
Comoy Fusaro
Dagli anni del trionfo del pensiero positivista agli esordi del Novecento le patologie nevrotiche pervadono la narrativa italiana, investendo le opere di Tarchetti, Verga, D'Annunzio, Fogazzaro, De Roberto, Pirandello, Tozzi, Borgese e tanti altri, fuoriuscendo dai campi specialistici della scienza sperimentale. Non a caso l'Ottocento è stato considerato "il secolo della nevrosi": di là dalla nascita e dai progressi della psichiatria, la nevrosi assurge progressivamente a simbolo del disagio dell'individuo e della collettività, il che spiega come essa diventi oggetto di indagine da parte della scienza quanto della letteratura. Edwige Comoy Fusaro propone, con questo libro, una ricerca articolata e di ampio respiro, collocando la sua indagine in un vasto contesto culturale, scientifico, filosofico, nel quale assume particolare rilievo per la cultura italiana il fondante interscambio con la coeva cultura psichiatrica francese. L'autrice offre al lettore, con un linguaggio chiaro e severo, una ricerca scientifica rigorosa e dettagliata, il cui valore si misura con la sua duplice condizione: da un lato il libro è un punto d'arrivo, per l'originalità dell'indagine e dei risultati; dall'altro è un punto di partenza per la grande quantità di ipotesi, suggerimenti e proposte in grado di aprire un dibattito culturale tra gli studiosi.
Sulla
malattia
Virginia
Woolf
Questo volume presenta, in una nuova traduzione e con un apparato di note esplicative, uno dei saggi più rivoluzionari di Virginia Woolf. Il saggio, che ha avuto circolazione autonoma e ha subito diverse revisioni tratta il tema della malattia. L'autrice lamenta che la letteratura non abbia rivolto alla malattia fisica altrettanta attenzione che alle attività della mente. Opponendosi a un pensiero e a una sensibilità secolari, rivendica le opportunità della malattia e mostra, con una serie di immagini originali, come senza malattia certe verità rimarrebbero per sempre escluse alla conoscenza umana. Il libro include un'introduzione storico-letteraria al saggio e una discussione più generale del complesso rapporto tra malattia e letteratura.
Scrivere
la follia. Matti, depressi e manicomi nella letteratura del Novecento
Giacomo
L. Vaccarino
Lo studio di Vaccarino indaga l'affascinante rapporto tra follia e letteratura, offrendo delle suggestioni su come la letteratura italiana anche contemporanea abbia rappresentato la malattia mentale. In particolare l'autore si occupa di studiare da vicino quelle rappresentazioni letterarie che più di altre hanno rispecchiato il pensiero collettivo sulla malattia mentale, confrontandola con quanto la scienza medica ha via via elaborato.
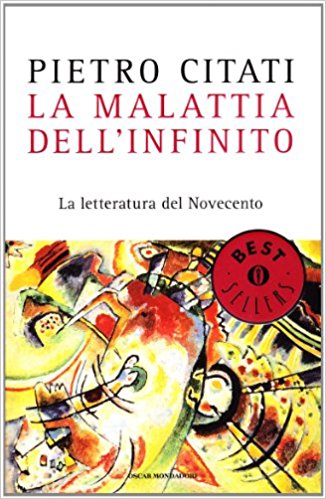
La
malattia dell'infinito. La letteratura del Novecento
Pietro
Citati
"L'infinito è nemico dell'uomo" dice Joseph Conrad nel romanzo che inaugura la letteratura del Novecento, Lord Jim. La "malattia dell'infinito" è il tema segreto, profondo come un fiume sotterraneo, che Pietro Citati ha scelto per comporre la sua vasta e fascinosa conversazione sulle opere e sulle esistenze dei romanzieri, dei poeti, degli artisti del ventesimo secolo. Il desiderio d'infinito, lo sguardo appuntato al di là dei consueti orizzonti umani, popola di una folla di stranieri la letteratura occidentale. Il pensiero della propria inappartenenza accompagna lo scrittore novecentesco come una musica cupa e in sordina, dando eco e risonanza ai suoi libri. Così, D'Annunzio è "il grande Straniero, che occupava come un dio fastoso e corrucciato le stanze immaginarie del Vittoriale"; Robert Walser è un escluso che bussa e bussa alla porta della vita; Pirandello "uno straniero in un luogo straniero"; Robert Musil ha la sensazione che "tra lui e il mondo si fosse stabilita per sempre ... una montagna di ghiaccio"; Marina Cvetaeva "aveva deciso di essere straniera sulla terra, come una gnostica"; Gottfried Benn è un "abitatore di stanze singole ... che vive abbandonato al silenzio e al ridicolo". Persino Giorgio Bassani, un autore che a lungo sembra conservare "la grazia e la gioia di vivere delle persone normali", diventa quasi all'improvviso "quello che non sapeva di essere: un ebreo, un paria, uno straniero". L'artista del Novecento - che sia uno scrittore, o un regista come Dreyer e Chaplin, o un ballerino come Nijinsky - abita la tenebra, racconta l'ombra, la follia, la debolezza, la morte. Uno dei numi tutelari del secolo, Carl Gustav Jung, "comprese che il mondo della luce non era fatto per lui: doveva abitare nel mondo della notte"; Fernando Pessoa, come tutti i grandi poeti moderni, "ascoltava il mare di Tenebra"; Virginia Woolf deve "discendere, gradino per gradino, nel pozzo, nelle acque profonde, negli abissi delle tenebre e della follia ... sfruttare l'ombra ... affondare di nuovo nella tenebra, trovando in essa la ragione e il fondamento della sua arte". Karen Blixen sembra a tratti devota alla riconciliazione, all'armonia del mondo, ma poi conferma anch'essa, negli enigmatici finali dei racconti, il suo invincibile attaccamento alle ironiche divinità dell'ombra. Come forse non ha fatto in nessuno dei suoi libri precedenti, nella "Malattia dell'infinito" Pietro Citati parla anche di sé. In un saggio su Hofmannsthal nasconde la più precisa definizione breve che si possa dare del suo metodo di scrittore e di critico: "Un'anima squisita e melanconica si introduceva nelle cose: per un momento, provava un brivido davanti al mondo estraneo; e poi, lentamente, con arti da polipo e da ragno, se ne appropriava, lasciando sulla carta una bella forma ibrida, che in parte aveva i colori di Hofmannsthal in parte i colori del libro o dell'oggetto nei quali si era insinuato". Nei saggi affettuosi, commossi, maliziosi dedicati agli amici che ha avuto, con cui ha lavorato (fra tanti: Cioran, Fellini, Gadda, Fruttero e Lucentini, Calvino, Manganelli, Bertolucci), ci dà, sospettiamo, quanto di più prossimo a un'autobiografia sia lecito aspettarsi da questo scrittore che da sempre tenta di scomparire dietro l'impersonalità del saggista.
Guarire
con le fiabe. Come trasformare la propria vita in un racconto
Maria
Varano
"Spesso chiedo ai miei pazienti in quale fiaba classica piacerebbe loro abitare o quale personaggio vorrebbero interpretare". Questo libro raccoglie le risposte date all'autrice che racconta così una storia di "storie", miti e leggende personali, narrazioni originali di persone diverse, metafore dell'esistenza. E ci fa comprendere come riproducano le tappe fondamentali dello sviluppo individuale e dell'evoluzione collettiva divenendo metafore della storia dell'umanità. Le fiabe sono infatti un viaggio avventuroso in cui gli individui si muovono: rendono attraente l'esperienza del cambiamento e permettono quel decentramento emotivo che fa rivedere e ripercorrere momenti di vita che divengono storia e non solo tempo passato.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG