
Nella categoria: HOME | Recensioni
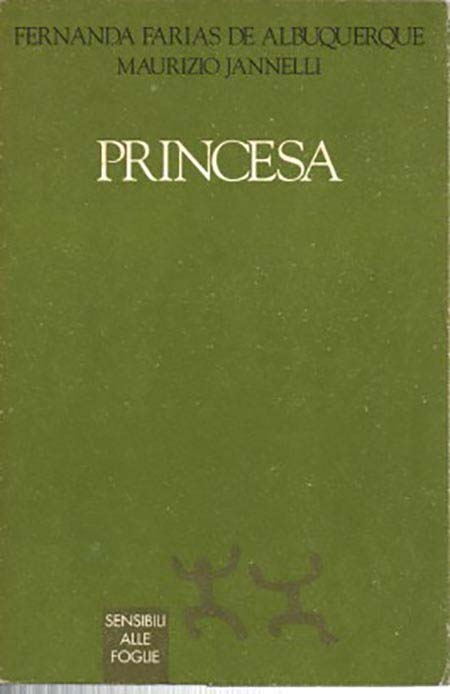
La prima cosa che bisogna dire su Princesa è che è una di quelle opere (tutte e nessuna) che necessita, prima di essere raccontata, di essere inquadrata all'interno di un contesto storico e letterario, nel caso specifico, tutto italiano. La dipendenza che quest'opera sviluppa con il contesto circostante è dovuta, gran parte, a quella che chiamiamo critica letteraria che mai sazia, caccia, afferra e sbrana ogni opera per farne una categoria e semmai fosse unica nel suo genere; e semmai si dovesse differenziare, a questo punto si creerebbe una nuova categoria, tutta per lei, perché si sa, ogni cosa ha la sua categoria atrimenti non sarebbe niente.
Oltre alla questione contestuale, ciò che caratterizza Princesa è la questione, cara alle letteratura e meno ai suoi autori, dell’autorialità. Per spiegare cosa sia quest'ultima non basterebbe una giornata e neanche i cento tomi di critica che la trattano. Ciò che in questa sede possiamo fare, è descrivere, scrivere, l’autorialità con una domanda: chi è l’autore del libro, chi vive la storia che è raccontata al suo interno o chi la racconta?
Sarebbe pretenzioso pensare di risolvere qui una questione che, in effetti, ancora non è stata risolta, ma ciò che possiamo fare è viverla concretamente grazie a Princesa e alle parole scritte che simulano la vita fino a derubarla.
Princesa è l’autobiografia di Fernanda Farias de Albuquerque, una donna trans brasiliana che, dopo una vita turbolenta fatta di prostituzione, abusi, e droghe, viene arrestata a Roma per tentato omicidio nel carcere di Rebibbia. E qui bussa alla porta, irrompe con la violenza di una piena, il contesto storico, che chiede di essere ascoltato promettendo aiuto.
Tutta la vita, la biografia e quindi la storia si sviluppa negli anni ’90, un periodo in cui nascevano e si diffondevano come un virus le droghe pesanti, dove i trans (basta leggere la storia della protagonista) erano i più soggetti al loro uso, lavorando la notte, rischiando la vita per le botte dei clienti e quelle della polizia, rischiando il gusto sadico di qualche gioco perverso. Erano anche gli anni dell'AIDS, questo sì un virus che serpeggia infame aggredendo le sue vittime senza mai stancarsi; i più colpiti erano trans e omosessuali, anche per questo sempre più emarginati di giorno e amati di notte, di nascosto.

Questo è il contesto storico, come sempre, con le sue luci e le sue ombre. Ma c’è altro da dire. Perché la storia di Princesa non finisce in prigione ma anzi, quasi da qui inizia, perché è in prigione che Princesa incontra prima Tamponi, un pastore sardo che le consiglia di scrivere la sua storia per non perdere la sua identità, di usare la scrittura come terapia e memoria. Poi incontra Iannelli, ex brigatista, promotore di concorsi letterari all’interno del carcere. Così Princesa passa a Ianelli ciò che aveva scritto insieme a Tamponi, la sua vita raccontata in un mix di portoghese e sardo. Iannelli legge, sempre più avaro di parole le chiede di scrivere ancora, perché è anche un po' la sua di storia: l’identità perduta e ritrovata, la lotta con la polizia, la droga. Fu così che un brigatista si rispecchiò in un trans, e fu per questo motivo che Iannelli giorno dopo giorno, aggiustava, riscriveva e tagliava la storia di Princesa (in accordo con lei) per poi farne, una volta uscito di prigione, grazie a Curcio, un vero e proprio romanzo. Siamo nel 1994, Princesa viene pubblicato, sulla copertina, dove viene scritto il nome dell’autore, ci sono due nomi: quello di Princesa e quello di Iannelli. Dunque il romanzo presenta una doppia autorialità, perché? Non è forse Princesa la protagonista del romanzo e della sua vita? Non è forse solo sua la storia? E Iannelli non ha forse ricoperto un ruolo, più che altro, redazionale?
Quante domande, tutte insieme, starete pensando, eppure non sembrano essere mai troppe. Iannelli parla di cooperazione tra parlante e scrittore, tra colui che racconta e colui che scrive, ma della cooperazione non risulta traccia se non nel doppio nome in copertina che Iannelli avrebbe, sicuramente, cancellato volentieri. Lo scrittore, con la sua capacità di narrazione, con le sue parole, è riuscito a rubare la storia, quella di un altro per farne la sua. Si è cucito addosso un discorso di buoni propositi per rivelare cattive intenzioni, appropiandosi non solo di una storia, ma di una vita. Ma tutto questo sistema di appropriazione e tecniche editoriali sono in uso da sempre e per sempre (sono portata a credere) all'interno di quella che la critica letteraria chiama "letteratura della migrazione". In questa categoria letteraria sembra che i residui del vecchio colonialismo fascista si risveglino con una certa dose di convinzione, portando l'ascoltatore nativo ad appropriarsi della storia del migrante, approfittando della lingua che, chiaramente, il nuovo arrivato non è in grado di parlare. Perciò quello che sembra essere un aiuto si trasforma fatalmente in un sopruso, l'ennesimo. Le storie vengono rubate e vendute sul mercato grazie alla garanzia di veridicità. L’happy ending dell’immigrato che dopo tanta fatica si riesce ad integrare nella societa ospitante, diventa garanzia di successo editoriale. Ma la storia vera nuota ancora in mare aperto, tra occhi che non sperano e ritorni difficili, e viene raccontata in una lingua a noi sconosciuta, distante secoli, e che per questo non capiremo mai.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG