
Breve storia della Letteratura Tedesca
di Beatrice Kupfahl
Nella categoria: HOME | Articoli critici
• Le origini
• Poesia cavalleresca e Umanesimo
• Età barocca e Illuminismo
• "Sturm und Drang" e Romanticismo
• Il Realismo
• Il Novecento
• Fonti
LE ORIGINI (IV secolo d. C. – XII secolo)
I primi resti scritti di popolazioni germaniche risalgono
al IV secolo d. C. e corrispondono a incisioni runiche; l’alfabeto
runico aveva principalmente funzione di scrittura “magica”.
Per sopperire alla mancanza di un alfabeto adatto ai documenti o alle
opere letterarie, il vescovo gotico WULFILA con la sua traduzione gotica
della Bibbia sviluppò una
scrittura ricavata dal greco.
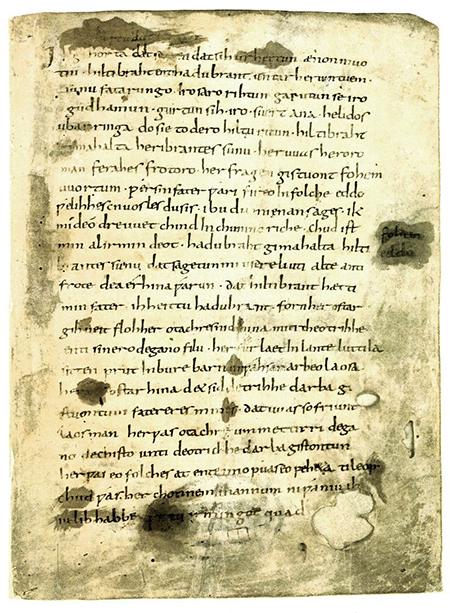 Opere rilevanti sono l’Heliand (VII
secolo), poema epico sulla vita di Cristo, il Canto di Ildebrando (VIII
secolo), poesia epico-eroica che narra dello scontro tra Ildebrando e
Adubrando. L’ “Heldenlied” (canto eroico) fu un genere
tipico del periodo germanico, in quanto le migrazioni e le lotte tra
le popolazioni migranti costituirono il contesto storico per i temi della
lotta tra la vita e la morte e i combattimenti tra due eroi-guerrieri.
Opere rilevanti sono l’Heliand (VII
secolo), poema epico sulla vita di Cristo, il Canto di Ildebrando (VIII
secolo), poesia epico-eroica che narra dello scontro tra Ildebrando e
Adubrando. L’ “Heldenlied” (canto eroico) fu un genere
tipico del periodo germanico, in quanto le migrazioni e le lotte tra
le popolazioni migranti costituirono il contesto storico per i temi della
lotta tra la vita e la morte e i combattimenti tra due eroi-guerrieri.
Si
fa coincidere la nascita della letteratura tedesca circa con l’anno
800, quando nella lingua si consolidò una modifica nelle consonanti
definita “seconda rotazione consonantica”; venne quindi fissato
l’uso dell’alfabeto latino. I primi documenti in lingua tedesca
a noi giunti sono vocabolari e glosse dal latino, compilati dai monaci.
Una delle opere del tempo è l’Evangelienbuch (Libro
degli Evangeli), simile all’Heliand per i contenuti
cristiani, scritto tra l’863 e l’870 dal monaco OTFRIED DI
WEISSENBURG. Da questo momento, fino alla traduzione della Bibbia in
volgare tedesco eseguita da Martin Lutero nel XVI secolo, la lingua tedesca
attraversò numerose fasi:
- Alto tedesco antico (750-110)
- Alto tedesco medio (1100-1350)
- Alto tedesco nuovo (1350-1750)
POESIA CAVALLERESCA E UMANESIMO (XII secolo – 1500)
Originaria della Francia e diffusasi poi in Germania,
la poesia cavalleresca, recitata presso le corti feudali, produsse opere
epiche, liriche e didattiche. Due furono le opere prese a modello per
la poesia cavalleresca: Tristan
et Yseute, legato alla saga arturiana, e Perceval legato
invece alla saga del Santo Graal.
L’iniziatore della poesia cavalleresca
in Germania fu HEINRICH VON VEDELKE, con la sua versione tedesca del
romanzo d’Enea (Eneit). Nei primi anni del XIII secolo, i due poemi
francesi furono ripresi in Germania come Tristan und Isolde da
GOTTFRIED VON STRAßBURG e Parzival da WOLFRAM VON ESCHENBACH.
Il
modello per la lirica d’amore fu la poesia provenzale trobadorica.
WALTER VON DER VOGELWEIDE, però, con la sua famosa poesia Unter
den Linden, ne stravolse i princìpi parlando di un amore
vero e congiunto alla natura. In seguito, grazie anche all’impulso
dell’erudito Enea Silvio Piccolomini (futuro papa Pio II), nelle
corti e nelle cancellerie si cominciarono a tenere in grande considerazione
gli eruditi e scienziati tedeschi di formazione umanistica.
Aspetti della
cultura tedesca del tempo furono la fondazione delle università (dalla
seconda metà del XIV secolo) e l’invenzione della stampa
(grazie a Johann Gutenberg, che tra il 1448 e il 1454 stampa a Magonza
la prima Bibbia). Durante il XVI secolo gli umanisti cominciarono a essere
impiegati nelle cancellerie di corte, nelle università e nelle
scuole cittadine, che conobbero così una grande prosperità culturale.
La
figura più rilevante dell’umanesimo tedesco fu ERASMO
DA ROTTERDAM (il cui pensiero si espresse nel conciliare il cristianesimo
delle origini e i valori del mondo classico) insieme a quella di MARTIN
LUTERO, grazie al quale la letteratura umanistica assunse i toni di letteratura “impegnata” nella
lotta contro gli sfruttamenti del papato.
Nel XVI secolo presso il popolo
si diffondono i cosiddetti Volksbücher (“libri del
popolo”), che raccontano in modo semplice eventi bizzarri e divertenti
e che hanno la funzione di mantenere sempre vivo l’interesse del
lettore. Il più famoso è sicuramente l’Historia
von D. Johann Fausten (Storia del Dottor Johann Faust), il cui personaggio
che instaura un patto con il diavolo è diventato un emblema universale,
uomo che travalica i propri limiti per ottenere conoscenza illimitata.
ETÀ BAROCCA E ILLUMINISMO (fine XVI secolo – 1700)
Con la stabilizzazione della monarchia, le corti rappresentarono
i nuovi centri culturali della Germania, in cui andarono imponendosi
l’importanza
di lussi e sfarzosità. Con la letteratura barocca, che visse di
questo spirito di corte, si contrapposero mondo terreno e ultraterreno,
esaltando l’aldilà come unico luogo autentico dell’esistenza
umana e trasfigurando il sovrano in vicario di Dio sulla terra.
In questo
periodo apparve il primo romanzo in lingua tedesca, Der abenteuerliche
Simplicissimus di HANS JAKOB CHRISTOFFEL VON GRIMMELHAUSEN. Altro
elemento caratteristico del tempo è l’importanza assegnata
alla musica sacra da parte della chiesa riformata. Questo evidenzia da
un lato la diffusione della cultura musicale, ancora oggi elemento tipico
della cultura tedesca, dall’altro lo sviluppo di una nuova e rilevante
tradizione (che giungerà al culmine nel XVIII secolo con Johann
Sebastian Bach e Friedrich Händel).
La filosofia di GOTTFRIED WILHELM
LEIBNIZ, caratterizzata dall’ottimismo, fu la chiave di volta per
il passaggio dalla cultura barocca a quella del mondo borghese.
La nascita
e la diffusione del giornalismo portò alla formazione di una nuova
consapevolezza borghese: l’essenza dell’Illuminismo è infatti
costituita dalla lotta della borghesia contro l’assolutismo, la
nobiltà, l’ipocrisia. Ruoli essenziali furono giocati da
GOTTHOLD EPHRAIM LESSING, che lottò per i principi di tolleranza
e uguaglianza attraverso le sue opere teatrali, e da FRIEDRICH GOTTLIEB
KLOPSTOCK, innovatore della poesia e della lingua tedesca.
Dopo il 1740
la letteratura si liberò dai vincoli della morale e della filosofia,
tornando ai modelli di quella cortese.
“STURM UND DRANG” E ROMANTICISMO (1700 – 1800)
L’Illuminismo portò con sé sentimenti
di ribellione e autonomia creativa, che si espressero in nuove posizioni
violentemente anticlassicistiche. La nuova filosofia borghese indirizzò così la
propria attenzione sulle tradizioni culturali e sul carattere specifico
della propria nazione, sul “Volk” (popolo). Alla fine del
1700, l’incontro tra due giovani poeti diede nuovo slancio alla
cultura tedesca. I due furono JOHANN WOLFGANG GOETHE, fondatore del dramma
storico moderno e fautore di una nuova lirica caratterizzata da molteplicità di
stilemi in perfetto equilibrio tra loro, e JOHANN GOTTFRIED HERDER.
I
motivi dello “Sturm und Drang” furono l’individualismo,
la libera espressione dei propri sentimenti, l’appassionata relazione
con una natura burrascosa e drammatica, il rifiuto di convenzioni in
vita come nell’arte, la ricerca di un’identità nazionale.
FRIEDRICH SCHILLER, amico e collaboratore di Goethe, con il quale intrattenne
un fitto carteggio, si occupò di teatro (in particolare di tragedie).
Entrambi svilupparono idee vicine all’arte e alla cultura classica,
definite “Weimarer Klassik” (“classicismo di Weimar”)
in quanto questo intermezzo fu una tendenza perseguita dai due autori
durante il loro soggiorno alla corte di Weimar.
Il Romanticismo, movimento
complesso e contradditorio, portò al declino le poetiche del barocco
e del classicismo. Caratterizzato dal rifiuto delle opere e delle tradizioni
antiche, il Romanticismo combatté per l’autonomia della
letteratura. I suoi temi principali erano i sentimenti (in particolare,
affettuosi e “cedevoli”); la notte e il sogno (la notte è il
momento preferito dal poeta, in quanto, donando il sogno, lo conduce
nel mondo della fantasia); la natura (la natura è un magico essere
vivente, ma non dall’aspetto spettrale, e il poeta è in
grado di percepirne l’anima e la “voce”); la musica
(i romantici la vedono come la massima espressione dell’amore e
della poesia); l’irrazionale (sia come sogno positivo che come
presenza demoniaca).
La ricerca dell’armonia fallì con la Rivoluzione
Francese. Questo nuovo clima venne descritto da due poeti, FRIEDRICH
HÖLDERLIN
e HEINRICH VON KLEIST, con toni diversi ma stesse allusioni tragiche.
Con il seguente sviluppo tecnico, nel XVIII secolo la ricchezza della
borghesia crebbe, e l’incremento dell’economia portò con
sé il fenomeno dell’urbanizzazione.
Nella prima metà del
secolo fiorì nella arti uno stile sobrio e armonioso definito “Biedermeier”.
Lo scrittore che in letteratura espresse al meglio lo spirito del Biedermeier
fu lo svizzero FRANZ GRILLPARZER. Per indicare il periodo 1815-1848,
durante il quale la letteratura si indirizzò verso il realismo borghese,
si utilizza spesso il termine “Vormärz”. Questa
età di mezzo viene solitamente divisa in tre periodi, scanditi
da eventi politici che ebbero le cui ripercussioni furono molto forti
anche in Germania: la prima è la rivoluzione del luglio 1830 in
Francia; la seconda, nel 1840, è la morte del re prussiano Federico
Guglielmo III.
Da questo momento, caratterizzato da numerosi conflitti
politici, fino alla rivoluzione del marzo 1848, la letteratura tedesca
sarà contraddistinta da grande politicizzazione. La scrittura
degli autori postquarantotteschi sarà caratterizzata da un punto
di vista incentrato sul limitato mondo della quotidianità borghese.
Il Realismo degli scrittori si incentrava ora sulla descrizione dei lavoratori
impoveritisi a causa della crisi della piccola borghesia. Tra gli
autori realisti ricordiamo FRIEDRICH HEBBEL, CONRAD FERDINAND MEYER,
GOTTFRIED KELLER.
I movimenti sorti alla fine del XIX secolo, tra i quali
il naturalismo,
fiorito in Germania attorno al 1890, svolsero la funzione di “cerniera” tra
le correnti letterarie precedenti e quelle che sarebbero sorte in seguito,
permettendo così grande continuità. L’interesse
degli scrittori si concentra sempre sulla società, ma punto di
interesse è ora il proletariato più umile.
Il naturalismo è strettamente
connesso alla teoria pessimistica del determinismo,
secondo cui l’uomo
non sarebbe libero nel suo sviluppo fisico e morale. Grande esponente
del naturalismo fu GERHART HAUPTMANN, vincitore del premio Nobel nel
1912. Contemporaneamente comparvero sulla scena l’estetismo e
l’impressionismo,
presentando radici comuni nonostante le profonde differenze. L’artista
era adesso ispirato non da immagini reali, ma dalla condizione della
propria anima, che si esprimeva tramite simboli e metafore.
Dal 1911
comparve il fenomeno dell’espressionismo, risultato del contesto
storico di imminente catastrofe bellica e caratterizzato dalla totale
opposizione al mondo borghese, dal rifiuto dell’ideologia della
sudditanza e dal conflitto generazionale tra padri e figli. Ancora in
pieno vigore, l’espressionismo fu negato dal nuovo dadaismo, nato
a Zurigo verso il 1916, che riteneva la cultura convenzionale una menzogna
ideologica.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG