
Nella categoria: HOME | Articoli critici

Con la riflessione etica di Aristotele l'uomo greco sembra liberarsi dagli antichi vincoli familiari e religiosi, per affermarsi come individuo conscio della responsabilità delle proprie azioni. L'indebolimento dei vincoli familiari propri della società gentilizia più arcaica crea un senso di ansia, un senso di relativa solitudine, anche se non è mai possibile pensare all'uomo antico come ad un individuo perfettamente autonomo. L'uomo antico si pensa, sempre, secondo la conosciuta formula aristotelica “un animale politico”, cioè come qualcuno che per natura vive in un contesto sociale, nel contesto della sua città, nel contesto della polis. L'uomo antico è dunque primariamente destinato a una vita comune collettiva; è tuttavia vero che la sostituzione della logica e della vita politica all'antica logica del legame familiare e gentilizio accentua l'esigenza di un approfondimento della riflessione morale. Vegetti propone un esempio molto significativo per tutto questo; il problema dell'uccisione è tradizionalmente visto come una colpa di ordine religioso che produce una contaminazione, di cui l'assassino si rende colpevole e per il quale è perseguitato dagli dei nella sua esistenza personale e anche fin dalla sua discendenza. D'altra parte l'uccisione è una lesione subita dalla famiglia, dal clan di chi viene ucciso, che va in tutti i modi vendicata, punita dai parenti dell'ucciso per evitare che questa onta resti a segnare anche la famiglia. Il pensiero della politica, la legislazione della città, non possono accettare né l'idea di una contaminazione che colpisca in ogni caso l'uccisore (perché esistono uccisioni legalizzate e legalizzabili) né l'idea di una catena infinita di vendette tra famiglie. Il conflitto fra la razionalità giuridico-politica e l'etica che l'accompagna, come quella aristotelica e la tradizione più arcaica di tipo religioso, non viene mai del tutto risolto nella coscienza dei greci, ma certo da questo conflitto si origina uno stimolo all'approfondimento e allo sviluppo della riflessione morale.
La riflessione etica di Aristotele ha ispirato e continua ancora oggi ad ispirare la ricerca intorno al significato dell'agire umano e dei suoi fini, in tal senso può essere considerato il fondatore del genere etico in filosofia. Esistevano certamente, prima di lui, dei discorsi etici, delle formule etiche, per esempio in Democrito; ugualmente c'era una teoria morale in Platone, ma è caratteristico il fatto che in Platone questa teoria sia sviluppata nel quadro di un dialogo che si chiama Politeia, cioè nella Repubblica, ovvero in un contesto politico, mentre Aristotele ha scritto addirittura due etiche: L'Etica Nicomachea e l'Etica Eudemia e ha scritto d'altro canto una Politica. Egli ha quindi chiaramente distinto questi due generi, che erano confusi nella tradizione platonica. D'altra parte Aristotele ha situato la sua etica e la sua politica in un insieme più generale ed è il primo ad averlo definito come tale: questo insieme è la filosofia pratica. Anche a questo proposito credo si potrebbe mostrare facilmente la differenza con Platone: in Platone non esiste una filosofia pratica autonoma. C'è certamente un interesse per la pratica, un'applicazione alla pratica di una teoria precedentemente costituita, ma non c'è filosofia pratica autonoma: la pratica non è che una conseguenza, un corollario della teoria, come si evince dalla Repubblica, dove le conseguenze pratiche in primo luogo ed in secondo luogo morali sono tratte dalla ben nota dottrina delle idee. Aristotele è invece il primo filosofo in Grecia ad accordare in maniera generale autonomia e specificità alla filosofia pratica.
E giungiamo a chiederci: qual è lo scopo che l'etica aristotelica persegue? Lo scopo dell'etica è ciò che Aristotele chiama tò agathon. Anche in questo caso si potrebbe riandare a Platone, in quanto Platone pensa che il bene, l'idea del bene sia la chiave di volta di tutte le azioni e anche di tutte le conoscenze, ma Aristotele aggiunge una precisazione fondamentale, ovvero che ciò cui mira l'etica è il bene umano, agathòn anthròpinon. Il bene umano, per gli uomini in generale, individuato eventualmente nella vita politica, nella vita collettiva, è individuato anche e forse in primo luogo nella vita individuale. Dunque il nostro accorda un'importanza considerevole e un'autonomia al fine individuale dell'uomo, e questi fini individuali possono essere riassunti in un solo termine, che è in greco eudaimonia, la felicità. Pertanto l'etica è la scienza delle azioni che conducono l'uomo individuale alla felicità, alla sua felicità propria. Per cogliere la particolarità dell'etica aristotelica è necessario un confronto con il pensiero platonico per il quale il bene o le forme del bene sono esattamente come gli oggetti matematici, degli oggetti assoluti, che ci precedono, che hanno una realtà propria, sono insomma delle idee, idee in senso platonico. Aristotele ha invece voluto avvicinare il bene all'uomo, mostrando che era contenuto innanzitutto nella sua aspirazione alla felicità e inoltre nelle strutture della sua azione. Perciò credo, come molti studiosi di filosofia antica, che l'apporto di Aristotele consista nell'aver articolato le virtù con l'azione umana. La nozione di prassi, che poi ha avuto grande fortuna con Marx, è nata con Aristotele. La prassi è l'azione, il luogo del bene e del male. E tutte le “perfezioni”, che chiamiamo virtù, sono delle forme che lui chiama abituali, delle disposizioni generali, nell'azione, in rapporto a situazioni tipiche, come il pericolo per il coraggio, la tentazione degli eccessi in ordine al piacere e al dolore corporale.
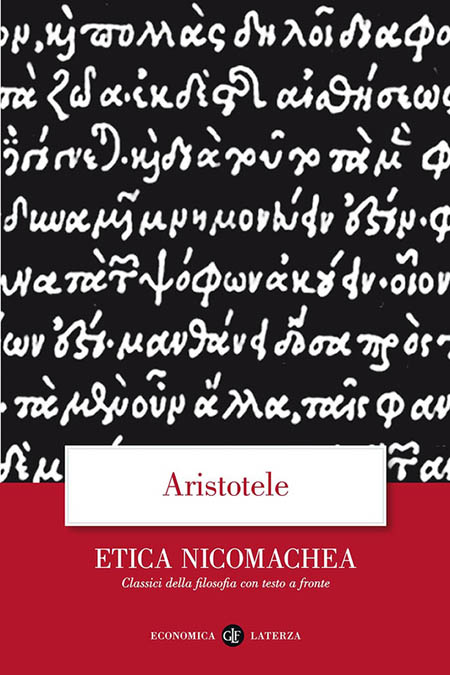
Un concetto fondamentale dell'Etica Nicomachea è il giusto mezzo. Argomenterò prima degli estremi, perché è assai più facile partire da essi. Prendiamo per esempio il coraggio. Il coraggio sta tra due estremi: l'uno è la temerarietà, il rischiare la propria vita inutilmente, l'altro è la viltà, l'aver paura. Il coraggio sta tra i due. Vorrei sottolineare, a questo punto, che anche l'espressione o sintagma “giusto mezzo” non ha buona reputazione, perché viene considerata una forma di compromesso; ma l'idea di Aristotele è che il giusto mezzo sia ciò che è più difficile da trovare, perché è un punto di equilibrio estremamente fragile. Vegetti sostiene: “credo ci sia un testo di Aristotele in cui si dice che il giusto mezzo è una cresta, un vertice, non già una specie di palude in cui si affondi”.
Aristotele distingue tra le virtù, alcune le chiama “etiche” altre “dianoetiche”, tra cui spicca la phrònesis. Ora senza fare della filologia bisogna tenere presente un aspetto fondamentale: “etica” deriva da una parola greca che vuol dire “costume”, ma che ha un omonimo che vuol dire “carattere”: ethos. Le virtù che Aristotele ha preso in esame nel primo libro, come la temperanza, il coraggio, la magnanimità, la giustizia, si possono chiamare virtù del carattere, perché fanno parte delle disposizioni ordinarie di un uomo nell'azione. Ciò che si giudica in etica non è ogni azione singolarmente presa, ma una disposizione ad agire in un certo senso. Ma Aristotele si pone un secondo problema e si chiede pure: qual è la virtù che si applica alla deliberazione messa in opera dalle virtù? Si può dire che qui ci troviamo di fronte a una virtù di secondo grado, al problema della phronesis, una parola greca difficile da tradurre. La traduzione latina prudentia è poco efficace, in quanto rimanda ad altri significati: l'idea della prudenza vera e propria, della precauzione, mentre per Aristotele la phronesis rientra in un'area semantica forte, perché è veramente la saggezza pratica in circostanze particolari e determinate. Cerco di spiegarmi in questi termini: Aristotele ha trovato sul suo percorso argomentativo il problema della deliberazione nel libro che precede l'enumerazione delle virtù, nel terzo libro, in cui si parla della praxis e della poiesis. Lì esprime un'idea assai limitata del ruolo della deliberazione e, in un certo senso, della ragione, che consiste per lui soltanto nel calcolare bene i mezzi, una volta posto il fine. Qualche esemplificazione: se uno fa il medico, ebbene, per essere un buon medico deve saper purgare, somministrare farmaci o tagliare; se uno fa l'architetto, deve saper costruire case. Come scrive il filosofo non si delibera sui fini ma sui mezzi. Nel libro sesto invece, in cui si argomenta sulla saggezza pratica, ciò che viene messo in questione sono proprio i fini. In rapporto al perseguimento della felicità, si deve fare il medico? Si deve fare l'architetto? Siamo di fronte a una virtù di secondo grado, perché rimette in causa i fini. E' ciò che fa uno studente, un giovane e che anche noi facciamo in tutti i momenti importanti della nostra vita, quando prendiamo una decisione per la nostra carriera, quando facciamo la scelta di ciò che solitamente viene detto un progetto di vita. In tal caso c'è una deliberazione che investe veramente il rapporto tra i fini e la felicità e non più soltanto tra i mezzi e i fini.
Alla conclusione del sesto libro c'è un capoverso che stupisce veramente, almeno me: in defintiva ciò che è più importante della phronesis, della saggezza, è il phronimos, l'uomo saggio perché è proprio lui con il suo tratto morale in una data situazione a riconoscere in che senso si può agire bene o male. Aristotele a questo punto confronta la phronesis con la sensazione, con l'aisthesis, che ci mette in contatto con le cose singole. Si può dire che la phronesis ci mette in rapporto con le situazioni singole, a partire dalle grandi importanti scelte di vita, che sono esse stesse “ordinate” alla felicità. Si può usare anche questa immagine: la phronesis circola dal basso verso l'alto: in alto c'è l'idea che ci facciamo della felicità, in mezzo le diverse virtù con cui la perseguiamo, in basso le singole azioni. La phronesis è questa arte di accordare tutti i livelli, dunque un'arte morale.
E' vero che lo scopo dell'etica per Aristotele è la felicità intesa come felicità individuale e allora mi chiedo: in che nesso sta la responsabilità civile del cittadino di fronte alla società e questo ideale etico di felicità, una felicità propria può talvolta contrastare con il bene comune? Penso, però, che non si debba dimenticare che per Aristotele c'è tra etica e politica un nesso assai stretto, ma per coglierlo è necessario tornare al concetto di azione, di prassi. L'azione vera è quella che ha luogo in pubblico, nell'agorà, nella discussione pubblica per la gestione della città. Proprio all'inizio dell'Etica Nicomachea c'è un passo in cui il filosofo scrive che l'etica è una parte della politica, perché la politica, per usare il linguaggio moderno di Hannah Arendt, è lo spazio pubblico della manifestazione delle azioni umane. Di conseguenza solo per astrazione certe virtù si possono considerare appartenenti, come oggi diremmo, alla vita privata. Per un greco, a cui quell'opera era destinata, non c'era separazione tra vita pubblica e vita privata, prodotto dell'individualismo moderno. L'uomo greco cui si rivolge Aristotele, è, integralmente, un cittadino. Non esiste per lui la nostra opposizione tra vita privata e pubblica; ne abbiamo un esempio nella lettura delle virtù stesse, molte delle quali sono pubbliche e la più importante è la giustizia che consiste nel lottare contro gli estremi del volere troppo in termini di profitti e nel volere meno, ad esempio, in oneri fiscali (ricordo il valore per Aristotele del procurarsi i beni necessari, ma nello stesso tempo quanto la crematistica volta al semplice arricchimento avrebbe determinato una degenerazione morale). Il giusto mezzo è la legge che incarna questo equilibrio tra due tendenze e pulsioni contrapposte, è la legge della polis che distribuisce i profitti, gli onori, dunque i beni comuni. Pertanto la linea di demarcazione tra etica e politica è estremamente flessibile. Siamo noi moderni che abbiamo fatto della morale un qualcosa afferente al privato e della politica qualcosa di pubblico regolato da criteri diversi.

Nella parte iniziale del secondo libro dell’Etica Nicomachea, Aristotele prosegue con la discussione iniziata nel primo libro, esaminando ciò che riguarda le virtù del carattere, o virtù morale. Si indaga come essa nasce, qual è il suo campo, poi se ne cerca la definizione generale: la virtù morale deriva dall’abitudine, da cui ha tratto il nome.
Non lascia dubbi l’affermazione di Aristotele: non si può intraprendere un cammino morale che non tenga conto di questo, cioè che non tenda a darsi la solidità di un ethos.
La virtù morale è l’esercizio di qualcosa di concreto; per fare un esempio è come se ogni individuo si domandasse in modo umanissimo e sempre risorgente: come devo vivere? cosa devo fare?
A questo punto l’esperienza vissuta nella concretezza delle sue articolazioni e dimensioni esistenziali risponde dando indicazioni su come si deve agire e quali qualità devono essere applicate.
L’ethos che letteralmente significa luogo fisso di abitazione, dimora, e anche consuetudine, carattere, costume, abitudine, è etimologicamente in connessione con l’infinito ethizein: abituare, formare un’abitudine.
Significativo è il passo dell' EN, II, 1, 1103 17-18 (ethizomenoi: se noi prendiamo l’abitudine):
“a seconda di come ci comportiamo nei pericoli, cioè se prendiamo l’abitudine di avere paura oppure di avere coraggio, diventiamo coraggiosi, gli altri vili”.
Il primo elemento su cui riflettere è il riferimento all’ethos; esso non indica semplicemente l’insieme degli usi e dei costumi, anzi il suo primo significato è quello di “dimora”, del luogo abituale del vivere.
Per questo motivo non solo gli uomini, ma anche gli animali, tendono ad avere un ethos.
Inoltre è ben presente ad Aristotele che l’ethos per l’uomo si esprime nella polis: gli studi di Vegetti sono, per questo motivo, altamente significativi:
“i soggetti del discorso delle Etiche e della Politica non sono individui chiamati a risolvere, uno per uno e singolarmente, il problema di una scelta fra il bene ed il male. Troppo spesso si dimentica che si tratta invece di cittadini …”.
Ciò spiega la specificità dell’ethos aristotelico, per il quale un comportamento è etico nella misura in cui si adegua appunto all’ethos esistente, cioè a quelle buone pratiche che fanno dell’uomo un buon cittadino.
La connessione costituita da Aristotele fra έϑος (costume) e έϑος (abitudine) rafforza questa tesi, indicando nell’osservazione del comportamento di padri, cittadini eminenti, nel lento adeguamento ad esso, nella formazione di abitudini pratiche il fondamento della virtù morale.
Rinvio all’organizzazione sapientemente strutturata del libro, dove lungo quasi tutto il testo Aristotele tratta delle virtù etiche, o del carattere (έϑος), in generale, definendole come disposizioni stabili che si esprimono in risposte emozionali corrette, cioè determinate dalla ragione, e producono scelte.
Dalla lettura dell’En può sembrare che nessuna virtù morale nasca in noi per natura. Aristotele adduce questo esempio:
“una pietra che per natura si muove verso il basso non prenderà mai l’abitudine di muoversi verso l’alto, neanche se qualcuno voglia abituarla lanciandola in alto migliaia di volte, né il fuoco prenderà l’abitudine di muoversi verso il basso, e nessun altra cosa che è in un certo modo potrà venire abituata ad essere diversa” (En II 22-28)
Secondo la prospettiva del rapporto potenza ed atto, virtuoso si definisce non un singolo atto buono o moralmente retto, ma l’abito o l’abitudine a compiere determinati atti buoni.
Noi acquistiamo le virtù con un’attività precedente: si diventa costruttori costruendo, giusti compiendo azioni giuste, coraggiosi compiendo azioni coraggiose.
Non basta l’intenzione morale di fondo che può essere buona, ma può tradursi, a causa di un impegno non sufficiente o un esercizio ancora manchevole, in atto cattivo. Nella prospettiva dell’etica delle virtù è importante la bontà dell’atto morale, più che la bontà dell’intenzione. L’intenzione buona di voler agire correttamente non produce di per se stessa l’atto buono, nonostante l’intenzione, si può produrre del male.
Ecco allora l’importanza che vi sia una scelta adeguata dei mezzi, che venga assicurata, attraverso un’adeguata formazione personale, anche di tipo tecnico-politico, la competenza.
Si crea un circolo virtuoso: l’intenzione buona è il frutto della maturazione della persona, della capacità di agire rettamente; la ripetizione di agire rettamente aiuta il soggetto ad assumere buone intenzioni anche di fronte a situazioni impreviste o conflittuali. Quindi le virtù non si generano né per natura né contro natura, ma è nella nostra natura accoglierle e sono portate a perfezione in noi per mezzo dell’abitudine (ethos).
Questa è la grande intuizione espressa da Aristotele nel secondo libro dell’Etica Nicomachea.
Egli concorda con Socrate che la virtù morale non si possa insegnare teoricamente; ed è anche convinto che essa si possa conquistare attraverso singoli atti buoni; tuttavia è anche sensibile all’importanza che tre fattori sono fondamentali per l’acquisizione della virtù:
Acquistiamo le virtù con un’attività precedente, come avviene anche per le altre arti.
Infatti, le cose bisogna averle apprese prima di farle, noi le apprendiamo facendole: per esempio, si diventa costruttori costruendo, e suonatori di cetra suonando la cetra. Ebbene così anche compiendo azioni giuste diventiamo giusti, azioni temperate ci rendono temperanti, azioni coraggiose coraggiosi.
Pertanto ogni virtù si genera a causa e per mezzo delle stesse azioni.
Per Aristotele, non è piccola, dunque, la differenza tra l’essere abituati subito, fin da piccoli, in un modo piuttosto che in un altro.
Questa tesi, in base alla quale pare che virtù, vizi e doti naturali in genere, siano abiti consolidati dal carattere e volontari, perché “dipendono da noi”, è stata oggetto di varie interpretazioni.
Nel pensiero di Aristotele, non si può non tener conto di una obiezione che più volte è stata avanzata alla teoria del filosofo: essa non avrebbe presente i condizionamenti esterni che dovrebbero in parte se non annullare, almeno ridurre, l’effettiva responsabilità degli agenti anche nell’acquisizione del loro definitivo carattere morale.
Oltre a dare importanza all’educazione, Aristotele avrebbe dovuto attribuire una funzione rilevante all’ambiente sociale o alla famiglia, invece che agli agenti stessi.
Rimane comunque convincente la posizione di alcuni studiosi, tra cui quella di Vegetti, che sottolinea il peso dei condizionamenti ambientali, familiari e sociali nel processo di costituzione degli abiti del carattere quale Aristotele non solo descrive, ma auspica. Forse ci si può spingere oltre e affermare che egli si sarebbe augurato che ci fossero condizionamenti maggiori di quelli operanti nella realtà storica e sociale, se si pensa al rammarico per l’assenza di un’iniziativa pubblica e soprattutto di una legislazione severa nel campo dell’educazione.
Nell’ambito di questa argomentazione alquanto articolata, Aristotele, indirettamente, mette in campo una terminologia nella quale vengono utilizzate parole, di cui è, a mio avviso, importante precisare il significato.
Egli sceglie per indicare il desiderio il significante greco orexis che afferma come una unione fra altre parole: “epithumia” (l’epithumia - appetito - come mostra la preposizione epi, introduce in una direzione che, tuttavia, non coincide ancora con il bene, ma semplicemente con il piacere e che contrasta con la ragione) e “boulesis” (un desiderio oppure una volontà che si accorda con la ragione). Dunque è chiaro che vi sono almeno due principi che, alternativamente, sono all’origine del movimento: il desiderio e la ragione.
Senza desiderio l’uomo sarebbe per lo più “immobile”; è auspicabile che il desiderio prevalente sia quello che si lascia controllare dalla ragione.
Il dettagliato discorso sulla prassi induce Aristotele a riflettere sull’eccesso e sul difetto:
“gli esercizi fisici eccessivi e quelli troppo scarsi distruggono il vigore, così pure avere a disposizione troppi cibi e bevande, o troppo pochi, distrugge la salute, mentre la giusta misura produce la salute e la aumenta e la difende” (EN II 1104a 15-18)
Con queste esemplificazioni, il filosofo introduce la” µεσότης”.
Nell’Etica Nicomachea (II 6 1106a-b) possiamo leggere:
“io chiamo posizione di mezzo di una cosa quella che dista ugualmente da ciascuno degli estremi, ed essa è una sola ed identica, in tutte le cose; e chiamo posizione di mezzo rispetto a noi ciò che non eccede né fa difetto; essa però non è unica, né uguale per tutti”.
Il criterio della medietà viene a rafforzare il giudizio della ragione e non si oppone ad essa: virtù è appunto la realizzazione in noi di una “disposizione stabile”(hexis); Aristotele indica poi la forma della virtù morale nella “medietà” (mesotes). Il “medio” che Aristotele ha in mente non è per nulla una disposizione alla mediocrità, bensì una disposizione a cercare il meglio in ogni circostanza.
L’uomo virtuoso, spoudaios, in cui questo atteggiamento è divenuto abituale, diviene familiare col bene: tanto da “vedere”, quasi a colpo d’occhio, come capita a chi è esperto di una certa materia “la verità in ogni cosa”.
Aristotele, illustrando la “medietà”, parla ad esempio del coraggio in relazione al pericolo; il coraggio è la medietà tra gli eccessi opposti: la temerarietà e la viltà, perciò rivela di avere in mente una medietà che non è di tipo aritmetico, bensì di tipo qualitativo (una sorta di media tra il più e il meno). La medietà, aristotelicamente intesa, è l’agire ponderato e scelto visto in contrapposizione all’agire sconsiderato.
La virtù quindi è una certa medietà, dato che è ciò che tende al giusto mezzo.
Inoltre l’errare si dà in molti modi, mentre l’essere corretti si dà in un sol modo: perciò vi è anche una cosa facile e una difficile, facile fallire il bersaglio, difficile coglierlo. Pertanto la virtù ha per oggetto passioni ed azioni, nelle quali l’eccesso costituisce un errore e il difetto è biasimato, mentre il “mezzo” è lodato ed ha successo: e queste sono, ambedue, caratteristiche della virtù. Inoltre l’errare ha molte forme (infatti, il male, potremmo dire, si trova nella colonna dell’illimitato, mentre il bene in quella del limitato), invece il riuscire ne ha una sola, per questo il primo è facile, il secondo è difficile. Anche per queste ragioni, dunque, l’eccesso e il difetto sono propri del vizio, la medietà della virtù.
Però non ogni azione né ogni passione ammettono la via di mezzo: per alcune infatti già il nome implica la malvagità, ad esempio la malevolenza, l'imprudenza, l'invidia e, nel caso delle azioni, l'adulterio, il furto, l'omicidio. Infatti tutte queste passioni ed azioni, e quelle del medesimo genere hanno quei nomi per il fatto di essere in se stesse cattive, nei loro eccessi e nei loro difetti.
Il giusto mezzo è la causa finale della praxis, e anche della poiesis, cfr Etica Eudemia,1227b-8-9: “necessariamente la virtù etica è uno stato abituale che sceglie la medietà relativa a noi”.
L’agire in modo sconsiderato diviene, a sua volta, una disposizione abituale, si può parlare addirittura di “vizio”.
Viene così introdotta la disamina sul rapporto tra piacere e dolore, vi è una indubbia relazione tra i due termini proprio perché entrambi correlati con la virtù.
Il piacere e il dolore sono disposizioni morali che si aggiungono alle azioni. Scrive Aristotele:
“Infatti la virtù morale riguarda i piaceri e i dolori: è a causa del piacere che la gente compie azioni ignobili ed è a causa del timore che si astiene da azioni belle” (EN II 1104b 9-11).
Inoltre, le virtù riguardano le azioni e le passioni, e a ogni azione e a ogni passione conseguono piacere o dolore, la virtù verrà a riguardare piacere e dolore anche per questo motivo. Le nostre azioni, chi più, chi meno, le giudichiamo col metro del piacere e del dolore:
“Di seguito bisogna indagare cosa sia la virtù, dato che tre sono le cose che si generano nell’anima: passioni, capacità, stati abituali e la virtù coincide con una di queste tre cose. Chiamo passioni il desiderio, l’ira, la paura, l’ardimento, l’invidia, la gioia, l’odio, la brama, la gelosia, la pietà e in generale tutto ciò cui fa seguito piacere e dolore, chiamo capacità quelle cose in base alle quali siamo capaci di provare passioni, ad esempio adirarci o al contrario provare pietà e addolorarci, chiamo stati abituali quelle cose in base alle quali ci atteggiamo bene o male riguardo alle passioni” (EN II 1105b 19-29).
In questo passo Aristotele introduce una diversa terminologia per indicare “gli stati abituali”: viene introdotta la parola εξІς che deriva dal verbo greco εχω il cui significato è affine al latino habeo: avere, possedere e exis equivale a possesso, al latino habitus, habitudo, cioè stato fisico o morale, condizione, qualità e temperamento.

L’etica di Aristotele non inizia con tavole di precetti né intende fornire regole assolute; assume come proprio campo di indagine il comportamento dell’uomo. Si presenta dunque come una scienza che ha per oggetto l’agire umano, considerato non solo nella sua forma astratta (l’azione come carattere proprio dell’umanità, la definizione di azione morale e le categorie che ne permettono la lettura e la classificazione secondo tipologie di vita), ma anche nella sua forma storica concreta (le azioni concrete degli uomini e l’agire sociale quale si manifesta “per lo più”), a partire dalle convinzioni e dalle abitudini che lo sorreggono.
L’impianto è descrittivo prima di essere prescrittivo o, meglio, propositivo. La scelta di uno sguardo analitico descrittivo spinge Aristotele ad allargare il campo della propria osservazione etica. Egli fa riferimento ai detti, alle massime, ai costumi condivisi e ricorrenti, alle opinioni autorevoli, alle tradizioni degli antichi.
Un’azione appartiene all’etica e non è un semplice fatto fisico, secondo Aristotele, sulla base di quattro caratteristiche:
Prosegue Vegetti nell'Etica degli Antichi: “non è la singola azione in sé ad essere oggetto centrale dell’etica, ma la virtù e il rapporto che le unisce”. L’azione è particolarmente rilevante non quando è considerata nella sua singolarità (considerazione già affrontata in precedenza) quando è fonte di virtù; quando genera un comportamento e, in modo più ampio, uno stile di vita. Le passioni non costituiscono per se stesse il male morale, né ipotizza Aristotele uno sradicamento d’esse da un punto di vista morale; le passioni sono una reazione, direi naturale, nell’ambito dei rapporti sociali e interpersonali. Nessuno sceglie tali passioni, pertanto nessuno può essere responsabile. Non si è buoni o cattivi per le passioni che si provano, ma per le virtù e i vizi, cioè per il modo con cui le passioni vengono regolate dall’azione morale.
Il problema della virtù non consiste nella soppressione delle passioni, presenti per Aristotele nel nostro apparato psichico, ma nel buon uso delle passioni stesse: è bene individuare verso chi ed il fine verso cui sono incanalate. La virtù si esplica, a tal proposito, proprio come capacità di governare, regolare le passioni. Aristotele non ci dà una catalogazione esaustiva delle passioni, ma elenca solo degli esempi. E’ soprattutto all’interno del testo “Categorie” che il filosofo affronta questo problema: “le passioni sono dei modi di reagire dell’anima, quando essa subisce le percezioni esterne”. Esse non qualificano l’individuo dal punto di vista morale, a meno che non divengano “stati abituali”: “gli stati abituali sono difficili da eliminare”.
Ora, scrive Aristotele, né la virtù, né i vizi sono passioni, perché noi non siamo definiti eccellenti o ignobili secondo le passioni, ma proprio in base ai vizi e alle virtù. Noi siamo convinti di essere mossi secondo le passioni, mentre per quanto riguarda vizi e virtù non diciamo di “venire mossi”, ma di trovarci in una certa disposizione. Per questa ragione vizi e virtù non sono nemmeno delle capacità. Se quindi le virtù come i vizi non sono né passioni, né capacità, rimane solo questa identificazione: essi sono stati abituali.
Che la virtù sia una disposizione o un “abito”, significa essenzialmente che non la possediamo per natura, ma l’acquisiamo per abitudine, mediante la pratica (En II 1103-25). La disposizione è inoltre un modo di comportarsi rispetto alle passioni, in riferimento al quale siamo lodati o biasimati (EN II 1105b-5e 1106-1).
Dalla lettura soprattutto di quanto è detto circa la virtù nel secondo libro, viene enunciata la felicità: nulla nel testo della Nicomachea ci consente di pensare che Aristotele concepisse la felicità come contraria alla virtù, come qualcosa che sia contenuto nell’atto che si propone alla ragione; la felicità riguarda piuttosto la virtù, l’uso della virtù è un mezzo per raggiungere la felicità.
Per eliminazione Aristotele indica quali sono le cause vere della felicità accantonando una dopo l’altra le competitrici che giudica prive di titoli adeguati.
Il primo passo consiste nell’eliminazione della causalità divina, poiché essa non ha alcuna importanza diretta per il problema che si sta affrontando. Il suo annunciato procedimento presenta subito un’anomalia, prima di aver preso in considerazione una competitrice elencata da lui stesso, ad esempio la tyche, sostanzialmente anticipa la soluzione, riconducendo l’origine della felicità alla virtù e ai suoi fattori “la felicità non è inviata dagli dei, ma proviene dalla virtù e da una qualche forma di apprendimento o di esercizio”.
Qualche riga più sotto, questa soluzione è ripetuta quasi con gli stessi termini “grazie ad una forma di apprendimento e di applicazione”, Aristotele riduce le cause della felicità alla virtù e limita i fattori della virtù a due soli: apprendimento e esercizio o (abitudine).
Si comprende perché vi sia questa incalzante preoccupazione aristotelica: cioè l’individuazione di elementi che concorrono alla felicità. Lo studio dell’etica e pertanto dell’Etica Nicomachea è inteso ad una finalità pratica, con molta chiarezza è presente in vari luoghi delle Etiche ed anche per esempio nel passo seguente della Nicomachea:
“Siccome la presente trattazione non si propone la pura conoscenza, come le altre (infatti non stiamo indagando per sapere cos’è la virtù, ma per diventare buoni, perché altrimenti non vi sarebbe nulla di utile in questa trattazione), allora è necessario esaminare il campo delle azioni, come le si debba compiere” (ENII2,1103b 26-29.
Aristotele ha probabilmente destinato questo discorso ad un pubblico che si potrebbe identificare, se non con i suoi discepoli, sicuramente con i cittadini impegnati nella vita politica ateniese: forse quelle “persone raffinate e attive” su cui si è soffermato nel primo libro, che “identificano la felicità con l’onore e per i quali è tuttavia necessario indicare una nozione di bene pratico (ENI,1095b 22-23 e segg.). Questa prospettiva, cioè di un discorso rivolto ad un pubblico non solo di scuola, induce a pensare che Aristotele fosse fiducioso riguardo alla possibilità di influire sull’orientamento della città stessa, ai fini della felicità che definisce per essa.
Aristotele pone però una limitazione all’accessibilità della felicità: non dice che sia accessibile a tutti, ma soltanto a molti e i molti sarebbero “tutti coloro che non sono incapacitati alla virtù”. Viene ribadito nell’EN che “la felicità è, attraverso l’esercizio e l’insegnamento, a disposizione di tutti coloro che non hanno danneggiato le loro disposizioni naturali”.
Questa teoria può essere accusata di ambiguità.
Che cosa si deve intendere infatti per “disposizioni naturali”?
Vi sono due significati, uno forte e uno attenuato.
Nel senso più forte, si dovrebbe pensare alle “virtù naturali” o agli “abiti naturali” di cui parlano l’Etica Eudemia e l’EN VI, i testi ritenuti più espliciti nel riconoscimento dell’importanza delle doti naturali in vista della formazione del carattere. In tal senso, allora Aristotele in EN I 9 avrebbe riproposto la physis: ciò che non ha fatto.
Un senso attenuato delle “doti naturali” proviene dal commento di Aspasio nel commento del passo dell’EN “incapacitati alla virtù alcuni nascono, come chi è privo di senno dalla nascita, altri sono mutilati dal loro comportamento diventando inguaribili”; la mutilazione potrebbe consistere nella mancanza di coraggio o generosità, ad esempio.
Secondo Aspasio l’EN potrebbe essere interpretata facendo riferimento alla classica teoria che prevede la formazione di abiti virtuosi o viziosi dalle abitudini contratte sin dalla puerizia e sotto l’influenza di buoni (o cattivi) educatori. Se un carattere malvagio si è definitivamente costituito come abito, per la ripetizione di comportamenti cattivi, il portatore di tale carattere non potrà sviluppare la virtù e diventare, di conseguenza, felice.
La disamina riguardo la felicità non termina ancora, in quanto Aristotele espone due possibilità per raggiungere la felicità: mediante esercizio e insegnamento o per caso. Affidare un bene così grande al caso, potrebbe sembrare una stonatura, è molto più ragionevole che la felicità sia il frutto dell’applicazione e dell’insegnamento e non del caso. La tyche quindi viene nuovamente esclusa.
Quali sono le cause della felicità? Non ci dovrebbero essere dubbi: la felicità dipende dalla virtù e dai fattori di questa, apprendimento e abitudine.
Etica Nicomachea di Natali
L'etica di Aristotele di A. Fermani
Il Determinismo aristotelico di Donini
Le strategie metaforiche nelle Etiche di Silvia Gastaldi
Studi sull'etica di Aristotele di Antonina Alberti
Quindi lezioni su Aristotele di Mario Vegetti
L'etica degli Antichi di Mario Vegetti
Storia delle passioni di Silvia Vegetti Finzi
Aristotele e l'etica: le virtù dianoetiche di Paul Ricoeur
Leggi anche: Aristotele e la crematistica

Maria Barchiesi è nata a Cremona nel '53; si è laureata in Lettere Classiche e perfezionata in Storia della Filosofia Antica presso l'Università di Pavia, sempre con il prof. Mario Vegetti con il quale ha collaborato presso lo IUSS pavese. Da sempre ama viaggiare e la cultura in tutte le sue manifestazioni e saperi è la sua scelta di vita prioritaria. Nell'insegnamento presso le scuole superiori e lo IUSS ha vissuto il rapporto con i giovani di età diversa sempre con entusiasmo e desiderio di vederli culturalmente crescere. Il principio che la guida nelle ricerche è: kalos kai agathos, ciò che esprime bellezza è anche buono eticamente, fa bene all'anima e alla mente.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG