
Nella categoria: HOME | Articoli critici
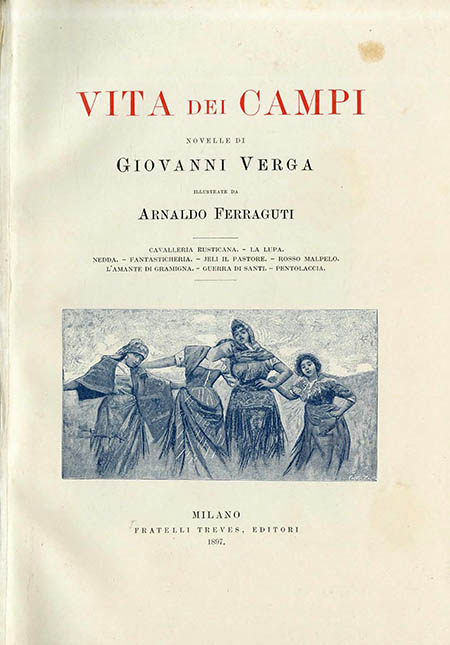
La novella viene pubblicata nella “Rivista nuova di Scienze, Lettere e Arti” e poi Verga la inserisce nella raccolta “Vita dei campi”, del 1880: sedici anni dopo ne fa una trasposizione teatrale di successo a Torino (con accenti più realistici), cosa che verrà ripetuta nel 1953 da Lattuada, che sposta l’ambientazione dalla Sicilia alla Lucania, nel 1966 da Zeffirelli, sino al film di G. Lavia trent’anni dopo.
Sette anni prima di scriverla, nella prefazione del romanzo Eva, aveva fatto una chiara denuncia del mondo borghese. Infatti tra il 1876 e il 1881 Verga, tutto intento a riscoprire la purezza del mondo rurale, vagheggiava una società arcaica, precapitalistica, incontaminata dall’egoismo e dal calcolo, influenzato in tal senso dal naturalista francese Zola che, però, s’era concentrato soprattutto sui bassifondi urbani, per mostrare le conseguenze dell’industrializzazione borghese.
Con La Lupa mai era apparsa in Italia un’eroina letteraria che sconsacrasse tanto radicalmente il culto della femminilità domestica, sottomessa all’uomo, assorta nel compito di badare alla casa e alla prole. La Lupa, una contadina siciliana che pare strumento nelle mani del destino, come nella tragedia greca, in cui però l’erotismo non poteva essere vissuto nella consapevolezza del “peccato”. In realtà una vera consapevolezza nella novella sembra assente, poiché La Lupa vuole vivere il proprio erotismo belluino, nel più assoluto ateismo, in totale dispregio di qualsiasi remora religiosa.
L’italiano antiletterario del Verga, desunto da costrutti e locuzioni dialettali, s’attaglia perfettamente, come tutta la descrizione ambientale, alla situazione ferina, pulsionale, priva di freni e di dubbi (“Te voglio…Voglio te”). Qui il sesso è concepito modernamente, come possesso esclusivo, il corpo va posseduto nella sua fisicità, indipendentemente da qualunque sovrastruttura ideologica, morale e ambientale. L’ateismo della Lupa, l’infernale caldo estivo, dai campi assolati, i lavori sporchi e faticosi, spossano e abbruttiscono: tutto fa parte di una situazione in cui la protagonista vuol far valere il primato dei sensi su ogni regola familiare e convenzione sociale. Di fronte a questa prepotenza egocentrica a nulla servono i rapporti familiari tra madre e figlia, tra genero e suocera, né quelli istituzionali tra parroco e genero, tra brigadiere e l’intera famiglia, e tanto meno quelli tra la comunità locale e la stessa famiglia.
La narrazione sembra condotta da un popolano del luogo (presso l’Etna, forse l’entroterra di Catania), si rivolge a dei compaesani, senza compiacenze di alcun genere, aderendo semplicemente ai fatti, lasciando “parlar le cose” in pieno stile verista, descrivendo le scene d’amore con pochissime allusive ma incisive frasi. In una novella breve, di neanche millecinquecento parole, in cui l’intreccio dei rapporti è così umanamente contorto da indurre a mille congetture, vediamo svolgersi una sequenza incredibilmente rapida di lavori rurali: mietere il grano, spremere le olive, potare le viti, sarchiare, zappare, accudire gli animali. Eppure, nonostante questi lavori, la novella non vuole rinchiudersi nella ruralità, anzi aspira ad un carattere più universale, non essendo scritta per i ceti che rappresenta, ma per il lettore borghese. Verga, durante la stesura della novella, si trovava ancora a Milano, un soggiorno che durerà vent’anni (1872-1893).
Si palesa sin dall’incipit della novella la raffigurazione della Lupa imperniata sul suo prorompente aspetto fisico destinato, però, a non esaurirsi in sé, per assumere accezioni molto più ampie:
Era alta, magra; aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna e pure non era giovane; era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi cosi, e delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano.
Subito dopo onde evitare che il lettore si lasci ammaliare da tale bellezza, chi narra provvede a correggere il tiro palesandole peculiarità tutte negative:
Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai di nulla. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell’andare randagio e sospettoso della lupa affamata…

Un simile contegno contrasta con il contesto sociale al quale appartiene la donna, come ho già evidenziato, perciò il compito di rimarcare l’estraneità di lei all’ambiente tocca al narratore la cui “prospettiva coincide, non solo concettualmente ma visivamente, con quella stessa dei personaggi, mentre la mediazione del commento ai fatti è annullata o ridotta a osservazioni minime e semplicistiche” (Luperini). Cosicché, entrando in medias res l’attenzione si sposta dalle caratteristiche fisiche della Lupa a quelle morali che appaiono direttamente consequenziali al suo aspetto:
ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d’occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso...
articolarità seduttrici dello sguardo conquistano un posto di effettivo rilievo nonostante fosse già emerso, all’inizio della novella, il dettaglio degli occhi grandi così adombrato, tuttavia, dal risalto assunto dal suo colorito spento, emblema di una sorta di fascino sinistro teso ad esaltarne la sensualità malata alla quale si contrappone il candore della figlia Maricchia che appare indossando i panni della vittima sacrificale:
Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto perché era figlia della Lupa, e nessuno l’avrebbe tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, e la sua buona terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio
Così sugli occhi piangenti della ragazza, contrapposti a quelli della madre che, invece, rimarranno asciutti fino all’epilogo della vicenda, si chiude la prima parte della novella nella quale la figura della donna giganteggia simile ad una divinità nefasta; l’improvviso innamoramento vissuto con violenza la tramuta a livello così infimo da arrivare a sedurre persino “un vero servo di Dio” come “Padre Angiolino di Santa Maria di Gesù”, il quale “aveva persa l’anima per lei”.
Una volta la Lupa si innamorò di un bel ragazzo che era tornato da soldato, e mieteva il fieno con lei nelle chiuse del notaro, ma proprio quel che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni sotto al fustagno del corpetto, e provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore calde di giugno, in fondo alla pianura.
Non è casuale che il narratore, per definire la portata delle sensazioni provate dalla donna, ricorra ad immagini il cui denominatore comune è costituito da un calore privo, però, di connotazioni vitali, una sorta di anticamera infernale nella quale “le carni” della Lupa cominciano ad essere lambite da una simbolica fiamma devastatrice, in carattere con la mortifera aridità dominante della natura durante le “calde ore di giugno”: all’interno dello scenario, spiccano gli occhi della Lupa fissi sul “ bel ragazzo” il quale, però, “seguitava a mietere tranquillamente col naso sui manipoli, e le diceva: “O che avete, gnà Pina?”.
Il contegno del giovane, antitetico a quello della protagonista, è indicativo di scarsa lungimiranza: il che, secondo Luperini, trova riscontro nel ritmo serrato che egli imprime al suo lavoro (“mieteva e mieteva”), molto simile con i dovuti mutamenti, alla fatica degli asini “nelle cave per anni e anni senza uscirne mai più” relegati “in quei sotterranei”. Il giovane tenta di conferire normalità all’interno di una situazione che sembra non averne: “Ed io invece voglio vostra figlia, che è zitella, disse Nanni ridendo.” La presenza degli uomini addormentati sullo sfondo costituisce un segnale poco rassicurante, sinistro, un segnale che allude al sonno della ragione di cui Nanni e la Lupa stanno per diventare preda. La richiesta di Nanni è accolta dalla donna con un silenzio anch’esso gravido di oscuri presagi:
La Lupa si cacciò le mani nei capelli, grattandosi le tempie senza dir parola, e se ne andò, né più comparve nell’aia.

Al giovane è negata la parola, quasi a non accordargli nessun’altra funzione oltre a quella di oggetto dei desideri erotici della donna-strega, situazione già evidenziata dal narratore all’inizio della novella e il narratore appare compartecipe della vicenda da parte delle “vittime”: “Maricchia poveretta, buona e brava ragazza” e Nanni “affatturato dalla donna-strega”. L’intensità febbrile della passione assume sempre più i tratti inquietanti di “un rovello che attraversa le stagioni e sfida la convivenza, la fatica e il dolore con eroica e luciferina determinazione”. Infatti ella torna ad insidiare Nanni il quale, ancora una volta è intento a svolgere un lavoro particolarmente gravoso: “cavare l’olio e lo scricchiolio del torchio non lo faceva dormire la notte…”. Il nuovo approccio è caratterizzato da una sottile astuzia della Lupa che arriva a far credere al giovane di aver desistito dall’intento di sedurlo, accettando la richiesta di sposare Maricchia: “la vuoi mia figlia Maricchia? Nanni “cosa gli date a vostra figlia Maricchia?” rispose Nanni. “Essa ha la roba di suo padre, e dippiù io le do la mia casa; a me basterà un cantuccio nella cucina, per stendervi un po' di pagliericcio… se è così se ne può parlare a Natale disse Nanni”. La Lupa determina le sorti familiari, ed il suo sguardo è già offuscato dal desiderio, la cui intensità la sospinge nell’unica direzione possibile quella, cioè, dell’immediato soddisfacimento. Maricchia invece nota quanto unto e sudicio fosse il giovane, non lo voleva, ma la madre le disse davanti al focolare: “se non lo pigli ti ammazzo”. L’aspetto del giovane unto e sudicio equivale ad una sorta di maschera atta ad esporlo alla seduzione. Ciononostante Maricchia cede ad una violenza che le consentirà di compiere un itinerario formativo al cui termine la sua individualità appare rafforzata in maniera proporzionale alla perdita dell’identità subita da Nanni e dalla madre. Il narratore non manca di osservare un mutamento della Lupa dopo le nozze, vittima di una forte inquietudine interiore. Il segnale più evidente della metamorfosi in atto è dato dalla ristrettezza cui è relegato il suo sguardo che non ha più la capacità di ammaliare chiunque, bensì è rivolto unicamente a Nanni il quale tenta di esorcizzare la potenza affascinatrice mediante un probabile rituale di scongiuro:
Suo genero, quando glieli piantava in faccia quegli occhi, si metteva a ridere, e cavava fuori l’abitino della Madonna per segnarsi.
Il ricorso a simili liturgie tradisce un sostrato di inettitudine, una sua incapacità di opporsi alle reiterate insidie della Lupa. Lei continua ad assediarlo perché lui capitoli e si reca da lui:
in quell’ora fra vespero e nona, in cui non ne va in volt femmina buona”, quando la gnà Pina era la sola anima viva che si vedesse errare per la campagna, sui sassi infuocati delle viottole, fra le stoppie riarse dei campi immensi che si perdevano nell’afa, lontan lontano, verso l’Etna nebbioso, dove il cielo si aggravava sull’orizzonte. “No! Non ne va in volta femmina buona nell’ora fra vespero e nona!” Singhiozzava Nanni, ricacciando la faccia contro l’erba secca del fossato, in fondo in fondo, colle unghie nei capelli.
Da qui Nanni inizia a compiere una vera e propria descente à l’enfer che prosegue con l’accettazione del legame incestuoso, una volta vanificato ogni suo tentativo, peraltro poco determinato, di resistere alle lusinghe della donna. Il carattere rituale della relazione è esasperato dal contegno della protagonista improntato da una minacciosa rigidità i cui segnali piuttosto evidenti sono dati dal suo porsi davanti a Nanni ritta col petto prepotente mentre incede guardando fisso davanti ai suoi passi come a voler dominare la realtà circostante mediante lo sguardo. Diverso è lo sguardo della figlia che ha acquisito una lucidità tale da proiettarla all’esterno dell’angusto spazio nel quale era stata confinata, nel rispetto dei canoni consueti, il ruolo di moglie e madre nello sforzo di conferire una parvenza di normalità alla vita coniugale invero del tutto irregolare. Gli occhi di Maricchia sono ben aperti, perciò, intuisce l’esistenza del legame incestuoso, chiama la madre: “Scellerata! Le diceva. Mamma scellerata Taci. Ladra. Andrò dal brigadiere. Il brigadiere non ottiene nulla: la Lupa si è riservata un cantuccio e da lì non si sposta. La donna continua, dopo la guarigione, a circuire Nanni rassegnato e lo si comprende dalla sua posizione, quel suo stare supino nel fossato dove si addormenta prima di consumare il rapporto incestuoso e anche quando in preda ai rimorsi, supplica la Lupa di non cercarlo più, “nasconde la faccia contro l’erba secca del fossato”. La Lupa, pur minacciata di morte da Nanni, non si lascia intimidire da questo proposito cruento del genero e dà una risposta che lascia intuire l’impossibilità di sciogliere la situazione se non nel modo prospettato da Nanni. “Ammazzami, rispose la Lupa, ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci”. E così all’ennesimo approccio tentato dalla donna, a Nanni non resta altro che ricorrere al gesto estremo sul quale, peraltro, il narratore si sofferma diffondendosi in una serie di particolari:
Ei come la scorse da lontano, in mezzi a’ seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a staccare la scure dall’olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che luccicava al sole, e non si arrestò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri-
Ah! Malanno all’anima vostra ! balbettò Nanni.
Come nell’incipit anche qui troviamo la presenza di elementi cromatici il cui scopo non è un ritornare all’aspetto ritrattistico iniziale che risulterebbe diverso solo per lo scambio di tinte, per cui il pallore è trasferito dalla donna all’uomo. La insistente ricorrenza del rosso e del nero, unitamente ai bagliori emanati dalla scure che, però, non rischiarano lo sguardo dei personaggi, bensì tendono ad offuscarlo ancora di più, è giustificata dal valore emblematico assunto da questi aggettivi adoperati per permettere il passaggio dal piano descrittivo a quello delle volontà simboliche e dell’uso metaforico, a vari livelli di traslato. Così l’epilogo appare connotato da una vera e propria apoteosi dello sguardo e della seduzione sui quali si fonda l’intera novella.
Questa analogia mi è giunta spontanea, in quanto nella novella come nella tragedia della Fedra di Seneca compaiono: la donna adulta, il giovane uomo e il giudizio morale. Per entrambe le protagoniste sembra ripetersi uno schema unico: Fedra, ancor più la Lupa sono incuranti della propria reputazione e della loro stessa vita (Fedra amans -amens amante è talmente coinvolta dalla passione per Ippolito che trasforma il suo amore in follia, che la induce a vendicarsi di Ippolito accusandolo ingiustamente, ma la morte straziante del giovane la porta al suicidio; la Lupa sa bene che Nanni con la scure in mano ha una evidente intenzione, ucciderla unica soluzione per il giovane per il quale la Lupa era, è una tentazione cui non sa resistere, ma la Lupa non arretra va incontro alla propria morte, un omicidio ed insieme un malcelato suicidio), entrambe intendono sedurre un giovane: Fedra ama Ippolito da desiderare una vita non a corte ma tra i boschi, prima è titubante e poi svela ad Ippolito il suo amore totalizzante ed in grado di ottenebrare la sua mente, un malum ma che non sa soffocare; la Lupa è la tentazione erotica, genera timore in ogni altra donna lontana dalla vita sociale, priva di remore morali l’uomo è una sua preda, con Nanni questo erotismo cessa, per così dire, di spalmarsi su più uomini, e tutto il suo erotismo è volto a sedurre e possedere il giovane in una abnegazione sessuale. L’esito è per entrambe tragico: la morte. Il legame incestuoso della Lupa per Nanni è un fuoco che brucia e consuma, che porta all’annientamento, all’avvilimento, alla morte (eros| thanatos- amore |morte, l’amore è morte).

Nel suo dettato drammatico la Lupa richiama la tragedia greca e in particolare Fedra. Nell’analogia emergono, però, ed è naturale, alcune differenze non trascurabili: la cultura di Fedra non comparabile all’asciutta essenzialità della Lupa: se Fedra utilizza il logos come parola per esprimere il suo amore, per far intuire ad Ippolito i suoi sentimenti la necessità della sua presenza, la Lupa lavora accanto a Nanni e con sguardi e poche ed essenziali parole esprime la propria passione “ te voglio…”; se Fedra vorrebbe che Ippolito la considerasse non una madre ma un’amante e le conferisse tale riconoscimento per ritrovare in amore la propria identità; la Lupa nella sua sensualità ed erotismo desidera il possesso fisico di Nanni. Fedra segue il sentimento, l’amore e l’autodeterminazione. La Lupa segue il suo erotismo, la sua passione sessuale che confluisce nell’incesto, assente nella tragedia di Seneca. E perché assente? L’amore, pur passionale, di Fedra non tende al possesso o abnegazione fisica, ma ad un pieno riconoscimento del suo amore da parte di Ippolito, un amore tale che dovrebbe essere contraccambiato; Ippolito quasi sino al termine della tragedia non si lascia coinvolgere da Fedra, è pronto a sostituire il padre lontano, ad aiutare Fedra, ma non ad un rapporto incestuoso; la Lupa in modo viscerale e sensuale ama Nanni e il suo unico desiderio è il suo possesso fisico, l’incesto oltre ogni remora morale e Nanni così non prova tenerezza, non prova nulla che esalti lo spirito vitale, può provare rimorso ma dotato di una debole personalità viene contaminato dall’erotismo della Lupa e da qui l’incesto assente nella Fedra di Seneca. Se Fedra in un amore passionale e sublime nello stesso tempo, in attesa della comprensione e riconoscimento da parte di Ippolito diventa un’eroina indimenticabile della classicità, la Lupa per il suo erotismo e trasgressione morale prima dell’incontro con Nanni e oltre per la sua solitudine, il suo isolamento e la sua diversità è altrettanto indimenticabile nella sua sofferenza, la Lupa soffre per la sua stessa fame, appena appoggiati gli occhi su Nanni è lei a subire un incantesimo demoniaco che tutti le attribuiscono e per questo la isolano come diversa. Discendente in parte da Fedra, la Lupa è indipendente e conscia della sua natura ferina e sensuale, mai tenta di opporsi ad essa ma ne rappresenta i tratti con doloroso travaglio ed è questo travaglio doloroso che accomuna due grandi protagoniste: Fedra e La Lupa.
Asor Rosa nella sua analisi della raccolta “Vita dei Campi” di Verga si sofferma su “La Lupa” confrontando la sua vicenda con le vicissitudini delle Petridi presenti nel mito greco nel tentativo di aprire una diversa prospettiva di lettura che lasci intendere la complessità dell’operazione dell’autore catanese.
Funzionale al rapporto col mito greco, vorrei riprendere aspetti che, in tale prospettiva, risultano utili :
Il mito delle Petridi si rifà al mito delle figlie del re di Argo, oppure di Tirinto. In alcune fonti esse sono indicate come parthenoi; altre, invece parlano di gunaikès, ma si tratta sempre di soggetti femminili, le quali resisi colpevoli di offese nei confronti della divinità (in alcune fonti Era, in altre Dioniso, in altre ancora Afrodite o addirittura Asclepio), per punizione impazziscono, si danno ad una vita sregolata in luoghi selvaggi, rischiano di mettere in crisi la struttura della polis in quanto al loro seguito si uniscono altre donne, anche madri di famiglia, ma alla fine ritornano ad una condizione di sanità grazie all’intervento di Artemide oppure all’indovino Melampo. Questa è, in rapida sintesi, la successione delle loro vicende.
Ora vediamo quali sono gli aspetti più rilevanti per la nostra analisi della Lupa.
Prima di operare uno stretto confronto con il testo verghiano, è necessario, a mio avviso, aggiungere alcuni particolari sul mito delle Petridi. E’ stato notato come al di là delle diverse versioni del mito, opera sempre la stessa struttura narrativa che secondo Vernant e Detienne è la seguente: “offense à une divinité -> calamité envoyée par cette divinité -> ordre retabli par une pratique rituelle regulière”. Ad essere in gioco è dunque sempre una dinamica di trasgressione: quando le protagoniste sono fanciulle, lo sbocco della vicenda deve essere il raggiungimento della nuova condizione sociale di moglie pronta a generare nuova prole e ad essere chiamate in causa sono le divinità che presiedono alla giusta composizione del nuovo nucleo familiare. Artemide si faceva carico del passaggio da uno status all’altro; Era si faceva carico del buon funzionamento dell’oikos; Afrodite come simbolo della forza dell’eros necessario per la riproduzione del corpo sociale; se quella delle Prediti si presenta come vero e proprio nosos, malattia, non stupisce che sia coinvolto anche Asclepio (il dio guaritore); quando invece il mito coinvolge le gunaikes, la conclusione è l’introduzione di culti cari a Dioniso e l’acquisizione di un nuovo status religioso. Tramite dei riti le Petridi operano il passaggio dallo stato di “natura” a quello di “cultura”.
Gli elementi strutturali di questo mito alquanto articolato e complesso sono: 1) ad essere interessati sono soprattutto soggetti femminili in connessione con determinati momenti critici della loro esistenza; 2) la crisi dà luogo ad una fuga verso solitudini arboree sotto lo stimolo di una pungente e allucinante sollecitazione, cioè la tendenza ad uscire da una situazione di “cultura” per inoltrarsi in una situazione di “natura”; il rischio che ciò determini istinti suicidi.
Con questo non intendo banalmente affermare che nella stesura della novella Verga si sia ispirato direttamente al mito delle Petridi. Non vanno, del resto, taciuti gli elementi di distanza tra novella siciliana e il mito antico. Se infatti nella prima tutto ruota intorno ad una figura a tutto tondo, la gnà Pina, nella leggenda mitica protagonista è tutta la collettività di donne; la tragicità della vicenda narrata da Verga, inoltre, si esplica in un destino di autodistruzione a cui va incontro La Lupa, laddove il movimento di fuoruscita dalla normalità delle Petridi è solo temporaneo e presuppone il processo opposto di reintegro. A ben guardare le differenze non inficiano il discorso precedente che ha come obbiettivo se realmente Verga mutato ambiente avesse realmente pensato di costruire qualcosa di analogo alla femme fatale decadente. A questo punto bisogna evidenziare gli aspetti di contatto tra la novella e il mito.
Come la Lupa manifesta la sua vitalità sessuale durante la calura estiva, questa è la stagione in cui maggiormente il mondo femminile manifesta la propria lascivia.
Note su “ La Lupa” rappresentata al Teatro Quirino di Roma
Sull’ampia scena del Teatro, Quirino, a Roma, lo spazio d’azione dei personaggi de La Lupa di Giovanni Verga è ridotto a pochi metri di profondità, composto da un pavimento scuro, su cui sono adagiati alcuni parallelepipedi, con un gradino a scendere verso il proscenio grigio, lucido e regolare. Perché l’ampio spazio del proscenio è stato così intenzionalmente ridotto? Perché è occupato da destra a sinistra, da una fitta coltre di messi gialle e secche. Sopra di esse all’orizzonte, si ricongiunge un cielo convesso dove un cerchio luminoso è alternativamente sole e luna. Dinanzi ai nostri occhi siede zia Filomena pronta a pagare i braccianti che stanno per rientrare. Dalle stoppie alte emergono, per tutta la durata del primo atto, chi di qua chi di là, tutti i personaggi, quasi venendo fuori dal profondo della terra, portando ceste sulle spalle con il lavoro della giornata.
Anche nel testo verghiano, messo in scena dal regista G. Ferro e costruito con la scenografia di Françoise Raybaud, tutti i partecipanti alla vicenda escono dal fondo del terreno, dove pare si fossero nascosti prima, chissà per procurarsi il cibo, i mezzi di vita e sussistenza per sé e i familiari: tuttavia sono spettatori o complici, in realtà, della fine della protagonista – ad opera in diretta del suo assassino – vale a dire della tormentata Lupa, suocera incestuosa, vestita di nero con grembiule, scialle o collana e orecchini rossi; così come nell’intera rappresentazione, in chiave speculare si presenta il genero- amante con un nastro vermiglio annodato alla camicia bianca indossata su pantaloni anch’essi neri . E’ il rosso, senz’altro segnale del colore della passione, ma anche del sangue, della morte, identificata con la luce scura, con il nero delle tenebre.

Lina Sastri, da quando appare la prima volta nella scena, si mostra posseduta, in modo penoso, dal fuoco della passione nutrito per il futuro genero Nanni Lasca. Avanza in scena già gravemente segnata, ferita dalle tracce imminenti di una morte a venire annunciata dal rosso accoppiato al nero: come nei complementari Eros e Thanatos studiati da Freud nel saggio “Al di là del principio del piacere” (1920), dove il padre della psicanalisi, illustrando le pulsioni di vita e di morte, si richiamava ad Empedocle di Agrigento. Vissuto nel V secolo a.C. nell’allora Akragas, il filosofo, da parte sua, concepiva una sorta di dissidio cosmico tra i principi, tra le forze di Amore (o Amicizia) e Odio (o la Discordia): attraverso questo spazio di millenni, la novella originaria di Verga pubblicata nel 1880 nella raccolta “Vita nei campi”, ne trasmette, in qualche misura ne evoca, le suggestioni.
La gnà Pina, Nanni e la figlia Maricchia si lasciano trasportare da una simile forza della terra, con le sue origini d’amore e amicizia, odio e sopraffazione, come parti stesse del ciclo dialettico della vita umana e della natura.
Nel passaggio dalle pagine del testo al palcoscenico, il triangolo amoroso al centro della storia sembra allontanarsi dalla concezione dialettica di Empedocle avvicinandosi a quella tipicamente freudiana: in essa si sostiene la presenza di un essenziale desiderio o pulsione di morte, relativo a una necessità intrinseca di morire, in diversa misura ed importanza in ogni essere vivente. Gli esseri umani, in qualità di organismi, accettando tale ipotesi seguirebbero l’impulso, lo slancio, a rientrare a far parte di uno stato pre-organico, inanimato. Ma – e in tale topos scattano la trama e l’intreccio del dramma de La Lupa – vogliono farlo in un modo del tutto “personale” ed auto causato. Nel testo del ’20 Freud sostiene che “nella vita psichica esiste davvero una coazione a ripetere, la quale si afferma anche a prescindere dal principio del piacere”. Sulla falsariga del motto errare humanum est, perseverare autem diabolicum, essa viene definita per quattro volte “demoniaca”.
Ed ecco Lina Sastri, nello stesso tempo scatenata ed abbattuta, distrutta ed infaticabile, ai piedi delle afose campagne dell’Etna, aggirarsi senza sosta, dapprima tentando di sedurre l’amato, poi offrendogli la figlia in moglie, ottenendone in cambio – almeno questo è il suo desiderio - la disponibilità sessuale. Poco dopo l’inizio dello spettacolo vediamo, sull’aia, tutti i personaggi della vicenda festosamente impegnati in balli campestri, mentre le lunghe gonne nere delle ragazze vanno su e giù seguendo i tempi di una danza ben ritmata all’interno di coreografia, musica e canto - in primis con la voce modulata della Sastri - capaci di entrare solidamente nel cuore del racconto in atto: e a consolidare l’utilità di una interpretazione in chiave psicanalitica di “Eros e Thanatos” intrecciati nella psiche umana, pare che la vicenda si ispirasse a un episodio di cronaca di quei tempi.
Non più giovane, rimasta vedova, con il nero del lutto ma anche il rosso, gnà Pina – a differenza della novella – appare inserita nella comunità, al cui interno è una lavorante, sicuramente la più anziana ma, in ogni caso, in grado di ragionare e discutere animatamente con gli altri. E’ sera. Nanni si offre di far da guardiano notturno al raccolto, alla “roba”, e si accovaccia sulla nuda terra per riposare: La Lupa riesce a sedurlo, mentre lo stridio della civetta fa da lugubre segno premonitore.
Alla riapertura del sipario per il secondo atto, sono trascorsi ormai alcuni anni. Nanni termina di arredare l’esterno della casa, in occasione della festa tradizionale del paese. La coppia ha avuto un bambino: in tale quadro di ordine sociale e affettivo, privo di elementi perturbanti, almeno evidenti, riappare la Lupa, la quale, lasciando alla figlia e al marito la casa, si era ritirata in campagna. La tendenza autodistruttiva che la domina, la coazione a ripetere (anche nel caso di azioni dolorose e causa di sicura sofferenza), è il meccanismo psichico al quale la donna non riesce a rispondere ignorandola, avvicinandosi - di conseguenza - attraverso l’amore, sempre più alla sciagura totale alla fine inevitabile. Lo scontro da lei preparato si verifica grave e drammatico: tra madre e figlia, tra gnà Pina e Nanni e anche tra loro e i compaesani, i quali cominciano a gridare allo scandalo, tanto da far giungere le urla alla piazza.
Nanni assume un comportamento violento, colpisce Maricchia, si rivolta anche verso le donne e gli uomini presenti, ha gesti e parole convulsi istintivi e ribelli. La donna sente avvicinarsi la realizzazione della sua libido, alleata ad un indice di scopo altamente distruttivo, e cioè quell’essenziale spinta o pulsione di morte, gestita con, contro o attraverso la passione amorosa, riferendosi al bisogno di morire custodito nel profondo di ogni essere vivente. Gli organismi, secondo questa idea, tendono a tornare ad uno stato pre- vivente, statico: ma vogliono farlo in modo personale.
Rimasta di nuovo sola con Nanni, gnà Pina gli si offre, ostentando il suo corpo con “lussuria”. Ed ecco: quel manico di legno, da tempo poggiato alla panca ora viene scoperto, visto distintamente, Nanni lo impugna e la lama della scure, chiara quasi luminosa si abbatte su di lei. Alla fine, la Lupa riesce in modo personale, irriproducibile, dopo un lungo cammino e una sequela di tentativi a ripetizione, a tornare allo stato preorganico, inanimato, al quale mirava, dopo essere rimasta sola, vittima di un amore non condivisibile, nelle pianure assolate intorno all’Etna, dove lei e la sua gente hanno sempre vissuto.
Bibliografia:
Leggi anche: Il mito di Fedra: mito, donna, amante

Maria Barchiesi è nata a Cremona nel '53; si è laureata in Lettere Classiche e perfezionata in Storia della Filosofia Antica presso l'Università di Pavia, sempre con il prof. Mario Vegetti con il quale ha collaborato presso lo IUSS pavese. Da sempre ama viaggiare e la cultura in tutte le sue manifestazioni e saperi è la sua scelta di vita prioritaria. Nell'insegnamento presso le scuole superiori e lo IUSS ha vissuto il rapporto con i giovani di età diversa sempre con entusiasmo e desiderio di vederli culturalmente crescere. Il principio che la guida nelle ricerche è: kalos kai agathos, ciò che esprime bellezza è anche buono eticamente, fa bene all'anima e alla mente.
Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?
 Scopri come collaborare con noi
Scopri come collaborare con noi






Rosario Frasca
VAI AL BLOG
Rosella Rapa
VAI AL BLOG
Davide Morelli
VAI AL BLOG
Elio Ria
VAI AL BLOG
Anna Stella Scerbo
VAI AL BLOG
Anna Lattanzi
VAI AL BLOG